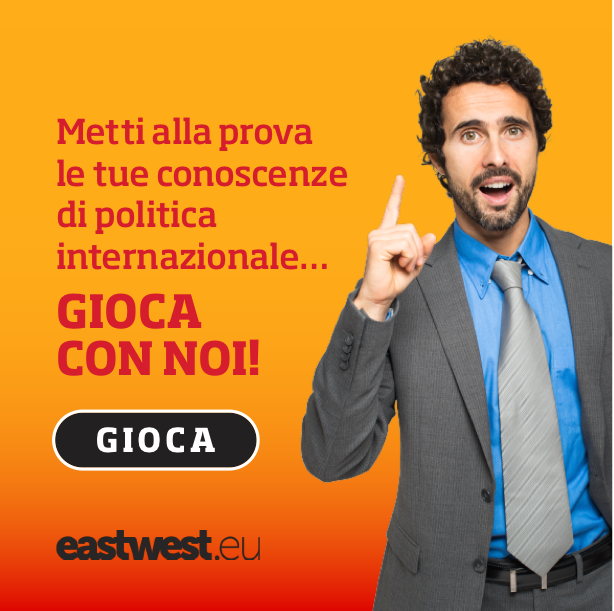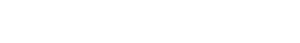Lo scorso 1° maggio, i confini ad Est dell’Europa si sono modificati e, insieme ad essi, le prospettive di sviluppo dell’Unione. Nel senso più ampio del termine. Realizzato l’obiettivo dell’allargamento, uno dei rischi è che questo venga percepito più come un traguardo che come una tappa intermedia di un processo ancora ricco di sfide.
Quando si considerano gli effetti economici dell’allargamento, i cittadini della “vecchia” Unione a 15 sono infatti istintivamente portati a percepirli in maniera “statica”, prestando attenzione ai dati di stock attuali (evidenziando ad esempio che i nuovi membri arricchiscono il Pil comunitario soltanto dell’8%, a fronte di un incremento del 47% nella popolazione) piuttosto che agli effetti “dinamici” di tale processo. Se è vero che la capienza della domanda del mercato europeo si modifica solo marginalmente, è tuttavia difficilmente contestabile che l’offerta produttiva della nuova Unione a 25 si arricchisce di una base industriale diversificata, in grado di rendere maggiormente competitivo il nostro settore manifatturiero in una fase di crescente internazionalizzazione delle produzioni. La presunzione che i “vantaggi” dell’allargamento ricadano esclusivamente a beneficio dei nuovi entranti, mentre la “vecchia” Europa si troverebbe a sostenere soltanto i costi derivanti dall’ampliamento del budget dell’Unione, appare troppo incentrata su un antistorico confronto “bipolare” fra vecchi e nuovi Membri, ignorando più o meno volutamente che alcuni dei nuovi entrati – in particolare quelli di minore dimensione – presentano già condizioni di reddito reale prossime alla media comunitaria. Non solo: nella mia esperienza “sul campo” ho potuto verificare che anche la qualità e la professionalità delle risorse umane, in quei Paesi, è già perfettamente allineata con i nostri standard.
Ciò premesso, costituisce ormai un fatto assodato che l’allargamento porterà – quale effetto indiretto del più consistente incremento di Pil dei nuovi Paesi membri – ad una crescita del Pil dei Quindici: di tale incremento, saranno proprio le economie dei Paesi europei con la quota maggiore di interscambio con i nuovi membri, quali innanzitutto Germania e Italia, a beneficiarne in misura più ampia.
Il processo di aggiustamento strutturale in corso nei dieci nuovi entrati, che continuerà a caratterizzare i prossimi anni, potrebbe peraltro comportare ricadute in termini di maggiore inflazione e di ampliamento dei disavanzi di parte corrente. Tale situazione presupporrà un’attenta governance del processo di integrazione dei nuovi membri all’interno dei meccanismi dell’Unione Economica e Monetaria, tenendo conto delle bande di oscillazione ristrette imposte a ciascun Paese dallo Sme 2.
Un importante contributo alla stabilizzazione della bilancia dei pagamenti dei nuovi Paesi potrebbe derivare da un’ulteriore accelerazione dell’attuale percorso di integrazione fra i mercati del credito e dell’intermediazione di vecchi e nuovi Stati membri. Proprio nell’anno in cui il Piano di Azione sui Servizi Finanziari, adottato dalla Commissione nel 1999, giunge felicemente a compimento, è ormai evidente che un progressivo consolidamento dei sistemi creditizi dei Paesi europei faciliterebbe considerevolmente l’attuale delicata fase di catchup, in cui i nuovi Stati membri necessiteranno di flussi addizionali di risorse per finanziare i propri programmi di sviluppo. Nonostante i grandi investimenti effettuati nell’ultimo quinquennio dai principali gruppi bancari europei nei Paesi della Nuova Europa (la partecipazione estera al sistema finanziario locale supera il 70% in Slovacchia, Estonia, Polonia e Ungheria), rimane a tutt’oggi evidente il forte divario dimensionale esistente fra sistemi creditizi, sia in termini di capitalizzazione di borsa (pari al 16% del Pil nei nuovi Stati, a fronte di una media dell’UE a 15 del 67%) sia di rapporto fra attività bancarie e Pil (80%, a fronte di una media europea del 260%). Un’accelerazione dell’integrazione sarà certamente garantita dall’estensione dell’unione monetaria. I benefici maggiori sono riconducibili all’eliminazione dei rischi di cambio e dei relativi costi, a una maggiore trasparenza dei prezzi e, in generale, alla conseguente riduzione della segmentazione dei mercati. Le opportunità che l’allargamento propone, tuttavia, diventano fattori di crescita e coesione solo se si accettano – e si vincono – una serie di sfide. L’Unione Europea non può continuare ad essere solo un’entità economica, in espansione geografica. È necessario che si sviluppi una “via europea” alla politica, per guidare il futuro di oltre 450 milioni di persone.
Se da un lato l’economia e la finanza sono riuscite ad abbattere numerosi confini e hanno dimostrato l’esistenza di una forte volontà di tutti e 25 i Paesi di crescere in un contesto europeo unito, il processo di integrazione rimarrà incompiuto e non potrà mai offrire quei vantaggi che tutti i cittadini europei si aspettano se non attraverso una chiara scelta politica unitaria, che coniughi equità e competitività, solidarietà ed efficienza. E se la bozza di Costituzione europea approvata il 18 giugno dovesse incontrare, durante gli iter di ratifica, difficoltà insormontabili, allora un nucleo di Paesi (e di leader illuminati) dovrebbe tornare a ricoprire quel ruolo di avanguardia che ha sempre trascinato – negli ultimi cinquant’anni – l’Europa verso i traguardi più ambiziosi.
Un’ultima considerazione sull’Unione Europea che si conferma un’entità aggregante e aperta e, quindi, destinata ad allargare ulteriormente i propri confini: questa circostanza merita una riflessione particolare, in quanto evoca una prospettiva che ripropone interrogativi che ci siamo già posti negli anni precedenti al 1 maggio 2004.
Ralph Dahrendorf, in un saggio di qualche anno fa, spiegava brillantemente che “i Paesi che si sono sbarazzati del socialismo reale non hanno abbracciato, in sua vece, un altro sistema, il capitalismo; hanno scelto la società aperta, nella quale esistono cento vie differenti verso la libertà”, e queste strade hanno condotto naturalmente verso l’Europa, così come lo sarà per Romania e Bulgaria, Croazia e Turchia.
Anche io più recentemente, come Timothy Garton Ash prima della caduta del muro, “ho viaggiato avanti e indietro fra le due metà del continente” e ho condiviso le sue riflessioni sul fatto che “il vero spartiacque è fra quelli (all’ovest) che hanno l’Europa e quelli (all’est) che credono nell’Europa. E in questi Paesi, la frase usata dalla gente per riassumere ciò che sta avvenendo è “ritorno all’Europa”: un’Europa di nuovi ideali e di nuovi entusiasmi, che si ribelli alla logica del negoziato infinito che ha tenuto lontani dalle urne, lo scorso giugno, migliaia di nuovi cittadini che hanno smarrito gli ideali dei primi anni, tra particolarismi e politiche del “bilancino”; un’Europa capace di ridare slancio al perseguimento degli obiettivi unitari, dove non sia necessario dimostrare continuamente che l’Europa “conviene”, ma dove tutti lavorano per fare in modo che l’Europa “convenga”.
Lo scorso 1° maggio, i confini ad Est dell’Europa si sono modificati e, insieme ad essi, le prospettive di sviluppo dell’Unione. Nel senso più ampio del termine. Realizzato l’obiettivo dell’allargamento, uno dei rischi è che questo venga percepito più come un traguardo che come una tappa intermedia di un processo ancora ricco di sfide.
Quando si considerano gli effetti economici dell’allargamento, i cittadini della “vecchia” Unione a 15 sono infatti istintivamente portati a percepirli in maniera “statica”, prestando attenzione ai dati di stock attuali (evidenziando ad esempio che i nuovi membri arricchiscono il Pil comunitario soltanto dell’8%, a fronte di un incremento del 47% nella popolazione) piuttosto che agli effetti “dinamici” di tale processo. Se è vero che la capienza della domanda del mercato europeo si modifica solo marginalmente, è tuttavia difficilmente contestabile che l’offerta produttiva della nuova Unione a 25 si arricchisce di una base industriale diversificata, in grado di rendere maggiormente competitivo il nostro settore manifatturiero in una fase di crescente internazionalizzazione delle produzioni. La presunzione che i “vantaggi” dell’allargamento ricadano esclusivamente a beneficio dei nuovi entranti, mentre la “vecchia” Europa si troverebbe a sostenere soltanto i costi derivanti dall’ampliamento del budget dell’Unione, appare troppo incentrata su un antistorico confronto “bipolare” fra vecchi e nuovi Membri, ignorando più o meno volutamente che alcuni dei nuovi entrati – in particolare quelli di minore dimensione – presentano già condizioni di reddito reale prossime alla media comunitaria. Non solo: nella mia esperienza “sul campo” ho potuto verificare che anche la qualità e la professionalità delle risorse umane, in quei Paesi, è già perfettamente allineata con i nostri standard.