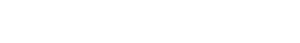Inizia oggi la presidenza López Obrador, destinata sulla carta a cambiare il Messico. Ma da quando è stato eletto il leader di sinistra ha mandato molti segnali contradditori, dal perdono per i funzionari corrotti alla ri-militarizzazione. E con Trump è quasi scoppiato l’amore
Lo scorso 1° luglio Andrés Manuel López Obrador è stato eletto presidente del Messico per la gioia della popolazione – il 53% dei votanti lo ha preferito agli altri tre candidati – ma con il timore degli investitori. López Obrador veniva infatti dipinto come un populista di sinistra che con le sue politiche radicali e sprovvedute avrebbe portato il Paese verso la crisi economica e finanziaria. Una narrazione certamente esagerata, tuttavia gli eventi delle ultime settimane hanno dato parecchio materiale ai critici del nuovo leader della seconda economia dell’America Latina.
López Obrador ha passato buona parte della sua campagna elettorale a presentarsi come un politico moderato e responsabile, attento alla stabilità macroeconomica e rispettoso dell’iniziativa privata. Però, a fine ottobre, ha indetto una sorta di referendum sulla cancellazione del nuovo aeroporto di Città del Messico: nonostante la bassa affluenza e le falle organizzative, López Obrador ha dichiarato di voler rispettare la volontà popolare e ha messo fine al progetto anche se i lavori erano già iniziati e c’erano delle imprese che avevano vinto degli appalti. La decisione ha mandato un segnale negativo agli investitori e provocato la brusca reazione dei mercati: la moneta e la borsa messicana sono crollate.
Più di recente, una proposta di legge – poi ritirata – per limitare le commissioni bancarie ha causato alla borsa la peggiore perdita da sette anni.
Nonostante le parole spese per allontanare le accuse di estremismo, i fatti danno l’impressione che il neopresidente voglia portare avanti il suo programma economico a prescindere dal comportamento dei mercati. E questa è solo una delle tante contraddizioni di López Obrador, un personaggio di cui si scrive molto ma che ancora non si è riusciti a comprendere davvero. Lo scarto tra il detto e il fatto, o tra una dichiarazione e l’altra, è spesso talmente ampio da concedere agli analisti un’unica certezza, almeno per il momento: López Obrador sarà un presidente imprevedibile ma capace di assorbire e risolvere ogni incoerenza nella sua persona.
Il suo mandato comincia ufficialmente oggi, con una cerimonia alla quale assisteranno anche Ivanka Trump e Nicolás Maduro, ma in questi mesi López Obrador ha già influenzato moltissimo la politica e l’economia del Messico. Merito del risultato elettorale, che gli ha assicurato una larga maggioranza al Congresso, e della sua popolarità, che gli conferisce molto capitale politico: López Obrador sale infatti al potere con un indice di gradimento del 66%, mentre il suo predecessore Enrique Peña Nieto lascia la residenza di Los Pinos con appena il 26% di consensi.
La popolarità di López Obrador deriva in buona parte dalla sua crociata contro la corruzione, diffusissima nel Paese, e dal suo buon esempio. Evita lo sfarzo e vive con una semplicità quasi austera se paragonata agli standard degli altri politici: al polso mostra un orologio da poche decine di dollari, dice di possedere solo otto completi e gira su una vecchia Volkswagen Sedan. La lotta inflessibile ai corrotti e all’impunità erano i punti centrali della sua retorica e del suo programma. Ma pochi giorni fa ha detto che perdonerà tutti i funzionari accusati di corruzione prima di sabato 1 dicembre, così da mettere un «punto finale» a questa «orrenda storia», chiudere con il passato e cominciare una «nuova fase» da zero. «La vendetta non è il mio forte», ha aggiunto.
Anche in materia di sicurezza, López Obrador ha ribaltato le sue posizioni di 180 gradi. In campagna elettorale aveva promesso il rientro dei soldati nelle caserme – in molte zone del Messico è infatti l’esercito a garantire l’ordine nelle strade –, mentre adesso vuole riformare la Costituzione per affidare la gestione della pubblica sicurezza alla Guardia nazionale, una formazione militaresca di sua creazione.
La strategia di López Obrador è davvero simile, nella sostanza, a quella degli ex-presidenti Calderón e Peña Nieto ed è quindi probabile che porterà agli stessi risultati. La militarizzazione del territorio messicano non ha risolto la crisi della sicurezza che, anzi, si è aggravata, complice la frammentazione dei gruppi criminali: gli omicidi sono in forte crescita dal 2014, nel 2017 se ne sono registrati oltre 31mila e le previsioni indicano che quelli commessi quest’anno saranno probabilmente ancora di più. Da tempo gli esperti insistono sulla necessità di rafforzare i corpi di polizia ma nel piano di López Obrador non sono previsti fondi per questo scopo.
López Obrador è anche un presidente ambientalista: vuole ridurre le emissioni di gas serra, piantare un milione di alberi, proteggere le riserve d’acqua dallo sfruttamento estremo e rendere le città più ecosostenibili. Promette di impegnarsi per rispettare i parametri dell’accordo di Parigi sul clima però, allo stesso tempo, vuole rilanciare la produzione petrolifera, che è in calo da alcuni anni e che ha portato il Messico a dipendere dalle importazioni di benzina dagli Stati Uniti. López Obrador ha intenzione di costruire una nuova raffineria – costo 8 miliardi di dollari -, di potenziare le capacità di quelle esistenti e di sussidiare il prezzo del carburante per mantenerlo basso. Tutte iniziative che contrastano con i propositi verdi e che ridurranno inevitabilmente i fondi da destinare allo sviluppo delle energie rinnovabili, rischiando di ritardare la transizione energetica di un Paese con un grande potenziale eolico e solare inespresso.
Tutto da capire rimane anche l’approccio di López Obrador nei confronti di Donald Trump. In campagna elettorale si è presentato come il campione dei poveri e dei migranti, sia messicani che centroamericani, ha definito Trump un neofascista e un dispensatore di odio e ha detto che il Messico deve smetterla di fare il «lavoro sporco» per gli Stati Uniti, riferendosi alla gestione dei flussi migratori che Washington ha delegato al suo vicino meridionale dal 2014.
Vinte però le elezioni, i toni sono cambiati e, anzi, tra López Obrador e Trump i rapporti sono adesso molto cordiali. Ma la crisi potrebbe sempre essere dietro l’angolo, perché le agende dei due presidenti entrano in conflitto su molti punti. E l’incognita López Obrador, con i suoi continui cambi di posizione, è motivo di inquietudine per gli Stati Uniti, secondo un rapporto presentato ad ottobre al Congresso americano.
López Obrador e Trump potrebbero tuttavia portare la partnership bilaterale su un nuovo livello. Washington e Città del Messico stanno negoziando un accordo migratorio di portata rivoluzionaria, che prevede che i migranti che faranno richiesta d’asilo negli Stati Uniti debbano attendere in Messico – e non più in territorio americano – i tempi di valutazione della domanda. Segnerebbe la fine del sistema catch and release tanto inviso a Trump e ridurrebbe la pressione sui varchi di entrata alla frontiera.
In cambio, l’amministrazione Obrador chiede qualcosa di altrettanto notevole: la partecipazione americana, cioè, ad un piano di sviluppo per il Messico del sud e l’America centrale, che avrà lo scopo di promuovere la crescita economica e risolvere alla radice le cause dell’emigrazione. Il nuovo ministro messicano degli Esteri, Marcelo Ebrard, ha paragonato la portata di questo progetto a quella che fu del piano Marshall per l’Europa del dopoguerra. La spesa richiesta, alla quale gli Stati Uniti dovranno eventualmente contribuire, è di 20 miliardi di dollari in sei anni per il Messico meridionale e altrettanti per El Salvador, Honduras e Guatemala. Il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha detto una settimana fa che l’amministrazione Trump sta «esaminando le possibilità di stimolare la creazione di posti di lavoro nella regione».
@marcodellaguzzo
Inizia oggi la presidenza López Obrador, destinata sulla carta a cambiare il Messico. Ma da quando è stato eletto il leader di sinistra ha mandato molti segnali contradditori, dal perdono per i funzionari corrotti alla ri-militarizzazione. E con Trump è quasi scoppiato l’amore