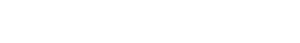Come abbiamo sottolineato già in altri nostri editoriali in passato, questi lunghi anni di crisi finanziaria non hanno solo messo in crisi la capacità autoregolatrice del mercato, ma anche il rapporto tra rappresentati eleadership politica nelle democrazie occidentali
Se in Europa dobbiamo gestire elezioni ogni sei mesi, è impossibile affrontare credibilmente i grandi problemi del nostro secolo: finanza, clima, energia, big data richiedono capacità tecniche rilevanti e decisioni politiche che impattino su aree di una certa consistenza geopolitica. Inutile affrontare, come abbiamo spiegato nelle nostre inchieste, il problema della mancanza di coordinamento dei gasdotti europei con decisioni nazionali. Finché non avremo una governance europea sul tema, saranno i paesi generatori di energia a decidere, in barba a noi consumatori, piccoli e divisi. Nell’attesa, i sistemi dove la tradizione maggioritaria è più solida riescono a ritagliarsi un ruolo di maggiore protagonismo, a scapito di quei paesi i cui esecutivi sono strutturalmente più deboli, in obbedienza a un confuso principio di democrazia partecipativa, dove le minoranze non sono solo i controllori del rispetto dei diritti, com’è giusto che sia, ma riescono spesso a bloccare completamente il processo decisionale.
Fino al 2005, meno della metà degli elettori italiani riteneva che il Paese avesse bisogno di un leader forte. Oggi, a pensarlo sono otto italiani su dieci e questo dato, in realtà, non si riferisce solo all’Italia ma riguarda la maggior parte dei paesi del mondo. Le democrazie occidentali moderne, a prescindere dalla loro collocazione storica e geopolitica, sembrano non essere più in grado di esprimere una rappresentanza efficiente: i mercati sono invadenti, così come lo è la globalizzazione, e questi sono elementi che infiltrano le società ad una velocità sicuramente maggiore rispetto all’andamento dei processi che portano un leader a conquistare la fiducia dei cittadini. È molto facile che questo risulti debole, lento, perché poco reattivo alla mutevolezza delle situazioni, delle dinamiche esterne, che non sono sempre ponderabili. Allora la ricerca del proprio rappresentante si concentra su qualcuno che si mostri abbastanza sicuro e forte da poter mettere il paese nelle condizioni di governare i mercati, la globalizzazione e la velocità del cambiamento: Trump, Putin, Erdogan, Orban… e, allargando lo sguardo verso Oriente, Xi Jinping in Cina e Narendra Modi in India.
Il primo, nel quinquennio tra il 2012 e il 2017, ha dimostrato un’abilità non comune nel rafforzare la propria posizione: ha dapprima limitato gli spazi di manovra del premier Li Keqiang, per poi indire una campagna anti-corruzione, che ha messo fuori gioco una serie di oppositori “scomodi”. Ha poi aggiunto “Il Pensiero di Xi” nella Costituzione cinese, emulando così Mao Zedong. Nel mettere il suo contributo politico-teorico all’interno del principale documento di organizzazione del Paese, il Presidente si è confermato non solo come leader della nazione, ma anche come guida storica del popolo cinese: attraverso un enorme piano di riforme che vanno dall’economia (pensiamo alla “New Normal”, che prevede un netto passo avanti rispetto alla chiusura protezionistica a cui il mondo era abituato, o ai piani di riqualificazione industriale) alla modernizzazione e potenziamento delle forze armate (ha annunciato che nel 2018 ci sarà un incremento dell’8% della spesa militare), il numero uno di Pechino sta rendendo la Cina sempre più competitiva su scala mondiale e questo piace a tal punto, che Xi Jinping potrebbe addirittura restare in carica a vita. L’11 marzo 2018, infatti, il Congresso ha votato a favore dell’abolizione della norma che prevede il limite dell’incarico presidenziale a due mandati. Su 3.000 membri votanti, solo 5 hanno votato contro, e questo ci conferma che Xi sarà verosimilmente rieletto e potrà quindi continuare a garantire quel protagonismo nei processi di globalizzazione, che consentiranno al suo paese l’inarrestabile corsa verso la leadership mondiale.
L’India, con l’elezione di Narendra Modi, nel 2014, ha cominciato la sua trasformazione “secondo Modi”, che vuole forgiare una futura “potenza guida” globale e democratica (a differenza della Cina), a partire dal dato demografico, che vede Dheli (più del 20% della popolazione mondiale) quasi al sorpasso sulla Cina: 1 mld 380 mln di persone, contro i 1 mld 325 mln dell’India, che però continua a crescere (+1,2% nel 2016, contro solo lo 0,5 in Cina). Ci si aspetta il fatidico sorpasso prima del 2030.
Per concretizzare il sogno indiano, Modi sta realizzando un enorme piano di riforme, che si prefiggono di dare un nuovo slancio all’industria e al commercio, con un forte accento sulla produzione interna, specialmente sul versante tecnologico: tra il 2017 e il 2018, le esportazioni IT stanno crescendo dell’8%.
Dobbiamo quindi tutti ispirarci ai modelli cinese o indiano?
No, ma i leader europei rischiano di avere una finestra non illimitata di tempo per accelerare il processo di integrazione europea verso un modello federale di stampo americano (o, in subordine, una Federazione di Stati sul modello svizzero): politica estera e di difesa accentrate, così come la politica economica e quella monetaria. Federalismi nazionali riorganizzati su accorpamenti di piccole regioni, superando quel gioco di veti locali che non consentono decisioni rapide, almeno sui grandi temi. Non possiamo tollerare in Europa istanze autonomiste come quelle catalane, a tutela di una comunità ricca che non vuole accollarsi oneri di solidarietà che sono alla base della formazione di Stati forti e competitivi.
Così come non ha senso suddividere la già debole Italia in 20 piccole regioni, in molti casi senza ancoraggio storico nè economico, e soprattutto senza una classe dirigente di qualità in grado di contribuire utilmente alla gestione delle comunità locali, come dimostra il moltiplicarsi di una miriade di casi di “mismanagement”, dalle acciaierie di Taranto al gasdotto in Puglia, dalla Linea ferroviaria veloce ovest-est (cosiddetta TAV) alla ristrutturazione dell’area industriale di Bagnoli-Napoli.
E se i Macron forti e competenti ci condurranno più rapidamente verso opzioni sensate, ben vengano! Ma attenzione: la prossima legislatura europea è quella decisiva! Non avremo un’altra chance…
Per continuare a leggere, acquista il pdf del numero.
Per abbonarti, visita la nostra pagina abbonamenti.
Come abbiamo sottolineato già in altri nostri editoriali in passato, questi lunghi anni di crisi finanziaria non hanno solo messo in crisi la capacità autoregolatrice del mercato, ma anche il rapporto tra rappresentati eleadership politica nelle democrazie occidentali