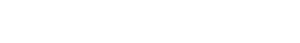L’Europa ha bisogno del Mediterraneo e il Mediterraneo di una leadership europea, che passa da un rapporto intelligente con attori chiave come Cina, Iran e Turchia
Il filosofo francese Paul Valéry definiva il Mediterraneo “una macchina per produrre civiltà”. Nel novembre del 1933 durante una conferenza all’Université des Annales dichiarò: “Mai in nessun altro luogo, entro una superficie così circoscritta e in un lasso di tempo così breve sono stati rilevati tanto fervore intellettuale, tanta produzione di ricchezze”. La rilevanza strategica che il Mediterraneo ha assunto nel corso della sua storia deriva dalla profonda relazione tra la sua posizione geografica e l’essere il luogo d’incontro di diversità culturali.
Oggi il Mare Nostrum, la culla della nostra civiltà, è diviso e frammentato tra mille contraddizioni religiose, sociali e territoriali: dalla Libia alla Siria, dall’Iraq all’Iran, da Israele alla Palestina.
In uno scenario mediterraneo così complesso, è utile interrogarsi su quali strumenti l’Unione Europea possa utilizzare per rendere la sua azione esterna più incisiva e adeguata al suo ruolo nella regione.
La storia non ha prodotto successi, purtroppo: già negli anni ‘60, l’allora Comunità economica europea, seppur con un numero limitato di Paesi, aveva intrapreso le prime politiche bilaterali di cooperazione mediterranea. Ma fu la guerra arabo-israeliana del 1967 a spronare la Cee (all’epoca composta solamente dai sei Paesi fondatori) a un ulteriore passo avanti: nacque così nel 1972 la “Politica mediterranea globale”, dove furono fissate le prime vere linee guida per accordi di cooperazione che identificavano i Paesi del Mediterraneo come un gruppo omogeneo. Il tentativo aveva una matrice politica (riuscire a bilanciare il ruolo delle superpotenze globali nella regione), ma anche economica, cioè espandere il mercato europeo verso sud. I risultati non furono particolarmente soddisfacenti.
Negli anni 80’, il Presidente forse più carismatico della Commissione Europea, Jacques Delors, provò a realizzare uno spazio economico unificato che rivitalizzasse la politica mediterranea, ma neanche questa volta i risultati furono quelli sperati. Anche l’Italia di Bettino Craxi provò a dare il suo contributo: Spagna e Italia proposero la CSCM (Conference on Security and Cooperation in the Mediterranean), un nuovo modello di relazioni che prevedeva la gestione multilaterale di tre aree di cooperazione (sicurezza, economia e diritti umani), poi evoluta nella Dichiarazione di Barcellona, promotrice del Partenariato Euro-Mediterraneo (1995), che ha provato ad affrontare il rapporto tra le due rive del mare in maniera organica, riconoscendo i reali squilibri tra i Paesi delle due sponde, garantendo pari dignità ai diversi partner. Trentanove nazioni unite dall’obiettivo di rendere l’area mediterranea una “zona di dialogo, di scambi e di cooperazione che garantiscano la pace e la stabilità”, rilanciando uno spirito di partenariato lontano dall’assistenzialismo che aveva accompagnato le fasi precedenti, e dando vita a un accordo internazionale produttore di effetti giuridici e di obblighi internazionali. Nonostante le lodevoli intenzioni, anche questo progetto si è imbattuto in numerosi ostacoli.
Poi si è sviluppata la politica europea di vicinato e, infine, L’Unione per il Mediterraneo (UpM), presentata a Parigi nel 2008 dal Presidente Sarkozy. Le primavere arabe hanno segnato il fallimento definitivo di decenni di tentativi di garantire una crescita economica che favorisse anche l’evoluzione democratica dei Paesi della sponda sud del Mediterraneo.
Oggi, non siamo ancora usciti dalle conseguenze delle primavere, che stanno impattando anche in Europa. In tema di sicurezza, ad esempio, Bruxelles sta faticosamente cercando di condurre le parti in guerra civile in Libia a una pace duratura, dopo aver fallito in Siria, e aver con fatica evitato la formazione di uno Stato Islamico nella terra di nessuno tra Siria e Iraq, con il sostegno di una coalizione internazionale; in tema di migrazioni, abbiamo dovuto gestire la più grave crisi politica degli ultimi 20 anni, non essendo pronti a regolare flussi crescenti dalla sponda sud del Mediterraneo, con rischi di tenuta tra gli stessi Paesi fondatori dell’Unione Europea. E con una demografia che ci condanna: nel 2050, il 27% degli europei avrà almeno 65 anni, mentre la popolazione africana raddoppierà, fino a 2 miliardi e mezzo di persone. Infine, l’emergere di nuovi superpotenze mondiali (Cina innanzitutto) impone all’Europa un protagonismo senza ritardi, pena l’irrilevanza. L’affermazione di un protagonismo europeo passa innanzitutto dall’assumere il ruolo di potenza mediterranea.
L’occasione storica c’è: il Mediterraneo sta acquistano una nuova centralità, qui transita quasi il 20% del traffico mondiale delle merci e non è un caso che la Cina guardi ai porti del Mare Nostrum come approdi fondamentali per la sua nuova Via della Seta. Il raddoppio del Canale di Suez ha reso la rotta mercantile mediterranea molto più veloce e nuovi investimenti stanno coinvolgendo i porti dei Paesi del sud.
Grazie alla sua geografia, l’Italia si trova in una posizione ideale e il Mezzogiorno non può perdere quest’ennesima opportunità di sviluppo, dotandosi di infrastrutture e competenze che gli consentano di svolgere un ruolo primario nella competizione globale dei flussi commerciali e del protagonismo politico della Ue.
L’Unione deve però consolidare un posizionamento internazionale che si avvalga del sostegno di tutti i Paesi membri e di risorse sufficienti a poter svolgere un ruolo nelle partite strategiche più rilevanti nel mondo che ruota attorno al Mar Mediterraneo. Ma per giocare la partita degli scenari globali, bisogna recuperare alleanze e mediazioni con attori chiave, dall’Iran alla Cina alla Turchia.
Come si è potuto pensare per decenni, ad esempio, di poter sviluppare un protagonismo Mediterraneo senza una partnership con Ankara, sempre esclusa da tutte le iniziative che abbiamo ricordato? Oggi ci troviamo nella difficilissima condizione di non poter criticare Erdogan per la disponibilità fornita al Governo legittimo libico di sostegno militare, subendo l’iniziativa turca da una posizione di debolezza difficilmente rimontabile.
E con la Cina, per citarne un altro, dobbiamo stare attenti a non farci ingabbiare nelle ossessioni dell’amministrazione americana di turno.
Non è irrimediabilmente tardi, ma abbiamo poco tempo…
@GiuScognamiglio
Il presente articolo è comparso su La Sicilia il giorno 31 dicembre 2019.

L’Europa ha bisogno del Mediterraneo e il Mediterraneo di una leadership europea, che passa da un rapporto intelligente con attori chiave come Cina, Iran e Turchia