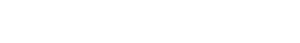Chi avrebbe mai potuto pensare che dei graffiti rupestri, con circa ottomila anni sulle spalle, potessero essere trattati da “infedeli” e additati come colpevoli per offesa alla religione tanto da dover essere cancellati?

È successo nell’autunno 2012, sulla catena dell’Atlante in Marocco, quando un gruppo di musulmani salafiti ha distrutto alcuni disegni preistorici presenti presso un sito archeologico.
Scoperti nella pianura Yakout, vicino Marrakech e a venti chilometri dall’alta cima di Toubkal, le immagini erano sopravvissute a millenni di intemperie e scorribande. Le incisioni su pietra, anteriori alla presenza dei Fenici in Marocco, rappresentavano il Sole. Sono state rimosse perché esempi di idolatria.
Per la potenza dell’atto simbolico, quello salafita contro i graffiti va di pari passo con la distruzione delle statue dei Buddha di Bamiyan, uno shock culturale che il mondo intero visse in diretta nel 2001 quando i talebani le fecero saltare senza ascoltare gli appelli internazionali: il Metropolitan di New York, l’India e il Pakistan si erano fatti avanti per salvare i colossi di pietra, vittime dell’odio religioso perché “idoli preislamici”.
Le statue erano alte l’una 38 metri, l’altra 53 e avevano un’età di 1.500 anni. Intorno al doloroso vuoto di pensiero e bellezza rimasto, si aggira da anni un artista visionario.
È giapponese, si chiama Hiro Yamagata e ha un progetto di ricreare i Buddha attraverso dei raggi laser da posizionare sulle colline di Bamiyan. Alimentati da pannelli solari e pale eoliche, dovrebbero proiettare le riproduzioni degli originali con colori fluorescenti.
A Kabul intanto, il Museo nazionale afghano si sta prendendo una rivincita per i grandi saccheggi del 2001, quando i talebani fecero uscire circa 2.500 oggetti dalle sale con la complicità dei custodi. Molti reperti vennero distrutti perché ritenuti sacrileghi. I frammenti furono però conservati e oggi, grazie a un certosino restauro, già trecento pezzi hanno ritrovato la loro identità.
Nonostante l’arte nei secoli sia stata sovente commissionata da papi, rabbini, monaci e imam, la sua convivenza con la fede è spesso stata difficile.
Quella contemporanea poi è entrata in un conflitto stabile con le istituzioni religiose e si è scontrata sul campo innumerevoli volte. Sconfitta nella sua battaglia per la libera espressione, a volte ha pagato con la propria distruzione, oppure ha subìto aggressioni e atti di vandalismo.
Sono vari i motivi che hanno scatenato gli anatemi contro certe espressioni artistiche, ma lo scandalo – quando non è a sfondo sessuale – spesso nasce dall’accusa di blasfemia. La Chiesa cristiana, nel tempo, ha disconosciuto un numero impressionante di opere d’arte: a partire da quelle di Caravaggio, respinte perché rappresentavano la Madonna nel corpo di una prostituta annegata, o i santi con le piante dei piedi inzaccherate di fango.
In tempi recenti ha suscitato molte polemiche e manifestazioni spontanee di credenti un lavoro del franco-algerino Adel Abdessemed. L’artista aveva installato nella cripta della Basilica di Notre Dame des Miracles, a Mayenne, in Francia, un video – intitolato Lise – in cui una donna, ripresa nell’iconografia tipica della Vergine allattante, donava il suo nutrimento non al bambino sacro, ma a un maiale. Non è piaciuta la provocazione.
Lo stesso autore aveva fatto infuriare i conservatori del Qatar con la sua statua del calciatore francese Zinédine Zidane mentre dava una testata all’italiano Marco Materazzi. Bollata come contraria ai principi dell’islam, offensiva per tutti i musulmani, la scultura di cinque metri è stata prontamente rimossa dalla sua esposizione a Doha: l’obiettivo dichiarato, quello di scongiurare qualsiasi tentazione di idolatria.
Tra i casi più noti c’è quello del Piss Christ di Andres Serrano. L’opera, realizzata nel 1987, propone la foto di un crocefisso di plastica immerso nell’urina dell’artista. Non è stata gradita dai visitatori di una mostra di Avignone nell’aprile del 2011, che le hanno causato danni irreparabili. Prima ancora, una petizione con 35mila firme aveva rigettato il contenuto dell’opera e, in difesa della fede, si erano svolte manifestazioni di movimenti cattolici integralisti.
Anche la scenografia dello spettacolo teatrale di Romeo Castellucci, Sul concetto di volto nel figlio di Dio, suscitò una bufera senza precedenti, con i manifestanti contrari incatenati davanti ai teatri di Parigi, Milano e altre città. Venne bollato come sacrilego perché la gigantografia del Salvator Mundi di Antonello da Messina faceva da sfondo alle incontinenze di un anziano uomo alla fine della sua vita.
Ha attirato pesanti critiche un’opera del 1999 dello scultore Maurizio Cattelan, che raffigurava papa Giovanni Paolo II atterrato da un meteorite. La Nona Ora – questo il titolo dell’installazione – esposta in Polonia nel 2000, venne presa d’assalto da due deputati polacchi che volevano così “salvaguardare il santissimo padre”, come dichiararono in seguito.
Un triste destino lo ha avuto anche la rana verde crocifissa del tedesco Martin Kippenberger. Esposta nell’appena inaugurato Museion di Bolzano, nel Tirolo italiano, Prima i piedi, è stata immediatamente oscurata da una parete di giornali dopo una campagna denigratoria pressante.
È difficile porre opposizione alle provocazioni spicciole intese a scuotere le anime cattoliche – forse più delitti contro il gusto che la fede – sullo stesso piano della distruzione dei Buddha di Bamiyan, ma sono fenomeni che insieme sottolineano il rischio di creare opere che in una maniera o l’altra passano per gli occhi per parlare all’anima.
Chi avrebbe mai potuto pensare che dei graffiti rupestri, con circa ottomila anni sulle spalle, potessero essere trattati da “infedeli” e additati come colpevoli per offesa alla religione tanto da dover essere cancellati?