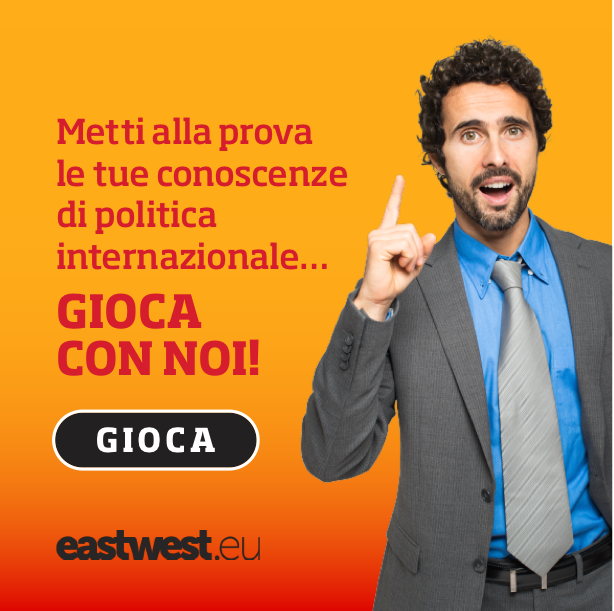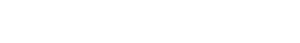Il nuovo premier ha confermato l’obiettivo di raddoppiare le spese militari, dedicandogli oltre il 2% del Pil nazionale, per rispondere a qualsiasi azione aggressiva da parte di potenze straniere
Quando i deputati giapponesi si sono alzati in piedi esclamando “Banzai”, dopo la conferma dello scioglimento della Camera Bassa del Parlamento e l’ufficializzazione della data per le elezioni generali, lo scorso 14 ottobre, il destino politico del Giappone, nel breve e medio periodo, appariva già segnato. Le sorti della terza economia mondiale, guidata dal nuovo Primo Ministro Fumio Kishida, apparivano già ben delineate ancora prima del voto con cui si dovevano scegliere i 456 rappresentanti dell’influente Camera Bassa del Parlamento, e i temi fondamentali della campagna elettorale-flash – durata appena due settimane, la più breve dal dopoguerra – rappresenteranno senza dubbio anche le fondamenta su cui costruire il Giappone dell’immediato futuro, in un Paese alle prese con le delicate conseguenze economiche dell’emergenza sanitaria e con un ancor più imprevedibile confronto con la Cina, sempre sospeso sul precario equilibrio delle tensioni geopolitiche.
Il 64enne Fumio Kishida, nuovo Primo Ministro e anima del LDP, il partito conservatore di maggioranza, è salito al potere il 29 settembre dopo le dimissioni di Yoshihide Suga, travolto da un’ondata di polemiche interne per la sua gestione della pandemia e per la scelta di confermare le Olimpiadi di Tokyo, svoltesi in un imbarazzato clima di generale contrarietà. Il 14 ottobre, Kishida ha sciolto la Camera bassa del Parlamento, anticipando il voto di diverse settimane e sperando di capitalizzare il consenso ottenuto tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, quando aveva conquistato la guida del partito di maggioranza, sfruttando anche la recente riduzione dei casi di positività al Covid-19 registrata in tutto il Paese. Nonostante un leggero calo di consensi, con cui dovrà misurarsi sin da subito, al partito di maggioranza di Kishida è affidato il compito di rilanciare l’economia nipponica nel periodo post-pandemico, partendo da un aumento del Pil che nel secondo trimestre del 2021 è stato dello 0.5%.
In una intervista al Financial Times rilasciata a metà ottobre, Kishida ha apertamente criticato l’Abenomics, la politica economica avviata dall’ex primo ministro Shinzo Abe durante i suoi mandati, affermando di voler aumentare i redditi di una fetta di popolazione molto più ampia rispetto a quella precedentemente interessata dagli interventi governativi, al fine di rilanciare i consumi in tutto il Paese. Kishida l’ha dichiarato senza mezzi termini: il suo obiettivo è dare vita a una nuova forma di capitalismo, tagliando nettamente con il passato. Il nuovo premier ha promesso anche più incentivi fiscali alle imprese, con conseguente aumento di salario per i dipendenti, spingendo per un’equilibrata mescolanza tra l’azione del pubblico e quella del privato che sostenga un’economia autosufficiente.
La riprogettazione del sistema fiscale giapponese, secondo Kishida, deve avere l’obiettivo di sostenere la classe media, rafforzandola strutturalmente e riducendo la distanza che la separa dalle classi più abbienti. Ma per il nuovo primo ministro, al momento, la priorità assoluta rimane la lotta al Covid-19: nel suo pacchetto di incentivi economici da 290 miliardi di dollari, a cui ha alluso ripetutamente nelle settimane precedenti al voto, troverà spazio anche un massiccio sostegno finanziario per quelle aziende giapponesi specializzate nello sviluppo di nuovi vaccini anti-Covid.
Uno dei punti più interessanti della strategia di Kishida è quello legato alle spese militari: anche prima della campagna elettorale, il nuovo premier aveva infatti confermato l’obiettivo di raddoppiarle, dedicandogli oltre il 2% del Pil nazionale. Per Kishida, ex Ministro degli Esteri, questa mossa rappresenta un chiaro messaggio a Cina e Corea del Nord, che costituiscono le due principali minacce per la sicurezza nipponica. Sin dal suo insediamento, avvenuto il 4 ottobre, Kishida si è dimostrato tutt’altro che esitante nell’affrontare i temi di politica estera, nonostante la sua fama di politico pacato: il nuovo primo ministro ha parlato di temi scottanti come Taiwan, le cui sorti ritiene inestricabilmente legate a quelle del Giappone, ma anche della Cina e del suo preoccupante espansionismo militare, con un chiaro riferimento alla situazione legata alle isole Senkaku/Diaoyu. Le due isole del mar Cinese Orientale sono amministrate dal Giappone e rivendicate dalla Cina, che infiamma ancora di più la contesa inviando regolarmente delle navi della guardia costiera a poche miglia dai territori in questione. Su questo dossier, Tokyo ha ricevuto l’appoggio formale anche degli Stati Uniti di Joe Biden, pronti a intervenire in difesa del Giappone in caso di attacco armato.
L’aumento delle spese militari – che dovrebbe comprendere anche un potenziamento delle capacità missilistiche del Giappone −, nella visione di Kishida, sembra orientato innanzitutto alla protezione del territorio, delle acque territoriali e dello spazio aereo giapponese, costantemente al centro di vivaci tensioni anche a causa dell’imprevedibilità della Corea del Nord.
Prima della conferma di Kishida alla guida del LDP, il confronto tra Cina e Giappone si era già acceso alla fine di settembre, quando il ministro della Difesa giapponese, Nobuo Kishi, in un’intervista al Guardian, aveva invitato le nazioni dell’Unione europea a concentrarsi con rinnovata attenzione sull’espansionismo cinese, sulle presunte aggressioni portate avanti da Pechino e sui rischi di un possibile conflitto. Secondo Kishi, la Cina “sta tentando di usare il suo potere per cambiare unilateralmente lo status quo nei mari della Cina orientale e meridionale”, esprimendo “forti preoccupazioni per quanto riguarda la sicurezza non solo del nostro Paese e della regione, ma per la comunità globale”. L’intervista proseguiva poi con chiari accenni alle potenzialità militari di Pechino, giudicate in continuo miglioramento in termini qualitativi e quantitativi.
Nonostante i toni forti utilizzati dopo il suo insediamento, da Kishida ci si aspetta un approccio più pacato, più equilibrato, anche tenendo conto che Pechino, in ultima analisi, rappresenta uno dei maggiori partner commerciali del Giappone, e che il mantenimento di relazioni stabili è nell’interesse di entrambi i Paesi. Tra il 2012 e il 2017, quando ricoprì l’incarico di Ministro degli Esteri, Kishida concluse importanti accordi con Corea del Sud e Russia, contribuendo anche in prima persona alla visita di Barack Obama a Hiroshima, nel 2016, la prima in assoluto di un presidente degli Stati Uniti nel teatro della tragedia del 1945. L’enfasi posta dal Primo Ministro sulle spese militari, in ogni caso, suona come un chiaro avvertimento: il Giappone, d’ora in avanti, sarà in grado di rispondere efficacemente a qualsiasi azione aggressiva da parte di potenze straniere.
Congratulandosi con Kishida per la sua elezione, il Presidente cinese Xi Jinping aveva espresso la speranza di poter “rafforzare il dialogo e la comunicazione, la fiducia e la cooperazione reciproche”, con lo scopo di “costruire relazioni che soddisfino i requisiti della nuova era”. Il confronto con la Cina, per il Giappone, si gioca anche sul piano dello sviluppo infrastrutturale nel Sud-est asiatico, dove Tokyo sta cercando silenziosamente di contrastare la Belt and Road Initiative cinese con massicci investimenti a supporto dei sistemi infrastrutturali locali. Kishida, da questo punto di vista, proseguirà in continuità con i suoi predecessori, enfatizzando il concetto di “infrastrutture di qualità” in contrapposizione all’enorme quantità di progetti ritenuti poco trasparenti della Nuova Via della Seta.
Con un buon risultato anche nel 2022, quando si rinnoverà la Camera dei Consiglieri, Kishida e il partito di maggioranza potrebbero trovarsi di fronte a tre anni senza alcun impegno elettorale. Prima di allora, il nuovo Primo Ministro è chiamato a ridisegnare il futuro del Giappone post-Covid 19, ripartendo dalla classe media e da un confronto con la Cina basato sull’esattezza dei rischi calcolati.
Questo articolo è pubblicato anche sul numero di novembre/dicembre di eastwest.
Puoi acquistare la rivista in edicola o abbonarti.