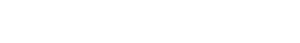Una lunga lista di sfide per il suo mandato di 4 anni, senza la maggioranza parlamentare. Prima di tutte le relazioni con la Cina, e sul fronte interno l’altissimo prezzo delle case rispetto ai salari e la dipendenza energetica alla quale i partiti di opposizione vorrebbero rispondere con il nucleare
Ci siamo. Lai Ching-te ora non è solo il presidente eletto, ma il presidente in carica di Taiwan. O meglio, della Repubblica di Cina, il nome ufficiale con cui Taipei è indipendente de facto e retaggio della sconfitta dei nazionalisti di Chiang Kai-shek nella guerra civile contro i comunisti di Mao Zedong.
Vincitore delle presidenziali dello scorso 13 gennaio, Lai si insedia lunedì 20 maggio, poco più di quattro mesi dopo le urne. A lasciargli il posto è Tsai Ing-wen, che ha governato per otto turbolenti anni cominciati nel 2016. Lai è stato il suo vicepresidente per il secondo mandato, cominciato nel 2020.
Si tratta della prima volta che il passaggio di consegne avviene all’interno dello stesso partito, visto che dalle prime elezioni libere del 1996 c’era sempre stata un’alternanza al massimo dopo due mandati. Ma stavolta il Partito progressista democratico (DPP) è riuscito a vincere un voto presidenziale per la terza volta consecutiva.
Non è stato solo merito di Lai, visto che una buona parte del suo successo si deve alla divisione dell’opposizione in due diverse candidature tra Kuomintang (KMT, lo stesso partito che ha governato ininterrottamente fino al 2000 grazie anche alla legge marziale rimasta in vigore fino al 1987) e il Taiwan People’s Party dell’ex sindaco di Taipei, Ko Wen-je. Ma la vittoria di Lai non è stata una passeggiata, visto che il DPP ha perso circa cinque milioni di voti rispetto alle elezioni del 2020. E, soprattutto, ha perso la maggioranza parlamentare. Allo yuan legislativo, il parlamento unicamerale di Taiwan, ha infatti un seggio in meno del KMT.
Lai ha di fronte a sé una lunga lista di delicate sfide per il suo mandato di quattro anni. La prima e più complicata, ovviamente, è la gestione delle relazioni intrastretto con la Repubblica Popolare Cinese. Negli ultimi otto anni, i rapporti sono precipitati.
Dopo la vittoria di Tsai, qualsiasi dialogo politico tra governi è stato interrotto, mentre Pechino ha aumentato la pressione militare e diplomatica per ridurre lo spazio di manovra di Taipei. Il motivo originario è rappresentato da due posizioni inconciliabili. Il Partito comunista cinese (PCC) si dice pronto al dialogo solo col rispetto del “consenso del 1992”, un accordo raggiunto tra le due sponde che riconosce l’esistenza di una “unica Cina”.
L’interpretazione che PCC e KMT danno a quell’accordo è diversa: il primo ritiene che sia la de facto accettazione da parte di Taiwan di far parte del territorio della Cina, dunque della Repubblica Popolare che è quella riconosciuta da quasi la totalità dei governi nel mondo. Il secondo aggiunge invece una coda alla formula “unica Cina”, vale a dire “diverse interpretazioni”. Lasciando dunque aperta la possibilità di una coesistenza, seppure temporanea, di due diverse Cine. Un concetto che non lascia in ogni caso spazio a una indipendenza formale di Taiwan.
Il DPP non riconosce invece il “consenso del 1992” e si dice pronto al dialogo, qualora il PCC non ponga precondizioni e riconosca che Pechino e Taipei sono due entità separate e non interdipendenti l’una con l’altra. Posizioni inconciliabili, anche perché l’obiettivo originario del DPP era il raggiungimento di un’indipendenza formale come Repubblica di Taiwan.
Il primo presidente del partito, Chen Shui-bian (2000-2008) ha provato a istituire un referendum, senza riuscirci. E la sua capacità di cambiare la costituzione è stata quasi del tutto assente, visto che ha governato per due mandati con il suo partito in minoranza allo yuan legislativo, il parlamento unicamerale di Taipei.
Tsai ha invece spostato il DPP verso il centro. Secondo la prima presidente donna, a Taiwan non serve dichiarare l’indipendenza formale ma basta quella de facto, seppure entro la cornice della Repubblica di Cina. Un cambio di prospettiva che le ha consentito di impadronirsi in parte della retorica dello “status quo”, che quasi il 90% dei taiwanesi dice di preferire come soluzione ai rapporti con Pechino. Fino a qualche anno fa, solo il KMT era percepito come garante dello status quo, perché l’unico in grado di mantenere il dialogo con il PCC.
Lai pare dunque intenzionato a mantenere la stessa linea di Tsai, anche se per lui si tratta di un cambiamento. In passato si è infatti esposto a favore dell’indipendenza formale. La sua frase più citata in tal senso è datata 2017, quando si definì un “lavoratore pragmatico per l’indipendenza”. Pechino non se lo è certo scordato e non a caso etichetta Lai come un “pericoloso secessionista”.
Pur non avendo mai aperto il dialogo con Tsai in questi otto anni, il PCC ha lasciato intendere di comprendere che fra i due esistono delle differenze. È prevedibile che Lai, pur mantenendo la stessa sostanza della postura intrastretto di Tsai, possa cambiarne leggermente la forma. In particolare sul fronte comunicativo, dove è solito rilasciare dichiarazioni meno misurate. Anche durante la campagna elettorale si è lasciato sfuggire un paio di dichiarazioni al di fuori della prassi istituzionale.
Nel primo caso ha confessato che il suo desiderio è che in futuro il presidente di Taiwan possa entrare alla Casa Bianca, eventualità che implicherebbe un riconoscimento ufficiale di Taipei da parte di Washington. Nel secondo caso ha invece detto che gli piacerebbe poter andare a cena con Xi Jinping, offrendogli un bubble tea. Pechino e Washington non hanno apprezzato.
Un ruolo importante sarà quello occupato dalla vicepresidente, Hsiao Bi-khim, molto popolare tra l’opinione pubblica e considerata una sorta di “garante” visti gli strettissimi rapporti con Tsai e la sua esperienza come rappresentate di Taipei negli Stati Uniti, dove è molto apprezzata.
Per il resto, Lai ha praticamente confermato buona parte della squadra di Tsai nei ruoli chiave. L’ex ministro degli Esteri Joseph Wu è passato alla Sicurezza Nazionale. Una nomina che potrebbe far presagire qualche acceso scontro retorico con Pechino, visto che Wu si è contraddistinto negli ultimi anni per una linea molto assertiva e ostile al governo cinese anche sui social.
Uno dei problemi principali di Lai sarà un parlamento frammentato e in cui il DPP non ha la maggioranza. Di fatto, il presidente rischia di essere una “anatra zoppa” sin dal primo giorno. Un antipasto di quanto potrebbe accadere è arrivato venerdì 17 maggio, con una clamorosa rissa in aula dopo un litigio furibondo su una bozza di riforma del potere legislativo, appoggiata da KMT e TPP ma osteggiata dal partito di governo.
Un episodio che ha fatto nuovamente scatenare divisioni interne all’opinione pubblica taiwanese, che negli ultimi anni sembravano in larga parte sopite. Elemento che può chiaramente diventare positivo per la Repubblica Popolare, che ha mostrato di voler fare leva sul KMT per mettere in difficoltà il DPP e conquistare qualche punto politico sul dossier taiwanese. In tal senso va letto il recente incontro tra Xi Jinping e l’ex presidente taiwanese Ma Ying-jeou, ancora un nome rilevante all’interno del KMT, a cui il leader cinese ha fatto seguire delle concessioni sul turismo.
Lai ha di fronte a sé anche diversi problemi interni. Tra tutti, l’altissimo prezzo delle case sempre più fuori portata per i salari minimi. Risultato: sempre meno giovani sono in grado di acquistare un’abitazione e di costruirsi una famiglia, come testimonia il continuo e irreversibile calo demografico. Attenzione poi anche all’energia: il DPP è tradizionalmente contro il nucleare, ma la dipendenza quasi totale dalle importazioni sta alimentando le richieste dell’opposizione che vorrebbe inserire l’atomo nel mix energetico taiwanese.
Vincitore delle presidenziali dello scorso 13 gennaio, Lai si insedia lunedì 20 maggio, poco più di quattro mesi dopo le urne. A lasciargli il posto è Tsai Ing-wen, che ha governato per otto turbolenti anni cominciati nel 2016. Lai è stato il suo vicepresidente per il secondo mandato, cominciato nel 2020.