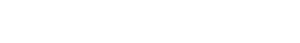Un accordo storico che arriva in un momento di vera svolta nella costruzione europea e che sancisce un asse in grado di guidare l’Europa nella lotta al Covid e verso una Unione più forte e integrata
Le Frecce tricolori e la Pattuglia acrobatica francese hanno disegnato venerdì mattina sul cielo di Roma i colori delle bandiere italiana e francese. Senza errori né incertezze, come quelle che videro gli aerei militari francesi nel 2018 alla festa del 14 luglio a Parigi sbagliare il loro tricolore. Con la stessa chirurgica precisione, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, poco prima, nel salone d’onore del Quirinale dopo la firma del Trattato di cooperazione rafforzata italo-francese, stringeva la mano a Macron e insieme a Draghi come quelle di due giovani un po’ litigiosi che vanno riportati alla ragione dal grande saggio.
La gestazione del Trattato non è stata breve né semplice. È andata avanti a singhiozzo con inciampi critici come durante il sostegno dei grillini ai gilet gialli francesi o le accuse di Salvini a Macron sui migranti. Ma Mattarella, anche nei momenti più bui, ha salvato il rapporto con Parigi e Macron glielo riconosce.
Un accordo storico che avvicina di più Roma e Parigi nella definizione di Mario Draghi ma arriva in un momento di vera svolta nella costruzione europea: dopo la Brexit, alla fine dell’era Merkel e alla vigilia delle elezioni in Francia come per la corsa al Quirinale. C’era bisogno che due grandi Paesi chiudessero subito quel triangolo motore dell’Europa che tra Roma-Parigi-Berlino è destinato a guidare le forme dell’Ue e le sfide che la attendono, si chiamino cambiamenti climatici, green economy, lotta alla pandemia, immigrazione, autonomia strategica nella difesa.
Tra Francia e Germania, oltre all’accordo di riconciliazione post bellico del ’63 firmato da De Gaulle e Adenauer, c’è stato il più recente Trattato di Aquisgrana del 2019. Il patto “per una cooperazione bilaterale rafforzata” tra Roma e Parigi sancisce ora un asse in grado di guidare l’Europa nella nuova era di lotta al Covid e verso una Unione più forte e integrata.
Vengono gettate le basi per un’alleanza tra pari, dove non c’è un pesce grande che mangia il pesce piccolo, nessun intento predatorio sui “gioielli” dell’economia italiana ma due Paesi integrati e sempre più complementari. Due Paesi, dice Draghi, che “condividono molto più di confini” che hanno in comune la visione di padri politici come Jean Monnet e Robert Schuman, Altiero Spinelli e Alcide De Gasperi. Per la cultura, Stendhal e Umberto Eco, nel cinema, Mastroianni, Belmondo a Claudia Cardinale. “La nostra storia, la nostra arte, le nostre economie e le nostre società si intrecciano da tempo immemore”.
Un’alleanza che prevede nuovi meccanismi di consultazioni periodiche, un vertice bilaterale annuale e la partecipazione reciproca di un membro di Governo di uno dei due Paesi, almeno una volta per trimestre e in alternanza, al Consiglio dei Ministri dell’altro Paese. Un’integrazione al Trattato voluta espressamente dallo stesso Draghi sull’esempio di quanto deciso con l’articolo 24 del Trattato di Aquisgrana con i tedeschi. Draghi parla di accordo storico, di una “collaborazione rafforzata che renderà Italia e Francia da oggi ancora più vicine”. C’è da riscrivere le regole del Patto di stabilità, rivedere quelle regole pro-cicliche che già non funzionavano prima della pandemia e che ora è “inevitabile” riformare. Su questo Italia e Francia marceranno unite senza preoccuparsi troppo delle gelosie tedesche.
Ma gli obiettivi di Italia e Francia coincidono anche in altri settori con quelli di tutta la Ue: cambiamento climatico, transizione ecologica e digitale, difesa europea, complementare alla Nato e non sostitutiva. Draghi ribadisce il sostegno al prossimo semestre di presidenza francese dell’Ue che si caratterizzerà per la conclusione della Conferenza sul futuro dell’Unione (probabilmente il 9 maggio, festa dell’Europa) e l’autonomia strategica in tema di difesa comune che sarà oggetto di un vertice europeo in giugno prima del summit Nato di Madrid.
Tra i nuovi istituti del Trattato, la cooperazione tra forze di polizia per la lotta al terrorismo, un comitato di cooperazione transfrontaliera, un Servizio civile volontario congiunto e la promozione della mobilità degli studenti. A questo proposito Draghi ha ricordato Valeria Solesin, l’italiana uccisa insieme a tanti cittadini francesi e di altre nazionalità nei “vili attentati di Parigi” del 2015. Tra le cooperazioni rafforzate anche la lotta contro le migrazioni illegali. Macron e Draghi condividono la stessa visione. “In ambito migratorio – osserva il Presidente del Consiglio – riconosciamo la necessità di una politica di gestione dei flussi e d’asilo condivisa a livello europeo, basata sui principi di responsabilità e solidarietà”. Nel settore delle grandi opere proseguirà il coordinamento sulla Torino-Lione “con l’obiettivo di raggiungere la piena operatività del tunnel e delle sue tratte di accesso e nella gestione del tunnel del Fréjus e del Monte Bianco”.
La gestazione del Trattato non è stata breve né semplice. È andata avanti a singhiozzo con inciampi critici come durante il sostegno dei grillini ai gilet gialli francesi o le accuse di Salvini a Macron sui migranti. Ma Mattarella, anche nei momenti più bui, ha salvato il rapporto con Parigi e Macron glielo riconosce.