
[MILANO] Laureato in Legge e specializzato in Diritto internazionale, giornalista e vice direttore di Pagella Politica, è esperto di Medio Oriente e Unione europea.

[MILANO] Laureato in Legge e specializzato in Diritto internazionale, giornalista e vice direttore di Pagella Politica, è esperto di Medio Oriente e Unione europea.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
A metà febbraio la sensazione prevalente tra gli analisti era che in Ucraina sarebbe potuto succedere di tutto, anche niente. Le tensioni che si sono addensate su Kiev negli ultimi mesi del 2021 e soprattutto nei primi del 2022 potevano infatti sia scaricarsi a terra nel modo più devastante, con un’invasione russa, sia rimanere nell’empireo delle prove di forza astratte.
Gli sviluppi di metà febbraio sembravano indicare una sorta di via di mezzo, con la Russia pronta a intervenire per “difendere” la popolazione russa che abita nelle province sud-orientali dell’Ucraina – in particolare nel Donbass, dove si trovano le due autoproclamate repubbliche separatiste di Donetsk e Luhansk –, se mai ci fosse un casus belli adeguato. Il timore americano era che questo casus belli potesse essere inscenato proprio dai russi o dai filo-russi con un’operazione di false flag, per fornire un pretesto al Cremlino per attaccare.
Ma questo era solo lo scenario più probabile al momento, non in assoluto (come si è visto): ancora a inizio febbraio sembrava che la diplomazia potesse tornare protagonista e che un accordo tra Mosca e Washington fosse alla portata. Considerato che la principale origine delle tensioni – il mancato accordo tra Russia e Occidente sugli assetti geopolitici in Est Europa, con la richiesta di fermare l’allargamento della Nato e di smilitarizzare in parte i confini orientali dell’Alleanza – era stata un fallimento della diplomazia, non si poteva escludere che le ragioni di un accordo che evitassero il peggio potessero risorgere improvvisamente. Ma specularmente non si potevano escludere sviluppi più drammatici di un intervento russo limitato alle regioni orientali, come ad esempio un’invasione su larga scala. Se infatti il Cremlino ha ritenuto di avere da perdere, in termini di sanzioni economiche e isolamento internazionale, tanto a conquistare Donetsk quanto a conquistare Kiev, non si vede perché avrebbe dovuto scegliere la prima opzione.
In questo scenario precedente la decisione di Mosca di attaccare, vale la pena soffermarsi sulle ragioni di fondo degli attori sul campo: Stati Uniti, Russia ed Europa. La Russia, dopo le tensioni in Bielorussia del 2021 e il sempre più marcato avvicinamento di Kiev all’Occidente, e soprattutto dopo il ritorno alla Casa Bianca di un’amministrazione ostile nei confronti di Mosca dopo la parentesi di Donald Trump, si è sentita probabilmente ricacciare nell’angolo in cui era finita nel 2014.
All’epoca, infatti, la reazione della Russia alla perdita di fatto dell’Ucraina – annessione illegittima della Crimea e sostegno alla guerriglia separatista nel Donbass – ebbe come conseguenza un duro isolamento internazionale e sanzioni economiche. Putin riuscì ad uscire dall’angolo negli anni successivi, sfruttando prima le indecisioni mediorientali di Obama e poi la postura meno aggressiva dell’amministrazione Trump. Ma quella parentesi favorevole per la Russia sembra essersi conclusa e le recenti decisioni di Putin – a partire dall’aver ammassato oltre centomila uomini al confine ucraino – testimoniavano verosimilmente l’intenzione di preferire una nuova stagione di crisi e di sanzioni a un logoramento costante della sfera di influenza russa in Europa.
E veniamo così agli Stati Uniti. Perché Washington è così restia a dare a Mosca rassicurazioni sull’espansione della Nato verso Est? L’indisponibilità americana a dare queste garanzie si può leggere in diversi modi. Poco plausibile la difesa del principio dell’autodeterminazione dei popoli (chiedere ad esempio a cileni e iraniani, che dal secolo scorso hanno appreso qualche lezione in proposito), più realistica la tesi secondo cui con l’aumento delle tensioni con la Russia l’amministrazione americana voglia rivitalizzare una Nato considerata cerebralmente morta (copyright Emmanuel Macron, 2019) ancora pochi anni fa, indebolire ulteriormente la Russia e riguadagnare lo smalto e l’immagine di forza persi con il disastroso ritiro dall’Afghanistan. E non solo.
Arriviamo così all’Ue: che posizione prendono l’Unione e i suoi Stati membri rispetto alla crisi, e poi guerra, in Ucraina? La prima, più importante, considerazione da fare è che ad oggi l’Ue ancora non esiste come soggetto in grado di avere una propria politica estera e militare comune. Le discussioni sulla creazione di un esercito europeo hanno ripreso slancio negli ultimi mesi ma ad oggi ancora il traguardo sembra lontano. Tuttavia se l’Ue vorrà un domani diventare un attore geopolitico forte e autonomo, alcune decisioni deve cominciare a prenderle fin da subito. Da un lato non può subire un allargamento a Est dell’Alleanza deciso dagli americani senza chiedere garanzie e porre condizioni. Agli Stati Uniti, banalmente per ragioni geografiche, non sembra infatti interessare avere Stati cuscinetto in Europa con la Russia. Gli Stati Ue potrebbero legittimamente avere delle sensibilità diverse. Dall’altro lato, se l’Ue vuole un domani essere ritenuto da tutti i suoi Stati membri l’attore geopolitico principale e il garante dei loro confini, non può dare già oggi la sensazione agli Stati membri dell’Est Europa che la loro sicurezza sia barattabile in cambio di accordi vantaggiosi con Mosca.
Se così fosse, Varsavia, Tallin e Vilnius – ad esempio – continueranno a volere la protezione americana piuttosto che quella europea per i propri interessi e per i propri territori. Se poi l’Unione europea, quando in futuro si fosse dotata di una politica estera e di una politica di difesa comuni, volesse mantenere con la Nato un rapporto buono ma non simbiotico, si porrà il problema di avere due attori (Ue e Nato) che operano nella stessa regione con geometrie variabili di Stati partecipanti e con agende diverse. Uno scenario probabilmente poco gradito alla Casa Bianca.
Ma mentre l’Ue decide che cosa vuol fare da grande, i suoi Stati membri sanno che non possono prescindere dalla protezione militare americana e se da Washington arriva la richiesta di assumere determinate posizioni nei confronti di Mosca sul dossier ucraino, le principali capitali europee – chi più, chi meno – si allineano, almeno formalmente. Il gioco che devono giocare gli Stati membri dell’Ue è un esercizio di equilibrismo tra il non compromettere le future evoluzioni che si auspicano per l’Unione e il preservare il rapporto speciale con gli Stati Uniti.
Ma le sensibilità degli Stati Ue a tal proposito sono molto diverse. In Est Europa – con l’eccezione dell’Ungheria, su posizioni più filo-russe – come detto, sono schierati con convinzione dalla parte della Nato e degli Stati Uniti (e, nei confronti del rafforzamento dell’Ue come entità sovranazionale, hanno dimostrato negli anni recenti segnali di insofferenza). La Francia tende a marcare la propria distanza rispetto all’agenda di Washington – la proposta di “finlandizzare” l’Ucraina non è stata bene accolta negli Stati Uniti – anche se non se ne smarca completamente. Berlino a sua volta sembra combattuta tra l’esigenza di dimostrarsi un alleato totalmente affidabile per gli Usa e tutelare i propri interessi economici ed energetici. Roma sembra ai margini della partita ma potrebbe essere una cartina tornasole interessante da osservare per capire gli sviluppi della possibile divergenza tra europeismo e atlantismo.
Questo groviglio che sono la realtà e le prospettive della politica estera degli Stati europei e dell’Unione europea, ovviamente, interroga anche gli altri attori della partita. La Russia ha dimostrato di avere uno scarso interesse a parlare con gli europei e vuole trattare direttamente con gli americani. Questo risponde sicuramente alla realtà attuale, per cui gli europei non sono artefici della propria sicurezza e non hanno una politica estera e di difesa autonoma rispetto a quella americana. D’altro canto è anche vero che la maggior disponibilità europea a concedere alla Russia delle garanzie, valutata positivamente al Cremlino, non compensa il danno strategico che Mosca subirebbe dall’eventuale nascita in futuro di un’Unione europea militarmente forte e autonoma.
Gli Stati Uniti poi hanno (quasi) sempre detto di vedere con favore un rafforzamento militare dell’Europa. Ma se a Washington potrebbe interessare un’Europa forte, di sicuro non interessa un’Unione europea autonoma. Di qui l’esigenza di rivitalizzare la Nato, aumentare la tensione con la Russia e tenere viva l’esigenza per gli Stati europei di fare affidamento sulla protezione americana. Un debito questo che può essere poi speso dagli Usa su molteplici tavoli, a partire da quello dei rapporti con la Cina.
Questo articolo è pubblicato anche sul numero di marzo/aprile di eastwest.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Negli ultimi dieci anni l’area del Mena (Medio Oriente e Nord Africa) è stata attraversata da forti turbolenze. Dalle Primavere arabe di inizio anni Dieci, alla faida tra sunniti (capeggiati dall’Arabia Saudita) e sciiti (capeggiati dall’Iran), che si è scaricata in una serie di guerre di prossimità, ad esempio in Siria, in Iraq e in Yemen; dall’allontamento degli Stati Uniti all’accresciuto ruolo della Russia; dalle crisi nel Nord Africa (in Libia, Sudan e nel Corno d’Africa) alla frattura interna alla galassia sunnita, tra regimi autoritari e monarchie da un lato, e Paesi vicini alla Fratellanza Musulmana – in particolare Turchia e Qatar – dall’altro.
In questo contesto, l’Egitto è stato spesso più un attore spostato sulla scena geopolitica dalle turbolenze scatenate da altri che non un attore in grado di creare, o placare, autonomamente simili fenomeni. Questo è dipeso sia dalla forza delle turbolenze, sia dalla perdita di peso – in termini di forza economica e politica – del Cairo. Ma la situazione ora appare in evoluzione: lo scenario geopolitico del Nord Africa e del Medio Oriente è meno burrascoso di quanto non sia stato nel recente passato e l’Egitto sembra nella condizione di poter giocare un ruolo maggiore e più autonomo.
Gli ultimi dieci anni sono stati un periodo di declino per l’Egitto. La Primavera araba nel 2011 ha abbattuto il regime autoritario di Mubarak, uno dei più longevi in Medio Oriente, aprendo la strada al Governo della Fratellanza Musulmana guidato da Mohamed Morsi. Il cambio, radicale, alla guida del Paese ha però avuto vita breve: nel 2013 il golpe del generale Abdel Fattah al-Sisi ha estromesso gli islamisti dalla guida dell’Egitto e ha riportato al potere i militari. Questi repentini mutamenti e la brutale repressione attuata del regime al potere, in particolare nei primi anni, hanno lasciato il Paese fratturato al proprio interno, indebolito agli occhi della comunità internazionale – con gravi ripercussioni sull’economia – e facile preda delle faide che negli ultimi anni hanno diviso gli Stati del Mena.
Lo scontro tra militari e Fratellanza Musulmana interno al Paese, in particolare, ha collocato l’Egitto sulla faglia di frattura interna al mondo sunnita, tra Stati che considerano i Fratelli Musulmani terroristi (Riad e Dubai in primis, e anche il Cairo dal 2014) e Stati che li sponsorizzano (Doha e Ankara, alleati del precedente Governo egiziano di Morsi). Considerato anche il disperato bisogno di sostegno economico, l’Egitto di al-Sisi si è presto schiacciato sulle posizioni dei Saud, partecipando ad esempio all’embargo imposto al Qatar e al confronto continuo con la Turchia. In cambio ha ottenuto, oltre al supporto economico, il coinvolgimento militare in particolare degli Emirati Arabi Uniti in Libia, a sostegno del generale Khalifa Haftar – appoggiato anche da Mosca e in parte da Parigi – contro il Governo di Tripoli, islamista e sostenuto in teoria dalla comunità internazionale ma in pratica soprattutto da Turchia e Qatar (e in parte dall’Italia). Non ha invece ottenuto lo sperato aiuto, sempre degli Emirati Arabi Uniti, nel Corno d’Africa, dove Il Cairo teme che la diga sul Nilo che intende costruire l’Etiopia possa danneggiare il suo approvvigionamento idrico e sperava nella sponda di Dubai, che è un attore influente nell’area.
Nel confronto con l’asse sciita, l’Egitto ha mantenuto invece una maggiore autonomia rispetto alla linea dettata dalle monarchie del Golfo, mantenendo buoni rapporti col regime siriano di Assad, partecipando sì alla guerra in Yemen, ma senza l’invio di truppe di terra, evitando lo scontro frontale con l’Iran sul dossier del nucleare e non solo. Se il Cairo non ha sposato appieno le posizioni dei Saud su questi dossier, non si può nemmeno dire che abbia saputo o potuto giocare un ruolo autonomo rilevante, almeno fino a poco tempo fa.
L’impressione generale è che l’Egitto sia stato aiutato dalle monarchie del Golfo dove i suoi interessi confliggevano con quelli di Turchia e Qatar – in Libia ma anche nella questione delle risorse energetiche nel Mediterrano orientale, dove il Cairo ha anche la sponda di Israele e di alcuni importanti Stati europei, come vedremo meglio tra poco – e abbandonato a se stesso dove invece gli interessi di Riad e alleati erano altri.
La posizione forzatamente defilata assunta dall’Egitto per buona parte dell’ultimo decennio ha comunque avuto come conseguenza positiva che il Cairo si è indebolito meno di quanto non sia successo ad altri – Riad e ad Abu Dhabi da un lato, Ankara e Doha dall’altro –, che hanno occupato le prime file nelle faide e negli scontri nel Mena.
Ora che – complice il cambio di amministrazione negli Usa, la fine della guerra in Siria e della presenza para-statale dello Stato islamico – la situazione geopolitica è meno incendiaria da un lato, e dall’altro l’economia dell’Egitto sembra uscita dalla fase di maggiore debolezza e instabilità, Il Cairo sembra nella condizione di poter tornare a giocare un ruolo più importante sullo scacchiere del Mena.
I rapporti con l’Occidente sono generalmente buoni: gli Stati Uniti – forse anche preoccupati dall’accresciuto ruolo di Mosca nella regione – hanno ristabilito gli aiuti militari ed economici all’Egitto e Israele continua ad avere nel Cairo uno dei principali interlocutori nel mondo arabo e musulmano.
Gli Stati europei hanno un rapporto più complicato. Il Cairo è utile per contrastare la Turchia: Egitto e Israele, insieme a Grecia e Cipro, hanno creato nel 2020 lo East Mediterranean Gas Forum, il che ha attirato in particolare l’interesse di Francia e Italia e suscitato le ire di Ankara. È anche un interlocutore indispensabile per pensare di poter stabilizzare la situazione in Libia. È poi un importante acquirente di materiale bellico prodotto dalle industrie europee. Ma il dossier dei diritti umani, calpestati dal regime di al-Sisi, è una nota dolente che rischia sempre di compromettere i rapporti con l’Europa. La speranza, secondo alcuni osservatori, è che il regime sentendosi più saldo al potere e avendo maggiore interesse a un dialogo a tutto campo con l’Occidente, sia ora più disponibile ad allentare la morsa della repressione interna.
L’Egitto può poi sfruttare la sua posizione non troppo schiacciata su quella saudita nei dossier siriano e iracheno per presentarsi come mediatore, aumentare la propria influenza (anche economica) nei due Stati arabi e tenere aperti i canali del dialogo con l’Iran. Può in questo anche smarcarsi in parte dai Saud e soprattutto dagli Emirati Arabi Uniti, che non sono riusciti a vincere la partita in Libia, che non tutelano gli interessi egiziani nel Corno d’Africa e che – essendosi troppo avvicinati pubblicamente a Israele negli ultimi anni di presidenza Trump – non sono ben visti da vasti settori delle opinioni pubbliche arabe.
Questa possibile emersione dell’Egitto come ritrovato attore influente sulla scena regionale sconta diverse incognite, su cui Il Cairo non ha che un controllo minimale. Se i venti dello scontro tra sunniti e sciiti, o anche solo interni al mondo sunnita, dovessero tornare a soffiare con forza, le possibilità che il regime di al-Sisi continui a muoversi con un certo grado di autonomia diminuirebbero.
Allo stesso modo una nuova esplosione della conflittualità interna all’Egitto – le repressioni brutali funzionano di solito nel breve periodo, ma nel medio e lungo rischiano di essere controproducenti – taglierebbe le gambe al neonato slancio del Cairo sulla scena internazionale.
In generale le variabili interne ai vari Paesi – dalle superpotenze globali alle potenze regionali – e quelle relative ai rapporti tra vari attori sono talmente tante e incerte, che è quasi impossibile fare previsioni di medio o lungo periodo. Un motivo in più per l’Egitto per sfruttare la fase di relativa calma per consolidare i propri rapporti con gli Stati più stabili nel Mediterraneo e tentare la via della pacificazione interna.
Questo articolo è pubblicato anche sul numero di novembre/dicembre di eastwest.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Da quando gli Stati Uniti hanno prima teorizzato, col celebre “Pivot to Asia” dell’allora Segretario di Stato Hillary Clinton, e poi dimostrato, tanto negli anni della presidenza Obama quanto in quelli della presidenza Trump, un loro minore impegno in Europa e Medio Oriente, la Storia ha qui ripreso a scorrere in canali che la pax americana sembrava aver ostruito negli ultimi decenni.
In particolare nel Mediterraneo orientale la competizione tra attori nazionali per il controllo delle risorse energetiche, per la spartizione dei mari e, in ultima analisi, per la supremazia geopolitica è cresciuta nel giro di pochi anni fino a toccare livelli preoccupanti. La Nato, che dell’allontanamento americano (ora unito alla malcelata insofferenza dell’attuale presidente degli Stati Uniti) è la prima vittima, finora non è sembrata essere in grado di assumere il ruolo di camera di compensazione tra le spinte divergenti dei suoi membri. La Russia, che storicamente nel Mediterraneo ha avuto un ruolo marginale, è ora in grado di proiettare la propria influenza strategica dalla Siria ai Balcani, dalla Libia all’Egitto, impersonando il ruolo del mediatore che in tutte le partite aperte conviene sia coinvolto e da tutte le mediazioni può trarre un profitto. Gli Stati nazionali si stanno disponendo su linee di frattura pericolose, che per ora sembra possano essere gestite prevalentemente con gli strumenti della diplomazia, ma che negli Stati più fragili già sfociano in guerre di prossimità (si pensi al caso della Libia) e che un domani potrebbero causare scosse ancor più pericolose per la pace nella regione.
Un ultimo allarmante capitolo riguarda i rapporti tra Turchia ed Egitto. I due Paesi sono storicamente tra i principali attori nel mondo islamico, ma oggi Il Cairo versa in una situazione di difficoltà economica e di dipendenza da altri Stati (Arabia Saudita e Russia in primis) che ne riduce lo spazio di azione, e anche Ankara deve tenere conto nelle sue mire espansionistiche di stampo neo-ottomano dei rapporti di forza con Mosca, che la vedono in posizione di subalternità da quando, nel 2015, è uscita sconfitta dal confronto con la Russia e ha dovuto sacrificare le proprie ambizioni in Siria in cambio di alcune garanzie (territoriali e non) contro il crescente indipendentismo curdo nella regione.
Pur in questa situazione di debolezza relativa, l’Egitto sta provando a elaborare una strategia che gli consenta una maggiore forza economica – e quindi politica – nel prossimo futuro. Questa strategia passa principalmente dallo sfruttamento delle enormi riserve energetiche che sono state scoperte negli ultimi anni nel Mediterraneo orientale, che il Cairo vorrebbe sfruttare per inserirsi nel mercato europeo delle risorse e ottenere i relativi dividendi economici. Il giacimento di Zohr, scoperto a inizio degli anni Dieci e considerato la più grande scoperta di gas mai realizzata in Egitto e nel Mar Mediterraneo, intreccia gli interessi dell’Egitto con quelli dell’Italia (Eni ha il 50% del blocco che controlla il giacimento), della Russia, degli Emirati e del Regno Unito, anche loro titolari di quote rilevanti. Ma, allo stesso tempo, può rappresentare una minaccia per Ankara, che ha l’ambizione di diventare – di nuovo, grazie ai suoi rapporti con la Russia – l’hub energetico per l’Europa grazie a TurkStream. Questo è un imponente gasdotto che consente a Mosca di trasportare e vendere gas in Europa via Turchia aggirando l’Ucraina (sottratta al controllo geopolitico russo nel 2014 con la “Rivoluzione arancione” e con cui da allora il Cremlino ha rapporti sempre altalenanti) e che ha iniziato a funzionare da gennaio 2020.
La Turchia inoltre vede minacciate le sue ambizioni anche da un altro progetto, quello del gasdotto EastMed, che dovrebbe portare altre risorse energetiche scoperte nel Mar Mediterraneo orientale (in particolare nei giacimenti a largo di Cipro, dove di nuovo sono coinvolti gli interessi economici di Stati europei, tra cui anche l’Italia, e di Israele) in Europa, e fare così concorrenza a TurkStream. In questo caso gli avversari di Ankara sono Israele, Grecia e, di nuovo, Egitto: tre Paesi con cui la Turchia ha già diverse frizioni in corso. Inoltre gli Stati Uniti, che sostengono le ambizioni energetiche israeliane e non vedono di buon occhio l’eccessiva dipendenza europea dal gas russo, sono favorevoli a questo progetto, che – siglato dai Paesi interessati a inizio 2020 – dovrebbe vedere la luce nel 2025.
In ogni caso, anche per bloccare queste minacce alle sue ambizioni in campo energetico, la Turchia è molto attiva su un altro tavolo – laterale ma collegato –, quello delle Zone economiche esclusive (Zee). Queste sono le aree di mare adiacenti alle coste di uno Stato su cui questo ha diritti sovrani per la gestione delle risorse naturali e ha la giurisdizione in materia di installazione e uso di strutture artificiali o fisse. Vista la disposizione dei confini degli Stati nel Mediterraneo orientale – in particolare la presenza di Stati insulari come Cipro o Malta, e la disposizione delle isole greche a ridosso delle coste turche – è molto complicato definire i confini di queste Zee. Già in condizioni normali un negoziato che bilanci gli interessi contrapposti degli Stati coinvolti sarebbe difficile, se poi gli Stati sono ai ferri corti su una serie di altre questioni ecco che la via che può percorrere la diplomazia si fa ancora più stretta e impervia.
La decisione di Ankara di stabilire una Zee in accordo con la Libia (o meglio, con il governo libico di Tripoli, guidato da Fayez al-Sarraj, e contrapposto al governo di Bengasi, guidato dal generale Khalifa Haftar, sostenuto tra gli altri dall’Egitto), che oltretutto non tiene in considerazione la presenza di diverse isole greche tra cui Creta, va inserita nel contesto ampio visto finora. Come detto, ha la funzione di bloccare la possibile minaccia che rappresenterebbe il gasdotto EastMed, ma ha anche la funzione di ribadire il ruolo (sempre più determinante) della Turchia in Libia e di dare un segnale ai vari Stati coinvolti nella contesa geopolitica nel Mediterraneo orientale.
Questa mossa turca – condannata dagli Usa e dall’Europa, preceduta e accompagnata da scaramucce pre-belliche come violazioni dello spazio aereo altrui, posizionamento di navi militari in aree contese e via dicendo – ne ha causata una uguale e opposta da parte dell’Egitto e della Grecia, che a inizio agosto 2020 hanno a loro volta dichiarato una loro Zee, che va a sovrapporsi in parte con quella turco-libica, riconoscendo il ruolo (negato dalla Turchia) delle isole greche nella definizione dei confini. La questione è quindi come trovare ora una soluzione diplomatica che accontenti tutte le parti in causa, un risultato che da un lato è reso complicato dalla molteplicità di scontri aperti tra gli attori coinvolti (non solo Turchia e Egitto ma anche Grecia, Cipro e Israele) ma che dall’altro potrebbe proprio avere una funzione di mediazione su più tavoli.
Gli Stati Uniti e la comunità internazionale al momento sembrano schierati contro l’espansionismo di Ankara e a favore delle pretese avanzate da Grecia, Egitto e Cipro, ma la situazione è probabilmente più complessa di quella che sembra. L’Italia, ad esempio, ha sia interessi convergenti con quelli dell’Egitto e di Cipro, sia con la Turchia, con cui ad esempio è schierata dallo stesso lato della barricata in Libia. La Francia invece sembra tra i grandi Paesi europei quello più attivo nel contrastare le ambizioni turche. Non è chiaro al momento che piega possano prendere gli eventi, in uno scenario liquido e ricco di variabili, ma di sicuro sembra che la prassi seguita finora, che vedeva nella dichiarazione di Zee un’eccezione rispetto al principio di garantire la massima estensione possibile dell’Alto mare, sia oramai morta e sepolta. Anche l’Italia, storicamente sostenitrice della linea ostile alla dichiarazione di Zee, sta ora ragionando su come definire la propria (anche in risposta alle mosse unilaterali di altri Stati tra cui, ad esempio, l’Algeria) e in Parlamento c’è in discussione una proposta di legge che va in questo senso.
La prospettiva della spartizione dei mari appena vista, come quella dello scontro per il controllo e la distribuzione delle risorse, sono parti fondamentali – ma non esaustive – della più generale contesa geopolitica che è in atto nel Mediterraneo orientale. La Turchia, come detto, non fa mistero da anni di avere ambizioni neo-ottomane, di proiettare la propria influenza sul mondo islamico e di sostenere una visione vicina a quella della Fratellanza Musulmana. L’Egitto di Abdel Fattah al Sisi, che è andato al potere con un golpe proprio contro il Governo sostenuto dalla Fratellanza Musulmana e guidato da Mohammed Morsi, si contrappone (con la determinante sponda saudita, che di Ankara è il primo avversario all’interno del mondo sunnita) a queste ambizioni. Questo scontro si sta concretizzando in maniera violenta e preoccupante nella guerra di prossimità in corso tra i due Paesi sul suolo libico, con l’Egitto impegnato a sostenere il generale Haftar (insieme a Emirati, Russia e di fatto Francia) e la Turchia che di recente è intervenuta direttamente sul terreno con mercenari, guerriglieri siriani di fatto da lei controllati e proprie unità speciali per sostenere il governo di Serraj.
Siamo insomma nel contesto dello scontro interno al mondo sunnita tra le monarchie (come quella saudita o emiratina) e i regimi (come quello egiziano) da un lato, e gli Stati simpatizzanti della Fratellanza Musulmana come la Turchia e il Qatar dall’altro. Uno scontro che si intreccia poi con quello tra il fronte sunnita guidato dai Saud e quello sciita capeggiato dall’Iran, visto che sia Turchia che Qatar sono state in qualche modo spinte a una maggior vicinanza con l’Iran dalla linea dura impressa alla politica estera saudita dal principe ereditario Mohammed Bin Salman (che oltretutto può contare, nella sua ostilità sia all’Iran sia alla Turchia, su una parziale sponda israeliana).
Ma allargando l’obiettivo la partita in corso tra Egitto e Turchia in Libia può essere letta anche con altri significati. Per Mosca, ad esempio, più che uno scontro in cui ha interesse a impegnarsi per far vincere una delle parti in causa (come ha fatto in Siria dal 2015 in poi), sembra una situazione in cui ha interesse a ritagliarsi un ruolo da mediatore. La Russia, che sostiene l’Egitto di al Sisi e il generale Haftar, non ha infatti interesse a esacerbare i rapporti con Ankara e, anzi, potrebbe essere danneggiata dalla concorrenza egiziana nel mercato energetico se si concretizzasse il progetto EastMed. Dunque il Cremlino ha tutto l’interesse a collocarsi al centro di un negoziato che garantisca sia la sfera di influenza turca, sia le ambizioni egiziane, sia i buoni rapporti con Israele che con l’Europa.
E proprio l’Europa è l’attore geopolitico che in questo momento rappresenta la maggiore incognita, soprattutto nella prospettiva di medio-lungo periodo. Finora ha agito divisa per non colpire unita e così facendo ha lasciato spazio ad altri attori (Russia e Turchia in primis) in scenari che storicamente erano invece nella sua sfera di influenza (Libia, ma non solo). Eppure per posizione geografica degli Stati che la compongono (in particolare Grecia, Cipro e Italia), per potenza economica e quindi per leva economica in qualsiasi negoziato, per rapporti con gli Stati Uniti – che un domani potrebbero quantomeno diminuire il disimpegno dallo scenario europeo-mediorientale –, per peso nella Nato e per possibile potenza bellica (un sentiero finora inesplorato o quasi a livello europeo, ma su cui le cancellerie del vecchio continente pare abbiano iniziato a ragionare negli ultimi anni), l’Unione europea sarebbe nella posizione ideale per guadagnare un ruolo centrale in tutti i tavoli aperti nel Mediterraneo orientale. Una sua azione unitaria e coerente potrebbe insomma cambiare tutte le carte sul tavolo.
Questo articolo è pubblicato anche sul numero di settembre/ottobre di eastwest.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Trump aveva annunciato il ritiro delle truppe americane dalla Siria. Poi ha fatto marcia indietro: dal Paese controlla Teheran, Mosca e Ankara
Donald Trump aveva annunciato, a dicembre 2018, il ritiro delle poche ma fondamentali truppe americane presenti in Siria. I circa duemila uomini si trovano in particolare nel nord-est controllato dalle Syrian Democratic Forces (Sdf), alleanza ribelle guidata dai curdi siriani dell’Ypg, e nel sud al valico di al Tanf. I mesi successivi all’annuncio hanno dimostrato che l’interesse strategico degli Usa di medio e lungo periodo in Medio Oriente sembra in grado di sopravvivere alla comunicazione, e ai desiderata, del Presidente in carica.
Jim Jeffrey, rappresentante speciale degli Usa per la Siria e inviato speciale della coalizione internazionale per sconfiggere l’Isis, in un’intervista alla stampa tedesca di inizio luglio ha infatti sostenuto che il ritiro “è stato annullato, nel senso che mentre il Presidente continua a procedere con il ritiro, il suo piano è di lasciare a tempo indeterminato una forza residuale nel nord-est”, magari chiedendo un maggior contributo agli alleati europei e arabi. Non solo. “Anche quando si parlava di ritiro” − prosegue Jeffrey – “era chiaro che non avremmo abbandonato tutte le città del sud. Ecco perché, quindi, non stiamo abbandonando del tutto la Siria.”
Insomma, al di là delle finezze linguistiche del diplomatico, è evidente che alla fine gli Stati Uniti non lasceranno le posizioni che hanno in Siria. Non se ne andranno dal nord-est del Paese, dove proteggono − paradossalmente soprattutto dalla Turchia, Paese alleato nella Nato − i curdi siriani, che sono stati alleati fondamentali nello sconfiggere lo Stato Islamico. E non se ne andranno dal sud, dove la piccola presenza americana nella base di al Tanf spezza la strada più diretta tra Baghdad e Damasco, consentendo agli Usa di avere un posto di osservazione (e non solo) privilegiato sul “corridoio sciita” che dall’Iran arriva al Libano.
Ma perché il ritiro annunciato con grande enfasi dal Presidente alla fine è stato annullato? I motivi, come sempre in questi casi, sono molteplici. Sicuramente non è vero, come aveva scritto Trump su Twitter dando notizia della smobilitazione dalla Siria, che “l’unica ragione per stare in Siria” durante la sua presidenza fosse sconfiggere l’Isis. Un risultato che oltretutto non è ancora stato consolidato, vista la presenza di cellule terroristiche che continuano a colpire nel Paese. Ma, al di là di questo, cerchiamo di capire quali siano le ragioni ulteriori che spingono gli Usa a voler tenere gli scarponi sul terreno in quell’area.
La prima, e più evidente, è la contrapposizione con l’Iran. Dopo la decisione di Trump di stracciare il nuclear deal, imporre nuove sanzioni su Teheran e − in generale − di schierare gli Usa su una tradizionale (ma mai così marcata) vicinanza alle istanze di Israele e Arabia Saudita, la tensione sta raggiungendo nuove vette. A giugno pare che il Presidente abbia deciso all’ultimo di non bombardare obiettivi iraniani, ma la notizia intanto è stata fatta trapelare e ha dato un chiaro segnale alla Repubblica islamica. Nonostante questo le settimane successive sono state caratterizzate da continue provocazioni, con droni abbattuti e petroliere bloccate (una iraniana a Gibilterra, da parte delle forze speciali inglesi, una britannica nello stretto di Hormuz, da parte delle forze speciali iraniane), e il rischio che un conflitto − magari su scala ridotta − possa esplodere da un momento all’altro è sempre presente. In questo scenario l’interesse a tenere delle truppe in Siria, dove è al potere il Governo filo-iraniano di Bashar al-Assad, dove operano milizie sciite legate all’Iran, l’Hezbollah libanese alleato di Teheran, nonché reparti delle forze speciali iraniane, sembra quasi scontato. La posizione è poi ottimale anche per dare un segnale anche ad altri attori regionali coinvolti nel confronto tra sunniti e sciiti − cioè tra Arabia Saudita e Iran, che sfruttano cinicamente la frattura religiosa per scopi geopolitici −, in particolare all’Iraq, che negli anni della guerra all’Isis è stato sempre più attratto nell’orbita di influenza iraniana.
Ma questa ragione non è l’unica e forse nemmeno la principale. L’Iran è infatti tenuto sotto pressione diplomatica e militare da parte di Israele e dell’Arabia Saudita − che ha di recente deciso di accogliere sul proprio territorio truppe Usa, cosa che non accadeva dal 2003 − in una misura tale per cui la presenza di poche migliaia di soldati americani nel nord della Siria non sembra determinante.
Una ragione forse più importante è il mantenere una presenza nella regione che è stata il trampolino per l’ascesa della Russia come superpotenza in Medio Oriente. Mosca, lo ricordiamo, prima della guerra in Siria non aveva storicamente una particolare proiezione della propria potenza strategica nell’area. Dai tempi della Guerra Fredda è alleata della Siria e negli ultimi decenni ha avuto un atteggiamento meno ostile di quello americano nei confronti dell’Iran, ma fino al 2015 in sostanza non si era andati oltre a questo. Dopo l’intervento in Siria invece la Russia è riuscita a fare sfoggio di una potenza militare − seppur ancora non paragonabile a quella statunitense − inaspettata, ha disseminato di basi militari e di sistemi d’arma avanzati il Paese, ha puntellato il proprio alleato siriano, ha allacciato un rapporto di collaborazione molto stretto con Israele, ha assunto in generale un ruolo talmente preminente nell’area da spingere il re saudita Salman a recarsi in visita al Cremlino (cosa mai successa dopo la fine della Guerra fredda) e più di qualsiasi altra cosa è riuscita a risucchiare nella propria orbita di influenza la Turchia, Paese membro della Nato.
Per Washington avere uomini e mezzi in Siria, che di questa improvvisa ascesa della Russia sullo scacchiere mediorientale è la chiave di volta, è utile sia per non lasciare totalmente campo libero a Mosca sia per dare un segnale ai propri alleati (Israele, Saud, Turchia) che hanno iniziato a dialogare con Putin come mai in precedenza.
Arriviamo così all’ultima, e forse principale, ragione per cui gli Usa vogliono restare in Siria: prevenire, e nel caso curare, lo scivolamento verso est di Ankara. L’allontanamento della Turchia dall’Occidente ha raggiunto dei livelli di guardia preoccupanti, da ultimo con l’acquisto da parte di Erdogan del sistema di contraerea russo S-400, uno schiaffo − e un motivo di allerta per l’intelligence − all’Alleanza Atlantica di cui Ankara fa parte.
La reazione degli Stati Uniti all’arrivo del sistema S-400 in Turchia è stata dura e immediata: Ankara è stata estromessa dal programma F-35 (caccia multiruolo di quinta generazione), con significative ricadute economiche e occupazionali, oltre che simboliche. A nulla sono valsi i buoni rapporti personali tra Trump ed Erdogan: la Turchia è stata punita, oltre che per le innegabili ragioni di sicurezza (secondo gli analisti il sistema S-400 potrebbe carpire segreti militari-industriali relativi al programma F-35 se i due coesistessero), anche per dare un segnale al Sultano.
Ecco allora che la presenza americana − affiancata da quella europea − a protezione delle milizie curde dell’Ypg (innegabilmente legate al Pkk curdo-turco, ritenuto da Ankara ma anche da Washington un’organizzazione terroristica) serve un duplice scopo. Da un lato dà agli Usa una fondamentale moneta di scambio, un’esca con cui cercare di riportare la Turchia dalla propria parte allontanandola da Mosca (che i “suoi” curdi siriani del cantone di Afrin li ha già sacrificati in nome di un accordo con Erdogan, per confinare quel che restava della ribellione siriana nella sola provincia di Idlib). Dall’altro ha una funzione deterrente nei confronti di ulteriori scarti da parte di Ankara: la soluzione alla questione curda ai confini meridionali della Turchia deve necessariamente passare per una mediazione con Washington. Non con Mosca. Qualsiasi eventuale azione di forza da parte turca metterebbe a repentaglio la vita di soldati americani. Se la cosa accadesse, le conseguenze per la Turchia da un punto di vista economico, diplomatico e militare sarebbero catastrofiche.
Questo articolo è pubblicato anche sul numero di settembre/ottobre di eastwest.
Puoi acquistare la rivista in edicola o abbonarti.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Lo scontro sunniti/sciiti è sfociato in un ulteriore conflitto interno sunnita: wahhabismo (petrol-Stati) e Fratellanza Musulmana si sfidano in politica ed economia
L’attenzione dell’opinione pubblica e dei mass media occidentali verso il Medio Oriente è andata scemando negli ultimi mesi. La scomparsa dello Stato Islamico, almeno come entità territoriale, la diminuzione degli attentati in Occidente e l’isolazionismo (altalenante, come vedremo) degli Usa di Trump hanno infatti relegato l’argomento in un cono d’ombra da cui anche le notizie sul dramma dello Yemen escono col contagocce. Ma questo non significa che lo scenario non sia in evoluzione, anzi.
Il recente passato è stato dominato dalla faida tra Arabia Saudita e Iran, che ha infiammato lo scontro settario tra sunniti e sciiti soprattutto in quei Paesi del Medio Oriente in cui le primavere arabe – e non solo – avevano lasciato ferite infette facili da sfruttare. In questo modo è stata cannibalizzata da potenze straniere l’insurrezione siriana contro Assad, fino a renderla di fatto una proxy war; in questo modo il Libano è tornato a essere terreno di scontro (più o meno mediato) tra Teheran e Riad; in questo modo l’Iraq è rimasto in una posizione ambigua – che prova ora a sfruttare a proprio vantaggio, presentandosi come possibile mediatore – tra il vicino iraniano, alleato sciita, e gli altri Paesi arabi; in questo modo l’insurrezione degli Houthi (sciiti) in Yemen è diventata un altro capitolo sanguinoso della guerra per procura tra Arabia Saudita e Iran.
Ma questa dinamica – un po’ per via della rinnovata ostilità americana nei confronti di Teheran, con le ripercussioni negative sul nuclear deal voluto da Obama, un po’ per l’atteggiamento aggressivo di Israele che (al netto delle incertezze sul futuro politico di Netanyahu e della sua coalizione) sembra non aspettare altro che l’occasione giusta per attaccare se non l’Iran almeno la sua proxy libanese di Hezbollah, un po’ per la concorrenza della Russia, alleata ma rivale di Teheran – sembra ormai insufficiente a interpretare i principali movimenti sullo scacchiere mediorientale. Non è ovviamente venuta meno, ma pare meno intensa che nel recente passato.
L’Iran si è ripiegato almeno in parte su se stesso. Continua a sostenere le milizie sciite in Yemen, Libano, Iraq, Siria e non solo, ma se la fase compresa tra il 2014 e il 2017 aveva visto una costante espansione della sfera di influenza iraniana, adesso sembra che Teheran fatichi a mantenere le posizioni guadagnate. Mancano in teoria ancora due anni alle prossime elezioni presidenziali ma, come emerso con il caso delle dimissioni del potente Ministro degli Esteri Javad Zarif (poi respinte dal presidente Hassan Rohani), uno scontro di potere in cui l’ala dura del regime teocratico vorrebbe tornare alla guida del Paese per richiuderlo in un maggiore isolamento bellicoso è già in atto. E su tutto questo aleggia l’incognita della successione dell’Ayatollah Ali Khamenei, che ha da poco compiuto ottant’anni.
Con l’Iran indebolito e tenuto nel mirino da Israele, con sponda americana (Donald Trump pare abbia deciso l’invio di altri 1.500 militari nel Golfo), l’Arabia Saudita e le altre monarchie del Golfo sue alleate – in particolare gli Emirati Arabi Uniti – sembrano aver aumentato l’attenzione verso un’altra linea di frattura interna al Medio Oriente e non solo: quella tra regimi (dittature militari come l’Egitito o regni wahabiti come Riad) e Stati della galassia sunnita che hanno un’agenda diversa – e spesso incompatibile – da quella dei Saud. Si tratta in primo luogo della Turchia e del Qatar, politicamente vicini alla Fratellanza Musulmana e ideologicamente lontani dal wahabismo saudita.
Questa spaccatura non è una novità, anzi. La ribellione siriana, ad esempio, ha pagato duramente la litigiosità tra i suoi “sponsor” che avevano agende diverse, con l’Arabia Saudita che sosteneva alcune fazioni – tanto estremisti salafiti quanto laici – e la Turchia e il Qatar che ne sostenevano altre rivali (spesso legate alla Fratellanza Musulmana). L’Egitto post-primavera araba guidato da Mohamed Morsi era sostenuto dalla Turchia, quello post-golpe militare di Al Sisi è sostenuto da Riad. In Libia il premier islamista – e riconosciuto dalla comunità internazionale – Al Serraj è sostenuto dalla Turchia, il generale Khalifa Haftar dagli Emirati Arabi Uniti e dall’Egitto.
Come evidente dagli esempi visti, un ruolo da protagonista nello scontro interno alla galassia sunnita, lo ricopre Ankara. L’erede dell’Impero Ottomano avrebbe in teoria le caratteristiche necessarie – a livello di popolazione, economia e società – per sostenere il confronto con Riad da una posizione di forza, specie nel lungo periodo, ma il Paese è indebolito, trascinato in basso dalla fase discendente della parabola del suo Presidente. Negli ultimi cinque anni Erdogan ha compromesso le alleanze a occidente, a causa del sostegno americano ed europeo ai curdi siriani nella guerra contro l’Isis (anche se con Trump alla Casa Bianca, e con l’Isis sconfitto, il supporto americano ai curdi è molto meno convinto che con Obama). Di conseguenza, dopo aver perso la prova di forza con Mosca nel 2015 seguita all’abbattimento di un caccia-bombardiere russo, ha finito con l’avvicinarsi a Putin per necessità più che per convinzione. Pagando oltretutto un prezzo salato: accettare la vittoria di Assad in Siria – sacrificando di fatto le ambizioni dei ribelli che aveva sostenuto per anni e ottenendo in cambio da Mosca di poter occupare un pezzo di Kurdistan siriano che faccia da zona cuscinetto sul proprio confine meridionale – e mettere a rischio i rapporti con la Nato. L’acquisto da parte turca del sistema missilistico russo S-400 rischia infatti di generare pesanti ritorsioni, anche economiche, da parte dell’Alleanza atlantica e degli Usa.
In questa situazione Riad ha gioco facile a infierire, soprattutto economicamente, sulle difficoltà di Ankara, che risponde martellando su tutti i punti dolenti dell’immagine saudita nel mondo musulmano: la vicinanza mai così accentuata con Tel Aviv, che sarebbe un tradimento della causa palestinese; il diverso impegno nel sostenere i profughi siriani, fuggiti da una guerra fomentata tanto dalla Turchia quanto dall’Arabia Saudita ma accolti solo dalla prima; l’omicidio Kashoggi che, da ultimo, ha mostrato il volto brutale e sanguinario del regno saudita e del suo uomo forte, il principe ereditario Mohammed Bin Salman. Per la monarchia wahabita, che storicamente cerca di accreditarsi come la paladina di un Islam puro e intransigente, sono critiche indigeste. Ma non è un inedito, anzi, che Riad lasci prevalere la ragion di Stato e la realpolitik sul ferreo rispetto dei princìpi che sostiene di voler difendere e diffondere.
Trump sarebbe anche disposto a sostenere più convintamente Erdogan, nonostante le divergenze sui curdi o i problemi interni alla Turchia per quanto riguarda diritti umani e libertà di stampa, a patto che termini il flirt con Mosca e con Teheran (i tre Paesi si sono avvicinati per gestire l’ultima fase del conflitto siriano). Ma avendo scelto come propri interlocutori principali in Medio Oriente l’Arabia Saudita e Israele, riportare all’ovile Ankara – almeno per ora – sembra difficile. Specularmente Mohammed Bin Salman sembra più interessato a eliminare i concorrenti per la leadership all’interno del fronte sunnita, che non a soprassedere sulle differenze in nome di una comune battaglia contro l’Iran sciita. La pressione su Teheran ovviamente rimane, ma non è una questione così urgente da impedire a Riad di rinfocolare lo scontro con i rivali sunniti.
Oltre alla Turchia, il secondo Stato mediorientale che è in cattivi rapporti con Riad è il Qatar. Come Ankara anche Doha ha intessuto rapporti con la Fratellanza Musulmana, considerata dai Saud un’organizzazione terroristica, ha avuto una linea autonoma (e vicina a quella turca) in Siria, non apprezza la vicinanza dell’Arabia Saudita con Israele e in generale mostra troppa autonomia in politica estera per i gusti dei Saud. Con l’aggravante, rispetto alla Turchia, di essere un piccolo Stato della penisola araba che (secondo i Saud) dovrebbe quindi obbedienza al vicino maggiore. Questa ostilità è sfociata due anni fa in un embargo da parte di Riad, Egitto, Emirati Arabi Uniti e Bahrein (altro Stato satellite dell’Arabia Saudita, dove la popolazione in maggioranza sciita è governata da un monarca sunnita sostenuto anche militarmente da Riad).
Proprio la lista degli assenti, tra chi partecipa a questo embargo, dice però molto su come la linea dura di Riad voluta da Mohamed Bin Salman – contro il Qatar, così come contro l’Iran e la Turchia – fatichi a trovare proseliti anche tra i Paesi storicamente più vicini alla monarchia saudita.
L’Oman per esempio non partecipa né all’embargo al Qatar né alla guerra in Yemen e l’anziano sultano Qabus bin Said al Said da sempre cerca di mantenere il Paese in una posizione di dialogo – politico e commerciale – con l’Iran. Anche il Kuwait, riportano gli analisti, non sembra entusiasta della linea dura con Teheran e di quella morbida con Tel Aviv. Persino la monarchia hashemita al potere in Giordania con Re Abdallah II, che dipende economicamente dagli aiuti di Riad, non sembra apprezzare la leadership del giovane e bellicoso principe ereditario saudita. A inizio maggio è stato rimosso il capo dell’intelligence del Paese con l’accusa di complottare contro il Re e a dicembre erano stati rimossi due fratelli del Re con posizioni chiave nell’esercito e il rumour era che fossero legati ai Saud. Il timore di Abdallah, pare, è che il sostegno saudita al piano di Trump (e del suo inviato, il genero Jared Kushner) per la pace in Israele e Palestina abbia come contropartita l’affidare a Riad la custodia dei luoghi santi per l’Islam di Gerusalemme, a oggi controllati da Amman.
Tra gli altri Paesi arabi non mancano poi Stati in posizione defilata, rispetto ai voleri dei Saud, se non contraria: la Siria ha riallacciato i rapporti con gli Emirati Arabi Uniti ma con Riad è ancora gelo; il Libano è spaccato ma anche nel nuovo Governo, nato a febbraio, Hezbollah e i suoi alleati cristiani (il Presidente, e generale, Michel Aoun in primis) hanno un peso determinante; l’Iraq, per quanto si stia aprendo verso Riad, che ha promesso di finanziare un grande stadio a Baghdad, resta comunque un Paese vicino all’Iran sciita.
Anche in Nord Africa Mohammed Bin Salman può contare su un sostegno a macchia di leopardo: l’Egitto di Al Sisi, sostenuto dai soldi di Riad, è ovviamente tra i più fedeli alleati, ma il crollo delle dittature in Sudan e in Algeria viene vissuto come un pericolo dai Saud (che infatti, almeno in Sudan, stanno finanziando – insieme agli Emirati – i militari perché mantengano il potere) e il Marocco ha preso, dopo il caso Kashoggi, una posizione di netta condanna nei confronti del principe ereditario saudita.
Anche il Pakistan, altro storico alleato dei Saud, sembra poco intenzionato a seguire la linea di Mohammed Bin Salman, tanto contro l’Iran (con cui, anzi, Islamabad ha da poco avviato un progetto di cooperazione in ambito di anti-terrorismo) quanto contro chi, tra i Paesi sunniti, intrattiene relazioni con la Fratellanza Musulmana o ha in generale una linea in politica estera sgradita al principe ereditario. La potenza nucleare asiatica preferirebbe che Iran e Arabia Saudita trovassero un bilanciamento tra i propri interessi che garantisse la stabilizzazione del Medio Oriente e delle regioni limitrofe in Asia e Africa.
Il dilemma che spacca le leadership di tutti i Paesi coinvolti nel Grande Gioco mediorientale – Arabia Saudita e Iran inclusi – alla fine è proprio questo: spartirsi le sfere di influenza cercando un equilibrio o cercare lo scontro? Mohammed Bin Salman pare più per la seconda opzione, e non si è fatto scrupolo a cercare alleanze indigeste per l’opinione pubblica islamica (Netanyahu e Trump su tutti), e teoricamente inconciliabili con un rigido rispetto del wahabismo, per portare avanti la propria agenda. Il tempo del resto sembra remare contro le monarchie del Golfo: a oggi vivono ancora di petrolio e l’oro nero sarà sempre meno necessario nel mondo del futuro. I loro avversari, in particolare Iran e Turchia, hanno un passato, un territorio e una società che sembrano più adatti a farli prevalere nel lungo termine. Forse per questo il giovane leader saudita ha una linea così aggressiva, secondo alcuni addirittura avventata: sa che il secolo breve dei petrol-Stati è agli sgoccioli.
Questo articolo è pubblicato anche sul numero di luglio/agosto di eastwest.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Compiuti i primi passi di una tregua e di un confronto tra Governo e ribelli con l’appoggio delle Nazioni Unite
Le possibilità che in Yemen venga trovata una soluzione al conflitto, che insanguina il Paese dal marzo 2015, crescono al diminuire delle possibilità che una delle fazioni in guerra riesca a ottenere una piena vittoria sulle altre. Così, in modo quasi matematico, si possono forse spiegare i recenti progressi negoziali nelle trattative tra Governo yemenita, sostenuto soprattutto dall’Arabia Saudita e dagli Emirati Arabi Uniti, e i ribelli sciiti Houthi, sostenuti dall’Iran, che occupano vaste aree del Paese e la capitale, Sanaa.
A fine dicembre 2018, in Svezia, ribelli e Governo hanno siglato il cosiddetto “accordo di Stoccolma”. In base a questo è stato stabilito un cessate il fuoco per la città di Hodeida, un porto di 600mila abitanti che rischiava di diventare la prossima “bomba umanitaria” a esplodere in una guerra che ha già creato una devastante crisi per la popolazione civile, con malattie, carestie, bambini scheletrici o spesso già scheletri. La città è stata consegnata dai ribelli alle truppe governative il 30 dicembre. Non solo. Governo e ribelli hanno anche concordato un imponente scambio di prigionieri, che dovrebbe coinvolgere oltre quindicimila combattenti, e l’istituzione di una commissione per discutere il futuro della città di Taiz, la terza più grande del Paese e attualmente contesa tra le due fazioni. Infine l’accordo prevede che ci siano altri round negoziali nelle settimane successive, per cercare di implementare – e possibilmente ampliare – le decisioni prese.
Ancora non è possibile sapere se l’accordo reggerà e se, auspicabilmente, si amplierà. La situazione in Yemen, e in Medio Oriente nel complesso, è meno fluida che negli ultimi anni, ma lo è ancora abbastanza da rendere incerta qualsiasi previsione. Tuttavia, se guardiamo alla situazione che ha generato questo insperato progresso negoziale, sembra sia lecito avere qualche speranza.
L’Iran, che già forniva ai ribelli Houthi un supporto nettamente inferiore di quello dato dall’Arabia Saudita al Governo yemenita − sia in termini militari che diplomatici, considerando che Riad è riuscita a coinvolgere nel conflitto, seppur indirettamente, anche gli Stati Uniti −, è stato indebolito nel corso del 2018 dalla rinnovata aggressività della politica estera americana. L’uscita di Washington dal nuclear deal e il conseguente ritorno delle sanzioni e dell’isolamento internazionale, sono state per Teheran un duro colpo. Allo stesso modo l’attivismo di Israele in Siria, nel colpire obiettivi iraniani o di milizie sciite collegate all’Iran, come ad esempio l’Hezbollah libanese, lascia presagire che se la teocrazia iraniana dovesse commettere qualche errore, Tel Aviv sarebbe pronta ad approfittarne. Sicuramente nella proxy siriana e libanese, e forse non solo. E dalla Siria viene anche un’altra fonte di preoccupazione per gli ayatollah: il ritorno nel Paese delle potenze arabe, di nuovo capeggiate da Riad. Sconfitte militarmente, avendo appoggiato gli insorti siriani spazzati via dall’intervento della Russia e dal tradimento della Turchia, le monarchie del Golfo sembrano intenzionate a vincere la partita economica della ricostruzione siriana, trovando in Assad – che è nel cono d’ombra del Cremlino più che di Teheran ormai – un interlocutore interessato. Sembra insomma che possa essere nell’interesse della repubblica islamica iraniana che il conflitto yemenita entri in una fase di stallo, se non di de-escalation.
Ma se Atene piange, Sparta non ride. L’Arabia Saudita, che è impegnata in una faida oramai decennale con l’Iran per l’egemonia sull’Islam politico e che da quando è salito al potere il principe ereditario Mohammed Bin Salman ha accentuato il proprio interventismo, ha speso moltissimo nella guerra in Yemen. In termini di risorse economiche, di prestigio politico, di sforzo diplomatico, di uomini. Eppure alla vittoria sul campo ora sembra preferire, o quantomeno non voler ostacolare, un accordo. Le ragioni secondo gli esperti sono molteplici, ma raggruppabili in due insiemi. Il primo riguarda le difficoltà militari di Riad: nonostante la sproporzione di risorse, uomini e mezzi, quasi quattro anni di guerra non sono bastati per spazzare via i ribelli sciiti. Alcuni osservatori hanno parlato di “Vietnam saudita”, in riferimento allo Yemen. E per l’attore più forte, non riuscire a vincere è già una sconfitta, tanto più indigesta per un giovane leader come Mohammed Bin Salman che ha bisogno di affermarsi, in patria e all’estero, e di stroncare sul nascere possibili fonti di malcontento.
Il secondo insieme di ragioni per cui i Saud sembrano quantomeno interessati alla possibilità di un dialogo con gli insorti è forse quello più importante, e ha a che fare con il futuro stesso delle relazioni diplomatiche della monarchia saudita, soprattutto con l’Occidente. Dal 2001 in poi, cioè da quando con l’attacco alle Torri Gemelle è esploso il fenomeno del terrorismo islamico sunnita, Riad è sempre più spesso finita nel mirino delle critiche. La versione oscurantista e fanatica dell’Islam che propaganda la monarchia saudita, all’interno del proprio Stato e, tramite una diffusa rete di moschee anche all’estero, è pericolosamente affine a quella dei predicatori di Al Qaeda prima e dell’Isis poi. E un legame anche operativo tra Saud e cellule islamiche estremiste, spesso usate da Riad per i propri fini e non di rado poi sfuggite di mano, risale addirittura ai tempi dell’invasione sovietica dell’Afghanistan e della resistenza dei mujaheddin. Sempre più opinioni pubbliche occidentali, europee soprattutto ma anche quella americana, chiedono ai propri Governi di rivedere la storica alleanza con l’Arabia Saudita. Questo è un pericolo esiziale per i Saud, che fin dalla nascita del loro regno hanno fatto delle buone relazioni – economiche e militari, soprattutto − con l’Occidente un elemento costitutivo. Uscita ammaccata dagli anni dello Stato Islamico (diciamo dal 2014 al 2018) in Siria e Iraq, la reputazione dei Saud stenta a risollevarsi, nonostante gli sforzi di Mohammed Bin Salman di dare un’immagine più moderna, e laica, al regno. Qualche progresso c’era forse stato con le inedite concessioni alla popolazione femminile, ad esempio il poter guidare le macchine, ma l’omicidio Kashoggi ha nuovamente scaraventato Riad in mezzo agli attacchi dei suoi alleati occidentali. La Germania, ad esempio, ha sospeso la vendita di armi alla monarchia saudita e, in generale, gli Stati europei faticano sempre più a giustificare il significativo interscambio economico con un Paese che brutalizza gli oppositori, andando a ucciderli anche all’estero, e che in generale fa scempio dei diritti umani.
Ecco allora che l’esigenza di evitare un tracollo della crisi umanitaria in Yemen per Riad è diventata forse più urgente dell’esigenza di vincere la guerra e punire gli insorti sciiti. Almeno per il momento, con l’Iran in posizione di relativa debolezza. Se i telegiornali occidentali iniziassero a inondare le case dei propri spettatori con immagini di bambini yemeniti moribondi, a causa della guerra condotta da quella stessa Arabia Saudita che già è ritenuta corresponsabile del diffondersi del fanatismo islamico e mandante dell’omicidio Kashoggi, la fiamma di ritorno del malcontento verso l’alleanza con Riad avrebbe proporzioni potenzialmente pericolose. Non tanto nell’immediato, con Donald Trump che da Washington sembra in grado di mettere un coperchio alle spinte critiche nei confronti dell’alleanza coi Saud in nome delle colossali commesse militari che Riad garantisce all’industria bellica americana, quanto negli anni a venire.
Quella dell’Arabia Saudita è infatti una battaglia per la sopravvivenza nel XXI secolo, non solo negli anni Venti. Passato Trump ci sarà un nuovo Presidente con cui avere a che fare e giocare d’anticipo sull’eventualità che il prossimo inquilino della Casa Bianca debba rendere conto a un elettorato più attento ai diritti umani oltre che all’import/export per Mohammed Bin Salman – che vista la giovane età potrebbe, salvo rovesciamenti imprevisti, regnare per molti decenni – è probabilmente la scelta più razionale. Meglio allora per i Saud rallentare, se non fermare, l’escalation di violenze in Yemen e vedere se per via negoziale è possibile raggiungere un compromesso accettabile con gli insorti.
La demilitarizzazione della città portuale di Hodeida e delle aree circostanti potrebbe, se gli sporadici scontri e violazioni della tregua non faranno precipitare la situazione prima, garantire una progressiva normalizzazione della situazione. Gli Houthi potrebbero decidere di restare al tavolo, con la speranza di veder riconosciuto il proprio ruolo (e la propria fetta di potere) in uno Yemen unitario alleato di Riad. A quel punto il rischio rappresentato dall’ingerenza iraniana ai propri confini meridionali sarebbe scongiurato per l’Arabia Saudita.
Specularmente, il rischio è che se questa tregua non reggerà e non porterà anzi altri, e maggiori, frutti, la situazione degeneri. Non solo la crisi umanitaria sarebbe devastante per la popolazione civile e pericolosa per le relazioni diplomatiche presenti e future di Riad. Un riaccendersi delle ostilità rischierebbe di lasciare spazio ad Al Qaeda, che in Yemen è molto forte e radicata nelle zone periferiche – e anche in alcune zone costiere – del Paese, e di eventuali fuggiaschi dell’Isis. E un nuovo santuario – dopo l’Afghanistan dei Talebani, l’Iraq e la Siria del dopo primavere arabe – per il fanatismo islamico sarebbe un problema per tutti: per gli Usa che si vogliono disimpegnare dalla regione, per i Saud che si vedrebbero chiamati in causa nella questione, per lo stesso Iran che – senza la base economica che rappresentava il nuclear deal – faticherebbe ad aiutare gli houthi yemeniti, e per l’Europa, che rischierebbe di pagare di nuovo il prezzo più alto in termini di attentati.
Questo articolo è pubblicato anche sul numero di marzo/aprile di eastwest.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

I curdi del Nord (Turchia), quelli dell’ovest (siria) e quelli dell’est (iran) sono avversati dalle potenze regionali che invece flirtano con i curdi del sud (iraq).
La questione curda non è un monolite privo di sfaccettature, anzi, le divisioni interne sono da sempre uno dei limiti maggiori della causa indipendentista. Il solco più largo sembra essere quello che divide il PYD (Partito dell’Unione democratica) curdo-siriano e il PDK (Partito Democratico del Kurdistan) curdo-iracheno. La formazione siriana è infatti di ispirazione socialista e propugna il confederalismo democratico teorizzato dal leader del PKK (Partito dei Lavoratori del Kurdistan) Abdullah Öcalan. La formazione irachena, guidata dal clan Barzani, è invece di ispirazione conservatrice e nazionalista. La prima è considerata un nemico mortale dalla Turchia, la seconda un’interlocutrice affidabile.
Negli anni della guerra allo Stato Islamico la causa curdo-siriana del PYD è diventata molto popolare anche in Occidente, grazie agli atti di eroismo delle Unità di protezione popolare (YPG e la brigata femminile YPJ) ad essa legate, e non solo. La fascinazione verso il PYD e le sue milizie non è infatti dipesa soltanto dall’antico adagio secondo cui “il nemico del mio nemico è mio amico”, ma anche – se non soprattutto – dalle caratteristiche “politiche” di questa causa.
Il sogno di una repubblica democratica parlamentare fondata sul pluralismo, sul decentramento del potere, sul rispetto dell’ambiente, sulla parità tra uomini e donne, sull’applicazione dei valori più alti del socialismo ha reso l’esperimento del Rojava – il Kurdistan siriano, liberato dall’occupazione dell’Isis grazie a una serie di scontri e battaglie, di cui Kobane è solo la più famosa – una fonte di seduzione per l’opinione pubblica occidentale. Sono così nate brigate internazionali di combattenti stranieri, spesso giovani, che andavano in Siria per affiancare le milizie dell’YPG nella loro guerra di liberazione. È nata così la leggenda delle guerrigliere curde dell’YPJ, temute sopra ogni cosa dagli uomini dell’Isis in quanto donne, che hanno dimostrato come anche in una società musulmana fossero possibili progresso e uguaglianza. Sono nate – o sono state rafforzate – le milizie delle altre minoranze etniche dei territori occupati e devastati dall’Isis, ad esempio quella degli Yazidi. Questa minoranza, che viveva al confine tra Siria e Iraq, è stata massacrata senza pietà dagli uomini del Califfato nel 2014. Abbandonati dai Peshmerga curdo-iracheni (legati al PDK), che avrebbero dovuto proteggerli e che invece si sono ritirati davanti all’avanzata inarrestabile dell’Isis, gli Yazidi sono stati aiutati dal PKK e dall’YPG, che hanno aperto dei corridoi sicuri per portare quanta più gente possibile nel Rojava siriano. A quel punto, sia uomini sia donne, si sono arruolati nelle loro milizie, YBŞ e (quella solo femminile) YJÊ.
Ovviamente non sono mancati e non mancano gli aspetti negativi: alcuni report internazionali accusano le milizie curdo-siriane di reclutamenti forzati di minorenni, di persecuzione politica degli oppositori, di pulizia etnica a danno delle popolazioni arabe, che sarebbero state spostate dai loro territori, e via dicendo. Ma queste accuse per ora non sono bastate a distruggere l’immagine positiva della propria causa che il PYD e le sue milizie hanno saputo proiettare negli anni della guerra all’Isis.
Ma a questo favore mediatico ed “emotivo” nei confronti dei curdi-siriani legati a PYD e YPG non ha sempre corrisposto un analogo favore da un punto di vista politico-internazionale. Gli Stati Uniti, che pure hanno sfruttato l’YPG come fanteria contro l’Isis, hanno a lungo rifiutato di fornire armamenti avanzati alle milizie curdo-siriane, per non scontentare eccessivamente la Turchia che del PYD è acerrima nemica, visti i legami di questa formazione col PKK, considerato da Ankara un’organizzazione terroristica. Ma non solo. Anche la Russia, che in Siria è l’attore principale che controlla e gestisce tutte le varie partite aperte sullo scacchiere, ha abbandonato e sacrificato i curdi siriani del cantone occidentale di Afrin, a lungo suoi interlocutori. Putin ha infatti lasciato che l’esercito turco occupasse militarmente questo cantone a inizio 2018, per avere in cambio l’appoggio della Turchia nello smantellare le ultime sacche di ribelli in Siria disposti a impugnare le armi contro la dittatura di Assad.
Specularmente i curdi iracheni del PDK hanno goduto, relativamente, di meno simpatia da parte dell’opinione pubblica occidentale negli ultimi anni. La loro guerra contro l’Isis in Iraq, forse a causa anche di episodi come l’abbandono degli Yazidi, non ha creato una narrazione affascinante ed eroica come quella dei curdi siriani e della resistenza di Kobane. Eppure il favore politico nei loro confronti è stato molto superiore a quello per il PYD, con gli Stati Uniti e la stessa Turchia che hanno storicamente cercato di avere buone relazioni – anche economiche e commerciali – con il Governo Regionale del Kurdistan (KRG) iracheno, guidato da Masud Barzani fino a poco tempo fa.
Questo favore politico è venuto solo momentaneamente meno quando Masud Barzani ha voluto spingersi troppo in là, per i gusti dei suoi alleati stranieri, indicendo un referendum per l’indipendenza della Regione Kurda Irachena e vincendolo nel 2017. Baghdad ha reagito presto e duramente, riconquistando la città di Kirkuk – importantissimo bacino petrolifero – che era stata liberata dall’Isis dai Peshmerga curdi e da loro controllata fino a quel momento, e alzando in generale i toni con Erbil (la capitale del Kurdistan iracheno). Ankara, Teheran e Damasco – gli altri Stati al cui interno vivono le comunità curde – hanno subito condannato le pulsioni indipendentiste dei curdi iracheni e nessuno in Occidente ha fornito una sponda sufficientemente forte alle ragioni del referendum. L’indipendenza non si è quindi concretizzata e Masud Barzani ha dovuto lasciare la guida del KRG, che aveva mantenuto ininterrottamente da dopo la caduta di Saddam Hussein nel 2003. Ma, come si era rapidamente mutato in ostilità, il favore dei vari attori regionali e internazionali nei confronti del PDK è altrettanto velocemente ritornato una volta accantonato il rischio di un Kurdistan iracheno indipendente. A distanza di neanche un anno dal referendum vinto ma fallito, le relazioni di Erbil con Baghdad, Ankara e Washington si sono nuovamente normalizzate. Un altro Barzani leader del PDK – il nipote di Masud, Nechirvan, che già ha l’incarico di primo ministro – potrebbe presto diventare il nuovo presidente, succedendo così allo zio.
Ma perché il PDK curdo-iracheno del clan Barzani gode di un trattamento tanto migliore rispetto al PYD curdo-siriano? In parte è una questione ideologica: il PYD è erede di una tradizione marxista che non ha mai avuto le simpatie degli Stati Uniti e della Turchia. Questo ha creato anche dei precedenti storici, ad esempio durante la guerra civile curdo-irachena di metà anni ‘90, quando il PDK è stato sostenuto dalla Turchia contro le formazioni marxiste legate al PKK (su tutte il PUK curdo-iracheno). Ma, al di là della storia e dell’ideologia, il vero discrimine oggi sembra essere soprattutto il rapporto con la Turchia. Chi le è nemico, come il PYD, viene facilmente sacrificato da altri Stati che pure potrebbero essere stati momentaneamente alleati dei curdi (come di recente gli Usa e la Russia), perché la pedina turca è troppo importante nello scacchiere mediorientale rispetto a quella curda. Chi non le è ostile, e non calca troppo l’accento sulla questione dell’indipendentismo, sa di poter godere delle buone relazioni con Ankara da un punto di vista commerciale e geopolitico. Questo schema, un divide et impera che corre sulle diverse relazioni tra componenti curde e Turchia, ha retto finora.
Nell’estrema fluidità che sembra caratterizzare il Medio Oriente dopo il fallimento delle Primavere arabe e l’infiammarsi dello scontro sunniti-sciiti – paravento dello scontro geopolitico tra Iran e Arabia Saudita -, e soprattutto con il progressivo allontanamento degli Usa dalla regione, la dinamica dei rapporti potrebbe tuttavia forse cambiare. La Turchia si è sempre più spostata nell’orbita di influenza del Cremlino, pur rimanendo formalmente all’interno della Nato, e i rapporti tra Washington e Ankara sono sempre più tesi. Se la crisi tra la Casa Bianca e Erdogan, cominciata già a inizio anni Dieci ma aggravatasi durante la guerra civile siriana e soprattutto dopo il fallito golpe del 2016, dovesse giungere alle sue estreme conseguenze lo scenario potrebbe cambiare radicalmente. Fantapolitica? Forse. Alla stessa Turchia in fondo probabilmente non conviene staccarsi definitivamente dall’Occidente, ma restare in una posizione ambigua per poter trattare sia con gli Usa che con la Russia. Ma se la miopia strategica mostrata da Erdogan nell’ultimo periodo dovesse giungere alle estreme conseguenze, la carta dell’autonomia curdo-siriana permetterebbe agli Stati Uniti di punire un ex alleato “traditore” come Ankara e contemporaneamente di creare gravi problemi a due Stati “nemici” come la Siria e l’Iran.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Per gridare slogan, provocare l’autorità, denunciare i soprusi, sfidare il potere, i giovani negli Stati autocratici fanno le loro lotte sui social media.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Troppi vincitori in campo, tanti e troppo potenti gli sconfitti. La “pace” siriana rischia di essere la temuta miccia della polveriera mediorientale.
La guerra civile siriana è pressoché terminata, le varie aree di influenza straniera vanno stabilizzandosi e si potrebbe quasi intravedere una “pace armata” all’orizzonte. Ma se questa pace dei vincitori (regime di Assad, Iran e Russia) viene subita dagli sconfitti (i vari gruppi ribelli, tra cui quelli appoggiati dalle monarchie del Golfo, e lo Stato Islamico) e tollerata da chi ha ottenuto un “pareggio” (la Turchia e i curdi siriani), rischia però di essere rifiutata da chi è rimasto più o meno alla finestra durante il conflitto: Israele. Lo Stato ebraico è molto preoccupato per la presenza iraniana – diretta e indiretta, grazie alla galassia di milizie sciite che controlla, tra cui l’Hezbollah libanese – in Siria e dà segnali di una crescente voglia di intervenire in questo scenario (con la sponda, se non la spinta, di Riad) per impedire il consolidamento dello status quo. La Russia sembra disposta a concedere, o meglio a confermare, un certo spazio di manovra per Tel Aviv ma, con la rinnovata sponda anti-iraniana degli Stati Uniti guidati da Trump, Israele potrebbe essere tentata da un’azione più incisiva di qualche sporadico strike mirato contro obiettivi iraniani in Siria, com’è accaduto finora. Ecco allora che la “quinta fase” della guerra civile siriana rischia di essere la più pericolosa per la regione dall’inizio delle violenze.
Possiamo schematizzare in quattro fasi, che si sono succedute e spesso sovrapposte, quel che è successo in Siria dallo scoppio delle violenze fino ad oggi. La prima, di inizio 2011, è quella della Primavera araba quando, come già accaduto in Egitto e Tunisia, le strade delle città siriane furono teatro di grandi manifestazioni poi brutalmente represse dal regime. La seconda è la fase dello scontro aperto tra Assad, sostenuto dall’Iran, e i ribelli armati sostenuti dalle potenze sunnite, in primo luogo Arabia Saudita, Turchia e Qatar. Questa fase, iniziata presto nel 2012, si è protratta praticamente fino ad oggi. Oltretutto va notato come le fratture tra Stati sunniti (filo-Fratellanza musulmana Turchia e Qatar, sua nemica Riad) abbiano prima indebolito e poi definitivamente azzoppato la ribellione siriana. Oggi la Turchia siede al tavolo con Russia e Iran per spartirsi le aree di influenza in Siria. Il Qatar, dopo lo scontro con Riad, si è avvicinato a Teheran. L’Arabia Saudita, da ultimo, sembra aver perso le speranze negli insorti e punta in modo più convinto sull’asse con Tel Aviv.
La terza fase è stata quella della guerra contro lo Stato Islamico, un’organizzazione terroristica sunnita. Questo conflitto è stato combattuto da una molteplicità di attori, spesso nemici tra loro, tra il 2014 e il 2018. Nel nord e nell’est della Siria l’Isis è stato scacciato dai curdi siriani (col sostegno Usa) in gran parte, e in misura minore dalla Turchia e dai ribelli da lei sostenuti (l’azione di Ankara fu principalmente in ottica anti-curda). Nel centro del Paese e nel sud sono stati il regime di Assad, le milizie sciite filo-iraniane, l’Iran e la Russia a sconfiggere gli uomini del Califfato, e talvolta anche gruppi ribelli anti-Assad si sono scontrati con gli uomini di Al Baghdadi. Dallo scontro sono emersi vincitori in particolar modo l’asse sciita, che ha sfruttato abilmente l’Isis “nemico di tutti” per portare propri armamenti e milizie nell’area, e dalla Russia, che ha usato lo Stato Islamico come pretesto per intervenire nel 2015. Ad oggi restano solo piccole sacche nell’ovest e due aree desertiche nell’est della Siria, dove ancora si annidano uomini dell’Isis, ma il conflitto di fatto è terminato dopo la caduta delle roccaforti di Raqqa e Deir ez Zor in Siria, e Mosul in Iraq.
L’intervento russo del 2015 ha aperto la quarta fase, che ha visto crescere la presenza e il ruolo di Mosca prima in Siria e poi nell’intero Medio Oriente. Al di là del rafforzamento dell’apparato bellico russo nell’area grazie a nuove e avanzate installazioni militari, è di grande importanza per il Cremlino l’aver attirato la Turchia nella propria area di influenza allontanandola dalla Nato. Dopo una prima fase di duro scontro nel 2015, culminato nell’abbattimento di un caccia-bombardiere russo e nelle sanzioni economiche reciproche, Erdogan ha finito col dover cedere alla linea di Putin: ha ridotto il suo sostegno militare alle fazioni ribelli indigeste per Mosca – di fatto propiziando la caduta di Aleppo − e ha accettato che Assad restasse al suo posto, rinunciando alle sue mire “neo-ottomane”. Da un lato il fallito golpe del 2016 l’aveva lasciato indebolito (e sospettoso nei confronti dell’Occidente), dall’altro il rifiuto americano di abbandonare i curdi siriani quali interlocutori sul terreno nella guerra all’Isis l’aveva spinto su posizioni di netto contrasto con gli alleati della Nato. La resa alla Russia almeno ha portato ad Ankara il “contentino” di poter occupare militarmente una zona cuscinetto nel nord-ovest della Siria, da lei “liberata” in parte dall’Isis e soprattutto dai curdi. Oltre alla “finlandizzazione” della Turchia, il Cremlino ha ottenuto anche il risultato di imporsi come interlocutore indispensabile per Israele, che colpisce obiettivi iraniani e di Hezbollah in Siria col consenso più o meno implicito di Mosca, e per le potenze sunnite, che sperano la strisciante competizione tra Russia e Iran limiti l’espansione dell’area di influenza sciita in Medio Oriente. Un esito, questo, che ambienti militari americani ritengono molto negativo per gli interessi di Washington.
La quinta fase, che potrebbe iniziare nel prossimo futuro, nasce dunque sui punti di frizione ancora irrisolti lasciati dalle fasi precedenti. In particolare l’insoddisfazione americana per il rafforzamento della Russia, in un’area storicamente più nella sfera d’influenza di Washington che di Mosca, spinge Trump a un rinnovato interventismo militare e soprattutto diplomatico. Si sono già registrati due strike missilistici “punitivi”, per l’uso di armi chimiche da parte del regime, e soprattutto la decisione di rinviare a data da destinarsi il ritiro delle poche, ma geopoliticamente importanti, truppe presenti in sostegno dei curdi-siriani nel nord-est della Siria. Anzi, le forze curde hanno annunciato l’avvio delle operazioni nell’estremo oriente del Paese per liberare le ultime sacche al confine con l’Iraq dalla presenza dell’Isis. Un modo questo anche per prendere il controllo di un’area desertica ma strategica (specie per gli Usa, che se non possono interrompere il “corridoio sciita” che dall’Iran passa per l’Iraq e arriva in Siria e Libano, almeno vogliono restringerlo il più possibile). Ma soprattutto gli Usa hanno fatto retromarcia sulla strategia geopolitica: basta scontentare i propri alleati nella regione – che per reazione si sono avvicinati al Cremlino – e dunque rinnovata ostilità verso l’Iran.
Arriviamo così al secondo punto di frizione rimasto irrisolto, quello più pericoloso: quello tra Iran e Israele. Tel Aviv, dopo anni di strike mirati, ha di recente colpito con un’unica ondata di missili decine di obiettivi militari iraniani presenti in Siria. La versione israeliana è che questa sia stata la risposta a dei colpi sparati dalle milizie iraniane contro proprie postazioni nel Golan. Potrebbe essere stato un avvertimento a Teheran, ma potrebbe essere un’inquietante overture del prossimo futuro. L’Iran, scottato anche dal ritiro degli Stati Uniti dal nuclear deal e dalla prospettiva di nuove sanzioni – chiari segnali della volontà di Trump di ghettizzare nuovamente Teheran sulla scena internazionale −, non sembra intenzionata a rinunciare alla profondità strategica guadagnata in Siria, e anche Hezbollah si sente rafforzata e legittimata dal recente buon risultato nelle elezioni libanesi. Se l’intenzione del regime di Assad di riconquistare anche la sacca ribelle di Daraa, nel sud della Siria al confine con Israele e con la Giordania, si tradurrà in una vasta campagna militare – probabilmente supportata come di consueto dalle milizie sciite e iraniane – a pochi chilometri dal Golan, il rischio di altri scontri con l’esercito con la stella di Davide sarebbe elevato. E il piano inclinato pericoloso.
Teheran, radicalizzata dal tentativo americano di isolarla e indebolirla, sospettosa nei confronti di una Russia alleata ma concorrente, e forse tentata dall’opportunità di sfruttare l’odio montante nelle opinioni pubbliche musulmane contro Israele per la violenta repressione delle proteste palestinesi (Hamas, che ha in gran parte controllato tali proteste, negli ultimi due anni si è riavvicinata molto all’Iran, dopo un allontanamento dovuto alla guerra civile siriana, in cui in un primo momento l’organizzazione terroristica palestinese sosteneva gli insorti), potrebbe commettere un errore in un contesto pericoloso. Israele, il cui governo nazionalista da anni alimenta la (e si alimenta della) paura nei confronti dell’Iran e che ora si sente nuovamente spalleggiata appieno dall’alleato americano, potrebbe fare altrettanto. Il rischio di un’esplosione della polveriera mediorientale non può essere sottovalutato.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Il contributo militare degli Usa è stato decisivo, ma i dividendi della vittoria li sta incassando Mosca. Cresce anche l’influenza di Teheran. Non pervenuta l’Europa.
Non è stata l’inizio e non sarà la fine del conflitto in Siria e del caos in Medio Oriente, ma la guerra contro lo Stato Islamico è stata uno dei momenti fondamentali della storia recente. Si è conclusa con la sconfitta del Califfato, la creatura nata dalla mente di ex ufficiali dei servizi segreti di Saddam Hussein che avevano capito come sfruttare le debolezze congiunte dell’Iraq post-dittatura baathista e della Siria investita dal vento delle Primavere arabe a inizio di questo decennio. Il mix di abilità tattiche e militari degli ex ufficiali baathisti e di presa del fanatismo islamico su parte delle comunità sunnite – soprattutto in Siria, sconvolta dalla guerra civile, e in Iraq, dove era sopravvissuto il brodo di cultura dell’Al Qaeda in Iraq del famigerato Al Zarkawi, ma non solo – aveva portato lo Stato Islamico a occupare, tra il 2014 e il 2015, un territorio a cavallo tra Iraq e Siria pari a quello del Regno Unito. Le sigle del terrorismo jihadista locale – dalle Filippine alla Nigeria – si affrettavano allora a giurare fedeltà al Califfo, decine di migliaia di foreign fighters accorrevano da Asia, Europa e Africa sotto le bandiere nere dell’Isis, le immagini raccapriccianti delle esecuzioni “spettacolari” sconvolgevano l’Occidente e galvanizzavano i jihadisti e i loro simpatizzanti, uno stillicidio di attentati (spesso compiuti da persone disturbate, “lupi solitari”, e solo raramente da cellule organizzate) insanguinava il mondo e diffondeva la paura.
Ora, circa tre anni dopo, pare tutto finito. Il rischio di attentati in Europa e non solo rimane, ovviamente, ma il mito dello Stato Islamico e la sua presenza territoriale sono stati spazzati via. Poche sacche di deserto sono quel che resta del Califfato che un tempo controllava città di centinaia di migliaia di abitanti come Mosul, Raqqa, Ramadi e Kirkuk, che costruiva scuole islamiche per indottrinare i bambini, imponeva codici di condotta e abbigliamento, terrorizzava e massacrava le minoranze, distruggeva le meraviglie archeologiche degli “infedeli”, riscuoteva le tasse, vendeva petrolio e ci pagava (meglio di tutte le altre milizie) i suoi combattenti. Le bombe della coalizione a guida Usa, la riscossa dell’esercito siriano aiutato dall’Iran e dalla Russia, quella dei Peshmerga curdi-iracheni, dell’esercito iracheno aiutato dagli Usa e dalle milizie sciite filo-iraniane, l’eroica resistenza prima e controffensiva poi dei curdi siriani sono tutti tasselli della sconfitta finale dello Stato Islamico. Ma chi ha vinto e chi ha perso, a parte il Califfato medesimo, questa battaglia?
I due principali vincitori sono la Russia e l’Iran. Non tanto perché abbiano contribuito più degli altri a sconfiggere lo Stato Islamico, ma perché sono i due attori che hanno tratto maggiore vantaggio dalla battaglia prima e dalla vittoria poi. Mosca era intervenuta in Siria nel settembre 2015 per evitare che cadesse il regime di Assad, alleato del Cremlino che ospita l’unica base navale russa nel Mediterraneo. La presenza dello Stato Islamico ha in primo luogo fornito a Putin un ottimo pretesto per intervenire, ma non solo. Ha anche reso zoppa la condotta del rivale statunitense. Gli Usa non hanno voluto abbattere Assad proprio per evitare di lasciare campo libero all’Isis e alle altre sigle jihadiste, e quindi non hanno attaccato Damasco nel 2013 dopo l’uso di armi chimiche e sono stati molto prudenti nell’armare le milizie ribelli sunnite. Allo stesso tempo non hanno voluto attaccare direttamente via terra l’Isis, non avendo una strategia per il dopo. Anche il rafforzamento dei nemici dell’Isis ha creato diversi problemi agli Usa. Alcuni erano impossibili da aiutare direttamente: il regime di Assad e le milizie sciite alleate dell’Iran (tra cui la libanese Hezbollah) sono nemici di Washington, oltre che dei suoi alleati sauditi e israeliani (già furiosi per il “nuclear deal” con Teheran). Gli insorti siriani “moderati” si sono rivelati inaffidabili. Inoltre anche l’aiuto Usa ai curdi siriani del Ypg, la forza di terra più efficace contro l’Isis nel corso della guerra, è stato centellinato per evitare di indispettire troppo la Turchia, che nel Ypg vede un’organizzazione terroristica legata al Pkk.
Così, anche se l’America ha dato un contributo maggiore rispetto alla Russia alla sconfitta dello Stato Islamico, in particolare nelle due battaglie principali di Mosul e Raqqa, i dividendi di questa vittoria sono stati incassati più da Mosca che da Washington. La Russia è vista da tutti gli attori mediorientali come la potenza che sta guadagnando terreno nella regione, mentre gli Usa come quella che ne sta perdendo. La Turchia, inizialmente ostile con Mosca, si è sempre più spostata (per necessità, per salvare il salvabile del proprio interesse strategico in Siria) su una linea filo-russa. L’Arabia Saudita, altra sconfitta della guerra in Siria, riconosce apertamente l’importanza delle relazioni col Cremlino. Il Qatar ha seguito la Turchia nel processo di allontanamento da Riad e avvicinamento a Mosca e Teheran. Lo stesso Iran, che pure sta tra i principali vincitori, ha dovuto constatare che senza l’intervento della Russia le sorti della guerra in Siria sarebbero state diverse. Ora il Cremlino ha potuto disseminare il territorio siriano di basi militari che gli danno una profondità strategica senza precedenti nel Mediterraneo Orientale e in Medio Oriente. Ha portato in loco sistemi avanzati anti-missile (S-400) che gli danno il predominio sui cieli della regione. Ha coltivato i rapporti con tutte le parti (asse sunnita, asse sciita, Israele e non solo) e si è in generale posta al centro del Grande Gioco che si è rimesso in moto in Medio Oriente nell’ultimo decennio.
Allo stesso modo l’Iran si può considerare uno dei vincitori. Come la Russia, è riuscito a sfruttare la presenza dello Stato Islamico prima per salvare Assad, e poi per espandere la propria influenza nella regione. L’Iraq è infatti ora più vicino all’Iran di quanto non sia mai stato in passato – cosa che aumenta le preoccupazioni di Riad e Tel Aviv – e le milizie sciite (Hezbollah in primis) sono più armate, addestrate e diffuse che mai nell’area. Lo stesso Qatar, prima alleato di Riad, dopo la crisi diplomatica con i Saud si è spostato verso Teheran. La Repubblica Islamica inoltre ha visto la propria reputazione internazionale, già migliorata grazie all’accordo sul nucleare e alla presidenza “moderata” di Rouhani, guadagnare grandemente dalla battaglia contro lo Stato Islamico. I Paesi europei, che con Teheran vogliono fare affari dopo il “nuclear deal”, sono più forti nell’osteggiare la linea dura di Trump contro l’Iran grazie al miglioramento dell’immagine internazionale della potenza sciita, anche nel confronto con la monarchia wahabita saudita (che non a caso di recente sta provando a dare al mondo un’immagine di sé più moderna e meno legata a una visione conservatrice e fanatica dell’Islam).
Un terzo vincitore ma parziale, della battaglia contro il Califfato sono i curdi-siriani del Ypg. Sono riusciti infatti a liberare i propri territori (il Rojava) dall’Isis e ad amministrarli autonomamente, liberandosi così anche dalla dittatura di Assad, con cui hanno poi avviato relazioni diplomatiche talvolta tese ma talvolta produttive. Hanno ricevuto armi e materiale dagli Stati Uniti, che in Siria hanno così assicurato una propria presenza (pare circa duemila uomini e alcune basi). Dovrebbero, ma il condizionale è d’obbligo, ottenere un qualche riconoscimento della propria forza e del proprio ruolo nella Siria del domani. Ma la loro vittoria contro lo Stato Islamico e i buoni rapporti con gli Usa (e in parte anche con la Russia) hanno scatenato una violenta reazione da parte della Turchia che, potendo offrire molto di più in termini di peso strategico sia alla Casa Bianca che al Cremlino, sta ottenendo pian piano di erodere il territorio curdo-siriano per occuparlo con le proprie forze. Dopo molte scaramucce minori, a gennaio 2018 Ankara ha attaccato in forze il cantone di Afrin, e non è al momento chiaro che sviluppi potranno esserci in futuro.
Gli sconfitti della battaglia contro il Califfato sono speculari ai vincitori. Nonostante il suo contributo determinante alla caduta dello Stato Islamico, Washington ha più perso che guadagnato da questa partita, a tutto vantaggio della Russia. L’Arabia Saudita ha perso lo scontro con l’Iran in Siria e si è indebolita a livello regionale. La Turchia ha logorato la sponda con l’Occidente, è stata costretta a rinunciare ad abbattere Assad e alle sue ambizioni di potenza regionale e si è dovuta sottomettere alla Russia, e ora vede il pericolo di un’entità autonoma curda al proprio confine meridionale crescere enormemente. Gli attori locali – il regime così come i ribelli – sono nei fatti entrambi sconfitti, in quanto praticamente del tutto privati di ogni autonomia decisionale.
Completa la lista degli sconfitti l’Europa, che alla battaglia contro lo Stato Islamico praticamente non ha partecipato. Pur essendo il bersaglio occidentale più colpito dal terrorismo dell’Isis, il suo contributo si è limitato al supporto della coalizione a guida Usa, ma quella che sarebbe potuta essere un’occasione storica per aggregare l’interesse strategico europeo contro un nemico “perfetto” e cercare di guadagnare influenza in uno scenario che – per la prevenzione del terrorismo, per la gestione dei fenomeni migratori e delle risorse naturali – è strategico per il vecchio continente, è andata in gran parte sprecata.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Sfruttando il disimpegno Usa e le molte e caotiche crisi regionali, Putin ha costruito una rete di alleanze e conquistato centralità in Medio Oriente.
Dal crollo dell’Unione Sovietica fino al 2014, la Russia ha subito un costante logoramento della sua sfera d’influenza. Durante questo periodo la Nato si è spinta sempre più in profondità in Est Europa e nella ex Jugoslavia. Alcuni Stati satellite si sono allontanati da Mosca e gli Usa hanno portato le proprie basi militari fin nel cuore dell’Asia centrale. Nel 2014, da ultimo, il Cremlino ha perso il controllo sull’Ucraina, pezzo molto importante sulla scacchiera. Ha reagito rabbiosamente con l’annessione della Crimea e la guerriglia separatista nel Donbass, anche a costo di subire salate sanzioni economiche internazionali. Il declino economico e geopolitico della Russia sembrava a quel punto un destino inevitabile. Ci troviamo invece, nemmeno quattro anni dopo la crisi ucraina, a commentare l’ascesa di Mosca sulla scena internazionale. Com’è potuto succedere?
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Nel Qatar si trova la più grande base militare Usa del Medio Oriente. Uno dei dettagli che il Presidente statunitense sembra aver dimenticato…
Il Medio Oriente negli ultimi anni ha visto frantumarsi intere aree, dove i confini degli Stati hanno perso significato e gli scontri si sono addensati su nuove linee di frattura: sciiti contro sunniti, iraniani contro sauditi, arabi contro curdi, curdi contro turchi, regimi contro popolazioni, organizzazioni terroristiche contro regimi e contro popolazioni, alleati dei russi contro alleati degli americani, e via dicendo. Il tutto secondo geometrie variabili in costante evoluzione. È successo in Iraq come in Siria, in Yemen come in Libia, in Nigeria come in Somalia. Là dove non c’è stata frantumazione si sono comunque create inquietanti crepe, possibili presagi di nuove e ulteriori crisi. L’ultima, e per gli interessi occidentali potenzialmente una delle più inquietanti, è quella che sta attraversando il fronte sunnita per via della “questione Qatar”.
L’Arabia Saudita, che del fronte sunnita è la capofila, ha inaugurato di recente una politica estera nettamente più aggressiva che nel passato. Hanno da un lato contribuito la sensazione di stare perdendo terreno nella regione, con l’Iraq finito nell’orbita sciita dopo la cacciata del dittatore sunnita, Saddam Hussein, da parte degli Usa, con l’insurrezione degli Houthi (sempre sciiti) in Yemen, la destabilizzazione del Bahrein – dove una monarchia satellite di Riad governa su una popolazione a maggioranza sciita –, il fallimento dell’insurrezione della maggioranza sunnita in Siria e, più in generale, con l’Iran in forte ascesa grazie all’accordo sul nucleare propiziato dalla presidenza Obama e grazie alla guerra all’Isis (che ha dato a Teheran un significativo spazio di manovra). Dall’altro sta pesando la successione al trono della dinastia Saud. Dopo la morte di Re Abd Allah, nel gennaio 2015, gli è succeduto Re Salman, che si è fatto espressione dei “falchi” della famiglia reale. Nell’estate 2017 Salman ha nominato come principe ereditario il proprio figlio, e già ministro della Difesa, Muhammad, fautore della guerra in Yemen e di un confronto più aspro contro Teheran.
In questo contesto delicato la visita di Donald Trump del maggio scorso si è rivelata un boomerang per gli interessi di Washington. Partito con l’idea di propiziare una qualche sorta di alleanza tra il fronte sunnita guidato dall’Arabia Saudita e Israele in funzione anti-iraniana, il presidente americano è invece riuscito a spaccare il primo, facendo un inaspettato regalo a Teheran. La pressione di Riad, galvanizzata dal sostegno americano, sui propri alleati sunniti per andare allo scontro con l’Iran ha fatto emergere in modo evidente i vari distinguo che fino ad allora erano rimasti più o meno velatamente nascosti. Il Qatar ha incarnato il ruolo dell’alleato dissidente e su di esso si è concentrata la dura ritorsione dei Saud.
Le motivazioni dello scarto di Doha sono molteplici. Dai rapporti economici che intrattiene con Teheran – in particolare il Qatar gestisce con l’Iran il giacimento di gas South Pars/North Dome nel Golfo Persico – all’insofferenza verso la leadership saudita, dall’atteggiamento verso Israele (più morbido quello di Riad, più vicino ad Hamas quello di Doha) alla visione del prossimo futuro della regione. Il Qatar sembra infatti essere la punta dell’Iceberg di una serie di Paesi del Golfo e dintorni che preferirebbero evitare lo scontro con Teheran e, anzi, approfittare del ritorno della Repubblica Islamica sulla scena internazionale per concludere affari e aumentare gli scambi economici. Si possono iscrivere a questa lista anche il Kuwait e sicuramente l’Oman. Forse proprio per questo la reazione saudita è stata tanto violenta.
Riad ha interrotto i rapporti diplomatici, varato sanzioni economiche, imposto la chiusura dei confini (l’unico confine terrestre del Qatar è con l’Arabia Saudita) e il blocco dei trasporti. Misure molto più drastiche di quelle assunte nel 2014, quando i Saud avevano costretto con una crisi diplomatica il Qatar a cacciare dal proprio territorio alcuni leader della Fratellanza Musulmana (poi riparati in Turchia). A separare i due Paesi c’è infatti anche il diverso approccio verso questa organizzazione politica panaraba. Per Riad si tratta di terroristi – sono nemici dichiarati della monarchia saudita – mentre il Qatar li ha spesso sostenuti, specie durante la stagione delle primavere arabe.
Ed è su questa ulteriore linea di frattura che Riad è riuscita a tirare dalla propria parte, nello scontro col Qatar, anche l’Egitto, altro Paese che dopo il golpe militare del generale Al Sisi considera i Fratelli Musulmani dei terroristi e mal sopporta l’attivismo di Doha nel sostenerli. Completano la lista gli Emirati Arabi e il Bahrein, piccoli ma ricchi alleati di Riad. L’aver creato una crepa nel fronte sunnita sulla duplice questione dei rapporti con l’Iran e dell’atteggiamento verso la Fratellanza Musulmana ha però portato la crisi a un’ulteriore conseguenza: l’ingresso in scena della Turchia come forte alleato del Qatar. Ankara da anni condivide con Doha infatti il sostegno alla Fratellanza, specie nelle primavere arabe, e spesso hanno sostenuto le stesse fazioni nelle varie crisi mediorientali in corso, come in Egitto, in Libia o in Siria. Inoltre in tempi recenti – diciamo da quando la partita contro Assad è sembrata definitivamente persa per Erdogan, e ancor di più dopo il fallito golpe del luglio scorso – la Turchia si è avvicinata alla Russia di Putin e all’Iran, nel tentativo di impedire la nascita di un’entità autonoma curda in Siria e non solo. In questa crisi era dunque l’interlocutore ideale per il Qatar, ma la durezza dell’intervento turco è stata inaspettata. Ankara ha infatti garantito la propria protezione militare a Doha in caso di attacco. Quello turco è il secondo esercito della Nato. La Turchia ha già inviato propri soldati nelle basi del Paese.
Così il piccolo ma ricchissimo Stato del Golfo, sulle cui capacità di resistenza alle pressioni saudite c’erano in principio forti dubbi, si è trovato nella posizione di poter respingere le richieste di Riad per interrompere le sanzioni (spaziavano dalla chiusura della Tv Al Jazeera all’interruzione dei rapporti con l’Iran, dalla fine della presenza militare turca sul suo terreno al risarcimento dei danni causati agli altri Paesi arabi dalla sua politica estera, etc.). L’Iran in questo scenario ha avuto buon gioco a sfruttare questa crepa nel campo avversario e sta già provando ad attirare il Qatar ancor di più nella propria orbita, ad esempio impegnandosi a garantire i rifornimenti di viveri che non possono più transitare dal confine terrestre con l’Arabia Saudita.
Per la politica estera americana si tratta di una débâcle. Il Qatar ospita la più grande delle basi americane in Medio Oriente, con oltre 11 mila militari. Non averne considerato le specificità quando si è ipotizzato di poter saldare Israele e Arabia Saudita, in vista del ritorno a una politica estera aggressiva nei confronti di Teheran, è stato un errore grave. Ora Doha viene inevitabilmente attratta da Turchia e Iran, con la Russia sullo sfondo: tre Paesi che dialogano costantemente sulla Siria e sul futuro della regione in generale, e che hanno un’agenda contrapposta a quella americana. Il peso geopolitico di Mosca e Teheran è già cresciuto negli ultimi anni, e potrà solo aumentare nella crisi del fronte sunnita. Un pezzo, quello turco, si è già di fatto allontanato da tempo dall’Occidente, scottato dai legami tra Usa e curdi siriani e dalle critiche della Ue per la svolta autocratica di Erdogan. Un altro, quello qatariota, potrebbe ora seguire. Non si tratta di svolte strategiche di lungo periodo probabilmente, e niente che un nuovo corso della politica estera occidentale non possa invertire, ma al momento è difficile azzardare qualsiasi previsione. Di sicuro nella fretta di andare allo scontro con l’Iran, Donald Trump non ha saputo vedere le crepe in quello che era il suo schieramento. Che ora rischia di sfaldarsi ed essere sbocconcellato proprio da quella Teheran (con sponda del Cremlino) che si voleva tornare a contenere dopo i precedenti anni di apertura.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

La complicata congiuntura internazionale può costringere Erdoğan a posizioni che rischiano di scardinare il tanto sospirato consenso interno, al di là del referendum.
La vittoria del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, al referendum costituzionale dello scorso 16 aprile rischia di essere una vittoria di Pirro. Il suo schieramento, favorevole alla riforma, ha prevalso ma il consenso che finora aveva circondato Erdogan, cresciuto ulteriormente dopo il fallito golpe del luglio 2016, si è pericolosamente assottigliato. Il “sì” alle modifiche costituzionali ha avuto appena il 51,41% e i “no” hanno prevalso nelle maggiori città turche. Più un segnale di debolezza che di forza per il presidente. Nelle prossime battaglie, e molte se ne vedono all’orizzonte, eventuali difficoltà potrebbero dunque essere molto insidiose per il destino di Erdogan.
I contenuti della riforma, lungi dal trasformare il presidente in un Sultano, sono meno drammatici di quanto non abbia spesso raccontato la stampa occidentale. Il Parlamento mantiene un forte potere su veto presidenziale, impeachment, dichiarazione dello stato di emergenza e ordini esecutivi. Il presidente della Repubblica turca sulla carta avrà indubbiamente più potere di prima, ma non più di quanto non abbiano i suoi omologhi francese o americano. Ma ciò che ha reso possibile la svolta autocratica impressa da Erdogan e dal suo partito (Akp) alla Turchia negli ultimi anni non è stato, e non sarà con questa riforma, un qualche intervento costituzionale o istituzionale. È stato il consenso plebiscitario − ottenuto grazie ai primi 10 anni di buon governo, durante i quali Erdogan ha operato la più grande redistribuzione del reddito della storia del Paese, favorendo la nascita e lo sviluppo delle PMI anatoliche − che a lungo ha circondato il presidente. Grazie a tale consenso, a un partito fortemente clientelare, al controllo sul Parlamento che si è poi esteso alla magistratura, alla polizia, all’esercito e ad ampie parti della società civile, Erdogan ha potuto comprimere la libertà di espressione e manifestazione, i diritti delle minoranze e in generale molti dei presidi di una democrazia liberale moderna, senza bisogno di cambiare le norme fondamentali. Di qui il timore che ora, con un consenso calato anche a causa del referendum che pure ha vinto, il presidente turco vada alle prossime fondamentali battaglie in una condizione di maggiore fragilità.
Tali battaglie hanno come proprio campo principale la politica estera, in particolare lo scenario siriano. Erdogan ha a lungo incarnato la figura di paladino delle Primavere arabe e delle ribellioni contro i dittatori mediorientali. In Siria, ha impegnato per anni la Turchia, economicamente, umanitariamente e anche militarmente, per aiutare i ribelli e abbattere Assad. L’opinione pubblica islamista turca lo ha sempre amato e sostenuto per questo. Da pochi mesi ha tuttavia dovuto cambiare approccio, da che l’indisponibilità degli Stati Uniti a rinunciare (per ora) all’alleanza con i curdi siriani dello Ypg – usati come fanteria della coalizione internazionale contro l’Isis – e, più in generale, lo scarso coinvolgimento di Washington nella partita siriana hanno spinto Ankara verso Mosca. Quest’avvicinamento al Cremlino, con cui appena due anni fa i rapporti erano molto tesi dopo l’abbattimento di un caccia-bombardiere russo da parte della Turchia, è stato tanto altalenante quanto gravido di conseguenze. Altalenante, già che, dopo lo strike americano in Siria ordinato da Trump come reazione all’utilizzo di armi chimiche da parte di Damasco, Ankara è subito tornata a chiedere la deposizione di Assad e un intervento militare americano con supporto turco in Siria. Gravido di conseguenze, dato che Putin – perdonate le intemperanze di Erdogan dopo lo strike Usa, in un momento che era comunque a ridosso del voto referendario turco – ha di recente incassato l’appoggio della Turchia all’accordo sulle quattro “aree di de-escalation” in Siria. Una mossa che nei piani di Mosca dovrebbe consentire di isolare Isis e qaedisti siriani dal resto della ribellione, di conseguenza indebolita, e di rafforzare la posizione del regime.
Avvicinandosi a Mosca, alleata di ferro di Assad, Erdogan rischia così di perdere consensi nell’opinione pubblica islamista che è il nocciolo duro del suo elettorato e che per anni è stata nutrita con sogni di grandeur per la svolta “neo-ottomana” nella politica estera turca. Non facendolo, con gli Usa che hanno una linea scostante e debole in Siria, tranne che nell’appoggio allo Ypg per conquistare Raqqa e i territori dello Stato Islamico, il presidente turco rischierebbe di restare senza sponde nella partita siriana e di non poter quindi impedire il peggior incubo strategico per Ankara: la nascita di un’entità autonoma curda, vicina ideologicamente al Pkk considerato dalla Turchia un’organizzazione terroristica, al proprio confine meridionale. Più questo rischio si fa concreto, più Erdogan perde l’appoggio dei nazionalisti turchi – il cui consenso era stato conquistato nel 2015 proprio grazie a una escalation contro il Pkk, con cui fino ad allora si era invece voluto trattare –, già allontanatisi nel voto del 16 aprile, e di pezzi di apparato militare e di intelligence che vedono nell’indipendentismo curdo la minaccia più pericolosa per il futuro del Paese.
Stritolata tra gli interessi, non allineati ai propri, delle due grandi potenze, la Turchia di Erdogan si trova in una posizione estremamente complicata. Dopo la vittoria del referendum costituzionale sembra che il presidente turco abbia voluto saggiare il terreno, bombardando una serie di postazioni curdo-siriane a fine aprile. La reazione russa e americana è stata tuttavia negativa per Ankara. Sia Mosca, nel cantone occidentale di Afrin, che Washington, nei cantoni orientali di Kobane e Cizre, hanno schierato le proprie truppe in difesa di quelle curde. Il Cremlino non vuol rischiare che i ribelli sostenuti a nord di Aleppo dalla Turchia, alleati di altri ribelli contro cui Assad combatte quotidianamente, possano espandersi al di fuori della sacca che Putin ha concesso a Erdogan con l’operazione “Scudo dell’Eufrate”. Un cuneo che dal confine turco va fino alla cittadina di Al Bab, il cui scopo principale è proprio impedire la contiguità territoriale dei cantoni curdi (un “contentino” dato alla Turchia a fine 2016, che ha in cambio sacrificato il proprio pieno sostegno alla ribellione, facilitando così la caduta di Aleppo di dicembre scorso). La Casa Bianca specularmente non vuole che le pur legittime preoccupazioni turche ostacolino l’unico obiettivo di politica estera in Siria ufficialmente proclamato da Trump: la sconfitta dello Stato Islamico.
In vista dell’assalto finale alla capitale siriana del Califfato, Raqqa, gli Usa hanno anche iniziato a inviare materiale bellico sofisticato alle Syrian Democratic Forces (SDF), la coalizione a guida curda che opera contro l’Isis. La Turchia ha protestato ma ancora nel recente incontro negli Usa tra Trump ed Erdogan non sono esplose le divergenze tra alleati. Il presidente turco sembra non volersi alienare le simpatie del nuovo presidente americano, unico leader occidentale a essersi congratulato con lui subito dopo la vittoria al referendum e che sulla Siria potrebbe sempre cambiare idea (le ultime affermazioni della Casa Bianca sui “forni crematori” di Assad potrebbero fare da preludio a un nuovo cambio di direzione, dopo la riappacificazione de facto con Mosca nelle settimane successive allo strike Usa in Siria).
Tuttavia, a meno di altre giravolte di Trump, Erdogan sembra condannato a fronteggiare un futuro in cui la ribellione siriana verrà lentamente soffocata dalle manovre del Cremlino, che vedono oltretutto la Turchia come parte attiva. E dovrà probabilmente anche accettare la liberazione di Raqqa a opera delle SDF, con la conseguente legittimazione per i curdi siriani al futuro tavolo delle trattative. Impedire che in questa morsa di politica estera si corroda il suo consenso interno, tra islamisti che non digerirebbero un “tradimento” della ribellione anti-Assad e nazionalisti che lo giudicherebbero debole nel lasciar ingrandire la minaccia curda al confine sud, sarà la sfida di Erdogan nei prossimi anni. Perché senza consenso, anche con la nuova costituzione, la sua parabola non potrà che iniziare a scendere.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Dalle ceneri di Al-Qaeda e Isis rinascerà una nuova macchina del terrore. E la tattica rimarrà la stessa: stragi e attentati anche sul suolo occidentale.
Il terrorismo jihadista è entrato negli incubi dell’Occidente 15 anni fa, quando Al Qaeda sbalordì il mondo distruggendo le Torri Gemelle e attaccando il Pentagono. Fino a quel momento il fanatismo islamico – la cui stessa definizione aprirebbe un discorso complesso – aveva insanguinato altri Paesi, talvolta colpendo obiettivi occidentali, come negli attentati alle ambasciate Usa in Kenya e Tanzania nel 1998, ma spesso inserendosi nel contesto di faide locali vecchie di decenni o più. Attacchi islamisti in territorio occidentale, salvo casi sporadici come quello di New York del 1993, non ce n’erano ancora quasi stati.
Per continuare a leggere, acquista il pdf del numero.
Per abbonarti, visita la nostra pagina abbonamenti.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Proprio ora che le porte di un potere quasi assoluto in patria gli si stanno per schiudere, il presidente turco Recep Tayyp Erdogan sente franare il terreno sotto i suoi piedi e – quel che è peggio – sotto quelli del Paese. Le recenti modifiche costituzionali che tolgono l’immunità ai parlamentari gli consentono – tramite una magistratura già portata sotto il controllo dell’esecutivo due anni fa – di controllare il potere legislativo.
Potenzialmente, alterando la composizione del Parlamento tramite l’arresto di alcuni deputati curdi incriminati per “terrorismo” grazie a una legge controversa, potrebbe addirittura far modificare al suo partito (Akp) la costituzione in senso iper-presidenziale senza dover affrontare un referendum popolare. Ma il quadro internazionale è dei peggiori per gli interessi turchi e, in particolare nelle ultime settimane, è diventato drammatico.
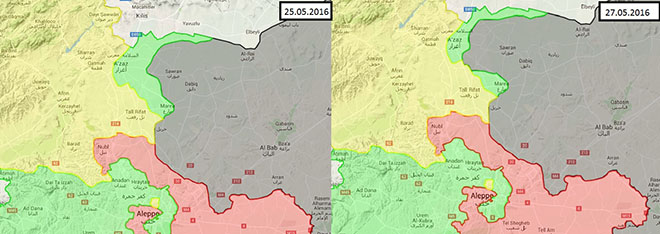
I ribelli siriani armati e sostenuti da Ankara che occupavano l’area a nord di Aleppo, tra Azaz e Mare (v. cartina 1), avevano il compito di scacciare l’Isis dalla regione, impedendo che tale onere e onore ricadesse sui curdi siriani del Ypg, unitisi ad altri ribelli (arabi, assiri, yazidi etc, pur restando i curdi la maggioranza) nelle Syrian Democratic Forces (Sdf). A fine maggio tuttavia un’improvvisa offensiva dello Stato Islamico li coglie impreparati, li spazza via da quasi tutti i villaggi che avevano conquistato nelle settimane precedenti e riesce anche a isolare Mare da Azaz, ponendo la prima sotto assedio (v. cartina 1). A questo punto sono i curdi stessi – con cui i ribelli filo-turchi si sparavano fino a poco tempo prima – ad aiutare i ribelli perché tengano almeno le posizioni nelle due città (in cambio, pare, di una tregua nella città di Aleppo, dove il quartiere curdo è spesso attaccato dagli altri ribelli). La conseguenza più importante tuttavia non avviene in Siria ma oltreoceano, negli Stati Uniti. A Washington matura la convinzione che la Turchia coi suoi ribelli non riuscirà mai a sradicare lo Stato Islamico da quell’area, tanto strategica in quanto unica via di rifornimento rimasta per l’Isis, e si decide di puntare sulla carta migliore – tenuta in disparte fino a quel momento per riguardo verso le preoccupazioni di un alleato Nato, quello turco, che ritiene i curdi siriani terroristi legati al Pkk curdo-turco -, cioè l’Ypg e in generale le Sdf, che vengono incaricati di attaccare l’Isis da est verso ovest, puntando sulla città di Manbij. E qui Erdogan è costretto a masticare amaro.
Fino a quel momento infatti il presidente turco aveva tracciato una “linea rossa”, che seguiva il corso del fiume Eufrate, che i curdi siriani non avrebbero mai dovuto attraversare pena la violenta reazione militare di Ankara (sporadici superamenti erano subito stati seguiti dal tiro di artiglieria turca sulle postazioni del Ypg). Ora gli Stati Uniti gli impongono di rimangiarsi le sue stesse parole, offrendo solo uno “strapuntino” per coprire l’inversione di 180 gradi: “gli Stati Uniti ci hanno detto che l’Ypg avrà in pratica solo un ruolo logistico a Manbij e che la vera forza combattente sarà composta da arabi”, ha dichiarato Erdogan in seguito a una telefonata con Obama a inizio giugno. A gettare altra benzina sul fuoco arrivano poi negli stessi giorni le foto che ritraggono membri delle forze speciali americane con i gagliardetti del Ypg (v. immagine 1), cosa che scatena una reazione molto dura nell’opinione pubblica turca, specie in quella islamista e anti-americana che costituisce una larga parte del bacino di consenso in cui pesca Erdogan.
«Da oggi in poi, indipendentemente da chi sarà al governo in Turchia, i Turchi metteranno in discussione il loro posto nella Nato e la legittimità della presenza americana nelle basi dell’Alleanza», sostiene Murat Ozer, presidente di un’associazione islamica che aiuta i profughi (Imkander). «Queste foto sono un punto di svolta nel segnalare come la Nato sia diventata inutile. La Turchia ha perso 50 mila uomini nella guerra contro il Pkk, e nessun partito politico potrà ora accettare la cooperazione con gli Stati Uniti dopo tutto questo». Rincara la dose Hilmi Demir, professore universitario turco esperto di movimenti salafiti, secondo cui «queste foto dimostrano come gli Usa abbiano scelto l’Ypg come maggior alleato nella guerra all’Isis. Questa scelta potrebbe spingere giovani turchi nazionalisti, così come gruppi di giovani pii musulmani, a guardare lo Stato Islamico con maggior favore».

Mentre infuria la polemica in Turchia le Sdf avanzano su Manbij. L’area circostante la città cade rapidamente (v. cartina 2) e anche il centro urbano sembra destinato a una rapida resa. Le forze a guida curda si confermano ancora una volta il miglior esercito di terra nella lotta contro lo Stato Islamico, anche grazie al coordinamento coi bombardamenti americani. L’Isis, in difficoltà a causa dell’attacco curdo (e in contemporanea anche di quello lealista più a sud, nell’area di Tabqa)(v. cartina 3), ritira molti suoi uomini anche dal fronte dove si stava scontrando coi ribelli filo-turchi, che passano al contrattacco, rompono l’assedio a Mare e conquistano molti villaggi (v. cartina 2). Pare che – mentre l’Isis si riorganizza a Dabiq – tutte le sigle maggiori di questi ribelli siano confluite sotto l’ombrello della Brigata al-Moutasem, un gruppo sostenuto da turchi e americani (e che ora gira voce risponda più a Washington che ad Ankara), e che si inizi a ragionare in termini di un possibile coordinamento con le Sdf, invece che di un perenne scontro.
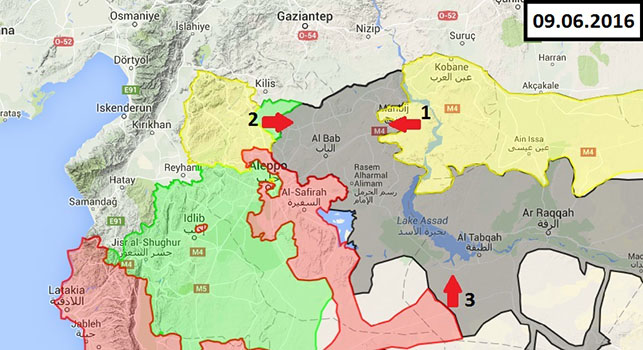
A questo punto Erdogan, che dopo aver perso credibilità sulla questione della “linea rossa” rischia di perdere anche il controllo sulle decisioni di almeno parte dei ribelli che finora ha protetto e sfruttato per portare avanti la sua politica di interferenza in Siria, è costretto a ingoiare un altro boccone indigesto: la possibile partecipazione del Pyd (il partito socialista di cui l’Ypg è il braccio armato, che secondo Ankara è legato a doppio filo al Pkk) ai prossimi colloqui di pace a Ginevra. La notizia, data da fonti curde, è ancora da confermare ma a questo punto le condizioni perché gli Usa si schierino a favore dell’inclusione ci sono tutte.
In un momento in cui gli attentati dei curdi si susseguono contro obiettivi militari turchi (polizia o esercito soprattutto), il presidente turco si trova costretto in un angolo dalla sua passata retorica, che equipara il Pkk e i curdi siriani del Pyd, e dalle scelte azzardate di politica internazionale. Non può abbandonare la Nato e gli Stati Uniti ma di fronte all’evidente collaborazione tra Washington e l’Ypg è costretto a mantenere e inasprire una retorica nazionalista e anti-imperialista per non perdere consensi. Se volesse – cosa che secondo diversi analisti gli converrebbe – interrompere le ostilità col Pkk e cambiare strategia in Siria, anche nei confronti del Ypg, rischierebbe di perdere la faccia (e forse le prossime elezioni). E tuttavia tanto più tempo aspetta tanto più gli interessi strategici turchi si deteriorano, con gli Usa sempre meno concilianti (e più filo-curdi) per via della guerra all’Isis, la Ue sempre più lontana a causa delle svolte autocratiche di Erdogan (tanto, pare, da considerare la possibilità di mettere a rischio l’accordo sui profughi siglato con Ankara, pur di non cedere a ricatti giudicati intollerabili per far chiudere a Bruxelles gli occhi sulle violazioni dei diritti democratici e civili), la Russia sempre più minacciosa e con il rischio che un’entità autonoma siriana nasca al confine meridionale della Turchia proprio in un periodo di violento scontro col Pkk. Le Sdf, infatti, presa Manbij sono a poco più di 50 km dal cantone curdo occidentale di Afrin. Una volta raggiunto, il Rojava (il kurdistan siriano) sarebbe unificato.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Doveva essere la settimana dell’offensiva curdo-americana su Raqqa, capitale dello Stato Islamico in Siria, e invece in poche ore lo scenario si è ribaltato, dimostrando ancora una volta che l’Isis ha sicuramente delle menti che ben conoscono tattiche e strategie militari (spesso ex ufficiali dell’intelligence e dei corpi scelti di Saddam Hussein, ora alleati dei jihadisti) e probabilmente più di un “santo” in paradiso.
I preparativi per conquistare Raqqa andavano avanti da settimane, le Sdf (Syrian Democrati Forces, una coalizione dominata dai curdi del Ypg ma che comprende anche arabi, assiri, yazidi etc.) ammassavano mezzi e truppe nelle proprie postazioni di confine, il 20 maggio gli aerei della coalizione anti-Isis a guida Usa avevano lanciato volantini (v. immagine) che invitavano la popolazione civile ad abbandonare la città in vista dell’imminente attacco e, finalmente, il 24 maggio le operazioni erano cominciate. Gli aerei americani – partendo dalla base turca di Incirlik (cosa che secondo alcuni analisti avrebbe dimostrato il beneplacito di Erdogan all’operazione) – bombardano alcuni obiettivi dell’Isis e i guerriglieri delle Sdf iniziano ad attaccare da nord i villaggi intorno a Raqqa. I primi risultati si vedono, gli uomini del Califfo sono costretti a ripiegare da diverse posizioni e la linea del fronte si avvicina progressivamente alla città (v. cartina 1).

Al terzo giorno di attacchi curdo-americani contro lo Stato Islamico nel quadrante di Raqqa, il 26 maggio, arriva la notizia: lo Stato Islamico ha sferrato un violentissimo attacco contro i ribelli sostenuti dalla Turchia a nord di Aleppo (dove controllano principalmente le città di Azaz e Mare), quegli stessi ribelli che – secondo i piani di Ankara – avrebbero dovuto liberare il confine turco dalla presenza dell’Isis impedendo che l’onere e gli onori di una tale impresa ricadessero sui curdi del Ypg, considerati da Erdogan alla stregua di terroristi per i loro legami col Pkk (con cui Ankara è attualmente impegnata in una violenta guerriglia nel sud-est dell’Anatolia). Diversi villaggi cadono rapidamente – pare che gli uomini dello Stato Islamico si fossero infiltrati con ampio anticipo e abbiano agito da cellule dormienti fino all’ultimo -, la città di Mare viene isolata dal resto del territorio controllato dai ribelli e posta sotto assedio, Azaz viene attaccata violentemente con diversi camion bomba e kamikaze ma regge alla prima ondata di attacchi (v. cartina 2).

Il 27 maggio la situazione è drammatica. Decine di migliaia di profughi siriani, già fuggiti ai tagliagole dell’Isis o alle bombe di Assad una volta, si trovano vicini alla linea del fuoco, scappano verso la Turchia ma per ora gli viene impedito di oltrepassare il confine. Gli anziani di Mare chiedono alle Sdf di intervenire per aiutarli contro l’attacco sferrato dallo Stato Islamico – evento abbastanza straordinario, considerato che i ribelli filo-turchi e i curdi siriani si sono sparati addosso fino a poco tempo fa, mirando entrambi a conquistare gli stessi territori – e vengono in parte accontentati: il 28 maggio la cittadina di Sheik Isa, subito a ovest di Mare, viene ceduta dai ribelli alle Sdf senza sparare un colpo (v. cartina 3), e ora pare che le Sdf si stiano preparando o per attaccare Mare quando questa dovesse cadere nelle mani dello Stato Islamico, o addirittura intervenire preventivamente al fianco dei ribelli. Ad Azaz la situazione migliora leggermente per i ribelli filo-turchi, che hanno resistito agli attacchi portati dall’Isis su tre diverse direttrici e riescono nel loro contrattacco a riconquistare alcuni villaggi (cosa strana, sia durante l’offensiva dell’Isis che durante la loro controffensiva il supporto da parte dell’artiglieria e dell’aviazione turche al di là del confine è stato minimale). Ma l’Isis ha raggiunto il suo scopo: le Sdf interrompono la loro offensiva verso Raqqa e iniziano a inviare i propri mezzi e i propri reparti verso Manbij, la testa di ponte orientale dei curdi nel territorio al confine con la Turchia controllato dall’Isis (v. cartina 3).
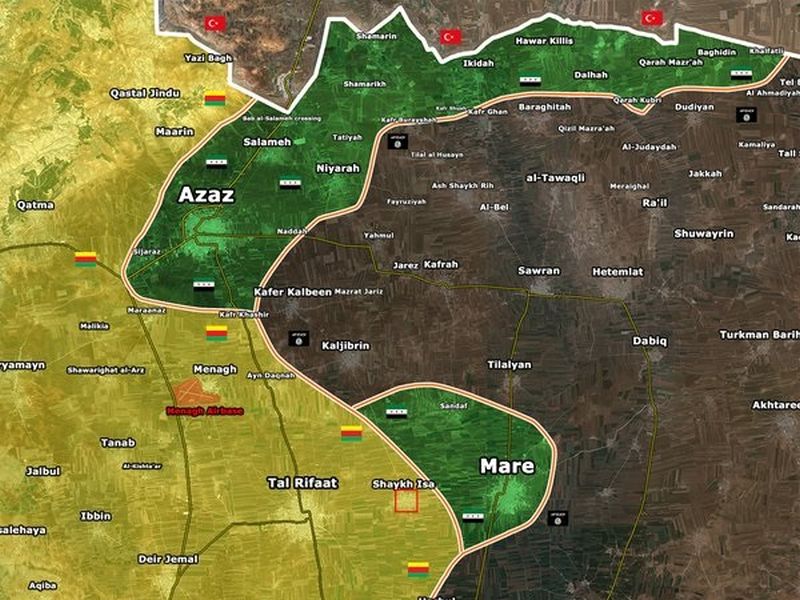
Gli uomini dello Stato Islamico al momento stanno continuando a tenere sotto pressione Azaz e Mare, hanno rallentato – se non interrotto – l’offensiva curdo-americana su Raqqa (che aveva il pregio di procedere in contemporanea o quasi a quella in Iraq contro Falluja, costringendo il nemico a difendere due dei suoi centri principali nello stesso momento) e hanno portato scompiglio in un’area, quella a nord di Aleppo, che è madre di gravi tensioni tra i suoi nemici (Turchia da un lato e Curdi e Usa dall’altro). Alcuni analisti si interrogano ora se la decisione dei curdi di interrompere l’offensiva su Raqqa sia una mossa concordata con Washington o meno. Se non lo fosse, si dovrebbe spiegare con il desiderio dei curdi siriani di unire i propri cantoni orientali con quello occidentale di Efrin, unico rimasto isolato: la caduta dei ribelli filo-turchi aprirebbe infatti l’opportunità (teorica) per le Sdf di subentrargli nella lotta contro l’Isis e di prendere il controllo dei territori di confine con la Turchia (in particolare la “zona proibita” da Erdogan, tra Manbij e il valico di Jarablus) che ne venissero liberati. L’unità del Rojava (il Kurdistan siriano) è da sempre l’obiettivo principale per i curdi siriani, ben più che non la presa di Raqqa, città estranea all’area storicamente da loro controllata e abitata. Dunque l’Isis li avrebbe attirati come le api col miele, lasciando gli Usa senza fanteria per l’attacco contro la capitale dello Stato Islamico in Siria.
Nell’ipotesi invece in cui l’interruzione dell’offensiva su Raqqa fosse una mossa concordata tra Usa e Sdf (i legami tra questi due attori sono andati intensificandosi notevolmente nelle ultime settimane) allo scopo di portare lo scontro con l’Isis nell’area a nord di Aleppo, il quadro tattico e strategico dell’area potrebbe diventare esplosivo. Se infatti Erdogan ha, sotto pressione degli Usa, dato il suo beneplacito alla conquista di Raqqa da parte di una coalizione dominata dal Ypg– teoria questa fondata ma comunque non certa – ha già ribadito di non voler tollerare la riunificazione dei cantoni curdi in Siria. E se gli Usa, di fronte all’innegabile fallimento dei ribelli finanziati da Ankara – che avrebbero dovuto ripulire dall’Isis il confine turco, e invece non sembrano in grado nemmeno di difendere le loro poche roccaforti – e al sospetto che da Jarablus continuino ad arrivare rifornimenti allo Stato Islamico, decidessero di forzare la mano e di dare sostegno alle Sdf a nord di Aleppo si rischierebbe un gravissimo scontro con Ankara. Erdogan ha infatti dichiarato nelle ultime ore che “Isis e Ypg si sostengono a vicenda e sconfiggere uno di loro significa sconfiggere l’altro, ma i nostri alleati si rifiutano di vederlo. Quelli che supportano l’Ypg per combattere l’Isis vogliono in realtà tagliare la Turchia fuori dal Medio Oriente”. Parole pesantissime che rispecchiano la situazione di isolamento, paranoia e debolezza in cui la linea di politica estera di Erdogan ha trascinato il suo Paese. Ora per contrastare eventuali operazioni dei curdi nella “zona proibita” al confine, ad Ankara resterebbe un solo alleato possibile: l’Isis. E una nuova puntata nel romanzo delle relazioni proibite tra la Turchia e lo Stato Islamico potrebbe essere stavolta troppo indigesta per gli alleati occidentali di Ankara per farla passare senza pesanti ritorsioni.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

La deriva autoritaria del presidente della Repubblica turco RecepTayyp Erdogan è sempre più evidente. Pur ricoprendo un ruolo privo (formalmente) di un reale potere, riesce a controllare l’esecutivo (ha da poco costretto alle dimissioni il premier Davutoglu, rimpiazzato con un altro fedelissimo – Binali Yildirim – personaggio dal profilo abbastanza dimesso da non mettere in ombra Erdogan), a condizionare il potere giudiziario (epurato e portato sotto l’autorità del Guardasigilli nel 2014) e ora sta facendo scempio di quello legislativo.
L’abolizione dell’immunità per i parlamentari sottoposti a indagine, votata dal Parlamento di Ankara pochi giorni fa, è l’ennesimo passo verso il sistema quasi-dittatoriale agognato da Erdogan (sostenuto in questo da ampi strati della popolazione turca).
L’immunità infatti ha fino ad oggi impedito l’arresto di decine di deputati dell’opposizione, in particolare del partito di sinistra filo-curdo Hdp, accusati di “terrorismo” in base a una controversa legge che ha già portato in carcere decine di intellettuali, giornalisti e attivisti. L’Unione europea pretende che tale legge venga ammorbidita come condizione per liberalizzare i visti per i cittadini turchi, ma Erdogan rifiuta categoricamente qualsiasi cambiamento. Se verranno arrestati anche solo una decina del centinaio abbondante di deputati indagati, il partito di Erdogan (la formazione islamista Akp) avrà i numeri per modificare la Costituzione a proprio piacimento senza dover sottoporre il risultato a referendum popolare. A quel punto il sogno iper-presidenzialista del “Sultano” turco sarà praticamente cosa fatta.
Questa tendenza accentratrice ha come corollario, a livello politico, un populismo accentuato, che si fonda su retorica anti-occidentale, sindrome d’assedio – nemici all’esterno e all’interno del Paese – e su sogni di grandeurneo-ottomana sempre più marcati (fenomeni, questi, che la guerra in Siria ha notevolmente accentuato).«L’approccio minaccioso di Erdogan nei confronti dell’Occidente è quel che più lo fa apprezzare dalle masse islamiche conservatrici in Turchia», spiega Semih Idiz, giornalista turco esperto di politica estera. «E, da quello che sostiene nei suoi discorsi e nelle sue dichiarazioni, ciò che desidera in definitiva è un modo islamico unito con una leadership in grado di confrontarsi con l’Occidente da una posizione di forza». Questa narrazione aggressiva e complottista lo rende popolare come uomo forte, e gli fornisce la giustificazione per portare a compimento le trasformazioni costituzionali che desidera.
Le conseguenze, in termini di relazioni con l’Occidente non sono all’altezza delle parole del presidente turco, ma sono comunque ritenute preoccupanti dagli osservatori internazionali. Il rischio di una rottura diplomatica grave con gli Stati Uniti – con cui il dissenso è ai massimi livelli, per il supporto che Washington fornisce ai curdi siriani, considerati da Ankara terroristi legati al Pkk contro cui è in guerra – è considerato dagli analisti quasi inesistente. I due Pasi sono alleati e membri della Nato, e nel lungo periodo per la Casa Bianca la Turchia è troppo importante in ottica di contenimento della Russia. Più complicato il rapporto con l’Unione europea.
Da decenni Ankara preme per entrare nella Ue e anche Erdogan ha a lungo spinto per questo risultato. Negli ultimi anni la “svolta neo-ottomana” della Turchia, propiziata dalle Primavere arabe, l’ha portata a concentrarsi più sulle relazioni con gli Stati arabi – ex provincie dell’Impero Ottomano – e a guardare verso est che non verso ovest. Tuttavia la ricerca di un rapporto privilegiato con l’Unione europea, e domani di un’adesione, non è mai stata accantonata. Lo dimostra la contropartita chiesta da Ankara a Bruxelles per concludere l’accordo sui profughi siriani: la ripresa del negoziato per l’adesione e la liberalizzazione dei visti per i cittadini turchi (oltre a 6 miliardi di euro).
Come si diceva, l’Unione europea ha però posto delle condizioni (settantadue) che garantiscano il rispetto dei diritti umani e delle libertà civili, tra cui la modifica della legge anti-terrorismo che Erdogan sta usando per stroncare proteste e opposizioni nel Paese. Il rifiuto di modificare tale legge, cui si aggiunge ora il tema dell’abolizione dell’immunità parlamentare, rischia di impattare in modo drammatico sui rapporti tra Turchia e Ue. In un incontro bilaterale molto teso la cancelliera tedesca Angela ha duramente attaccato le politiche del presidente turco, dichiarando di essere “preoccupata per la democrazia in Turchia” e che una democrazia ha bisogno di “un sistema giudiziario indipendente, una stampa indipendente e un Parlamento forte“. Durissima la risposta di Erdogan, che minaccia di stracciare l’accordo sui migranti (voluto fortemente in primo luogo dalla stessa Merkel), sostiene che se la Ue vuole andare per la sua strada Ankara farà lo stesso, e accusa gli europei di essere insensibili di fronte al dramma dei migranti e di avere un doppio standard per gli attentati jihadisti in Europa e per quelli del Pkk in Turchia.
La situazione rischia di arrivare a un punto di rottura, con entrambi i protagonisti dell’accordo sui profughi che hanno ragioni valide per volerne i risultati ma forse ancor più valide per non volerne pagare il prezzo. L’Unione europea invita gli Stati membri a non fare un dramma dell’accoglienza di migranti in fuga dalla guerra, anche per svincolarsi dal ricatto di Erdogan. “Un continente di 508 milioni di abitanti, dovrebbe essere in grado di integrare 2 milioni di rifugiati”, ha dichiarato il presidente della Commissione europea, Claude Junker. Ma qui sta il problema: “dovrebbe”, ma per ora non lo è. Le opinioni pubbliche europee sono spaventate dal flusso di profughi, collegano (impropriamente) il fenomeno al terrorismo e vengono tentate da soluzioni xenofobe, nazionaliste e anti-europee. I leader politici dei vari Paesi (almeno dove i populisti non sono già al potere), nel tentativo di sbarrare la strada ai partiti di estrema destra, sembrano disposti a gravi compromessi al ribasso e ad aumentare a loro volta la retorica anti-europea. Se, a fronte della deriva autoritaria di Erdogan, il più evidente di questi compromessi – l’accordo sui profughi – dovesse venir meno e il flusso migratorio dovesse riprendere più impetuoso che mai, l’Europa sarebbe chiamata a uno sforzo importante per dimostrare infondato il ricatto del presidente turco. E questo è un azzardo che nelle cancellerie di mezza Unione europea si preferirebbe non prendere.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Se dalla conferenza di Vienna sulla Libia del 16 e 17 maggio, convocata per iniziativa di Italia e Usa, ci si aspettava un chiarimento su quello che sarà il futuro del Paese, le aspettative sono state frustrate. I passi in avanti che pure ci sono stati negli ultimi giorni – soprattutto l’allentamento dell’embargo sulle armi per consentire la creazione di una Guardia Presidenziale che difenda il nascente governo libico del premier incaricato Serraj – non sono ancora sufficienti a far intravedere un approdo al percorso negoziale che faticosamente procede da circa due anni sotto l’egida dell’Onu.
L’ostacolo principale è noto: Khalifa Haftar, ex generale di Gheddafi poi fuggito in esilio per venti anni negli Usa, tornato durante la rivoluzione del 2011 e da allora uomo forte della Cirenaica, in prima linea nella guerra all’Isis e ai gruppi jihadisti, protettore ma anche padrone del parlamento di Tobruk (quello riconosciuto internazionalmente), sostenuto dall’Egitto, dagli Emirati Arabi, dalla Francia e forse non solo. Essendo un elemento divisivo e praticamente inaccettabile per molte milizie della Tripolitania era stato escluso dal nascente governo unitario di Serraj, ma nelle ultime settimane – visto il sostegno internazionale, palese o meno, che lo ha reso di fatto inamovibile e imprescindibile – la posizione di Serraj si era ammorbidita (anche il ministro degli Esteri italiano Gentiloni aveva fatto delle aperture), e si era cercato di coinvolgere Haftar in un comando congiunto delle operazioni contro l’Isis lasciando anche intravedere possibili accordi per una suo ruolo di rilievo nella futura Libia unita. Ma non è bastato. All’indomani della conferenza di Vienna è arrivato il suo “no” ufficiale al governo Serraj: “non mi interesso di questo governo. Le sue decisioni sono solo inchiostro su carta”, ha dichiarato il generale.
«Questo è già un risultato della conferenza di Vienna: ha costretto Haftar a venire allo scoperto», spiega Mattia Toaldo, ricercatore dell’Europeancouncil on foreign relations esperto di Libia. «Dopo aver espresso ufficialmente il suo “no” a Serraj ora difficilmente potrà tornare indietro sui suoi passi, accettando le offerte di un qualche incarico nel governo unitario». Una scelta netta, quella del generale, che potrebbe lasciare stupiti, considerando che gli Stati suoi protettori e alleati erano presenti a Vienna e avevano formalmente dato il proprio sostegno al governo Serraj. «I Paesi che hanno una posizione ambigua sulla Libia sono molti, e parrebbe che anche l’Italia si possa aggiungere alla lista», prosegue Toaldo. «In Cirenaica, a fianco delle milizie di Haftar, sono presenti forze speciali francesi, inglesi, americane e ora pare anche italiane. Questo dà al generale la tranquillità per tirare dritto per la sua strada. Sa perfettamente di essere lui il “piano B” rispetto al governo Serraj, ed è convinto (non senza un interesse personale) che il “piano A” sia destinato a fallire. Quanto agli Stati che più apertamente e direttamente lo sostengono, come l’Egitto e gli Emirati, non deve stupire la loro doppiezza a Vienna: non vogliono infatti essere estromessi da simili conferenze da un lato, e dall’altro sono anche legati formalmente (in particolare l’Egitto, che è membro non permanente del Consiglio di sicurezza dell’Onu) alle decisioni prese dalle Nazioni Unite in favore del governo unitario».
Haftar si è dunque sbilanciato scommettendo apertamente sul fallimento del tentativo di Serraj e, al momento, i fatti sembrano dargli parzialmente ragione. «Serraj è a Tripoli da circa due mesi e la situazione generale è ancora disastrosa», dice ancora Toaldo. «L’economia è sempre in grave crisi, si avvicina il Ramadam e le banche non sono ancora in grado di garantire i prelievi; la fornitura di elettricità procede a singhiozzo con frequenti black-out; i ministeri ancora non funzionano e lo stesso Serraj vive chiuso in una base militare da cui è uscito rarissimamente. Adesso ha circa due settimane per dare qualche segnale di ripresa, per far tornare a funzionare le banche, dare una scossa all’economia e rendere operativi i ministeri. Su quest’ultimo fronte si è registrata una buona notizia (finora una delle poche) per il governo unitario: il ministro della Difesa incaricato, Mahdial-Barghati, è giunto in pompa magna a Tripoli per iniziare a lavorare dalla capitale. Al-Barghati è un colonnello di Bengasi, un militare dell’est del Paese. Ora bisognerà capire se ha un suo seguito in Cirenaica o meno. Nel primo caso lui (per la Cirenaica) con Serraj (per la Tripolitania) e Jadran (il capo delle milizie petrolifere, ex alleato di Haftar che ora pare si sia schierato con Tripoli e con al-Barghati) avrebbero la possibilità di costituire di fatto un nucleo decisionale rappresentativo di una Libia unita».
La situazione quindi potrebbe anche evolvere in modo positivo secondo i piani delle Nazioni Unite. In questa prospettiva gli Stati Uniti non smettono di paventare possibili interventi militari di sostegno alle nascenti forze armate libiche “per contrastare l’Isis”. In quel caso l’Italia – a certe condizioni – potrebbe prendere la guida della missione. Ma si tratta di discorsi prematuri. Un qualsiasi intervento militare richiederebbe come presupposto un comando militare unificato in Libia, e per ora siamo lontani da un simile risultato. Al momento la grande incognita è se Serraj ce la farà a uscire dallo stallo nelle prossime settimane o meno.
«Se dovesse fallire probabilmente Serraj verrebbe comunque lasciato formalmente al suo posto, ma sarebbe un guscio vuoto», conclude Toaldo. «Il rischio, probabile, sarebbe un riesplodere delle violenze tra le milizie di Haftar e quelle della Tripolitania (e tra quelle della Tripolitania tra loro). In quel caso torneremmo sostanzialmente alla situazione di guerra civile ad alta intensità del 2014». Ed è in questa evenienza che evidentemente nessuno dei Paesi europei maggiormente interessati alla Libia vuole trovarsi impreparato. La Francia è noto già da tempo che abbia stanziato suoi uomini a Bengasi nella base di Benina. Voci analoghe – ma meno palesi – riguardano forze speciali americane e inglesi. In un simile contesto non sarebbe quindi difficile immaginare che anche l’Italia abbia voluto mettere la sua bandierina in Cirenaica (pur in palese contrasto con le posizioni ufficiali della diplomazia e del governo). Perché se le violenze dilagassero nuovamente e diventasse impossibile chiedere alle sole forze libiche (quali poi?) di sradicare lo Stato Islamico da Derna, Sirte e altre città del Paese, allora sarebbe necessario avere uomini sul terreno per preservare una capacità operativa reale. E nessuno sembra intenzionato – Roma in testa – a voler perdere posizioni nei confronti degli altri Stati che mirano a difendere o espandere i propri interessi in Libia.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Sulla scacchiera del Grande Gioco in corso in Medio Oriente il fronte sciita guidato dall’Iran appare in forte ascesa in diversi scenari – dall’Iraq alla Siria, dallo Yemen al Libano, dalle relazioni diplomatiche a quelle commerciali -, e tuttavia lo schieramento sunnita che fa capo all’Arabia Saudita sta forse per piazzare un’importante vittoria politica e di immagine: un successo diplomatico sulla questione israelo-palestinese, la battaglia ideale più importante per le opinioni pubbliche musulmane. Negli ultimi pochi anni Riad si è mossa con astuzia, spesso nel cono d’ombra di altri attori – ora l’Egitto, ora la Francia, ora gli Usa, ora altri – con interessi convergenti, per portare in posizione strategica le proprie pedine. Ora, parrebbe, è arrivato il momento per colpire.
L’occasione per Riad si presenta grazie al fallimento di un proprio alleato, e fondamentale partner commercio di armamenti: la Francia. Parigi aveva infatti preso l’iniziativa (approfittando della scarsa presenza degli Usa, concentrati sulla campagna elettorale) e annunciato una conferenza internazionale per il 30 maggio con oggetto la questione israelo-palestinese, a cui tuttavia in un primo momento non avrebbero partecipato le due parti interessate. Se da parte palestinese la proposta francese era stata ben accolta, non altrettanto aveva fatto Tel Aviv. Israele infatti temeva la mancanza di imparzialità di Parigi, e anche Usa e Russia non sembravano convinte. L’iniziativa rischiava di nascere morta ma il 17 maggio vengono prese due decisioni per salvarla e anzi rilanciarla: prima la Francia annuncia il rinvio “all’estate” della conferenza (ufficialmente perché il Segretario di Stato americano John Kerry non avrebbe potuto partecipare ma di fatto guadagnando tempo), poi il presidente egiziano al Sisi – altro fondamentale alleato di Riad, a cui di recente ha ceduto due isole strategiche nel Mar Rosso e da cui dipende economicamente per mantenere il potere nel Paese – entra in scena ritagliando per sé, pur nella cornice dell’iniziativa francese, il ruolo di mediatore tra Israeliani e Palestinesi. “C’è una concreta possibilità di stabilire una pace reale, la sicurezza e la stabilità”, ha dichiarato al Sisi nella città meridionale di Assiut. “Se c’è l’accettazione vera degli sforzi arabi e internazionali – ha aggiunto – e se voi avete fiducia in me”. Stavolta il consenso è unanime.
“Israele è disposto a partecipare assieme all’Egitto e ad altri Paesi arabi per portare avanti il processo diplomatico e la stabilità nella regione”, dichiara il premier israeliano Netanyahu, che aggiunge “l’apprezzamento per l’operato di al Sisi”. Concorda Isaac Herzog, leader dell’opposizione, che ritiene le dichiarazioni del presidente egiziano “un’opportunità storica”. Anche dal lato palestinese si registraun forte apprezzamento. Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese, Mahmoud Abbas (del partito Fatah), ha dichiarato che l’Egitto è sempre stato “un’ancora” per i paletinesi, da cui si aspetta “un grande aiuto”. E anche Hamas ha espresso il proprio sostegno per “trovare un accordo nazionale”. Le parole di apprezzamento per l’iniziativa egiziana sono la cartina tornasole del (precario) equilibrio strategico che si è andato creando negli ultimi anni in Medio Oriente.
L’Egitto è stato storicamente – dopo gli accordi di Camp David del 1978 – uno dei pilastri della sicurezza di Israele. La parentesi del governo islamista e filo-Hamas di Mohammed Morsi – deposto dal golpe di al Sisi – è stata chiusa e la vicinanza, per non dire la dipendenza, del Cairo con Riad in questo momento non è affatto sgradita a Tel Aviv. L’Arabia Saudita e Israele sono andati infatti rafforzando i propri legami negli ultimi anni, da quando la decisione degli Stati Uniti di far emergere l’Iran dall’isolamento internazionale (e dalle sanzioni) ha di fatto allineato gli interessi strategici dei due Paesi. L’Egitto può quindi legittimamente proporsi come interlocutore per Israele, e gli viene infatti tributata una maggior fiducia che non alla Francia. Ma l’alleanza con Riad porta in dote ad al Sisi anche una tela di rapporti con le formazioni palestinesi di grande valore strategico.
Se infatti il Cairo ha da sempre mantenuto, nonostante gli accordi di pace con Israele, buoni rapporti con l’autorità palestinese e con al Fatah, non altrettanto si può dire di Hamas. Imparentata con la Fratellanza Musulmana (considerata dal Cairo un’organizzazione terroristica) e spesso in contrasto con l’Egitto per il blocco del confine con Gaza, l’organizzazione palestinese è stata spesso (e soprattutto dopo la caduta di Morsi) oggetto di accuse di complicità coi terroristi del Sinai (oggi vicini all’Isis). Non a caso, si può forse dire alla luce dei recenti sviluppi, la situazione si era cominciata a distendere già a marzo con una visita di cinque giorni dei dirigenti di Hamas al Cairo. Forse Riad già propiziava la mossa del proprio alfiere egiziano.
Storicamente più vicina ad al Fatah, l’Arabia Saudita ha aumentato i propri contatti con Hamas soprattutto in seguito all’esplosione della guerra civile siriana nel 2011. In quell’occasione, dovendo scegliere se appoggiare i suoi protettori sciiti (la Siria di Assad e l’Hezbollah libanese, longa manus dell’Iran) o i ribelli sunniti, nel 2012 Hamas si è schierata coi secondi, spostando la propria dirigenza dalla Siria al Qatar (all’epoca molto attivo nel sostenere la Fratellanza Musulmana nelle varie Primavere arabe). Perso l’appoggio di Teheran (che poi avrebbe comunque tentato un riavvicinamento dopo la guerra di Gaza del 2014), l’organizzazione islamista palestinese perde poi anche quello egiziano (in seguito al golpe di al Sisi nel 2013) e vede ridursi quello della Turchia (impegnata nella guerra in Siria e distratta dalla questione curda) e del Qatar (che a fine 2014 esce sconfitto da uno scontro diplomatico con Riad, scontenta dell’attivismo diplomatico del piccolo vicino). Col nuovo Re, Salman, nel 2015 l’Arabia Saudita comincia ad avvicinarsi ad Hamas e iniziano a circolare voci su una trattativa segreta che Riad starebbe propiziando tra l’organizzazione islamista palestinese e Israele. Finora non erano emersi risultati significativi ma questa rete diplomatica tessuta negli ultimi mesi dai Saud può ora essere messa a frutto nelle trattative future.
Eventuali progressi, se non un successo, sarebbero nell’interesse dei principali attori coinvolti nella trattativa: le fazioni palestinesi si legittimerebbero di fronte a un’opinione pubblica esasperata (come dimostra la cosiddetta Intifada dei coltelli) e potrebbero contare sull’apertura del valico tra Gaza e l’Egitto – ad oggi ancora oggetto di trattative – e forse sulle risorse economiche di Riad, per migliorare la situazione; Netanyahu potrebbe ottenere un risultato storico (forse uno dei motivi per cui in Israele si discute di un possibile governo di unità nazionale coi laburisti di Herzog); al Sisi otterrebbe una legittimazione interna e internazionale molto forte; la Francia espanderebbe ulteriormente la sua influenza in Medio Oriente; e l’Arabia Saudita potrebbe intestarsi una enorme vittoria di immagine, anche ai danni del rivale sciita iraniano. Teheran – se avesse intenzione di tentare un sabotaggio dell’iniziativa – sembra costretta a combattere in salita questa battaglia, essendo già molto impegnata in Iraq e in Siria (dove sta anche utilizzando l’Hezbollah libanese), e anche la Fratellanza Musulmana – altro sconfitto da un eventuale accordo patrocinato dal Cairo – attraversa un momento di isolamento e debolezza. Ma il rischio, sempre elevato nella questione israelo-palestinese, è che la buona predisposizione dei protagonisti e il quadro geopolitico favorevole comunque non bastino. I dettagli di un qualsiasi accordo, dove la saggezza popolare vuole si nasconda il diavolo, possono sempre riaccendere gli odii e i rancori seminati tra i due popoli per decenni.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Negli ultimi due anni il prezzo del greggio è passato da più di cento dollari al barile a meno di quaranta (v. grafico). Le conseguenze sulle economie dei Paesi produttori sono state molto pesanti. Dalle monarchie del Golfo fino al Venezuela, dalle ex repubbliche sovietiche del centro-Asia fino agli Stati africani, la lista di chi ha dovuto intaccare le proprie riserve di valuta, o peggio di chi ha dovuto ricorrere al Fondo Monetario Internazionale – o si reputa che vi dovrà ricorrere presto – è lunga.
Le spiegazioni sui motivi di questo crollo, e soprattutto sul perdurare di questa situazione, variano a seconda dell’analista o dell’esperto. Alcuni hanno imputato il mantenimento dei prezzi bassi del greggio a una volontà dell’Arabia Saudita di azzoppare un’eventuale ripresa dell’economia iraniana, una volta entrato in vigore l’accordo sul nucleare ed eliminate le sanzioni internazionali. Altri vi hanno visto una manovra, sponsorizzata dagli Usa (che in cambio concederebbero ai Saud di soffocare nella culla la nascente industria americana dello shale oil) per dare un’altra spallata – dopo le sanzioni per la Crimea – all’economia russa. Altri ancora hanno invece ritenuto che fossero proprio le industrie dello shale l’obbiettivo di Riad.
Di sicuro i recenti tentativi di trovare un accordo tanto all’interno del perimetro dell’Opec quanto all’esterno – ad esempio coinvolgendo la Russia – non sono andati a buon fine. L’Iran ha dichiarato la propria intenzione di non partecipare a un eventuale accordo per stabilizzare il prezzo del greggio e Riad, di conseguenza, ha ritirato la propria disponibilità facendo fallire da ultimo il round negoziale previsto per fine aprile in Qatar, a Doha.
Abbiamo chiesto a Fabio Scacciavillani, chief economist del Oman Investment Fund (il fondo sovrano del sultanato dell’Oman), la sua opinione di esperto sui fatti e sulle ricostruzioni che circolano a proposito di questa “guerra del petrolio”.
Dietro la politica dell’Arabia Saudita di mantenere basso il prezzo del greggio (si pensi ad esempio al fallimento di Doha) quale obiettivo politico-economico si cela secondo lei? È una strategia per cercare di sterilizzare definitivamente la minaccia che potrebbe rappresentare un domani lo shale americano, già oggi in crisi, oppure per danneggiare l’Iran libero dalle sanzioni, o altro?
La strategia dell’Arabia Saudita nell’attuale fase di eccesso di offerta consiste nel tenere costante o aumentare la sua quota di mercato. È la strategia che prescrivono tutti i manuali di economia per i produttori che in un qualsiasi mercato hanno i costi di produzione più bassi. In sostanza, in questo modo si mettono fuori mercato i produttori con i costi maggiori (nella fattispecie molti di quelli che sfruttano lo shale oil in USA, ma anche i depositi di sabbie bituminose canadesi o alcuni giacimenti russi) e i prezzi gradualmente risalgono, come infatti sta avvenendo.
Si tratta quindi di ragioni economiche e non politiche?
Questa strategia è dettata da motivi prevalentemente economici. Gli obiettivi politici sono del tutto secondari e comunque non determinanti, ma trovano ampio spazio sui media con spiccate tendenze a pompare teorie complottistiche di vario conio e provenienza.
Quanto è destinato a durare questo atteggiamento da parte di Riad?
La strategia perseguita dall’Arabia Saudita è destinata a durare fino a quando il prezzo del petrolio non sarà almeno equivalente al costo marginale di estrazione di lungo periodo comprensivo dei costi del capitale, che al momento si situa intorno agli 80 dollari al barile. Questo processo di riequilibrio probabilmente non seguirà un andamento lineare, ma sarà caratterizzato da una marcata volatilità.
Considerata la situazione di difficoltà di numerosi Paesi produttori (membri dell’Opec e non) a causa del prezzo basso del greggio, secondo lei Riad non rischia di logorare i rapporti con questi Stati, alcuni dei quali sono sui alleati? Che sviluppi – premessa la fluidità della situazione – si attende? C’è il pericolo per l’Arabia Saudita di trovarsi più isolata di prima, se non addirittura “tradita” da qualche Paese amico?
La discesa dei prezzi petroliferi è legata a condizioni di mercato. In primo luogo l’aumento dell’offerta grazie alla produzione dagli shale plays, ma anche dai giacimenti Opec, e in secondo luogo la crescita anemica della domanda dopo il rallentamento in Cina. Pertanto non esistono ricette magiche che possano riequilibrare la situazione in tempi rapidi. L’idea che l’Arabia Saudita possa far risalire i prezzi è semplicemente puerile ed anche Paesi che sono in condizioni disperate hanno capito non esistono alternative all’attuale strategia saudita di spingere fuori mercato il petrolio estratto da giacimenti ad alto costo.
Non si aspetta quindi grandi scarti da parte di questi Paesi?
A parte qualche occasionale battibecco (come quello presumibilmente avvenuto a Doha, ma amplificato oltre misura da giornalisti annoiati e irritati per la mancanza di notizie), gli sviluppi saranno graduali e i Paesi produttori dovranno armarsi di pazienza. Se qualcuno potesse trarre un qualche beneficio da un tradimento (o da una strategia alternativa) avrebbe già “tradito” da tempo senza farsi troppi scrupoli.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
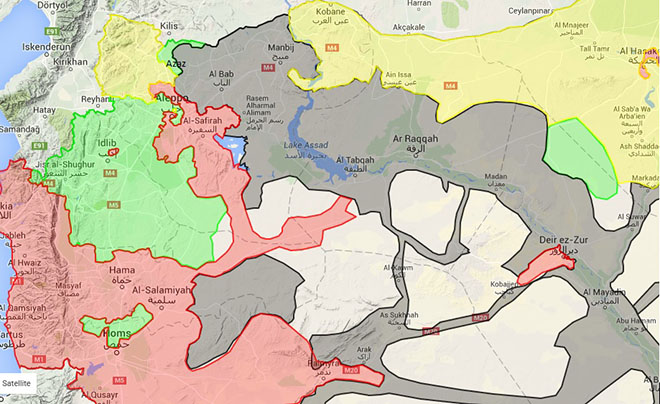
Secondo i piani diffusi dagli Stati Uniti, la caduta di Raqqa in Siria e Mosul in Iraq – le due capitali dello Stato Islamico – sono un passaggio fondamentale per lo sradicamento dell’organizzazione terroristica. A questo fine sono stati inviati centinaia di uomini delle forze speciali americane, per addestrare e aiutare sul campo l’esercito iracheno, i peshmerga (curdi iracheni) e le Syrian Democratic Forces (una coalizione di ribelli siriani, dominata dal Ypg curdo). Le operazioni tuttavia procedono a rilento. In Iraq pesa il caos politico, la spaccatura all’interno delle comunità sia sunnita che sciita (con i curdi che sempre più speditamente vanno verso la dichiarazione di indipendenza anche formale), la disorganizzazione dell’esercito e la conseguente presenza di milizie sciite (spesso finanziate dall’Iran) che spaventa la minoranza sunnita del Paese, e le diffidenze verso i Peshmerga.
In Siria – dove, per stessa ammissione del colonnello Steve Warren (comandante della coalizione a guida Usa che combatte contro l’Isis), gli Usa hanno un piano meno sviluppato su Raqqa e non possono contare sulla cooperazione di un esercito regolare come in Iraq – la situazione è peggiore per l’Isis a causa della presenza russa. Gli americani sono infatti resi, almeno per il momento, quasi impotenti dall’ostacolo rappresentato dalla Turchia. Ankara non vuole che l’Ypg curdo – legato al Pkk, considerato dalla Turchia un’organizzazione terroristica – guadagni altro territorio in Siria, specialmente al suo confine, anche se i curdi siriani sono la forza di fanteria che meglio ha fatto contro gli uomini del Califfo e sono già tatticamente posizionati sia per tagliare i rifornimenti allo Stato Islamico sigillando il confine con la Turchia sia per portare un eventuale attacco contro Raqqa (vedi cartina).
Per ora la Casa Bianca sostiene quindi il tentativo dell’alleato turco di armare, addestrare e aiutare i ribelli siriani che stazionano nell’area di Azaz (v. cartina). «Negli ultimi mesi Washington ha fatto di tutto per accontentare la Turchia», spiega Amberin Zaman, esperta di Turchia del Washington Post. «Gli Stati Uniti hanno intensificato il supporto aereo per i ribelli siriani filo-turchi, inclusa l’organizzazione jihadista Ahrar al-Sham (non inserita tra le fazioni escluse dalla tregua Onu ndr.). Questi gruppi ribelli stanno combattendo per espellere l’Isis – finora senza successo – dalle aree confinanti della Turchia, con l’obiettivo di impedire all’Ypg di farlo e rivendicare così questi territori». Questa accondiscendenza verso Ankara sta di fatto rallentando le operazioni e, secondo esperti militari, non è a tempo indeterminato. Obama è intenzionato a “premiare” i recenti sforzi della Turchia, che fino a pochi mesi fa aveva tenuto una linea ambigua nei confronti dell’Isis, contro l’organizzazione terroristica (che ha colpito anche diverse città turche). Ma ha già preparato un “piano B”. Se il tentativo dei ribelli filo-turchi si rivelasse inconcludente gli Usa potrebbero decidere di scontentare Erdogan e lasciare che siano i curdi del Ypg, avanzando su e oltre Manbij (v. cartina), a sigillare il confine. Non solo. Se le forze del regime siriano di Assad, sostenute dalla Russia, dovessero accelerare le operazioni per riconquistare Raqqa, gli americani potrebbero di nuovo sfruttare l’Ypg e i suoi alleati arabi – già posizionati a nord della città – per intervenire nella partita.
E che la Russia stia preparando qualche manovra è confermato da diversi elementi. Lo scorso 9 aprile i comandi militari delle forze russe e siriane hanno annunciato l’imminente avvio di una campagna per liberare Aleppo “dalle fazioni che non sono incluse o che hanno violato il cessate il fuoco”. Da allora gli scontri e i bombardamenti sulla città si sono intensificati. A fronte delle proteste dell’opposizione siriana e dell’Occidente, Mosca ha sostenuto di aver colpito gruppi jihadisti collegati a Jabhat al Nousra (il ramo siriano di Al Qaeda, che oscilla tra la fedeltà alla casa madre – che le ha dato il via libera per la costituzione di un suo Califfato – e le lusinghe del Qatar di renderla una “forza presentabile”). La situazione frammentaria e caotica sul terreno rende difficile tracciare linee di demarcazione chiare. È sicuramente vero che la controffensiva più violenta subita dalle forze lealiste nel quadrante di Aleppo è stata portata negli ultimi giorni dai jihadisti di Jabhat al-Nusra, Ahrarash-Shame delTurkistanIslamic Party – uniti in un’unica massa d’urto – nella città di Khan Touman. Il regime, complice la situazione di parziale difficoltà, e i ribelli “moderati” hanno quindi siglato dei brevi cessate il fuoco relativi ad Aleppo. Se la tendenza a ricercare intese di carattere locale dovesse tuttavia consolidarsi sui vari fronti aperti nel Paese, la tregua formalmente in vigore dal 27 febbraio sarebbe di fatto morta e le conseguenze della frammentazione sarebbero potenzialmente disastrose per i ribelli e promettenti per Mosca e Damasco.
La Russia sta poi proseguendo i bombardamenti nella regione di Idlib – la più vasta ancora in controllo di una moltitudine di fazioni ribelli – e vicino Palmira, dove i jihadisti dell’Isis continuano una costante azione di logoramento. E proprio nella città che fu capitale del regno della Regina Zenobia pare – secondo quanto riportato dai ribelli siriani – che Mosca stia costruendo la sua seconda nuova base militare in Siria, dopo quella vicino Latakia (che già si era aggiunta alla base navale di Tartus). Per ora si tratta di voci non confermate, che potrebbero rientrare nel gioco della propaganda sui destini del meraviglioso sito archeologico (l’orchestra di San Pietroburgo ha di recente suonato nel Teatro di Palmira, prima usato dall’Isis per le esecuzioni capitali). Tuttavia se ne venisse dimostrata la fondatezza si tratterebbe di un chiaro segnale che il Cremlino sta progettando il supporto alle prossime offensive lealiste su DeirezZur e Raqqa (oltre a una presenza ancora più stabile in Medio Oriente). E un Assad vincitore nella guerra contro il Califfato – almeno in Siria – sarebbe ancora più difficile da rimuovere dal potere.
Putin, con il suo interventismo in Siria, sta guadagnando centralità in tutte le dinamiche Medio Oriente. Se da un lato non ha comunque interesse a indispettire eccessivamente le monarchie del Golfo, nemiche di Assad e dell’Iran ma con cui Mosca non disdegna di fare affari nell’ambito degli armamenti e non solo, dall’altro pare intenzionato a prendersi tutto lo spazio possibile fintanto che gli Stati Uniti insistono su una linea di politica estera mediorientale non interventista. Una linea che, oltretutto, potrebbe cambiare tra poco più di un anno, quando verrà eletto il nuovo inquilino della Casa Bianca.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Il Consiglio presidenziale libico guidato da Fayez al Sarraj – nato sotto la spinta del negoziato voluto dall’Onu per unire il Paese e, tra le altre cose, sradicare lo Stato Islamico – nei giorni scorsi ha chiesto ufficialmente di interrompere qualsiasi offensiva militare contro le postazioni dell’Isis a Sirte. Dietro quello che a prima vista può sembrare un paradosso si nascondono le contraddizioni e le gravi problematiche della Libia in questo momento.
Su Sirte pare stiano infatti convergendo due diverse forze militari, quelle legate al generale Khalifa Haftar – capo delle forze armate di Tobruk, dove risiede il parlamento riconosciuto dalla comunità internazionale ma che finora si è rifiutato di dare il suo sostegno a Sarraj – e quelle della brigata di Misurata. Quest’ultima da quando Sarraj è sbarcato nella capitale ha dato il suo appoggio al governo unitario targato Onu, ma in passato era la principale fazione militare che sosteneva il parlamento di Tripoli (quello “islamista” vicino alla Turchia e alla Fratellanza Musulmana, non riconosciuto internazionalmente). Se i due schieramenti dovessero entrare in collisione non solo se ne avvantaggerebbe l’Isis, ma si rischierebbe di sprofondare il Paese in una guerra civile. Di qui la richiesta di Sarraj di fermare l’offensiva e di aspettare la creazione una leadership militare congiunta per le operazioni contro lo Stato islamico a Sirte.

Contro la degenerazione dello scontro tra Sarraj e Haftar sono in teoria allineati tutti gli attori occidentali, europei e Stati Uniti, e le stesse Nazioni Unite. Tuttavia c’è chi soffia sul fuoco e chi si tiene le mani libere per qualsiasi evenienza. Alla prima categoria appartengono sicuramente l’Egitto, che di Haftar è il primo sostenitore e che ha mire egemoniche sulla Cirenaica controllata dal generale, e le monarchie del Golfo. È riconducibile a queste ultime ad esempio la corposa spedizione via Egitto di oltre mille mezzi militari (400 blindati leggeri e 650 pickup modificati), in barba all’embargo sulle armi che vige per la Libia, alle forze armate di Tobruk. «L’obiettivo principale dei sostenitori di Haftar è imporlo nella trattativa da una posizione di forza», spiega Arturo Varvelli, ricercatore dell’Ispi esperto di Libia. «L’Egitto e i Paesi del Golfo – e in modo più ambiguo anche la Francia – vogliono impedire la rimozione di Haftar. Si tratta di un obiettivo pericoloso. Il generale è un elemento fortemente divisivo e, se i suoi “protettori” non acconsentono a che sia sacrificato nella trattativa, il rischio è di perdere il sostegno alla trattativa Onu di molte milizie tripolitane (alcune delle quali stanno ora dando segnali incoraggianti per Serraj). Inoltre Haftar è un cane sciolto, persegue anche suoi personali disegni nella partita libica e armarlo oggi, come stanno facendo alcuni Paesi, potrebbe essere un problema domani».
Addirittura c’è chi ipotizza che il primo obiettivo delle forze del generale, ora sostanziosamente rafforzate, non sarà lo Stato Islamico ma i pozzi di petrolio del bacino della Sirte, in gran parte controllati dalle milizie petrolifere di Ibrahim Jadhran, unico o quasi attore della Cirenaica ad essersi schierato con Sarraj prendendo le distanze da Haftar. In questo quadro si potrebbe quindi interpretare la richiesta di Sarraj all’Occidente di “proteggere le installazioni petrolifere” del Paese. Non contro gli uomini del Califfo, ma contro i soldati di Haftar. «Il rischio che si arrivi a uno scontro tra le truppe del generale e milizie che sostengono il governo appoggiato dall’Onu c’è», sostiene Varvelli. «E sarebbe un segnale che gli Stati che lo supportano non riescono a controllarlo a sufficienza. Un effettivo scontro con forze che si sono schierate con la comunità internazionale sarebbe un fatto molto grave. Proprio per questo tuttavia penso che Haftar ci penserà molte volte prima di aprire le ostilità, e secondo me al momento non è comunque abbastanza forte per potersi permettere una mossa del genere».

Ma, come si diceva, oltre ai Paesi che direttamente mirano a far deragliare il tentativo di Sarraj, ci sono anche Stati che dietro alle dichiarazioni pubbliche mantengono un atteggiamento di maggiore realpolitik. In Europa in particolare è la Francia che sembra divisa – forse tatticamente – al proprio interno tra un convinto sostegno al governo unitario sponsorizzato dall’Onu e il mantenimento di una relazione privilegiata con Haftar (cioè anche con l’Egitto e con le monarchie del Golfo, con cui Parigi sta chiudendo affari miliardari per la vendita di armamenti). Oltre agli interessi economici legati ai sostenitori del generale, la Francia ha poi delle mire espansionistiche sulla Libia fin dai tempi dei bombardamenti contro Gheddafi nel 2011. Una scissione del Paese, con una Cirenaica indipendente – e sottratta all’influenza del governo centrale, tradizionalmente e anche ora più vicino all’Italia -, potrebbe essere nell’interesse di Parigi, economico e non solo. In Africa infatti la Francia sta portando avanti un deciso contrasto militare al jihadismo – obiettivo che condivide con il Cairo –, specialmente con l’operazione Barkhane: una missione che coinvolge oltre tremila uomini delle forze francesi e che si dispiega nel Sahel attraverso cinque stati (Mali, Niger, Chad, Burkina Faso e Mauritania), due dei quali confinanti con la Libia.

«In questo momento, con il consiglio presidenziale guidato da Serraj a Tripoli che sta espandendo la sua influenza nel Paese, si può dire che l’Italia ha ottenuto – muovendosi nell’ambito della cornice della trattativa Onu – un ottimo risultato per i suoi interessi nazionali», dice ancora Varvelli. «Lo stesso non può dirsi per gli altri Stati, che spesso sono nostri alleati, coinvolti nella partita: Francia, Egitto ed Emirati. È con loro che andrà trovato un bilanciamento di interessi e si potrebbe anche pensare di concedere che Haftar resti in una posizione di potere, magari affidandogli la sicurezza della Cirenaica e trovando un suo pari grado per fare lo stesso in Tripolitania, e avendo entrambi integrati in un progetto unitario. La creazione di un esercito libico – che abbia un nucleo “nuovo” assolutamente fedele, ma che sappia integrare progressivamente le milizie esistenti – è fondamentale per il nation building di cui la Libia ha bisogno. Serve un nuovo patto sociale tra tutti i vari attori del Paese», conclude Varvelli. «Non dobbiamo inviare chissà quanti uomini per supportare questo processo. La Libia deve trovare una stabilità autoctona e con le sue forze sarà in grado anche di sconfiggere lo Stato Islamico». Trovare un accordo sulla creazione di un comando congiunto per l’offensiva su Sirte contro l’Isis, come chiesto da Serraj, potrebbe essere un primo importante passo nella giusta direzione.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Dopo mesi sulle difensive, lo Stato Islamico ha sferrato nei giorni scorsi un contrattacco vincente nel nord della Siria. La città di al-Ra’i, appena persa, è stata riconquistata, e il corridoio in mano ai ribelli filo-turchi tra Azaz e Marea (dove sono accampate decine di migliaia di profughi) è stato attaccato e razziato. La notizia è tanto più amara per Ankara, che in questo settore aveva da poco avviato una nuova strategia – concordata con gli Usa – per difendere i propri interessi.
«Le forze speciali possono guidare i ribelli siriani», aveva dichiarato a inizio aprile il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, a margine della visita del presidente Erdogan a Washington. «Con un addestramento aggiuntivo, si possono preparare dei quadri per comandarli. L’idea è di non mandare il nostro esercito, ma spostare il Free Syrian Army dal nord-ovest all’area sotto il controllo dell’Isis. La Turchia fornirà supporto aereo e terrestre dal suo lato del confine. Abbiamo i mezzi per farlo ed è così che quell’area verrà ripulita dallo Stato Islamico». E così è stato. Nella prima settimana di aprile i ribelli – turcomanni, Fsa e salafiti (Ahrar al sham e altri gruppi jihadisti), che già in passato avevano goduto del sostegno turco – sono stati armati e consigliati da Ankara e il 7 sono cominciate le operazioni. Il piano, in sintesi, era di ripulire dall’Isis la fascia di territorio al confine tra Siria e Turchia – la “buffer zone” che la Turchia chiede insistentemente dall’inizio della guerra e che ora, dopo l’escalation di tensioni con la Russia, non può sperare di creare in prima persona -, liberando in particolare al-Ra’i e il valico di Jarablus. In questo modo si sarebbe anche evitato che l’area cadesse un domani nelle mani del Ypg curdo-siriano, unica forza che ha finora ottenuto significativi risultati contro l’Isis, e che accerchia da est e da ovest l’area di confine controllata dallo Stato Islamico, ma il cui possibile intervento è osteggiato da Ankara per il suo legame col Pkk (il partito marxista turco-curdo considerato dalla Turchia un’organizzazione terroristica, con cui infuriano gli scontri da quasi un anno nel sud-est del Paese).
Grazie al sostanziale contributo dell’aviazione e dell’artiglieria turca, i ribelli tra il 7 e il 10 aprile avanzano lungo il confine, incontrando scarsa resistenza da parte degli uomini del Califfo che si ritirano, e conquistano al-Ra’i. L’11 però la situazione si rovescia. Sfruttando l’allungamento delle linee ribelli, gli uomini dell’Isis sferrano un massiccio attacco con uomini e mezzi esplosivi. Al-Ra’i è martoriata da 11 camion-bomba, e cade rapidamente. Così molti villaggi circostanti. Il panico si diffonde anche nei campi profughi, e un fiume umano si riversa al confine con la Turchia, implorando di farli passare. Nei giorni successivi il guadagno territoriale per lo Stato Islamico si ridimensiona (non poteva del resto sperare di mantenere il controllo su una fascia di Siria che è all’interno del perimetro di gittata dell’artiglieria turca, se la Turchia decide di impedirglielo), ma la vittoria è comunque fondamentale. In primo luogo l’Isis ha catturato armi avanzate e munizioni in grandi quantità (materiale bellico da poco fornito ai ribelli da Ankara), poi ha ottenuto un successo di immagine dopo mesi di difficoltà, infine ha esasperato la situazione dei profughi (alcune fonti temono anche possibili infiltrazioni) mettendo in difficoltà la Turchia.
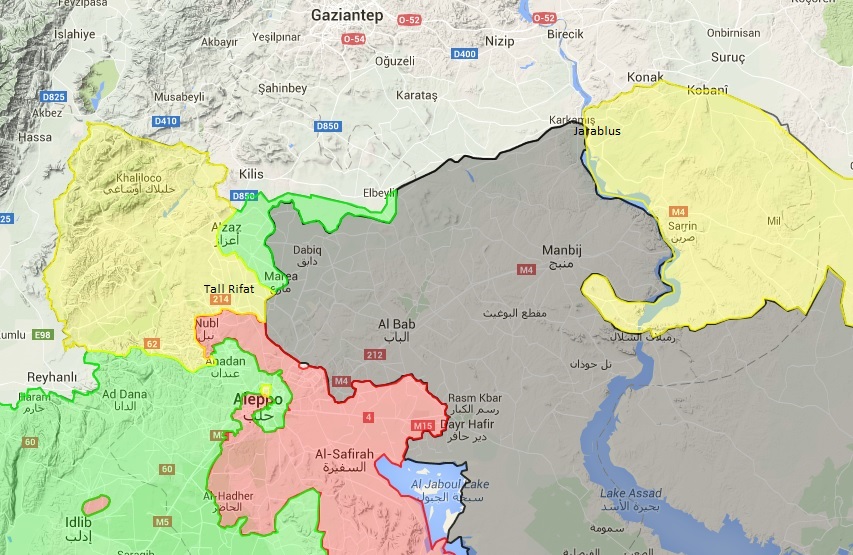

La situazione per il presidente turco Erdogan è molto complicata. Questa debacle dei ribelli (e della Turchia) probabilmente non sarà sufficiente per far cambiare i piani a Washington – che ancora spera di poter isolare lo Stato Islamico tagliandolo definitivamente fuori dal confine con la Turchia (pare che proprio dal valico di Jarablus passino armi e uomini destinati al Califfato) ricorrendo ai ribelli e non ai curdi, cosa che causerebbe uno scontro diretto con Ankara -, ma altri errori potrebbero non essere tollerati. Per ora, nei piani degli Usa, i curdi-siriani verranno impiegati per un’offensiva nella stessa zona ma più a sud, verso la città di Manbij, col supporto aereo americano (l’attacco sarebbe già dovuto scattare, in contemporanea con quello dei ribelli verso al-Ra’i e oltre, ma vista la dura battuta d’arresto è per ora stato rimandato). Ma il loro spazio di manovra potrebbe aumentare in futuro se i ribelli filo-turchi dovessero fallire nuovamente.

Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Dopo mesi di stallo, nelle ultime settimane la situazione in Libia si è evoluta rapidamente. Il premier designato dalle Nazioni Unite – al termine di uno sfiancante negoziato tra fazioni e milizie legate ai due parlamenti rivali di Tripoli e Tobruk, fortemente “stimolate” dalle diplomazie internazionali, e culminato dopo diciotto mesi con l’accordo firmato il 17 dicembre in Marocco – Feyez el-Sarraj è sbarcato a Tripoli il 30 marzo.
Fino a quel momento aveva operato dalla Tunisia, visto che la perdurante opposizione dei due parlamenti libici al riconoscimento del suo ruolo. Insediatosi in principio all’interno della base militare navale di Abu Sittha, a 3 chilometri dal centro della capitale, Sarraj ha osservato da un posto in prima fila lo sgretolamento di uno dei suoi rivali. Dopo un iniziale accenno di violenze, la maggior parte dei sostenitori del parlamento islamista di Tripoli sono passati dalla parte di Sarraj e del governo sostenuto dall’Onu. Importanti soprattutto le adesioni di alcune milizie legate alla Fratellanza Musulmana, di alcune componenti della Brigata di Misurata (una delle più potenti e armate del Paese, che fino a quel momento si era opposta a Sarraj), e di alcune pedine fondamentali dell’economia libica, in particolare la Compagnia petrolifera nazionale (Noc) e la Pfg, milizia che controlla le installazioni petrolifere nel Golfo della Sirte e che finora era stata alleata di Tobruk e del suo capo militare, il generale Haftar. Sarraj, avendo poi l’appoggio della Banca Centrale Libica (che tuttora paga indistintamente gli stipendi alle varie milizie), ha goduto in generale di un effetto “bandwagon”, che ha portato molti attori ostili fino al suo arrivo a Tripoli a schierarsi dalla sua parte.
Dalla larghezza di questo consenso che si è subito creato – almeno in Tripolitania – intorno a Sarraj si può dedurre l’entità dell’appoggio internazionale di cui gode. In particolare dietro la desistenza, e in alcuni casi il sostegno, di varie milizie islamiste legate alla Fratellanza Musulmana c’è la mano della Turchia e del Qatar, sponsor internazionali del movimento. In questa occasione evidentemente Ankara ha preferito non schierarsi contro la comunità internazionale, valutando di poter ottenere di più da un’alleanza che da una contrapposizione con Sarraj (che, forse non a caso, ha di recente espresso opinioni concilianti verso gli islamisti e un’eventuale applicazione della legge coranica). Per quanto riguarda poi il sostanziale sostegno delle forze – politiche, tribali e militari – che orbitano all’economia del petrolio, è probabile che abbia pesato il lavorio della diplomazia italiana e dell’Eni. Non è un caso, sicuramente, che Paolo Gentiloni sia il primo ministro degli Esteri di un Paese occidentale a recarsi in visita ufficiale al governo di Sarraj (scatenando peraltro l’ira del premier precedentemente insediato a Tripoli, l’islamista Khalifa Ghwell, che lamenta la violazione della sovranità libica).
«Se nell’Ovest e nel Sud della Libia stiamo assistendo a una sorta di luna di miele con Sarraj, a Est la situazione è molto problematica», spiega Mattia Toaldo, analista dell’European Council on Foreign Relations. «A parte il capo delle milizie petrolifere (Pfg), tra l’altro sempre più contestato, gli altri attori della Cirenaica sembrano tutti schierato con il parlamento di Tobruk e con il generale Haftar. Finora non ci son stati segni di apertura verso Sarraj e, con l’imminente voto del 18 aprile a Tobruk sul suo tentativo di formare un governo unitario, la situazione sembra poter solo peggiorare. O, infatti, il quorum non sarà raggiunto nemmeno stavolta e proseguirà lo stallo, oppure è più probabile una bocciatura, o un assenso comunque condizionato al riconoscimento del ruolo di Haftar. Rischiamo insomma di passare da una situazione in cui Tobruk non si è espressa a una in cui si è espressa contro Sarraj».
Come dietro alle mosse delle forze tripolitane, che aprivano a Sarraj, si vedeva l’ombra della Turchia e del Qatar, così dietro la resistenza di Tobruk è intuibile la lunga mano dell’Egitto del generale Al Sisi (e forse non solo). «Il gioco di Haftar e dell’Egitto è chiaro, vogliono avere la loro zona cuscinetto in Cirenaica e intanto aspettare il fallimento del tentativo di Sarraj. Eliminata dal piatto questa possibilità, contano tornare ad essere la migliore opzione per la comunità internazionale per controllare il Paese e combattere l’Isis», dice ancora Toaldo. E l’Egitto parrebbe avere una sponda importante in questo suo gioco. «La Francia sta giocando questa partita in proprio, con qualche oscillazione. Si può vedere la doppiezza di Parigi – che da un lato sostiene formalmente gli sforzi della comunità internazionale per Sarraj, ma dall’altro flirta con l’Egitto e con Tobruk (a febbraio erano attivi uomini delle forze speciali francesi al fianco di quelle di Haftar ndr.) – in due modi: come il segno di una spaccatura tra il ministero degli Esteri, che vorrebbe supportare il dialogo con il governo sostenuto dall’Onu, e il ministero della Difesa (e il presidente Hollande stesso pare), che vorrebbe sposare di fatto la linea del Cairo; oppure come un’abile tattica per tenere il piede in due scarpe, salvaguardando le apparenze e allo stesso tempo i rapporti con l’Egitto. Per uscire dalla crisi economica la Francia sembra infatti voler puntare sulla vendita di grandi quantità di armamenti all’Egitto ed al suo alleato (e finanziatore), l’Arabia Saudita».
In uno scenario del genere le prospettive di un’effettiva pacificazione della Libia sono, ancora una volta, lontane all’orizzonte. «Mi sembra siano due le direzioni principali verso cui può evolvere la situazione se Tobruk, come sembra, non sosterrà Sarraj», afferma Toaldo. «O la comunità internazionale decide di andare avanti comunque con chi gli attori che sostengono il governo unitario benedetto dall’Onu, e allora si può presumere che progressivamente Sarraj prenderà il controllo di ampie parti del Paese, oppure l’esperimento implode. In questo caso, specie se il governo unitario non avrà saputo risolvere la crisi economica che sta devastando la Libia, temo che le milizie tripolitane cercheranno di andare a prendere direttamente loro le risorse di cui hanno bisogno», conclude Toaldo. «A quel punto sarebbe definitivamente l’anarchia».
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Una fiammata, e subito una tregua. Ma la paura, quella resta alta, perché nella regione del Nagorno-Karabakh – enclave armena (cristiana e filo-russa) all’interno dell’Azerbaijan (musulmano e filo-turco, anche se in buoni rapporti con Mosca) – la conflittualità congelata da ventidue anni di stallo è pronta a deflagrare da un momento all’altro. Specialmente se qualcuno, anche in maniera occulta, si mette a soffiare sul fuoco.
Storicamente l’inclusione del Nagorno-Karabakh all’interno dell’Azerbaijan è imputabile a una pensata – contestata, ma inutilmente – di Stalin negli anni ’20 del secolo scorso. Sessant’anni di pax sovietica hanno tenuto sotto il tacco di Mosca le pretese e le aspirazioni dei popoli caucasici ma, nel 1988, quando l’Urss iniziava a sgretolarsi dall’interno, le violenze nella regione sono esplose, causando oltre 30 mila morti e un milione di sfollati. All’iniziale pulizia etnica di ambo le parti seguirono le dichiarazioni di indipendenza, dell’Azerbaijan nel 1991 e del Nagorno-Karabakh nel 1992. Baku tentò di riconquistare con la forza il territorio perduto ma emerse sconfitto dallo scontro con l’Armenia. Le armi furono messe a tacere nel 1994, grazie allo sforzo della comunità internazionale, con gli Accordi di Pace di Bishkek. Il Nagorno-Karabakh è de facto una repubblica autonoma, anche se non riconosciuta dalla comunità internazionale. Da allora rivendica il proprio diritto all’autodeterminazione (anche se lo status quo di fatto già la favorisce). Da allora l’Azerbaijan lamenta la mutilazione del proprio territorio, potendo in questo contare sul supporto di Ankara (che pone il ritiro dalla regione come precondizione per stabilire relazioni diplomatiche l’Armenia). Sulla delicata situazione è incaricato di vigilare, e di cercare di mediare un accordo, il Gruppo di Minsk, organo istituito dall’OSCE nel 1992 e guidato dalla co-presidenza di Russia, Francia e Stati Uniti. Finora non sono stati ottenuti risultati significativi. Anzi, periodicamente le violenze si riaccendono, anche se mai come in questi ultimi giorni, con decine di caduti da ambo i lati nei pesanti scontri avvenuti dal 1 al 5 aprile
Uno degli elementi più preoccupanti è la corsa al riarmo, speculare nei due Paesi, che ha caratterizzato l’ultimo decennio e sottratto risorse ad altre possibili voci di investimento (come sviluppo economico, sanità o istruzione). “Sostenuto dall’abbondanza di petrolio e gas, l’Azerbaigian ha aumentato la sua spesa militare più di venti volte tra il 2004 e il 2014”, spiega Magdalena Grono, direttrice del programma Europa e Centro Asia per l’International Crisis Group. “Il presidente azero IlhamAliyev si è vantato che la spesa per la Difesa nel 2014è stata due volte l’intero bilancio statale dell’Armenia”. In questa escalation il Cremlino ha ingrassato di materiale bellico entrambi i contendenti.“L’Azerbaijan ha comprato la maggior parte delle armi dalla Russia, con cui storicamente mantiene buoni rapporti”, prosegue Grono. “L’Armenia, tradizionale alleato della Russia, ha cercato di tenere il passo (rifornendosi sempre da Mosca, che in cambio ha ottenuto il controllo su importanti infrastrutture energetiche e la possibilità di posizionare due basi militari strategiche nel Paese ndr.), pur essendo economicamente indebolita dalla mancanza di sviluppo economico e dalle frontiere chiuse con la Turchia e l’Azerbaigian. In ogni caso le forze di etnia armena hanno mantenuto il controllo delle alture strategiche nei dintorni del Nagorno-Karabakh, il che gli dà un forte vantaggio tattico e ha reso lo sbilanciamento complessivo in termini di armamenti meno”.
Considerata questa situazione di stallo armato, in cui sia Armenia che Azerbaijan sono fortemente dipendenti dalla stessa super-potenza – la Russia -, la domanda che ha preso a circolare in ambienti diplomatici dopo l’esplosione delle violenze di inizio aprile è perché la polveriera del Nagorno-Karabakh ha ripreso a sprigionare pericolose scintille. Da un punto di vista razionale, l’Azerbaijan non può sperare di soggiogare militarmente la regione su cui ha perso il controllo senza affrontare una lunga e dispendiosa guerra. In un momento in cui il greggio è ai minimi storici, e in cui la Russia – dovendo scegliere – appoggerebbe l’Armenia cristiana contro l’Azerbaijan turcomanno (e sostenuto politicamente da Ankara, che parla apertamente di “un popolo, due Stati”), la guerra aperta non sembra una scelta sensata. L’Armenia dal canto suo ha tutto l’interesse al mantenimento dello status quo, che la vede in situazione di vantaggio. Ancora lo scorso 21 marzo Olena Melkonian, esperta di Caucaso del Centro Studi Internazionali, scriveva: “Ad oggi, è molto più plausibile la continuazione di una politica volta al mantenimento dello status quo, poiché un ulteriore escalation della violenza porterebbe ad un disastro degli equilibri geopolitici dell’area”. E quindi, cui prodest?
Una tesi che circola in ambito Nato è che dietro la recente fiammata di violenze (e nel suo immediato spegnimento) ci sia una manovra del Cremlino che, palesando in questo modo la propria assoluta centralità in qualsiasi dinamica nell’area, mira ad allontanare Baku da Ankara. Putin otterrebbe così un duplice risultato: isolare ancor di più Erdogan – con cui ha ingaggiato un duro scontro, da quando le agende dei rispettivi Paesi sono entrate in conflitto nello scenario siriano –, allontanandolo da un Paese che è fondamentale per l’approvvigionamento energetico della Turchia (e con cui condivide legami etnici, politici e religiosi); e acquisire un alleato prezioso – l’Azerbaijan, a cui la Russia potrebbe concedere qualcosa a livello geopolitico, penalizzando un’Armenia che ha poco da offrire da un lato e una quasi totale dipendenza da Mosca dall’altro – in vista di una possibile futura competizione ancor più serrata con Ankara. Il tutto in un momento in cui la Turchia ha poche chance di reagire, considerato l’impegno sul fronte siriano, su quello dei profughi e sulla guerra interna contro il Pkk curdo. Una seconda tesi sostiene invece che ci sia lo zampino proprio della Turchia dietro la recente condotta aggressiva dell’Azerbaijan. Erdogan starebbe mirando a destabilizzare il Caucaso, costringendo Mosca alla trattativa. In questo caso Ankara avrebbe una merce di scambio importante con la Russia da poter spendere anche nella partita sulla Siria.
In entrambi i casi gli osservatori occidentali esprimono una grande preoccupazione. Nel Caucaso sono mescolate popolazioni cristiane e musulmane, slave, iraniche, armene e turcomanne. Un’eventuale esplosione di violenza settaria in una regione anche piccola rischierebbe di scatenare una reazione a catena che potrebbe destabilizzare diversi Paesi. A quel punto il caos, tracimato dal Medio Oriente ai confini meridionali dell’ex Unione Sovietica, esploderebbe e le sue schegge impazzite (potenzialmente affascinate da un’affiliazione col jihadismo internazionale) potrebbero arrivare anche in Occidente.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Nel caos che ha travolto il Medio Oriente negli ultimi anni – dai moti rivoluzionari delle Primavere Arabe alle guerre civili, dall’ascesa dello Stato Islamico alla faida intra-religiosa tra sunniti e sciiti (schermo della contesa egemonica tra Iran e Arabia Saudita) – la Giordania è rimasta un’oasi di (relativa) pace. Il Regno Hashemita – governato cioè da quella stessa dinastia che quasi un secolo fa Lawrence d’Arabia aveva sperato unificasse sotto di se l’intero popolo arabo –, popolato quasi per intero da sunniti, è stretto tra l’Arabia Saudita a sud, l’Iraq a est, Israele a ovest e la Siria a nord.
La sua stabilità è figlia della relazione speciale che la Giordania ha con l’Occidente, prima con l’Inghilterra e poi, a partire dagli anni ’50, con gli Stati Uniti. Washington a partire dal 1951 fino al 2015 ha aiutato, economicamente e militarmente, la Giordania per un totale di oltre 15 miliardi di dollari e, a fronte della crisi siriana con le sue ricadute anche in termini di profughi e contrasto all’Isis, si è impegnata a garantire un miliardo l’anno di finanziamento fino al 2017. Amman è quindi un alleato fondamentale degli Stati Uniti e ne ha quasi sempre sostenuto, a volte con pragmatismo, le linea.
Nella guerra in Siria, di conseguenza, alla linea confusa della Casa Bianca ha corrisposto una condotta altrettanto altalenante da parte della Giordania che, sostenendo gli elementi moderati della ribellione ma non ostacolando nemmeno le controffensive di Damasco e della Russia, ha avuto come stella polare la garanzia della sicurezza del confine nord del Paese. «Che nel sud della Siria controllino il terreno le truppe lealiste di Assad o i ribelli siriani del Free Syrian Army (FSA) – addestrati, pur con discontinuità, dall’Occidente proprio in Giordania ndr. -, per Amman la priorità resta avere una zona cuscinetto che tenga lontani i jihadisti di Al Nousra o dell’Isis», sostiene Sultan Hattab, commentatore politico giordano (contro gli uomini dello Stato Islamico la Giordania ha inasprito lo scontro in particolare dopo la macabra esecuzione di un suo pilota che partecipava ai bombardamenti della coalizione internazionale). «Se fossero i lealisti a prendere il controllo del territorio, molti profughi ospitati in Giordania potrebbero fare rientro nella zona di Dara’a».
L’appoggio di Amman alla ribellione dunque, al netto del supporto offerto – di concerto con gli Usa – al FSA, non è totale e incondizionato, anzi, dopo l’intervento militare di Mosca e il seguente alteramento degli equilibri di forza sul terreno, la Giordania ha assunto una posizione quasi neutrale, ispirata alla realpolitik. I rapporti del Paese mediorientale con la Russia, che sono storicamente buoni, negli ultimi anni si sono fatti ancora più stretti (ad esempio il 24 marzo 2015 la Giordania ha firmato un accordo da 10 miliardi con Mosca per la costruzione del primo impianto per la produzione di energia nucleare). Così, nonostante il sostegno di Amman al FSA, dopo nemmeno un mese dall’inizio dei bombardamenti russi la Giordania – rimasta prudentemente silenziosa in proposito fino a quel momento – annunciava di aver trovato un accordo con Mosca per coordinarsi militarmente in Siria. Questa scelta potrebbe stupire, considerato che la maggioranza della popolazione giordana è sunnita, al pari dei ribelli siriani che stanno provando a rovesciare la dittatura di Assad, filo-sciita. Ma nel regno hashemita le dinamiche politiche sono meno incendiarie che negli altri Stati della regione e le istituzioni godono di una migliore salute. Gli elementi salafiti, che vorrebbero imporre la sharia (legge islamica), sono minoritari e comunque tenuti sotto controllo dal Gid (General Intelligence Directorate, i servizi segreti giordani), che lavora in stretto collegamento con la Cia. La Fratellanza Musulmana, poi, è inserita nel contesto politico nazionale e le sue tendenze rivoluzionarie sono sostanzialmente tenute sotto controllo (di recente, dopo l’innalzamento della tensione seguito alla Primavera Araba, il movimento si è spaccato in due). La maggioranza dei giordani sembra in generale sostenere la casa regnante, in grado – grazie al sostanzioso supporto degli Usa – di garantire discreti livelli di benessere e stabilità.
La crescente vicinanza con la Russia – che non ha comunque impedito ad Amman si sostenere un blitz dei ribelli del FSA, dopo la tregua del 27 febbraio, per sottrarre all’Isis il valico di Tanaf, tra Siria e Iraq, e l’area desertica circostante – potrebbe essere alla base anche di un recente e clamoroso scontro tra la Giordania e la Turchia, un Paese con cui pure il regno hashemita ha un rapporto di alleanza e vecchia amicizia. Il 30 marzo è stato diffuso – e difficilmente notizie di questo genere emergono senza un motivo – il contenuto di un incontro tra Re Abdallah II di Giordania e alcuni membri del Congresso americano. Abdallah ha sostenuto che “il fatto che i terroristi arrivino in Europa è parte di una strategia della Turchia, la radicalizzazione viene realizzata in Turchia”, che “sicuramente Ankara compra petrolio dall’Isis” e, sempre riferito alla guerra allo Stato Islamico, che “siamo costretti a risolvere continuamente problemi tattici contro l’Isis, ma non il problema strategico. Ci dimentichiamo che la Turchia non è, da un punto di vista strategico, dalla nostra parte in questa guerra. Erdogan ritiene che la soluzione ai problemi della regione sia il radicalismo islamico”. Parole straordinariamente pesanti a fronte delle quali ancora non è stato rilasciato alcun commento dal governo della Turchia, anche se una fonte vicina all’esecutivo ha accusato Re Abdallah di essere diventato “il portavoce di Bashar al-Assad”.
Questa dura presa di posizione della Giordania ricalca, e anzi inasprisce, le accuse che da mesi Mosca rivolge ad Ankara. Gli Stati Uniti, storici alleati della Turchia ma che con Erdogan hanno un rapporto sempre più teso (complice il supporto di Washington alle milizie curde in Siria e la linea ambigua di Ankara nei confronti dell’Isis), non sono evidentemente contrari a questo ulteriore passaggio nell’indebolimento e isolamento di Ankara. Per come sono i rapporti di forza al momento nello scenario siriano, una possibile soluzione negoziale alla guerra passa quasi certamente dal riconoscimento della vittoria di Mosca (che può quindi decidere se scaricare o meno Assad, e a quali condizioni) e dal contenimento delle pretese turche. La mossa giordana dunque potrebbe rispondere a un sostanziale via libera da parte degli Usa e, sposando inoltre la linea russa, posiziona il regno in una situazione di vantaggio per le future trattative sulla Siria. Non solo. Se dovesse confermarsi la tendenza del progressivo allontanamento degli Stati Uniti dal Medio Oriente, per Amman trovare (o in questo caso rafforzare) un’altra solida sponda è di vitale interesse.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

La Turchia è stato un solido alleato degli Stati Uniti fin dal termine della Seconda Guerra Mondiale quando, in osservanza della dottrina Truman, ad Ankara furono garantiti ingenti forniture economiche e militari in ottica anti-sovietica. Dal 1952 è un membro della Nato e ad oggi è il suo secondo esercito più vasto, proprio dopo quello americano. La guerra in Siria tuttavia sta logorando i rapporti tra i due Paesi, che nella regione portano avanti agende e priorità diverse.
Per Washington l’obiettivo principale da conseguire in Siria è la distruzione dello Stato Islamico. Per Ankara è impedire che i curdi siriani (specie il Pyd, il partito marxista collegato al Pkk curdo-turco) riescano a ottenere il controllo prima e l’indipendenza poi sulla Rojava, il territorio che i curdi rivendicano come proprio e che si estende lungo quasi l’intero confine turco-siriano.
Il problema è che al momento i curdi siriani sono l’unica forza di fanteria in grado di fronteggiare vittoriosamente gli uomini del Califfato, come dimostrato dall’impressionante avanzata del 2015 nel nord del Paese. I ribelli sostenuti dalla Turchia si sono rivelati meno efficaci contro l’Isis, molto più interessati ad abbattere il regime di Assad (non una priorità questa per la Casa Bianca, che in assenza di una exit strategy ha sempre rallentato sull’opzione di causare una caduta immediata della dittatura siriana), e spesso si sono alleati con fazioni jihadiste (la qaedista Al Nusra, o i jihadisti di AhrarashSham etc.) considerate dall’Occidente gruppi terroristi. Per questo gli Usa hanno sostenuto con sempre maggiore intensità le formazioni curde, specie l’Ypg – il braccio armato del Pyd –, rifornendole di armi e facilitandone l’avanzata con bombardamenti mirati. La Turchia ha spesso protestato in passato contro questo atteggiamento americano, senza riuscire tuttavia a impedirlo. Nel corso degli ultimi mesi è divenuto evidente come anche la Russia e lo stesso regime di Damasco stiano aiutando i ribelli curdi, ma non senza contropartita. Nelle ultime settimane i curdi si sono scontrati violentemente nel nord della Siria con i ribelli filo-turchi. L’Ypg sta infatti cercando di unificare i territori curdi della Rojava e se arrivando da est ha ancora molte miglia presidiate dallo Stato Islamico da percorrere, quando si è mosso da ovest – dal cantone di Afrin – è subito andato a cozzare contro i ribelli che presidiavano il corridoio che congiungeva direttamente i territori ribelli a nord di Aleppo con la Turchia. Tale corridoio è stato chiuso a febbraio da un blitz del regime di Assad e i curdi ne hanno approfittato per espandersi a danno dei ribelli, conquistando la cittadina di Tall Rifat. Da allora l’artiglieria turca ha iniziato a bombardare pesantemente i cantoni curdi siriani – suscitando le proteste degli Usa – e spesso ha lasciato circolare l’ipotesi di un’invasione di terra.

Questa eventualità è stata da ultimo ridimensionata, con la Turchia che si è detta disponibile a un intervento deciso nell’ambito della coalizione anti-Isis (un’eventualità quindi al momento remota), ma non da sola o con la sola compagnia dell’Arabia Saudita. Ma intanto quello con gli Stati Uniti sembra un dialogo tra sordi. «Gli Stati Uniti stanno facendo pressione sulla Turchia perché fermi i bombardamenti sulle postazioni curde nel nord della Siria ma senza molto successo», spiega Sinan Ulgen, analista esperto di Turchia del Carnegie Europe. «Ankara è determinata a dimostrare il proprio disappunto per l’avanzata territoriale dei curdi. Se continueranno ad avanzare è possibile che ci sia un’escalation nella risposta della Turchia nonostante le pressioni della Casa Bianca. Il problema è che da un lato Washington vorrebbero che Ankara sposasse la sua linea, accettando la collaborazione col Pyd, ma questo è politicamente inaccettabile per il governo turco, che vede il partito curdo siriano come un ramo del Pkk, considerato un’organizzazione terroristica».
In questa frattura tra alleati si è insinuata la Russia. Prima ha esacerbato la tensione con la Turchia, portando Ankara ad abbattere un suo cacciabombardiere che aveva sconfinato (l’ennesimo pare), e poi ha approfittato della situazione conseguente: è emerso chiaramente che la Nato non è pronta a seguire la Turchia in un’avventura siriana, se esce dai suoi confini non ha – anche da un punto di vista della legalità internazionale – il diritto di chiedere l’aiuto degli Alleati; inoltre Mosca ha posizionato in Siria sistemi di contraereaavanzati(S-400) che le hanno garantito la superiorità nei cieli del Paese. Dopo questi progressi sul campo il Cremlino ha anche provato un “colpo gobbo” diplomatico: ha chiesto una convocazione urgente del Consiglio di Sicurezza dell’Onu per chiedere uno stop ai bombardamenti turchi contro i curdi siriani, sperando gli Stati Uniti cedessero alla tentazione di dare un segnale duro a un alleato che negli ultimi tempi pare abbia spesso giocato nella squadra avversaria (addirittura ci sono voci insistenti di un possibile aiuto allo Stato Islamico da parte di Ankara, in funzione anti-Assad e anti-curda). Il blitz russo non è riuscito e il Consiglio di Sicurezza, per via della contrarietà di americani e altri alleati occidentali, ha respinto la proposta. «La mia impressione è che gli Usa abbiano respinto la proposta perché l’hanno subito qualificata come un gioco di potere di Mosca, volto a distrarre l’attenzione dal coinvolgimento russo nella regione, a imbarazzare la Turchia e a creare problemi tra Ankara e Washington», spiega Paul Stronski, esperto americano di ex Urss. «La mossa del Cremlino si spiega anche alla luce del deterioramento dei rapporti tra Russia e Turchia. In generale non penso che fosse dettata da un sincero desiderio di fermare gli spargimenti di sangue nella regione o di aiutare i curdi».
La domanda che ora tutti si pongono è: la condotta della Turchia contro i curdi siriani è potenzialmente in grado di far deragliare la strategia americana di contenimento dello Stato Islamico? «Personalmente non credo», dice ancora Sinan Ulgen. «I bombardamenti turchi si fermeranno nel momento in cui i curdi siriani cesseranno i tentativi di espandere il proprio territorio. Potrebbe quindi essere una dinamica di breve termine, mentre la lotta contro l’Isis è sicuramente di lungo». Guardando alla cartina del nord della Siria è tuttavia chiaro quanto i curdi siriani siano vicini a unificare i propri territori. Inoltre la maggior parte – se non la totalità – delle zone che dovrebbero liberare sono in mano all’Isis. Pare molto probabile a numerosi analisti che la leadership curda decida di tentare di raggiungere il proprio obiettivo secolare: l’unificazione e l’autonomia (se non l’indipendenza) di uno Stato Curdo. La conquista di Raqqa – la capitale dello Stato Islamico – è sicuramente meno importante per il Pyd e così come la Casa Bianca non riesce a costringere i turchi ad abbandonare il proprio interesse strategico – evitare la nascita del Kurdistan alle proprie porte – allo stesso modo è dubbio che ci riesca coi curdi.
Questa dinamica esplosiva getta delle ombre preoccupanti anche sulla tregua che in Siria dovrebbe scattare il 27 febbraio. Già debole alla nascita – molti dei gruppi jihadisti esclusi dal cessate il fuoco sono alleati, talvolta mescolati, con gruppi ribelli “moderati” o filo-turchi – la tregua è stata ulteriormente azzoppata dalle dichiarazioni del governo turco, che ha annunciato di volersi tenere le mani libere per rispondere a eventuali attacchi da parte dei curdi. Molti analisti si chiedono che atteggiamento prenderà Ankara se i curdi siriani approfittassero della tregua per attaccare l’Isis al confine con la Turchia – conquistando Manbij, Al Bab e Dabiq (v. cartina) -, ignorando i ribelli filo-turchi e congiungendo, anche se solo per un sottile lembo di terra, i propri cantoni. Il rischio di un’ulteriore escalation in una regione dove si stanno ammassando decine di migliaia di profughi – Ankara li fa entrare col contagocce, secondo alcuni usandoli cinicamente come “scudi umani” contro possibili azioni dei curdi – è molto alto e gli Stati Uniti hanno dimostrato di non poter (o non voler) costringere gli attori regionali a seguire la propria agenda.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Venerdì 26 febbraio l’Iran è chiamato al voto per rinnovare il Parlamento (Majlis) e l’Assemblea degli Esperti, l’organo incaricato di eleggere una nuova Guida Suprema in caso di necessità. Dopo l’elezione del presidente moderato Rohani (nel 2013) e soprattutto dopo il successo del negoziato sul nucleare – l’accordo è stato implementato poche settimane fa, secondo diversi analisti proprio in vista di queste elezioni – c’è grande attesa, in Iran e nel resto del mondo, per l’esito di questa tornata elettorale.
La linea “moderata” di Rohani, che ha riportato Teheran – anche complice la comune battaglia con l’Occidente contro lo Stato Islamico in Iraq prima e in Siria poi – al centro dei giochi della diplomazia internazionale, verrà confermata anche per i prossimi anni, o alla fase di apertura (che ha prodotto il principale risultato sperato, cioè la fine delle sanzioni internazionali) dobbiamo aspettarci che ne segua una di chiusura? Qualche elemento utile per dare risposta a questa domanda è emerso chiaramente già durante la fase precedente al voto. L’attuale Guida Suprema, l’Ayatollah Alì Khamenei, che ha un controllo pressoché completo sulla Repubblica Islamica – nel complesso sistema istituzionale iraniano le redini, alla fine, sono tutte nelle sue mani –, ha già lasciato intravedere quella che sembra essere la sua posizione.
Per il Parlamento, 290 posti (di cui 5 riservati alle minoranze religiose), si erano presentati oltre 12 mila candidati e in un primo momento più della metà erano stati bocciati dal Consiglio dei Guardiani (il 99% dei 3 mila riformisti). Il Consiglio è un organo di 12 membri – 6 clerici nominati dalla Guida Suprema e 6 giuristi scelti dal Parlamento all’interno di una rosa stilata dal Capo del potere giudiziario, a sua volta nominato dalla Guida Suprema – che ha il compito, tra gli altri, di vagliare ed eventualmente ammettere i candidati alle varie elezioni. Attualmente è guidato da un “falco” conservatore, l’Ayatollah Ahmad Jannati, considerato molto vicino a Khamenei. Dopo le proteste per il gran numero di esclusi sono stati riammessi circa 1.400 candidati – tra cui pochi riformisti -, portando il totale degli ammessi al 51% del totale. Di fronte a questa situazione tuttavia i riformisti non hanno invitato a boicottare il voto, come successe nel 2012 quando fu eletto l’attuale Parlamento dominato dai conservatori, ma hanno anzi fatto appello al voto, in molti casi “utile” contro un’affermazione dei “falchi”. «Quello che emerge dalla corsa verso questo voto», spiega Ellie Geranmayeh, analista dell’European Council on Foreign Relations, «è che c’è un allineamento tra riformisti, moderati e conservatori “pragmatici” (quelli più concilianti con la presidenza Rohani ndr.) per impedire una netta vittoria dei falchi conservatori che erano al potere durante il mandato di Ahmadinejad. L’obiettivo di questa alleanza non è portare stravolgimenti nella politica interna o estera dell’Iran. Piuttosto è un tentativo di allentare l’attuale presa dei falchi sul potere, per consentire all’amministrazione Rohani di portare avanti le proprie priorità economiche e, nel migliore dei casi, far progredire le riforme politiche».
Per quel che è emerso finora pare che la Guida Suprema non sia ostile a un’eventualità del genere. Il fronte riformista – duramente osteggiato da Khamenei, specie a causa del sostegno che tanti suoi esponenti diedero alle proteste del 2009 dell’Onda Verde – è costretto ad annacquare le proprie rivendicazioni, a scegliere una linea pragmatica e “centrista” che sostenga l’attuale presidenza. Una sua vittoria probabilmente assorbirebbe parte del malcontento che, specie tra i giovani, ancora cova verso la teocrazia. Una alta affluenza poi, ritenuta probabile, legittimerà ancor di più la Repubblica Islamica, e un eventuale eccessivo rafforzamento di Rohani può sempre essere sterilizzato alle prossime elezioni presidenziali del 2017. Un discorso diverso vale invece per l’elezione dell’Assemblea degli Esperti.
L’Assemblea è composta da 88 membri e rimane in carica per otto anni. Alì Khamenei ha 76 anni e la possibilità che non sopravviva – o non mantenga comunque condizioni di salute idonee – fino al 2024 è ben presente a tutti gli attori della scena politica iraniana. Di 800 candidati circa il Consiglio dei Guardiani ne ha ammessi 161. «I candidati ammessi si possono dividere in quattro gruppi da un punto di vista dell’appartenenza politica: conservatori, moderati conservatori, moderati e nuovi membri di cui ancora non è chiaro l’orientamento», sostiene Shahir ShahidSaless, analista iraniano che vive all’estero. «La composizione dell’Assemblea tuttavia è nota già da adesso. I conservatori avranno la maggioranza. Tuttavia vanno notate alcune cose: moderati e riformisti pare vogliano far convergere i propri voti, in quelle circoscrizioni dove i loro candidati sono stati esclusi, su conservatori di seconda e terza fila, sperando di avere un’Assemblea dove il fronte avversario non abbia personaggi di spicco (mentre i moderati potrebbero eleggere all’Assemblea il presidente Rohani, uno dei candidati ndr.). Poi a moderati e riformisti potrebbe bastare avere 30 eletti all’Assemblea per avere una minoranza di blocco in caso di elezione della nuova Guida Suprema, che per legge deve avere i due terzi dei voti».
Khamenei ha lasciato aperta la porta a queste strategie difensive del fronte moderato-riformista, ma sta cercando di evitare una qualche sortita di riformisti e moderati per mettere le mani sul futuro della Repubblica Islamica nei decenni a venire. Hassan Khomeini, clerico sciita di 43 anni, è il nipote dell’Ayatollah Khomeini, il padre della Rivoluzione del 1979 e la prima Guida Suprema. Gode di molta fama e molta stima in diversi ambienti, ha uno stile moderno ed è considerato vicino al fronte centrista e riformista. Era uno dei candidati all’Assemblea e il suo nome girava già da qualche tempo come possibile successore di Khamenei. Forse proprio per questo il fronte conservatore – probabilmente col placet se non con l’impulso di Khamenei – ha reagito con durezza: il Consiglio dei Guardiani ha escluso la sua candidatura “perché il suo grado di conoscenza della giurisprudenza religiosa non poteva essere stabilito”, contraddicendo i numerosi attestati raccolti in passato nel mondo accademico e religioso. La verità, secondo diversi osservatori, è che Khomeini è considerato da Khamenei troppo riformista e soprattutto troppo vicino a Hashemi Rasfanjani, chierico, ex presidente un tempo molto forte nell’establishment, ora marginalizzato dopo il supporto all’Onda Verde.
Il piano dei moderati e riformisti, di mandare Khomeini, il presidente Rohani e Rasfanjani all’Assemblea per preparare l’ascesa di Khomeini a nuova Guida Suprema è probabilmente fallito. Non solo il loro nome forte è stato “bruciato” dal Consiglio, ma anche la nuova composizione dell’Assemblea pare lasciare poco spazio alle speranze. «La portata e l’estensione delle esclusioni dei candidati – dice ancora Ellie Geranmayeh – ha lasciato molti scettici se queste elezioni possano avere un impatto, anche solo nominale, sulla traiettoria politica dell’Iran». La natura teocratica e conservatrice della Repubblica Islamica può, questa sembrerebbe essere la posizione di Khamenei, essere ammorbidita in situazione di emergenza (ad esempio quando cova il malcontento della popolazione, specie giovane) ma non messa in discussione per il lungo termine.
«Stiamo assistendo a forti tensioni interne all’elite iraniana, in particolare al clero, con Rasfanjani da un lato e Khamenei dall’altro», afferma Pejman Abdolmohammadi, docente di Politiche del Medio Oriente della London School of Economics. «Non credo che queste elezioni – per il Parlamento e per l’Assemblea – possano generare proteste significative da parte della popolazione, non si respira l’aria del pre-Onda Verde. In questo momento la Repubblica Islamica pare decisamente solida. Può darsi che Rasfanjani, se continuasse a sentirsi emarginato anche da Rohani, decida di soffiare sul fuoco, come fece anche nel 2009 ma, ripeto, non mi pare che ci siano situazioni che possano portare a grandi proteste e scontri violenti». Nessuno insomma sembra aspettarsi significativi cambi di rotta da queste elezioni. Da un lato il potere teocratico sembra aver assorbito – grazie anche alla linea moderata di Rohani – il malcontento popolare. Dall’altro uno scontro tutto interno all’establishment della Repubblica Islamica non pare sufficiente a compromettere la stabilità ritrovata negli ultimi anni.
@TommasoCanetta
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Nella seconda settimana di Febbraio sono arrivate notizie di segno opposto sulla Siria. Mentre da Monaco il segretario di Stato americano John Kerry e il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov annunciavano un’intesa per un cessate il fuoco che inizi (teoricamente) il 18 febbraio, il dittatore siriano Bashar al Assad annunciava la sua determinazione a voler riconquistare l’intero Paese, e l’Arabia Saudita e la Turchia – sue nemiche – lasciavano trapelare la propria disponibilità a l’invio di truppe di terra in Siria “per combattere lo Stato Islamico”.
Un nemico quest’ultimo contro cui tutti hanno schierato le proprie truppe, la Russia in primis, ma che quasi nessuno pare intenzionato a combattere realmente, preferendo accanirsi sui propri rivali (sunniti o sciiti a seconda dello schieramento di appartenenza).
Dietro le parole della diplomazia si nasconde una situazione estremamente confusa e rischiosa. Il “cessate il fuoco” sembra esistere solo sulla carta, visto che esclude non solo l’Isis, ma anche la branca siriana di Al Qaeda, Jabhat al Nusra, e altri gruppi jihadisti (il più significativo dei quali è Arhar al Sham) che sono presenti su tutti i fronti di combattimento o quasi. Se alla Russia è consentito proseguire i bombardamenti contro tali obiettivi – spesso mescolati o comunque vicini a ribelli considerati “moderati” – la tregua è morta prima ancora di nascere. Gli Stati Uniti, proprio per smentire questa lettura del risultato diplomatico di Monaco, hanno avvertito Assad, Russia e Iran (suoi alleati) che se i patti non saranno rispettati si prenderà in considerazione l’ipotesi di inviare truppe di terra in Siria, offrendo così una sponda alle dichiarazioni di Ankara e Riad.
Nell’ipotesi di un’invasione terrestre della Siria da parte di truppe degli Stati sunniti lo scenario, secondo numerosi esperti, diverrebbe estremamente pericoloso: truppe turche, guerriglieri curdi, aviazione e artiglieria russa, aviazione americana, truppe saudite, truppe iraniane e gruppi jihadisti tutti mescolati in un unico teatro bellico. Il rischio è che la partita sfugga di mano ai vari giocatori e la guerra civile – pure già inquinata dagli interessi e dalla partecipazione delle potenze regionali e mondiali – evolva in qualcosa di molto peggio. Alcuni segnali del surriscaldamento della situazione sono già visibili: Ankara ha iniziato a far fuoco con la propria artiglieria su postazioni curde nel nord-ovest – di recente i curdi stavano avanzando dal cantone di Afrin verso est, a danno dei ribelli sostenuti dalla Turchia – e su postazioni lealiste a nord di Latakia; l’Arabia Saudita ha inviato alcuni caccia bombardieri e aerei da trasporto nella base aerea turca di Incirlik, in vista di possibili operazioni congiunte in Siria; gli Emirati Arabi Uniti hanno inviato un ridotto contingente – in accordo con gli Usa – per addestrare guerriglieri sunniti, in teoria in vista dell’assalto a Raqqa, capitale dello Stato Islamico.
Ma al rischio che si scivoli verso un’escalation delle violenze si oppongono molte ragioni. La disponibilità dell’Arabia Saudita a farsi coinvolgere direttamente nella guerra siriana va vista alla luce del già estenuante intervento militare che Riad sta portando avanti, con scarsi successi, in Yemen. Senza contare gli enormi rischi di un confronto diretto con le milizie di Teheran, suo diretto avversario per l’egemonia regionale con cui mai tuttavia c’è stata guerra aperta. Allo stesso modo la Turchia, al di là delle dichiarazioni bellicose, deve muoversi con estrema cautela. Mandando le sue truppe le esporrebbe non solo al rischio di attacchi da parte della guerriglia curda – e quella siriana è ben armata e addestrata -, dell’esercito lealista, degli Hezbollah e delle milizie iraniane, ma anche da parte della Russia. Mosca, dopo l’abbattimento del suo jet ad opera della Turchia, ha schierato in Siria un imponente sistema di contraerea (gli S-400) che gli garantisce la supremazia nei cieli del Paese. Qualsiasi contingente turco sarebbe esposto a gravissimi rischi. Infine gli Stati Uniti sembra che usino lo spauracchio di un’escalation più come arma negoziale che non altro. L’amministrazione Obama è determinata nel non voler mandare il proprio esercito in Siria e, al di là delle parole, non sembra felice di far intervenire i suoi alleati sunniti (Riad e Ankara in particolare). Non a caso Kerry ha immediatamente chiesto alla Turchia di fermare i bombardamenti contro le postazioni curde in Siria, cercando una ricomposizione diplomatica tra le parti.
Il futuro della Siria resta quindi molto incerto, con scarse prospettive di pace da una parte, e abbondanti motivi per non far degenerare la già devastante guerra dall’altra. Le prossime settimane, in particolare con l’arrivo della primavera (quando storicamente si concentrano le operazioni belliche di terra più importanti)diranno se le accelerazioni degli ultimi giorni sono destinate a concretizzarsi, cambiando drasticamente lo scenario del conflitto, oppure se il piano inclinato che al momento avvantaggia il regime di Damasco verrà sostanzialmente lasciato immutato.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

«La Turchia sta preparando un’invasione di terra della Siria». L’accusa arriva direttamente dal portavoce del Ministro della Difesa russo Igor Konashenkov, secondo cui i movimenti di uomini e mezzi turchi al confine siriano sono segnali inequivocabili. Immediata la risposta di Ankara, che smentisce Mosca e anzi rilancia, sostenendo si tratti di una mossa propagandistica del Cremlino per distogliere l’attenzione dalle stragi di civili siriani causate dai bombardamenti russi. Cauti gli Stati Uniti, che tramite il portavoce del Dipartimento di Stato, John Kirby, hanno rifiutato di confermare o smentire le accuse russe o le repliche turche.
Secondo diversi analisti le insinuazioni di Mosca hanno di per sé un valore tattico: parlando apertamente di un’eventualità che si vuole evitare si cerca di “bruciarla”, costringendo il nemico (in questo caso la Turchia) a prendere una posizione ufficiale. Ma l’ipotesi di un intervento diretto nel conflitto siriano da parte di Ankara è qualcosa di più che una speculazione del Cremlino, non fosse altro che negli ultimi anni di guerra civile siriana sono stati proprio i turchi a parlare apertamente di questa ipotesi. La creazione di una “zona cuscinetto” in territorio siriano – sorvegliata dai ribelli, dalla Turchia e, nelle speranze di Erdogan, anche dagli Usa – per accogliere i profughi, tenerli (insieme ai ribelli) al riparo dai bombardamenti lealisti e russi, e (questo è l’ovvio non detto) impedire l’unificazione dei territori curdi siriani, è una richiesta che è stata avanzata spesso e con insistenza da parte di Ankara. Non avendo finora trovato sponda a Washington il progetto è rimasto fermo, ma la possibilità che la Turchia si muova autonomamente non è esclusa. Non solo.
Accanto a quelli che sono i piani – più o meno noti – di Ankara, c’è la situazione sul confine, attualmente molto calda. Già lo scorso 19 gennaio era scattato un allarme, poi rientrato, sull’avvio di operazioni di sconfinamento da parte della Turchia. Da settimane si susseguono scaramucce di confine tra l’artiglieria turca e i miliziani dell’Isis al valico di Jarablus. L’irrequietezza turca si spiega con la piega – “brutta” per gli interessi di Ankara – che stanno prendendo gli eventi bellici in Siria. In primo luogo i curdi siriani – supportati dagli Usa, dalla Russia e pare ora anche dalla Francia – hanno attraversato l’Eufrate e avanzano verso ovest (v. cartina n.1). Il grande fiume era la “linea rossa”, tracciata da Erdogan, passata la quale sarebbe scattato l’intervento militare diretto da parte dell’esercito turco contro l’Ypg. Finora non è successo – hanno pesato la contrarietà dell’alleato americano e il rischio di esporsi a pesanti attacchi militari curdi, russi e lealisti – ma di sicuro ad Ankara non hanno dimenticato. La paura è che i curdi siriani, che ora pare stiano ammassando uomini e mezzi alle porte della cittadina di Manbij in vista di una grande offensiva di primavera, riescano a conquistare l’ultimo tratto di confine – attualmente in mano quasi interamente all’Isis, tranne per un ridotto corridoio controllato dai ribelli –, mettendo così in collegamento i cantoni orientali con quello occidentale, e ottenendo l’unificazione della Rojava (il Kurdistan siriano).

In secondo luogo le forze del regime di Assad – aiutate da truppe iraniane, Hezbollah e aviazione russa – stanno macinando vittorie contro i ribelli sostenuti dalla Turchia nella zona di Aleppo. Di recente i lealisti hanno rotto l’assedio alle cittadine di Zahraa e Nubl, troncando in due il corridoio ribelle che andava dal confine turco alla città di Aleppo e compromettendo così le linee di rifornimento del nemico (v. cartine 2 e 3). Ora la battaglia per il controllo della città vede, secondo gli esperti, le forze lealiste in posizione di netto vantaggio. Inoltre l’avanzata lealista anche nel territorio controllato dall’Isis, verso al Bab, speculare a quella curda verso Manbij (v. cartina n.1), rischia di sigillare un altro tratto di confine, lasciando alla Turchia l’accesso a zone controllate dai ribelli – non isolate in “sacche” – praticamente solo nella provincia di Idlib.
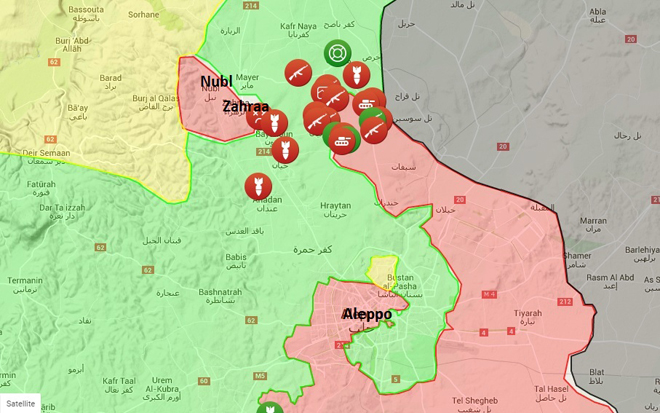

L’opzione militare per Ankara si va complicando col passare del tempo, diventa sempre meno fattibile e sempre più rischiosa. Anche per questo alcuni analisti temono che possa azzardare una sortita fintanto che è ancora in condizione di farlo. Ma qui si arriva alle ragioni per cui alla Turchia non conviene rischiare avventure in Siria. Gli alleati della Nato – americani ed europei – non hanno apprezzato le ambiguità di Erdogan nei confronti dei gruppi jihadisti siriani nel corso degli ultimi anni, e sulla questione dei curdi le visioni sembrano inconciliabili. Gli americani usano l’Ypg come fanteria contro lo Stato Islamico, considerando i curdi siriani come preziosi alleati, mentre per i turchi sono terroristi legati al Pkk (e ne hanno pretesa l’esclusione dai colloqui di pace a Ginevra, del resto subito falliti). Se la Turchia intervenisse direttamente in Siria rischierebbe di esporre i suoi uomini ad attacchi di gruppi che sono stati finora armati, finanziati e supportati dall’Occidente. Inoltre non potrebbe godere della protezione automatica della Nato, che copre solo il caso di attacchi contro la Turchia e non contro suoi uomini impegnati all’estero. Infine una presenza militare turca in Siria sarebbe esposta agli attacchi anche di Mosca, che ha dispiegato ora un imponente dispositivo militare, col rischio di esasperare una situazione già molto tesa.
L’ipotesi valutata come la più realistica dagli esperti è che per ora la Turchia non intenda rischiare un’invasione della Siria. Cercherà piuttosto di trovare delle sponde diplomatiche – e non solo – per contenere i successi curdi, russi e di Assad. L’Arabia Saudita ha da poco dato la sua disponibilità a un intervento di terra in Siria contro l’Isis, se la coalizione a guida americana lo chiedesse. Secondo fonti militari russe si tratterebbe di un bluff, in quanto le forze armate saudite sono già duramente impegnate in Yemen e difficilmente Riad potrebbe sostenere una guerra aperta su più fronti. Tuttavia un impegno diretto delle potenze sunnite, almeno contro lo Stato Islamico, è forse l’unica soluzione teoricamente possibile che non veda del tutto sacrificati i loro interessi. Al momento infatti un’eventuale sconfitta del Califfato porterebbe vantaggi quasi solo all’asse sciita guidato dall’Iran, in prima fila contro gli uomini in nero di al Baghdadi, e ai movimenti curdi. Ad Ankara tocca quindi scegliere tra una difficile – forse impossibile – alleanza militare con i Sauditi (con cui ci sono duri contrasti ad esempio sul ruolo della Fratellanza musulmana, considerata da Riad un’organizzazione terroristica e da Erdogan un prezioso interlocutore) e un immobilismo forzato che avrebbe il sapore di un’accettazione della sconfitta.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

La guerra in Yemen tra i ribelli sciiti Houthi – pare finanziati dall’Iran – e il governo sunnita guidato dal presidente Abd Rabbih Mansur Hadi – supportato dall’Arabia Saudita e da altri Paesi – sta causando una delle peggiori emergenze umanitarie del pianeta. Migliaia i morti, centinaia di migliaia i profughi e milioni le persone che patiscono la fame. Nella disperazione e nel caos prosperano i movimenti jihadisti.
Al Qaeda, che qui ha la sua branca più pericolosa (l’Aqap), e lo Stato Islamico compiono frequenti attentati terroristici, tanto contro obiettivi sciiti quanto contro obiettivi sunniti. Pochi giorni fa un’autobomba, rivendicata dall’Isis, è esplosa davanti al Palazzo Presidenziale ad Aden, capitale provvisoria del governo Hadi – Sanaa è ancora sotto il controllo dei ribelli – dove era da poco rientrato l’esecutivo, rimasto in esilio in Arabia Saudita fino al 25 gennaio scorso. Dieci i morti tra civili e forze di sicurezza. Inoltre i jihadistsi stanno espandendo l’area sotto il loro diretto controllo nel Paese. L’Aqap controlla l’importante porto di Al-Mukallah e il primo febbraio ha conquistato la città di Azzan. Ma la minaccia terroristica non è comunque la principale preoccupazione del governo sunnita e dell’Arabia Saudita, sua protettrice: la guerra scatenata da Riad lo scorso marzo contro gli Houthi si sta trasformando in un Viet Nam. L’Iran sciita, senza dover subire il costo di un coinvolgimento diretto, si avvantaggia delle difficoltà del rivale per l’egemonia regionale, e l’accordo sul nucleare da poco implementato dà alla Repubblica Islamica una tranquillità sul medio periodo senza precedenti.
«L’Arabia Saudita pensava di fare una guerra lampo, invece si ritrova bloccata in una palude», spiega Leandro Di Natala, analista dell’European Strategic Intelligence and Security Center. «L’orografia del Paese, ricco di montagne e caverne, non ha consentito un blitzkrieg. La superiorità tecnologica-militare saudita è servita a poco finora. La guerra è subito degenerata in guerriglia, tanto che gli Emirati Arabi Uniti – non potendo rifiutare la richiesta di Riad di partecipare alla coalizione anti-Houthi – hanno arruolato mercenari sud americani (colombiani in particolare) esperti di guerra non convenzionale. Inoltre lo Yemen non è una vera e propria nazione, è più una somma di tribù e gruppi di potere con diverse agende, molto difficile da controllare anche per i sauditi. In quasi un anno di guerra sono riusciti a conquistare praticamente solo Aden – che comunque è tutt’altro che pacificata -, e ora stanno provando a togliere l’assedio Houthi a Taiz. La capitale Sanaa per ora è ancora saldamente nelle mani degli insorti. A fronte di questi magri risultati, si stima che Riad spenda circa 200 milioni di dollari al giorno per sostenere il suo sforzo bellico».
Il perché di un impegno tanto forte da parte dei Saud si spiega con due ordini di ragioni. Il primo è relativo alla posizione strategica dello Yemen, confine meridionale del regno Saudita e Stato strategico per il controllo dei traffici marittimi sul Mar Rosso. Il secondo riguarda invece lo scontro egemonico in corso con l’Iran. «Da quando si è capito che l’accordo sul nucleare con l’Iran si sarebbe fatto per davvero, i Saud hanno reagito in modo veemente in tutti gli scenari di scontro con Teheran», prosegue Di Natala. «Il nuovo Re, Salman, e il suo entourage hanno inaugurato nell’ultimo anno una politica più aggressiva che in passato nei confronti degli sciiti, si sentono accerchiati: hanno una minoranza sciita all’interno del proprio Stato – stanziata oltretutto in una regione ricca di giacimenti petroliferi – che periodicamente protesta e causa instabilità, in Bahrein la popolazione sciita è costantemente sobillata dall’Iran contro la famiglia regnante sunnita (alleata di Riad), l’Iraq – alleato ai tempi del regime sunnita di Saddam Hussein – è finito nell’orbita iraniana, in Siria gli sforzi per abbattere Assad si sono finora dimostrati inutili, in Yemen i ribelli sciiti si sono rivelati avversari temibili, e sono pericolosamente vicini allo stretto di Bab el Mandeb, che controlla i traffici sul Mar Rosso. Ora, è discusso quanto e come Teheran stia aiutando gli Houthi. Il blocco navale e areo sunnita rende quasi impossibile consegnare armamenti, probabilmente c’è solo un sostegno finanziario. Ma secondo alcuni analisti Riad ha esagerato il ruolo dell’Iran in Yemen a fini di propaganda, per giustificare un intervento col pugno duro contro una ribellione che in realtà ha radici profonde, e che solo di recente si è inserita nella cornice delle proxy war tra Iran e Saud per l’egemonia sul Medio Oriente».
L’Occidente lascia carta bianca a Riad, sostenendo ufficialmente – ma nel modo più silenzioso possibile – la repressione della ribellione Houthi. L’Arabia Saudita infatti, storica alleata degli Usa, è già stata scontentata su altre importanti questioni come, appunto, l’accordo sul nucleare con l’Iran o l’alleanza de facto tra Iran, Russia e Stati Uniti nella guerra allo Stato Islamico in Iraq e Siria. La complicità nella guerra yemenita – mai come ora l’industria bellica occidentale sta vendendo armi a Riad – è stata ritenuta un prezzo ragionevole da pagare, e non senza sostanziosa contropartita economica. Solo che mentre l’intervento diretto saudita in Yemen si sta rivelando complicato e con gravi rischi di fallimento, quello iraniano in Iraq e Siria – anche grazie al recente apporto di Mosca – sembra sempre più destinato al successo. «La casa regnante saudita ha un forte bisogno dello scontro in questo momento. Se adesso sono indeboliti dall’ascesa dell’Iran, un domani lo saranno ancora di più», dice ancora Di Natala. «Gli Stati Uniti si stanno progressivamente disimpegnando dalla regione – anche se bisognerà vedere la linea del prossimo presidente in proposito -, le proxy war in corso vedono quasi ovunque in difficoltà i Saud e i loro alleati, l’Iran sta concludendo affari miliardari con quelli che un tempo erano suoi nemici, e la guerra petrolifera – per cui Riad tiene basso il prezzo del greggio, per danneggiare le esportazioni russe e iraniane – non può durare in eterno: già ora per sostenerla l’Arabia Saudita sembra sarà costretta a depotenziare il proprio stato sociale, uno dei pilastri di stabilità interna. Un domani potrebbe diventare insostenibile. Per rispondere quindi a questo logoramento Riad ha bisogno di ribaltare la situazione, e spera di farlo trascinando in uno scontro violento (anche se non diretto) Teheran. In questa cornice si spiega l’esecuzione di Nimr al Nimr, l’Ayatollah sciita giustiziato lo scorso 2 gennaio (utile anche a compattare il clero fanatico sunnita-wahabita dietro al trono saudita). E così si spiega anche la violenza contro gli sciiti yemeniti. Per ora pare tuttavia che l’Iran non voglia cedere alle provocazioni, conscio di essere in una situazione di momentaneo vantaggio in cui ha tutto da perdere. Se la situazione di violenza endemica in Yemen non troverà uno sbocco, militare o negoziale, il rischio è che tra i due litiganti sia il terzo a pagare il conto: l’Occidente è infatti bersaglio primario per l’Aqap, oltre che per l’Isis – conclude Di Natala – e già in passato lo Yemen è stato usato come base logistica di sanguinosi attentati».
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Nelle ultime settimane la preparazione di un intervento militare in Libia ha subito una netta accelerazione. Sulla stampa internazionale stanno trapelando voci di un imminente avvio di bombardamenti mirati per contenere l’espansione dello Stato Islamico nel Paese. Il generale Usa Joseph Dunford ha parlato apertamente di questa eventualità, collocandola temporalmente “nelle prossime settimane”. Secondo gli esperti far girare questa possibilità è sia una mossa per mettere pressione agli attori politici libici perché raggiungano l’accordo fino ad oggi mancato su un governo unitario, sia un modo per preparare l’opinione pubblica e i mass media occidentali al probabile intervento armato. Pare poi confermato che siano già operativi sul terreno libico diversi nuclei di forze speciali: americani, inglesi, francesi e italiani. Starebbero raccogliendo informazioni di intelligence in vista dei futuri bombardamenti (chi colpire, dove, con chi trattare etc.), e non solo. A Sirte stanno misteriosamente morendo diversi leader dell’Isis colpiti da cecchini non identificati.
Finora era stato considerato requisito necessario, per una possibile azione militare straniera in Libia, l’accordo tra fazioni libiche per un governo di unità nazionale. Due elementi pare abbiano però cambiato la situazione. In primo luogo il processo politico di creazione del governo unitario va a rilento. Il parlamento di Tobruk – unico riconosciuto internazionalmente – non ha approvato la lista di ministri che il premier Mohamad Fayaz al Sarraj, incaricato di formare un governo dopo la firma dell’accordo in Marocco, ha presentato in prima istanza. Formalmente perché i ministri (trentadue) erano troppi, in realtà pare che abbia pesato l’opposizione del generale Haftar, capo militare delle forze di Tobruk e grande escluso dalla lista. In secondo luogo l’espansione dello Stato Islamico, che oltre a minacciare da vicino gli impianti petroliferi si teme possa saldarsi con i movimenti jihadisti del Sahel e con Boko Haram, ha accresciuto l’urgenza di un intervento. Ora è quindi possibile che l’Occidente avvii i bombardamenti contro l’Isis anche senza una formale richiesta da parte di un legittimo governo libico.
«La nascita di un governo unitario è una possibilità che ancora non si può escludere ma, considerato l’andamento delle trattative fino ad oggi, non sono ottimista», spiega Arturo Varvelli, ricercatore dell’Ispi ed esperto di Libia. «I nodi che hanno impedito il successo del negoziato finora sono tutt’ora irrisolti, in particolare il ruolo che avrà il generale Haftar nel futuro della Libia e la perdurante ostilità all’accordo delle potenti milizie della Tripolitania che fanno riferimento al presidente islamista del Parlamento di Tripoli, Nuri Abu Sahimin. Se non verrà trovata un’intesa – al di là di quelle che sono le indiscrezioni di stampa – l’opzione militare di cui si discute sarà molto problematica. Da un lato è resa urgente dalla presenza dello Stato Islamico, dalla paura della sua espansione e fusione con altri gruppi, e dal rischio che destabilizzi Egitto e Tunisia. Dall’altro, intervenendo senza un accordo con gli attori libici, si correrebbe il rischio di spingere tra le braccia dell’Isis altre sigle jihadiste e di screditare definitivamente qualsiasi governo unitario (a quel punto palesemente irrilevante o peggio “fantoccio” dell’Occidente). La mancanza di chiarezza poi sugli obiettivi dell’eventuale missione – contenimento dell’Isis, State building, protezione della capitale etc. – è poi un altro ostacolo. Iniziare una guerra», conclude Varvelli, «senza avere perfettamente chiaro verso quale fine si tenda è un grave errore, si pensi al caso dell’Iraq nel 2003. E se anche in Libia l’obiettivo fosse estirpare lo Stato Islamico non è coi bombardamenti mirati che si può ottenere il risultato. Serve una pacificazione nazionale che faccia cessare lo stato di anarchia in cui prospera l’Isis».
«Se continuerà lo stallo decisionale e nel breve periodo non sarà formato un governo unitario, credo che le possibilità di un intervento armato aumentino», sostiene Mattia Toaldo, analista dell’European Council on Foreign Affairs. «Si tratterebbe a quel punto di un intervento minimo, bombardamenti aerei mirati su obiettivi precisi. Inutile, secondo me, dal momento che senza forze di terra è impossibile risolvere alla radice il problema. Questo tipo di azione sarebbe poi quasi interamente decisa a Washington, e più al Pentagono che non alla Casa Bianca. All’Italia spetterebbe un ruolo ancillare. Diverso sarebbe se invece un governo unitario nascesse e richiedesse l’aiuto dell’Occidente. A quel punto si potrebbe discutere di se e come mettere in sicurezza la capitale, pianificare un intervento che coinvolga anche truppe di terra, addestratori, forze speciali, e l’Italia potrebbe aspirare a un ruolo di guida e coordinamento vista la sua conoscenza dello scenario. Ma in questo momento mi sembra che una simile prospettiva si sia ulteriormente allontanata».
L’Italia si sta comunque preparando all’eventualità che un accordo venga raggiunto – l’Unione europea ha fatto trapelare l’ipotesi di emettere sanzioni contro gli attori libici che stanno sabotando il negoziato, affiancando alla pressione bellica anche quella diplomatica – e le venga assegnato un ruolo preminente nella eventuale coalizione. «In caso di un intervento militare basato su bombardamenti e forze speciali – lo scenario che al momento è ritenuto più probabile, anche se l’accordo venisse raggiunto – gli Stati Uniti sarebbero ovviamente quelli che si occuperebbero del controllo aereo, essendo gli unici che hanno a disposizione i mezzi necessari per farlo», spiega Claudio Neri, direttore dell’Istituto italiano di studi strategici. «Italia, Francia e Uk avrebbero probabilmente forze speciali a terra (per l’Italia si parla degli uomini del Comsubin e del Col Moschin). In questo contesto Roma potrebbe ottenere un ruolo guida per diversi motivi. In primo luogo è geograficamente vicina, ha degli asset logistici che mancano agli altri Stati. Poi è lo Stato che meglio conosce i gruppi e la situazione sul terreno, può fornire un aiuto in termini di intelligence politica e strategica (quella tattica sarebbe lasciata agli Usa). La Francia potrebbe ambire a un ruolo analogo ma è già impegnata su molti scenari (secondo alcune fonti il rifiuto di Renzi di sostituire truppe francesi in scenari di guerra all’indomani degli attentati di Parigi nasceva da questo calcolo di interessi sulla Libia ndr.), e – conclude Neri – dall’intervento contro Gheddafi del 2011 non ha brillato per competenza nella gestione di questo scenario». Al momento questa resta comunque l’opzione minoritaria ma l’alternativa di un intervento ridotto e senza “invito” da parte dei libici, se ha il pregio di sottrarre l’Occidente al ricatto dell’immobilismo delle fazioni, avrebbe sicuramente il difetto di comportare gravi rischi con poche chance di ottenere successi duraturi.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

La nuova strategia russa per la sicurezza nazionale, pubblicata il primo gennaio 2016, inserisce l’espansionismo della Nato in Est Europa e il sostegno occidentale alle “rivoluzioni colorate” (dei colpi di stato illegittimi, secondo Mosca) tra i principali pericoli che minacciano la Russia. Secondo gli esperti non è uno sviluppo recente – anche se potenzialmente pericoloso – che l’intellighenzia del Cremlino consideri la Nato come una rivale, e non più come un possibile partner.
Il meeting di Pratica di Mare, del 2002, quando per la prima volta le porte della Nato si aprirono all’ex nemico sovietico per discutere di una maggiore cooperazione, è un ricordo sbiadito. I rapporti tra l’Occidente e la Russia sono in deterioramento da quasi un decennio. Da quando, nel 2008, Mosca dimostrò di essere pronta a fare una guerra in Georgia pur di difendere la propria sfera di influenza strategica dalla costante erosione che aveva subito negli ultimi anni, fino ad arrivare all’annessione della Crimea nel 2014 con le seguenti sanzioni occidentali all’economia russa.
L’espansionismo della Nato in Est Europa comincia poco dopo la caduta dell’Unione Sovietica e porta nella sfera di influenza occidentale Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca nel 1999; Romania, Bulgaria, Slovacchia, Repubbliche Baltiche e Slovenia nel 2004; Albania e Croazia nel 2009, ed è attesa nel 2016 l’adesione all’Organizzazione del Montenegro. Tale costante erosione viene subita o tollerata da Putin durante i suoi primi anni di presidenza (cominciata nel 2000), quando le frizioni con Washington – sulla guerra in Iraq e soprattutto sullo “scudo anti-missile” che George W. Bush voleva dispiegare in Est Europa -, già cominciavano a incrinare il clima di cooperazione con l’Occidente instaurato dai suoi predecessori, Gorbachev e Eltsin. A partire dagli ultimi anni del secondo mandato di Putin (2007-08) in poi, l’atteggiamento della leadership russa diviene marcatamente più aggressivo. Potendo, forse per la prima volta dal 1989, porre un freno all’erosione della potenza russa, Putin dimostra (in Georgia prima, e in particolar modo in Ucraina poi) di essere disposto a prendere dei rischi – e a imporre alla sua popolazione sacrifici economici e non solo – pur di ottenere un tale risultato.
“Storicamente la Russia ha bisogno del nemico esterno, della sindrome da accerchiamento per poter consolidare la propria leadership interna. Putin non fa eccezione”, spiega Claudio Neri, direttore dell’Istituto italiano di studi strategici. “Così si spiega in parte il testo della nuova Strategia per la sicurezza nazionale. Ma non solo. Da un punto di vista strategico la Russia ha come obiettivo – esplicitato nella Strategia – di confermare il proprio status di potenza globale. Si tratta quindi di rallentare il declino che, complici un’economia fondata su materie prime (gas e petrolio soprattutto) il cui prezzo è in picchiata sui mercati e un andamento demografico calante, per ora sembra inevitabile. Per farlo Mosca deve assolutamente difendere le posizioni geo-strategiche che ancora tiene, e così si spiegano gli interventi in Ucraina prima (dove l’influenza russa è in calo) e in Siria poi (dove al contrario, complice la quasi-assenza degli Usa, Mosca ha aumentato il peso della propria presenza). I due scenari non sono tuttavia equivalenti: l’Ucraina è molto più importante per il Cremlino, e credo che nelle trattative sul futuro della Siria Putin cercherà di avere delle contropartite dall’Occidente su questo scenario piuttosto che non in Medio Oriente”.
Per evitare che Kiev finisca definitivamente nell’orbita occidentale – i Paesi dell’Est, nuovi membri Nato, sono molto attivi su questo fronte -, Mosca sarebbe dunque disposta a concedere qualcosa sulla Siria. E se anche questo scambio (già stigmatizzato dagli Stati Uniti) non dovesse avvenire, il Cremlino spera di assistere a un collasso “spontaneo” dell’Ucraina, tale da farla rientrare nei giochi. L’economia ucraina è infatti in grave crisi, e solo un’inedita decisione del Fondo Monetario Internazionale di non dichiarare il default dell’Ucraina a fronte del non pagamento di un prestito di tre miliardi della Russia ha finora evitato lo sfascio. Anche la leadership politica di Kiev è in difficoltà, con sondaggi che le danno un consenso ai minimi storici. L’Unione europea poi – ad eccezione dei Paesi dell’Est, come Polonia e Repubbliche Baltiche – non sembra pronta a farsi carico di uno Stato povero e quasi-fallito solo per danneggiare gli interessi russi. Considerato l’accento posto dalla nuova Strategia russa su questo dossier, è probabile che alla prima opportunità il Cremlino provi a riguadagnare posizioni anche nella partita ucraina.
“Putin è un bravo tattico, se vede una possibilità di solito è abile nel coglierla”, prosegue Claudio Neri. “L’aumento della tensione nell’Est Europa è comunque molto pericoloso. Se le manovre della Nato dovessero spingere il “cerchio magico” che sostiene Putin – nessun autocrate o dittatore governa mai da solo – a chiedere una dura risposta, rischieremmo di assistere a manovre destabilizzanti che fanno perno sulle minoranze russofone nei Paesi dove queste sono abbastanza cospicue, come ad esempio nei Paesi Baltici (un modus operandi questo già visto in Georgia e in Ucraina ndr.). Questo è uno scenario su cui da un po’ di tempo il Pentagono sta compiendo studi e simulazioni. Se una delle Repubbliche Baltiche dovesse essere destabilizzata e magari attaccata da Mosca, considerato che si tratta di membri Nato, l’Occidente si troverebbe di fronte alla scelta se scatenare una guerra contro la Russia o se accettare la morte di fatto della Nato. Questa ipotesi fa ancora più paura – conclude Neri – se si considera che con la fine della guerra fredda è andata perdendosi la consuetudine e la preparazione militare – tra Mosca e Washington – alla de-escalation, che eviti il precipitare della situazione verso scenari da terza guerra mondiale”.
La maggior parte degli analisti ritiene comunque minoritaria l’ipotesi che la Russia possa attaccare un Paese membro della Nato. Spesso questo spauracchio è anzi stato usato dai governi dei Paesi dell’Est per chiedere una maggior presenza militare occidentale sul proprio territorio, e anche per fini di politica interna (la paura del nemico alle porte è carburante per la retorica dei partiti nazionalisti, quale che sia il loro Paese). Tuttavia l’attenzione resta molto alta. La Nato si trova nella difficile posizione di continuare da un lato la sua politica di espansione (ora sono i Balcani al centro del contendere con Mosca), di prevenire provocazioni da parte della Russia (in questo senso si spiega anche la ultima grande esercitazione del 2015), e di evitare che siano le sue di mosse a scatenare reazioni esasperate. Specularmente la Russia deve contrastare l’espansione Nato – pare che sia già molto attiva in Serbia e nella Republika Srpska di Bosnia -, prevenire le “rivoluzioni colorate” nei pochi Stati-satellite che le rimangono, ed evitare di dare pretesti all’Occidente per ledere gli interessi russi (come successo con le sanzioni dopo l’annessione della Crimea). Un tavolo affollato di tessere dove l’effetto domino è un pericolo sempre presente.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

La Libia ha un piede e mezzo nel baratro del caos. Quasi due anni di guerra civile – con due parlamenti (a Tripoli e Tobruk) impegnati a combattersi, una crescente infiltrazione dello Stato Islamico a Sirte, una dilagante frammentazione del potere, con bande criminali, milizie e gruppi jihadisti che prosperano nell’anarchia – hanno ridotto allo stremo l’economia e quel che resta del tessuto sociale libico.
L’accordo firmato da diversi rappresentanti delle due assemblee legislative (e non solo, anche sindaci e capi tribù) in Marocco il 17 dicembre, sotto una determinante spinta della comunità internazionale, è l’estremo tentativo di salvare il Paese, pedina fondamentale nel Mediterraneo per il controllo dei flussi migratori e per il mercato energetico.
«Credo che si sia fatto bene a procedere col negoziato, pur con la contrarietà dei presidenti dei parlamenti di Tripoli e Tobruk. Finora gli era stato concesso un ruolo di interdizione politica esagerato rispetto al reale seguito che avevano nel Paese. Se avessimo aspettato un loro via libera saremmo probabilmente andati avanti all’infinito. Ma tanto premesso, secondo me questo accordo resta una scommessa, e con poche chance di risultare vincente», sostiene Arturo Varvelli, ricercatore dell’Ispi ed esperto di Libia. «Sono scettico sul fatto che possa reggere, in particolare perché – pur esprimendo il massimo dello sforzo internazionale – è un accordo di carattere politico, e la politica in Libia conta relativamente poco. Conta chi ha le armi in mano, le milizie, e tra queste non si può escludere che siano numerose quelle tentate dal creare una fronda ostile all’intesa. Molto si capirà dalla fase di implementazione dell’accordo delle prossime settimane. Si farà un patto sulla sicurezza che consenta al nuovo governo di insediarsi a Tripoli? Al momento Paolo Serra (consigliere militare dell’Onu, che affianca il tedesco Kobler nella sua missione diplomatica in Libia) sta ancora trattando, un compromesso condiviso ancora non è stato trovato. Se lo fosse, allora si potrebbe ragionare sul portare il governo unitario nella capitale, e magari assisterlo con una missione internazionale di addestramento dell’esercito libico e di State Building. Ma senza un via libera da parte degli attori locali tutto questo sarebbe impossibile, e proprio sulla difficoltà di costringere le varie milizie a un’intesa si fonda il mio scetticismo».
Un tentativo di sabotaggio dell’accordo sarebbe già in corso. «I falchi dei due parlamenti hanno incaricato diciassette deputati per parte di condurre una trattativa “libica-libica” – cioè senza l’assistenza della comunità internazionale –, parallela a quella nata dalla firma dell’accordo in Marocco del 17 dicembre, con lo scopo di far deragliare quest’ultima», spiega Mattia Toaldo, analista dell’European Council on Foreign Relations. «Per ora sembra comunque che la maggior parte delle milizie più importanti sostenga l’intesa promossa dalla comunità internazionale, e il negoziato ha visto una partecipazione alta (anche se non altissima) dei vari attori libici. Tuttavia la situazione resta delicatissima. Nei 40 giorni che sono stati dati al nuovo governo unitario per strutturarsi – possibile che i tempi si allunghino, come già spesso accaduto in passato in Libia – il deragliamento del processo istituzionale è dietro l’angolo. La Russia, che pure ha sostenuto il recente accordo, ha già espresso alcune perplessità tramite il ministro Lavrov, e ha ospitato alcuni delegati dell’assemblea di Tripoli ostili alla trattativa. Le potenze sunnite, anche loro a parole favorevoli all’intesa, a fronte di eventuali fibrillazioni sul terreno potrebbero tornare a interferire nella questione libica. Insomma l’incidente è una seria possibilità. Bisognerà capire se gli esclusi dal nuovo governo di unità nazionale saranno abbastanza forti per impedirgli di svolgere le sue funzioni. Un altro rischio poi – prosegue Toaldo – è quello che alcuni attori stiano cercando di provocare un intervento militare occidentale, agitando lo spauracchio della caduta di Ajdabiya (importante snodo petrolifero) nelle mani dell’Isis. Se la provocazione dovesse riuscire il neonato governo sarebbe di fatto in un vicolo cieco: se appoggiasse apertamente l’intervento occidentale confermerebbe la propaganda dei suoi detrattori che già lo dipingono come fantoccio di europei e americani, se invece si opponesse si paleserebbe la sua irrilevanza. L’unica soluzione compatibile con la salvaguardia della credibilità del nuovo governo è che anche la questione Stato Islamico venga affrontata in primo luogo dai libici. Per aiutarli l’Europa, e l’Italia in particolare, al massimo può intestarsi una missione di addestramento delle truppe regolari libiche (qualora venissero costituite), ma al momento è impensabile che prepari un intervento militare di terra. Eventuali soluzioni intermedie poi – appunto, bombardamenti “stranieri” contro una città libica occupata dall’Isis, ma in maggioranza abitata da civili, come Sirte – rischiano di essere controproducenti».
Anche il tempo non scorre a favore della soluzione negoziale del caos libico. «Se dovesse proseguire la situazione di anarchia e frammentazione delle istituzioni – anche finanziarie – del Paese, il totale sfacelo sarebbe inevitabile», dice ancora Varvelli. «Già adesso la Banca centrale è costretta a pagare gli stipendi di due amministrazioni distinte (Tripoli e Tobruk) e le esportazioni di gas e petrolio da tempo sono a un quinto delle normali capacità. Senza una tregua che porti a una soluzione unitaria presto i soldi a livello centrale finiranno. Con la possibilità che l’unico governo “legittimo” sia in esilio (magari in Tunisia, mentre le assemblee di Tobruk e Tripoli restano al loro posto, “protette” da milizie fedeli), il rischio che il controllo dell’economia finisca quasi interamente nelle mani dei gruppi armati, criminali e jihadisti sarebbe molto serio. In un simile scenario – in cui appunto l’accordo siglato in Marocco si rivelasse lettera morta – potrebbe anche tornare credibile la possibilità di scissione del Paese, tra Cirenaica e Tripolitania. Ciò sarebbe possibile – conclude Varvelli – specialmente se un attore militarmente forte (ad esempio il generale Haftar, finora sponsor di Tobruk) operasse una scissione di fatto. A quel punto un riconoscimento informale da parte delle potenze regionali sarebbe probabile, e l’unità della Libia definitivamente compromessa».
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Nel Medio Oriente sconvolto dalla faida tra sunniti e sciiti (alimentata dallo scontro tra Arabia Saudita e Iran), dalla minaccia dello Stato Islamico, dalle guerre in Siria, Iraq, Libia, Yemen e, più in generale, dallo sfaldamento dell’ordine regionale che aveva retto per l’ultimo secolo, un importante attore è finora rimasto ai margini della scena: Israele.
Negli ultimi anni Tel Aviv si è avvantaggiata della guerra in Siria e dello scontro interno al mondo musulmano. Gli Stati che storicamente supportavano la causa palestinese con armi e finanziamenti – Iran, Siria, Arabia Saudita, Qatar, più di recente Turchia etc. – sono impegnati a combattersi gli uni con gli altri, e in generale l’attenzione verso la Palestina è ai minimi storici. Non è un caso che la nuova esplosione della rabbia e della frustrazione palestinese nei territori occupati e in Cisgiordania abbia come proprio simbolo il coltello. Dopo le ultime operazioni delle forze armate israeliane – in particolare i bombardamenti a Gaza dell’estate del 2014 – ai gruppi armati palestinesi è rimasto poco materiale bellico a disposizione.
Fin dagli albori della guerra in Siria – in particolare da quando, per aiutare Assad, è entrata in scena la milizia sciita libanese Hezbollah, storico e pericoloso nemico di Israele – sono circolate voci che l’aviazione di Tel Aviv violasse occasionalmente lo spazio aereo di Damasco per colpire determinati obiettivi, ritenuti potenzialmente pericolosi per la sicurezza nazionale. Lo scorso primo dicembre è arrivata la conferma ufficiale, direttamente dal primo ministro israeliano: «Abbiamo condotto operazioni occasionali in Siria» ha dichiarato Netanyahu in un incontro pubblico ad Acri, «per evitare che diventi un fronte contro di noi e per contrastare il trasferimento di armi letali, specialmente dalla Siria al Libano».
Ma la superiorità aerea di Israele, che gli ha consentito finora di agire di nascosto e in modo indisturbato, è da pochi mesi in discussione, e da poche settimane nei fatti venuta meno. Il coinvolgimento diretto della Russia nella guerra siriana ha infatti cambiato le regole del gioco, e il recente dispiegamento in Siria dei sistemi missilistici S-400 (in risposta all’abbattimento del cacciabombardiere russo ad opera dell’aviazione turca) garantisce a Mosca un controllo quasi totale dello spazio aereo, consentendogli di rilevare e abbattere qualsiasi aereo si alzi in volo nei cieli della regione. Di fronte a questa situazione Israele non ha esitato a muoversi di conseguenza.
«La visita di Netanyahu a Mosca lo scorso settembre, subito dopo l’inizio dei bombardamenti russi in Siria, era probabilmente almeno in parte intesa a trovare un accordo che assicurasse a Israele la perdurante libertà di colpire obiettivi all’interno della Siria», spiega Yezid Sayigh, senior associate del Carnegie Middle East Center. «Allo stesso tempo Netanyahu voleva rassicurazioni da Putin che Hezbollah e l’Iran non avrebbero potuto approfittare della copertura russa per importare armi “strategiche” nel Paese». Finora questo accordo pare abbia funzionato – anche se, secondo alcuni analisti, non ci sono state azioni israeliane in Siria da quando Mosca ha posizionato gli S-400 – e non senza contropartita per Mosca. Gli aerei russi, come confermato anche dal generale israeliano Amos Gilad, hanno occasionalmente violato lo spazio aereo israeliano, senza subire – a differenza di quanto accaduto in Turchia – ritorsioni: i piloti sono stati avvisati e hanno immediatamente invertito la rotta. In generale il coordinamento tra i militari russi e israeliani – come affermato anche dall’ex ministro degli Esteri israeliano Avigdor Lieberman – è assolutamente costante.
Quello che, secondo gli esperti, sarà fondamentale capire nel prossimo futuro è se un simile accordo possa reggere alle tensioni che lo scenario siriano genera in continuazione. La Russia, sostenendo Assad insieme all’Iran e a Hezbollah, non dovrebbe godere delle simpatie di Israele, che da sempre considera “l’asse sciita” come la principale minaccia alla propria sicurezza. E tuttavia Mosca ha tutto l’interesse a non esacerbare i rapporti con Tel Aviv e finora si è mostrata sensibile alle esigenze israeliane di impedire che armi in grado di alterare l’equilibrio strategico (che vede l’esercito con la stella di Davide in posizione di irraggiungibile vantaggio) entrino nella regione. Piuttosto Putin sembra disposto ad accettare una qualche corrispondente frizione nei rapporti con Teheran, che pure non dovrebbero degenerare nel breve periodo. «Iran e Russia hanno sfere di influenza distinte in Siria», spiega ancora Yezid Sayigh. «Fintanto che la Repubblica Islamica iraniana potrà far entrare uomini e materiali in Siria, presumo che l’accordo tra Russia e Israele non cambierà troppo i rapporti esistenti e le cose potranno essere sempre aggiustate». L’Iran, almeno al momento, sembra infatti molto più determinato a impedire la caduta di Assad sconfiggendo la guerriglia siriano-sunnita (foraggiata da Turchia e Saud soprattutto) che non a porre le basi per future minacce alla sicurezza di Israele, tanto che avrebbe accettato la mediazione russa con Israele volta a congelare gli attacchi di Hezbollah (anch’esso al momento comunque più impegnato a combattere i sunniti che gli israeliani) dal Golan.
Ma nel medio periodo le cose potrebbero cambiare. Come rilevato da diversi analisti occidentali e non, Russia e Iran hanno diverse agende per la regione e per la Siria stessa. Se Mosca infatti vorrebbe riportare la Siria nelle mani dei militari, laici, legati al regime Baathista di Assad, Teheran è più interessato a farne il santuario di consistenti e forti milizie sciite (alla pari di Hezbollah in Libano), utili un domani nel perseguire lo scontro con l’Arabia Saudita e le altre potenze sunnite. Inoltre le vedute dei due Paesi differiscono proprio circa l’atteggiamento da tenere verso Israele: l’Iran vorrebbe che la “nuova” Siria che emergerà al termine della guerra tornasse ad essere un baluardo anti-israeliano e un ponte tra Teheran e Hezbollah, la Russia invece – che da tempo sta cercando di forgiare buoni rapporti con Israele, e che nell’attuale escalation con la Turchia può contare sulla simpatia di Tel Aviv (fredda con Erdogan dai tempi della guerra di Gaza del 2008-09) – vorrebbe l’esatto contrario. Nella complessità e nella liquidità dell’attuale scenario mediorientale è comunque impossibile pronosticare se queste alleanze e accordi “a geometrie variabili” siano destinate a resistere nel tempo, e il rischio di un incidente è sempre presente.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Quella in Yemen è una guerra quasi ignorata dall’Occidente. E non senza un motivo. Dopo la rivolta della minoranza sciita del Paese (Houthi) che ha causato la caduta del precedente governo – nato all’indomani della Primavera araba che nel 2012 aveva posto fine alla trentennale presidenza di Ali Abdullah Saleh e guidato dal sunnita Abed Rabbo Mansour Hadi – e l’occupazione della capitale Sanaa da parte dei ribelli, lo scorso marzo è intervenuta l’Arabia Saudita (poi sostenuta da Egitto, Emirati e altri Stati arabi sunniti).
Riad infatti temeva di perdere (a vantaggio del nemico sciita iraniano) la propria influenza su uno Stato strategico sia militarmente sia per il controllo del traffico marittimo, e che la rivolta sciita potesse sconfinare nel proprio territorio (dove pure abita una minoranza sciita, insofferente verso la casa regnante sunnita). I bombardamenti sono da subito stati molto violenti, spesso indiscriminati, e hanno contribuito a causare – secondo quanto riferito dall’Onu – una delle peggiori crisi umanitarie del pianeta. Gli Houthi, sostenuti dall’Iran e dall’ex presidente Saleh, stanno tuttavia opponendo una strenua resistenza, e questo accresce il costo (economico e in termini di vite umane) della guerra. L’Occidente – alleato dei Sauditi e che sullo Yemen ha lasciato carta bianca a Riad, per evitare di irritare il proprio partner già furibondo per l’accordo sul nucleare siglato dai suoi alleati con l’Iran – ha tutto l’interesse a parlarne il meno possibile. Ma se evitare di parlarne significa evitare di preoccuparsi di quanto sta succedendo, il rischio è che si stia commettendo un tragico errore. Nel caos yemenita sta infatti trovando terreno fertile per tornare all’antico splendore Al Qaeda, da sempre qui presente con la sua branca più pericolosa, l’Aqap (Al Qaeda in the Arabian Peninsula).
Prima della guerra civile, il caso yemenita veniva portato dagli Usa come esempio di un efficace contrasto al jihadismo, mediante la collaborazione tra i droni americani e le truppe di terra di Sanaa. Oggi, con le truppe di terra yemenite impegnate nella guerra civile, non è più così. «Innanzitutto non si può operare con soli droni contro il terrorismo», spiega Germana Tappero Merlo, analista di intelligence ed esperta di terrorismo. «Se anche colpisci un membro importante, non solo viene subito sostituito ma nell’azione sono più i danni collaterali (uccisioni di civili innocenti) che vantaggi a lungo termine. Poi l’Aqap è avvantaggiato anche dall’essere situato geograficamente ai margini dell’area di conflitto vero e proprio tra Houthi e coalizione a guida saudita». Il territorio controllato dall’Aqap si estende in fatti nella zona centrale del Paese, dal confine con l’Arabia Saudita fino al porto di Al Mukalla. Qui i ribelli sciiti non arrivano – tendono a muoversi soprattutto nelle aree dove sono etnicamente radicati – e le bombe saudite, per una convenienza tattica di breve periodo, non cadono.
«Non è un caso che la guerra si stia combattendo esclusivamente nell’area occidentale del Paese» spiega ancora Tappero Merlo. «Lo Yemen – che è un paese non certo ricco di greggio – è vittima di questo conflitto, combattuto sotto le mentite spoglie di una guerra civile interconfessionale musulmana, esclusivamente per la sua posizione geografica strategica: chi controlla lo stretto di Bab el-Mandeb controlla le vie marittime passanti dall’Oceano Indiano al Mar Rosso e fino a Suez, e da lì al Mediterraneo. È facile immaginarne la valenza dal punto di vista economico ma soprattutto militare: lo scontro fra Iran e Arabia Saudita è per il dominio regionale, avere un trampolino di lancio del genere verso un’Africa con Paesi come Somalia, Sudan e Libia nel caos, o un Egitto non ancora del tutto stabile, è di importanza capitale».
In questa, ennesima, proxy war tra Teheran e Riad il campo saudita ha dato l’ennesima dimostrazione di non farsi troppi scrupoli nell’armare e sfruttare a proprio vantaggio formazioni estremiste sunnite, pur di contrastare gli sciiti (sospettati sempre di essere longa manus dell’Iran). «Dal ’94 in Yemen è al potere al-Islah – una formazione politica islamista n.d.r. – sostenuta da sottogruppi come i Fratelli Musulmani e dotata di una omonima milizia armata», dice ancora Tappero Merlo. «Era stato proprio per contrastare l’avanzata di queste e di altre forze salafite (e vicine alla Fratellanza), all’indomani della Primavera araba, che gli Houthi avevano deciso di scatenare la rivolta contro il potere centrale. A quel punto è intervenuto anche l’Iran, che ha inviato consiglieri militari (primi fra tutti Hezbollah), che hanno dato vita a un gruppo-milizia chiamato Ansarollah. Ciò ha permesso e sta permettendo agli Houthi di evolvere da clan più perseguitato della Penisola Arabica a potente forza popolare in grado di togliere terreno ai salafiti di al-Islah, e tutto quanto ad esso collegato, anche frange estreme come l’Aqap. La reazione di quest’ultima non si è fatta attendere, anche con attentati kamikaze in moschee sciite, e Riad non sembra interessata ad arginarla».
Se la pericolosità del lasciare indisturbato – e anzi, rafforzato – l’Aqap riguardasse solamente l’ennesima proxy war tra Iran e Arabia Saudita sarebbe comprensibile la disattenzione occidentale. Ma Al Qaeda ha da sempre avuto come propria strategia – per ottenere visibilità, finanziamenti e anche per ragioni ideologiche – il portare attentati anche sul suolo occidentale. A differenza dell’Isis, poi, Al Qaeda non si basa tanto sull’operato di “lupi solitari” quanto sull’azione di cellule addestrate, che preparano un’azione magari per anni prima di compierla. Lasciare all’Aqap una zona franca in cui poter addestrare e armare eventuali terroristi (come avvenuto, pare, per la strage di Charlie Hebdo) comporta gravi rischi nel medio periodo. Soprattutto ora, che pare anche l’Isis si sia infiltrato in Yemen (ha già rivendicato alcuni attentati contro gli sciiti). «Quel che trovo più allarmante – conclude Tappero Merlo – è una possibile evoluzione delle relazioni fra al-Qaeda e Isis (di recente il leader di Al Qaeda, al Zawahiri, ha lanciato un messaggio che pare preludere a un’alleanza tra i due gruppi n.d.r.) che li porti a unirsi. Questa unione potrebbe avere effetto in Yemen e, da lì, muoversi per il resto della regione e magari minacciare l’Occidente».
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
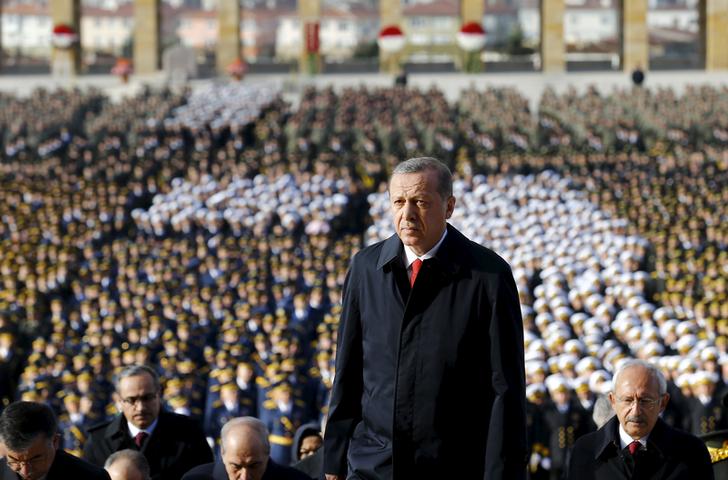
La netta vittoria del partito islamico Akp nelle ultime elezioni parlamentari in Turchia, lo scorso primo novembre, è soprattutto una vittoria del Presidente Erdogan: la sua strategia della tensione ha pagato. Grazie all’infiammarsi dello scontro con i guerriglieri marxisti del Pkk curdo e al dilagante senso di insicurezza, i voti dei nazionalisti – e forse anche della componente più conservatrice-islamica degli stessi curdi – sono confluiti sul suo partito.
Mancata di poco la soglia numerica di deputati per modificare senza difficoltà la Costituzione (ne servono 330 e l’Akp ne ha guadagnati 316), gli analisti ritengono comunque questo obiettivo a portata nel prossimo futuro per Erdogan, che non ha mai fatto mistero di propugnare una svolta presidenzialista. Ma se all’interno della Turchia la presa del leader islamico si fa sempre più forte – le ultime notizie che arrivano da Ankara parlano di ennesimi arresti di giornalisti ostili a Erdogan -, verso l’esterno la sua linea rimane traballante e potenzialmente pericolosa.
I rapporti con il mondo sciita – Iran, Iraq, Hezbollah libanese etc – si sono deteriorati negli ultimi cinque anni, da quando Erdogan, abbandonando la tradizionale linea turca “nessun attrito coi nostri vicini”, ha deciso di supportare la Primavera araba in Siria per rovesciare il dittatore alawita (setta assimilata agli sciiti) Bashar al Assad. All’epoca la Turchia coltivava infatti l’obiettivo di avere un ruolo di “madrina” nei confronti delle ribellioni capeggiate dai Fratelli Musulmani che stavano dilagando nel mondo arabo, e riconquistare così un ruolo egemone nella regione. Degenerata in una proxy war tra Teheran e Riad, la guerra civile siriana ha visto comunque la Turchia al fianco dei Sauditi nell’aiutare i ribelli – anche i qaedisti, e per un certo periodo pare anche lo stesso Stato Islamico – pur di abbattere il regime di Damasco, specularmente aiutato dall’asse sciita (Ankara è anche sospettata di aver favorito per lungo tempo l’Isis in ottica di contrasto ai curdi siriani, che nel nord del Paese stanno costruendo un’entità autonoma).
Sempre a causa della vicenda siriana i rapporti si sono logorati anche con la Russia di Putin, recentemente entrata nel conflitto. La decisione del Cremlino di intervenire in aiuto di Assad, e di concentrare i propri bombardamenti prevalentemente sui ribelli non legati all’Isis – quelli appunto sostenuti apertamente tra gli altri dalla Turchia –, ha portato Ankara ad alzare i toni nei confronti di Mosca, minacciando ritorsioni anche di carattere economico (in particolare sul gasdotto Turkish Stream, che Gazprom vorrebbe costruire per aggirare il blocco di Paesi dell’Est Europa ostili alla Russia, Ucraina in primis). Così svaniscono anni di avvicinamento tra Putin ed Erdogan, che sperava nella sponda russa per compensare la freddezza degli storici alleati occidentali.
Gli Stati Uniti sono infatti da tempo in rapporti tesi con la Turchia governata dall’islamico Akp. L’atteggiamento di Erdogan verso Israele – ostile come mai prima nella storia della Repubblica turca – ha già anni fa raffreddato i rapporti con gli Usa, e il recente malcelato supporto al terrorismo islamico in ottica anti-Assad e anti-Curdi in Siria ha fatto il resto (anche considerato che i curdi siriani sono alleati degli Usa, e vengono utilizzati come fanteria contro il Califfato). Washington non può rinunciare all’alleanza con Ankara, secondo esercito della Nato e Paese strategicamente posizionato a cavallo tra Asia ed Europa, specie in un periodo di tensioni con la Russia. E viceversa. Tuttavia la partnership è logora come non mai, e se la Turchia è sembrata a lungo sorda ai richiami degli Usa di dare un reale sostegno contro lo Stato Islamico, specularmente ora sembra sorda l’America verso gli avvertimenti turchi a non dare troppo spazio (e armi) ai movimenti curdi.
Anche l’Unione Europea è poi in una fase di gelo verso Erdogan, specie per le gravi violazioni della libertà di stampa e dei diritti civili che vanno intensificandosi con il permanere del presidente al potere. Ma Bruxelles ha sopra la testa la spada di Damocle dei rifugiati siriani: i due milioni attualmente ospitati in Turchia se, a fronte di un cambio di linea da parte del governo turco, dovessero decidere di cercare rifugio in Europa, rappresenterebbero una bomba (politica più che demografica) per la stabilità europea. Quindi, suo malgrado, si vede costretta a trattare.
La linea di politica estera tenuta finora da Erdogan – specie il sostegno alla Fratellanza Musulmana, anche divenuta palese la recrudescenza delle Primavere arabe in uno scontro tra sunniti e sciiti, fomentato dalla rivalità iraniano-saudita – non risulta meno fallimentare se si guarda al campo dei suoi teorici “alleati” sunniti. Anzi. I Saud, alleati della Turchia in Siria nel sostenere i ribelli contro Assad, sono una monarchia wahabita (una setta ultraconservatrice dell’islam sunnita) e considerano da sempre i Fratelli Musulmani come una organizzazione terroristica. La partnership con Ankara si è infatti intensificata nel momento in cui la Fratellanza ha perso terreno nel dopo-Primavere arabe (golpe militare in Egitto di Al Sisi, elezioni in Tunisia dove vincono i laici, seconda guerra civile libica etc) e Assad ha cominciato a macinare vittorie in Siria: le differenze sono state accantonate e di fronte al nemico comune sciita è stato trovato un accordo. Ma le agende di lungo periodo restano differenti.
Discorso simile per l’Egitto: Al Sisi ha restaurato il potere laico e militarista e ha messo fuori legge i Fratelli Musulmani (che avevano vinto le precedenti elezioni, portando Mohammed Morsi alla carica di presidente), fino a quel momento fortemente supportati da Erdogan. Ora poi Turchia e Egitto sono alle soglie di una proxy war in Libia. Mentre Ankara sostiene il governo islamista di Tripoli (politicamente dominato dalla Fratellanza), il Cairo sostiene il governo laico di Tobruk (in particolare il generale Khalifa Haftar, anch’egli sospettato di avere mire golpiste).
Erdogan si trova dunque ora di fronte a un bivio: sfruttare il ritrovato consenso interno per mantenere salda la sua linea, oppure approfittare della forza che gli hanno conferito le elezioni per imprimere una svolta anche in politica estera. Il primo caso, ritenuto più probabile da diversi esperti, avrebbe quasi certamente l’effetto di esasperare l’isolamento internazionale della Turchia, con ripercussioni su tutti gli scenari in cui Ankara vanta degli interessi. In primo luogo, la questione curda.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Dal voto di domenica 25 ottobre in Polonia esce vincitore, di stacco, il partito populista di destra Diritto e Giustizia (PiS). La formazione xenofoba e anti-europeista fondata dai gemelli Kaczyński – Jarosław, ex premier e attuale presidente del partito, e Lech, l’ex presidente della Repubblica morto nel 2010 in un incidente aereo in Russia – ha conquistato il 37,6% dei voti, aggiudicandosi così la maggioranza assoluta dei seggi in Parlamento (la stima è di 236 su 460). A primavera aveva già trionfato alle elezioni presidenziali, portando alla vittoria l’avvocato nazionalista Andrzej Duda.
Dopo i risultati di domenica per la candidata premier, la fedelissima di Jarosław, Beata Szydlo, è spianata la strada per formare un governo monocolore. Pesante sconfitta invece per il partito liberale al governo dal 2007, Piattaforma Civica, che si ferma al 24,1% dei voti. Rimasto orfano del leader e co-fondatore Donald Tusk – premier fino al 2014, quando venne eletto Presidente del Consiglio d’Europa – il partito si era affidato a Ewa Kopacz, premier uscente e candidata anche in questa tornata, che però non ha “scaldato” l’elettorato. Per la prima volta dalla caduta del comunismo, poi, non entra in Parlamento nessun partito di sinistra. Quello che stupisce, a prima vista, di questo risultato è che abbia trionfato una formazione razzista e anti-europeista in un Paese che praticamente non ha mai conosciuto il fenomeno dell’immigrazione (semmai il contrario) e che dall’ingresso nella Ue ha ottenuto enormi benefici (il pil, nonostante la crisi, è in crescita costante da anni – nel 2014 del 3,4% e le previsioni per 2015 e 2016 sono simili – e la disoccupazione è calata di quasi due punti l’anno scorso). Perché dunque trionfano i nazionalisti euro-scettici?
Secondo gli analisti ha sicuramente influito lo scarso carisma della candidata liberale, Ewa Kopacz, da un lato, e l’aspetto “ripulito” che ha assunto Diritto e Giustizia, lasciando in seconda fila il leader Kaczyński e presentando volti più moderati, come quello di Beata Szydlo (o, nel recente passato, di Duda). Hanno poi avuto presa le accuse, alla classe di governo degli ultimi anni, di non aver redistribuito la ricchezza creata durante il boom economico. Le fasce più povere e delle zone rurali del Paese pare abbiano premiato le proposte da “destra sociale” del PiS: introduzione di un salario orario minimo (3 euro), abbassamento dell’età pensionabile a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne (dai 67 anni previsti in precedenza), aumento del reddito esentasse, intervento dello Stato nell’economia, tutela dei lavoratori del carbone (e della centralità del carbone stesso nell’economia del Paese, con buona pace degli impegni per l’ambiente), assegni familiari da 125 euro per ogni bambino e farmaci gratuiti per gli anziani con oltre 75 anni di età.
La ricetta protezionista e statalista si accompagna in parallelo al rifiuto di sottostare a quella che viene chiamata “dittatura” dell’Unione europea. Le regole comunitarie (divieto di aiuti di Stato, concorrenza, libero mercato etc.) vengono vissute con fastidio e gli slogan “mai nell’Euro” hanno accompagnato tutta la campana elettorale del PiS (in base alle regole del diritto dell’Unione gli Stati membri – salvo particolari diritti di opt-out – sono obbligati ad aderire all’Euro una volta raggiunti determinati parametri). In Polonia la crisi non ha dunque colpito, ma ha lasciato lo stesso pesanti strascichi psicologici nell’opinione pubblica. Pur non volendo abbandonare l’Ue, Varsavia preferisce ora rinnegarne le regole da cui pure nel passato recente ha tratto enormi vantaggi. Ancor più della crisi ha spaventato l’opinione pubblica polacca l’annessione della Crimea da parte della Russia. Il timore di un attacco da parte di Mosca – decisamente improbabile, considerata la partecipazione della Polonia alla Nato – ha attecchito nell’immaginario popolare, ed è quindi stato premiato il partito di chi chiedeva a Bruxelles più sostegno in ottica anti-Russa, una maggior presenza della Nato sul territorio e ora intende aumentare la spesa militare per la Difesa (la Russia ha già fatto trapelare la propria preoccupazione per una possibile escalation). Il tutto ovviamente condito da una retorica nazionalista e patriottarda fortemente centrata anche su una visione ultraconservatrice dei valori cristiani e cattolici. Tra i vari punti del programma del PiS – fortemente sostenuto dall’espiscopato polacco – c’è anche la lotta all’aborto (diverrà quasi impossibile), ostacolare l’accesso alla fecondazione in vitro e dare maggior peso alla catechesi nei programmi scolastici.
La miscela di estremismo religioso e nazionalismo trova terreno fertile in una popolazione ancora mentalmente chiusa e spesso razzista. Secondo uno studio del 2013 del Centro di ricerca sui pregiudizi – un centro accademico dell’Università di Varsavia – il 69% dei polacchi non vuole che vivano nel loro Paese persone con la pelle non bianca. La questione immigrazione viene inquadrata di conseguenza: i migranti sono un rischio per la salute (lo ha sostenuto anche il Presidente della Repubblica Duda), se poi sono musulmani aumenta il pericolo di terrorismo, la Polonia non può permettersi di accoglierli e, anzi, dovrebbe al massimo cercare di riportare in patria i polacchi espatriati. La campagna elettorale del PiS ha ovviamente solleticato gli istinti peggiori dell’opinione pubblica rilanciando e cavalcando questi stereotipi, di nuovo in contrapposizione con l’Unione europea che la scorsa estate ha stabilito di implementare una maggior cooperazione nella gestione del fenomeno migratorio, ripartendo i richiedenti asilo tra tutti i Paesi membri.
L’Unione si trova quindi di fronte a una situazione molto delicata. Una parte consistente dei Paesi protagonisti del generoso allargamento del 2005 – quando gli Stati membri della Ue passarono da 15 a 25 – sta cadendo nelle mani di formazioni nazionaliste, populiste e anti-europee. La Polonia potrebbe ora fare asse con l’Ungheria di Viktor Orban (la vicinanza ideologica è stata spesso sottolineata in campagna elettorale), e il gruppo Visengrad – che riunisce oltre ai due Stati citati anche le Repubbliche Ceca e Slovacca – potrebbe mettersi ancor più di traverso alle scelte del resto dell’Unione (ci aveva provato già sulle quote obbligatorie per i migranti, ma proprio l’ormai ex-governo polacco aveva rotto il fronte dando il suo assenso). Se così fosse la sola speranza per la Ue di evitare la paralisi decisionale – e la deriva verso una somma di Stati nazionali, più che verso una comunità omogenea – sarebbe utilizzare gli strumenti previsti dal Trattato di Lisbona (in particolare le cooperazioni rafforzate) per arrivare a una “Europa a più velocità”. Il nocciolo duro della Ue potrebbe marciare più speditamente verso una maggiore integrazione, mentre gli scettici – vecchi, come l’Inghilterra, o nuovi, come alcuni Paesi dell’est – verrebbero lasciati indietro.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Quattro anni dopo l’uccisione di Gheddafi e la fine della prima guerra civile libica, e un anno abbondante dopo la deflagrazione dello scontro tra il governo islamista di Tripoli e quello internazionalmente riconosciuto di Tobruk (seconda guerra civile libica), l’ex colonia italiana ancora non riesce ad emergere dal caos in cui è sprofondata. La missione dell’inviato Onu, lo spangolo Bernardino Leon, si è conclusa il 20 ottobre con un nulla di fatto: un anno di mediazioni e trattative – che nelle intenzioni della comunità internazionale avrebbero dovuto portare alla nascita di un governo di unità nazionale, per contrastare il flusso migratorio nel Mediterraneo e l’ascesa dell’Isis in Libia – non è bastato.
Sia a Tobruk che a Tripoli, per ora, il piano di Leon non è stato accettato (secondo il ministro degli Esteri italiano, Paolo Gentiloni, non si tratta di una vera bocciatura in quanto i parlamenti ancora non si sono espressi). Adesso la parola passa al suo successore, il tedesco Martin Kobbler, a cui spetta il difficile compito di trovare una quadratura del cerchio in un Paese non solo diviso tra due governi rivali, ma frammentato in centinaia di milizie, paradiso dei traffici illeciti (specie di esseri umani), dove ha trovato spazio lo Stato Islamico e dove gli scontri – tra bande criminali, gruppi etnici e tribù – sono all’ordine del giorno.
«La Camera dei Rappresentanti a Tobruk ha detto che voterá sulla proposta di Leon lunedí prossimo. Tuttavia il generale Haftar ha fatto capire chiaramente che non gradirebbe un voto a favore dell’accordo e ha giá dimostrato in passato di avere un certo ascendente su Tobruk», spiega Mattia Toaldo, analista dell’European Council on Foreign Affairs esperto di Libia. «A Tripoli ci sono simili pressioni dei gruppi armati. L’obiettivo dei duri, al di lá dei proclami di guerra, é la continuazione dello status quo. Tuttavia con l’andare del tempo l’equilibrio si fa sempre più precario e Isis si espande. Il problema di fondo é ottenere un voto favorevole ad un accordo di pace da parte di parlamenti che sono sotto pressione di gruppi armati che verrebbero marginalizzati da quell’accordo». E fintanto che l’intesa non viene raggiunta rimangono ai blocchi di partenza le soluzioni internazionali per il caos libico. L’Onu ha infatti chiaramente detto che non intende autorizzare alcuna missione fintanto che i due parlamenti libici non troveranno un accordo, e anche l’Unione europea – che ha pronto un sostanzioso pacchetto di aiuti per la Libia – non può muoversi in assenza di un governo di unità nazionale.
Le pressioni internazionali si stanno dunque facendo sempre più forti sui due principali attori libici, anche per contrastare le spinte speculari di chi – Haftar come le milizie islamiche, sostenuto l’uno dall’Egitto le altre dalla Turchia – avrebbe tutto da perdere da un’eventuale intesa. La speranza è che Kobbler non debba ricominciare da capo ma, anzi, che riesca nell’impresa sfuggita per poco a Leon di percorrere l’ultimo miglio per arrivare a una soluzione concordata tra le parti. «La Libia rischia di diventare una Somalia alle porte del Mediterraneo», afferma Leandro Di Natala, analista dell’European Strategic Intelligence and Security Center. «Al momento l’unica strada che sembra essere rimasta all’Occidente, per costringere gli attori libici all’accordo, è quella di imporre delle sanzioni – congelamento conti, divieto di espatrio etc. – a quei soggetti che per proprio interesse stanno ostacolando il raggiungimento di un’intesa, come il generale Haftar a Tobruk e il gran muftì Sadiq Al-Ghariani a Tripoli, ad esempio. Altrimenti si corre il rischio di una scissione del Paese: la Cirenaica si separa dalla Tripolitania, rimanendo sotto il controllo militare di Haftar e col sostegno dell’Egitto, e nascono due Stati indipendenti. Al momento infatti nessuna delle due fazioni è abbastanza forte da poter pensare di prevalere militarmente sull’altra».
Se anche alla fine l’accordo venisse raggiunto, la situazione rimarrebbe comunque delicatissima. «Il documento preparato da Leon aveva l’avallo di 50 milizie di Misurata, ma è bastata l’opposizione di una delle più forti – la Central Shield Force, sospettata di legami con Al Qaeda – e di pochi altri “falchi” per far scattare il “no” della politica. In uno scenario tanto frammentato e violento, una qualsiasi missione terrestre internazionale in Libia dovrebbe mettere in conto di subire attacchi e probabilmente perdere uomini», prosegue Di Natala. «In particolare l’Italia sembra volersi candidare al ruolo di guida di questa eventuale missione. Ancora di recente – nell’ambito della missione marittima “Mare sicuro” – ha compiuto un’operazione nei pressi delle coste libiche con fucilieri e incursori di marina per contrastare il traffico di vite umane (arrestati 17 presunti scafisti in acque internazionali), che sembra un segnale in tale direzione. Devono essere chiari – conclude Di Natala – i rischi a cui si andrebbe incontro». Riattivare l’economia libica – incentrata prevalentemente sull’esportazione di petrolio – sarebbe probabilmente il miglior viatico per diminuire la violenza nel Paese e, per storia e rapporti economici, l’Italia ha il massimo interesse a che ciò avvenga. Guidare la missione internazionale incaricata di affiancare le autorità libiche nella ricostruzione di uno Stato avrebbe dunque sicuramente anche un tornaconto economico, oltre che di immagine. Ma tra la situazione attuale e quell’obiettivo si pone il problema non solo di costringere Tripoli e Tobruk a un accordo e a ottenere successivamente un mandato internazionale, ma anche di portare militari italiani in uno scenario dove imperversano criminalità, gruppi armati e Stato Islamico. E accettarne le conseguenze.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Per contrastare l’ascesa dello Stato Islamico, nell’agosto 2014 la dottrina del presidente Obama prevedeva: “Prima l’Iraq”. “Prima” rispetto alla Siria, l’altro Stato in cui il Califfato controlla parte del territorio. Questa decisione nasceva da varie considerazioni. A Baghdad, in primo luogo, il governo (prima di Al Maliki, poi di Al Abadi) è alleato degli Stati Uniti – a differenza del regime siriano di Bashar al Assad – e ha chiesto direttamente il supporto americano.
L’esercito statunitense poi conosce molto meglio il territorio iracheno, presidiato per otto anni dopo l’invasione del 2003. Infine, e soprattutto, lo scenario iracheno è meno complicato di quello siriano (un caos iper-frammentario dilaniato dagli interessi delle potenze regionali), politicamente prima ancora che militarmente. In Siria infatti lo Stato Islamico si scontra con la dittatura di Assad, contro cui combattono – indirettamente, armando diversi gruppi ribelli – anche gli alleati regionali di Washington, Turchia e Sauditi in testa.
A settembre 2014 l’America, vista la rapida evoluzione dello scenario siriano, si è vista costretta tuttavia ad una correzione di rotta, allargando sempre più l’area dei propri bombardamenti al di là del confine iracheno. Presto si è arrivati a una situazione de facto di “Prima la Siria”, e la Casa Bianca si è trovata nella difficile posizione di dover colpire un proprio nemico – l’Isis – senza però poterne avvantaggiare troppo il principale avversario – la dittatura di Assad – per non irritare i propri alleati. Washington inoltre non ha voluto aiutare in modo determinante l’unica forza terza rispetto a Stato Islamico e dittatura di Assad, cioè gli altri ribelli siriani, in quanto pesantemente infiltrati da formazioni jihadiste, tra cui anche la stessa Al Qaeda.
Mentre l’attenzione internazionale era concentrata sulla Siria – sia per il dramma umanitario dei profughi, arrivato nelle case degli Europei, sia per i timori suscitati dal recente intervento militare della Russia – in Iraq la campagna di attacchi mirati da parte dell’aviazione americana è comunque proseguita. Senza produrre al momento (come del resto anche in Siria) grandi risultati sul terreno. Le fila dei combattenti del Califfato sono state sfoltite e la dirigenza decimata, ma nuove reclute hanno riempito i vuoti lasciati e le grandi città irachene – soprattutto Ramadi, capitale della provincia sunnita di Anbar, e Mosul, più a nord – sono ancora sotto il controllo dello Stato Islamico. La situazione però potrebbe essere ora vicina a un punto di svolta.
Dopo un trimestre di preparativi – gli annunci di un imminente attacco risalgono allo scorso maggio – sarebbe finalmente giunto, secondo fonti militari americane, il momento opportuno per l’esercito iracheno per lanciare un’offensiva su Ramadi e sottrarne il controllo all’Isis. Per mesi l’avanzata è stata rallentata dai campi minati che gli uomini dello Stato Islamico hanno disposto a protezione delle loro postazioni e dall’impreparazione dell’esercito iracheno (fuggito senza combattere l’anno scorso di fronte all’avanzata del Califfato). Ma il quadro pare sia cambiato. Il portavoce della coalizione a guida Usa che combatte contro l’Isis, il colonnello Steve Warren, ha annunciato che – anche grazie all’intensificarsi dei bombardamenti americani nella zona – le forze irachene sono avanzate di alcune miglia negli ultimi giorni, circondando la città, e possono ora portare un attacco da quattro diverse direttrici. I soldati a disposizione di Baghdad – molti dei quali con addestramento Usa – sarebbero diecimila, contro il migliaio di uomini del Califfo che si stima siano ancora barricati nel centro urbano. La caduta di Ramadi alleggerirebbe la pressione dell’Isis su Baghdad e aprirebbe le porte dell’intera provincia di Anbar alle forze governative. Ma qui si pone un grave problema.
Da quando è stato abbattuta la dittatura di Saddam Hussein – già durante gli anni di occupazione americana ma in modo ancor più evidente dopo il ritiro del 2011 – l’Iraq è sempre più diventato uno Stato sciita (sciita è la maggioranza della popolazione), e sempre meno uno multietnico. Al nord i curdi godono di un’autonomia che sfiora l’indipendenza, a nel resto del Paese la minoranza sunnita è stata sempre più gravemente sottorappresentata. Il precedente premier, lo sciita Al Maliki, aveva già esasperato gli animi dei sunniti reprimendone violentemente le proteste nel 2011 e facendo arrestare alcuni loro leader, ponendo così le basi per una facile penetrazione dello Stato Islamico. L’avvicinamento costante poi tra Baghdad e Teheran, unito all’impiego di milizie irregolari sciite nel contrasto all’Isis, ha definitivamente logorato quel che restava dei rapporti tra le maggiori tribù sunnite dell’area e il governo centrale. Le milizie sunnite che affiancano le truppe governative rappresentano sempre più una minoranza all’interno della comunità. Se alla eventuale caduta di Ramadi facessero seguito violenze settarie da parte degli sciiti contro la popolazione civile sunnita, sarebbe facile immaginare che – piuttosto che subire un simile destino – l’intera provincia di Anbar preferisca schierarsi in pieno sostegno degli uomini del Califfato, rendendo la guerra al gruppo terroristico una snervante avanzata paese per paese, casa per casa. La sempre maggior vicinanza tra Iran e Iraq ha dunque portato a quest’ultimo un importante contributo militare nel contrasto all’Isis, ma rischia di complicare ulteriormente la situazione, qualificando definitivamente l’offensiva al Califfato come ennesimo capitolo della guerra intra-religiosa tra sunniti e sciiti.
Il potere di attrazione sull’Iraq da parte di Teheran è di recente stato tale da portare Baghdad dallo stesso lato della barricata anche degli altri alleati dell’Iran: Russia e Siria. Di recente è stato creato nella capitale irachena un centro di coordinamento nella lotta all’Isis che riunisce uomini di Mosca, Damasco, Teheran e Baghdad. Non solo. Secondo quanto riportato dalla Reuters l’aviazione irachena starebbe già utilizzando le informazioni di intelligence prodotte da tale centro per colpire obiettivi dello Stato Islamico. Addirittura circolano voci secondo cui l’Iraq potrebbe nel prossimo futuro chiedere, come già ha fatto la Siria, un intervento diretto e più consistente dell’apparato militare russo per contrastare il Califfato. Queste notizie ovviamente creano grande apprensione negli Stati Uniti, timorosi di perdere presa su un Paese che hanno contribuito a ricreare – dopo aver distrutto nella guerra del 2003 –, in cui hanno investito miliardi di dollari e che considerano un partner strategico (viste anche le ingenti risorse petrolifere) per il futuro.
Ultimo tassello del mosaico iracheno è poi la questione curda. Già praticamente indipendenti, i curdi moderati iracheni si stanno sempre più avvicinando – complice il comune sforzo bellico contro l’Isis – a quelli marxisti siriani (collegati al Pkk curdo in Turchia). Se dal caos siriano emergesse un’entità autonoma curda, legata a quella irachena, la distanza verso uno Stato indipendente si ridurrebbe drasticamente. Questo non solo scatenerebbe le ire (e forse più) della Turchia e gli appetiti delle potenze internazionali (Russi e Iraniani potrebbero cercare di cavalcare l’indipendentismo curdo per conquistare una pedina ricca di risorse e strategicamente posizionata sulla cartina; l’America potrebbe provare a contrastare questa mossa avallando a sua volta le richieste curde, anche a rischio di scontentare l’alleato turco), ma rischierebbe di dare il via a quella disgregazione degli Stati multiconfessionali (non solo Iraq ma anche Siria, Yemen, Bahrein etc) che tanti temono possa far definitivamente esplodere quel che resta dell’ordine mediorientale.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Questo autunno è nuovamente esplosa la violenza in Israele e nei territori palestinesi, a un livello che non si vedeva dalla guerra a Gaza dell’estate 2014. Dal primo ottobre non è passato un giorno senza scontri, in particolare in Cisgiordania e a Gerusalemme Est. Secondo le ultime stime la miriade di attentati delle scorse due settimane (spesso opera di “lupi solitari” palestinesi armati solo di coltello, o che si gettano sui passanti con la propria autovettura), e la risposta (sproporzionata secondo le accuse) delle forze di sicurezza di Tel Aviv, avrebbero causato nove morti e decine di feriti israeliani, e ventisette morti (tra cui diversi attentatori) e centinaia di feriti palestinesi.
Il clima era diventato rovente già a settembre, quando – alla vigilia delle festività ebraiche e musulmane – si erano registrati scontri nella Spianata delle moschee, luogo sacro per entrambe le religioni (qui gli ebrei ritengono fosse collocato il Tempio distrutto dall’imperatore romano Tito nel 70 d.C.). In particolare il 13 settembre le forze di sicurezza Israeliane avevano fatto irruzione nella moschea Al Aqsa per – secondo la loro ricostruzione – neutralizzare un gruppo di giovani palestinesi che avevano portato molotov e pietre nel luogo di culto, con l’intenzione di colpire i fedeli ebrei che nei giorni successivi avrebbero visitato la Spianata in occasione del capodanno ebraico e del Sukkot (festa dei Tabernacoli). Le conseguenti restrizioni all’accesso alla Spianata per i fedeli musulmani – specie durante il periodo festivo del Eid al Adha (festa del Sacrificio, quello che Abramo era disposto a fare uccidendo Isacco) -, e la “visita” di alcuni parlamentari israeliani avevano scatenato le proteste dei palestinesi (nel 2000 fu proprio la “passeggiata” sulla Spianata del leader del Likud, Ariel Sharon, a scatenare la Seconda Intifada). In particolare veniva lamentata – tanto da al Fatah quanto da Hamas – la violazione dello “status quo” (patrocinato da ultimo dalla Giordania nel novembre 2014, per svelenire il clima che si era creato) che, tra le altre cose, garantiva a palestinesi e giordani il controllo all’interno della Spianata.
Avendo quindi il governo israeliano fatto presidiare dalle forze di sicurezza la Spianata, le proteste palestinesi esplodono altrove. Alle manifestazioni con lanci di pietre e molotov si affiancano presto gli attentati. Il primo ottobre vengono assassinati due israeliani in una sparatoria in Cisgiordania. Il tre ottobre vengono accoltellati e uccisi altri due israeliani nella Città Vecchia a Gerusalemme. I giorni seguenti vedono uno stillicidio di attacchi all’arma bianca tanto nei territori palestinesi quanto in Israele. L’apparato di sicurezza israeliano compie retate per arrestare i responsabili – quelli del duplice omicidio del primo ottobre vengono identificati in alcuni uomini di Hamas – e reprime con violenza le proteste di migliaia di giovani palestinesi. Un tredicenne muore, ucciso “per sbaglio” dai soldati di Tel Aviv. Centinaia di palestinesi rimangono feriti negli scontri con le forze israeliane. La rabbia continua a montare, da ambo i lati. Un fanatico israeliano accoltella quattro arabi a Neghev. Il sindaco di Gerusalemme Nir Barakat esorta chi è in possesso del porto d’armi a girare armato, specie ex soldati «con esperienza operativa di combattimento». Il premier israeliano Netanyahu prova a svelenire il clima, garantendo che lo status quo sulla Spianata non verrà modificato, e proibendo ai parlamentari israeliani di recarsi sul luogo. Ma non basta. Altri attentati continuano a susseguirsi, da ultimo due terroristi palestinesi hanno attaccato un autobus israeliano, ferendo 16 passeggeri (alcuni in modo grave). Nessuno sa dire con certezza quando questi episodi potrebbero terminare. Hamas intanto comincia a lanciare razzi sul territorio israeliano da Gaza, e l’aviazione israeliana risponde. Netanyahu manda sei compagnie dell’esercito nelle città israeliane per aiutare la polizia a prevenire ulteriori attentati e prevede la possibilità di sigillare i quartieri arabi di Gerusalemme in caso di violenze di strada. Lo spettro di un altro conflitto si fa sempre più reale.
«Nessuno degli attori istituzionali palestinesi ha molto da guadagnare da questa nuova fiammata di violenze. Nemmeno Hamas», spiega Yezid Sayigh, senior associate del Carnegie Middle East Center. «Hamas non ha pianificato questa situazione. Alcuni suoi membri possono essere coinvolti negli attentati (in particolare nell’omicidio della coppia di israeliani del primo ottobre), ma credo si tratti di azioni non pianificate centralmente, portate avanti in modo isolato da pochi soggetti. Ovviamente Hamas sta cavalcando le proteste, e ha anche lanciato alcuni razzi su Israele. Non può infatti correre il rischio di perdere la presa sulla propria base di consenso, magari a favore di gruppi estremisti salafiti, simpatizzanti dello Stato Islamico o anche sue componenti interne più fanatiche. D’altro canto Hamas non vuole rompere la tregua siglata con Israele dopo la guerra di Gaza dell’estate 2014. Non le conviene politicamente e in ogni caso non è abbastanza forte, non si è ancora ripresa dall’ultimo conflitto. Possiamo dire che Hamas è bloccato in una situazione che non vorrebbe ma da cui non si può dissociare. Il suo unico tornaconto è di breve termine: può sperare di erodere il consenso dei moderati di Fatah. Avendo il presidente dell’Autorità nazionale palestinese, Mahmud Abbas, puntato tutto sulla via del dialogo, queste violenze non gli convengono e, anzi, cerca di invitare alla calma. Hamas, dicevo, può lucrare su questa posizione “debole” di Abbas e del suo partito Fatah, ma non essendoci nemmeno delle elezioni in vista non è che destabilizzare il potere palestinese in Cisgiordania le sarebbe poi tanto utile».
Se i partiti palestinesi, Fatah e Hamas, sembra che non abbiano molto da guadagnare dal clima di scontri e violenze, altrettanto pare si possa dire per Netanyahu. Il premier israeliano ha vinto le scorse elezioni promettendo soprattutto sicurezza ai suoi elettori, la prospettiva di una “terza intifada” (già si discute se sia in corso o meno) per lui sarebbe un grave danno. Secondo diversi esperti europei sta provando ad ammorbidire le proprie posizioni, evitando – come invece richiesto dal laburista Herzog – di isolare la Cisgiordania, proibendo ai parlamentari israeliani di recarsi sulla Spianata, ammettendo pubblicamente di aver rallentato la costruzione di colonie per cercare maggior consenso internazionale alla sua lotta contro il terrorismo. La linea della calma (comunque “relativa”, considerati i bombardamenti su Gaza, il dispiegamento dell’esercito e la ripresa delle demolizioni delle case dei terroristi, interrotte da anni in quanto considerate inefficaci come deterrente) potrebbe però non essere destinata a durare. La sua base elettorale gli chiede maggior forza nella reazione contro i palestinesi, e il suo partito – il Likud – subisce la concorrenza delle formazioni di estrema destra religiosa e dei coloni. Il quadro complessivo sembra dunque vedere i protagonisti più come vittime che artefici di eventi che non sono poi in grado di controllare.
«Per quanto riguarda i palestinesi è da notare come queste proteste, questi attacchi, nascano da azioni individuali. C’è una chiara mancanza di una struttura organizzata. I giovani palestinesi sono mossi dalla frustrazione e dalla assenza di prospettive: l’economia va male, i colloqui di pace sono fermi e non sono in vista elezioni per cambiare la dirigenza palestinese. Insomma – conclude Yezid Sayigh – visto che i partiti tradizionali non offrono più alternative, invece di aderire ad essi e partecipare a eventuali azioni pianificate, finisce che molti giovani cedono alla esasperazione e fanno da soli». Le prossime settimane diranno se le violenze che nascono da questa disperazione possono ancora essere controllate da una classe dirigente in larga parte delegittimata o se finiranno col travolgerla, causando un’escalation che potrebbe anche portare a una nuova guerra con Israele. Gli analisti danno a queste due opzioni le stesse chance.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Sono passati più di quattro anni e mezzo da quando è scoppiata la guerra in Siria. Da allora hanno perso la vita più di 250 mila persone, e quattro milioni di siriani vivono ora al di fuori dei confini della loro patria. Pochi “fortunati” emigrati in Europa, moltissimi di più nei campi profughi turchi, libanesi o giordani. Il loro Paese è diventato progressivamente lo sfogatoio delle pulsioni egemoniche (e delle paure) degli attori regionali, la calamita per eccellenza del fanatismo jihadista, la pedina di un Grande Gioco che coinvolge anche le superpotenze mondiali e di cui ancora non si intravede la fine. Ma quali sono i fili che, tendendosi e cambiando improvvisamente angolazione, hanno reso lo scenario siriano un groviglio inestricabile?
L’inizio della rivolta
A inizio 2011 il vento delle Primavere Arabe soffia su tutto il Medio Oriente. A gennaio in Tunisia è stata abbattuta la venticinquennale dittatura di Ben Alì, in Egitto a febbraio si è dimesso – dopo trent’anni al potere – Hosni Mubarak, la Libia di Gheddafi è sconvolta dalle proteste, e così lo Yemen, il Bahrein, l’Iraq e la Giordania. In Siria a marzo cominciano i cortei di protesta contro Assad e settimana dopo settimana diventano sempre più imponenti . Il contenimento della polizia diventa una brutale repressione militare, le manifestazioni si trasformano in insurrezione armata. L’estate passa in un crescendo di scontri e violenze. In autunno la guerra è sotto gli occhi di tutto il mondo.
La mutazione: da Primavera Araba a proxy war tra Iran e Sauditi
A inizio 2012 le massicce defezioni di ufficiali e soldati dal lato della dittatura vanno a ingrossare le fila dell’Esercito Siriano Libero (ESL), il primo nucleo armato e organizzato dei ribelli – supportato specialmente dalla Turchia – che comincia ad ottenere i primi successi contro il regime di Damasco. Parallelamente sono tuttavia già attivi sul territorio diversi gruppi jihadisti, finanziati soprattutto da Qatar (che in quel periodo, insieme alla Turchia, è in una fase di attivismo politico-internazionale per supportare la Fratellanza Musulmana nei Paesi travolti dalle Primavere Arabe) e Arabia Saudita (che invece considera i Fratelli Musulmani dei terroristi, ma non esita ad armare cellule salafite ancor più fanatiche – e legate ad Al Qaeda, come Jabhat al Nousra – pur di abbattere Assad). Il 2012 è un anno di importanti vittorie per gli insorti, ma la compresenza di diverse agende e di diversi interessi all’interno della ribellione – turchi, sauditi, qatarioti, locali etc – presto ne frantuma l’unità. Si registrano anche i primi episodi di violenza confessionale: le formazioni jihadiste attaccano le minoranze cristiana, drusa, sciita e alawita (quella del presidente Assad), cominciando ad alienare alla ribellione parte della simpatia popolare di cui godeva all’inizio. Vista la situazione di debolezza del regime di Damasco, e per contrastare la oramai palese presenza di interessi stranieri (Sauditi e Turchi specialmente) ad abbattere Assad, a metà 2013 intensificano il proprio coinvolgimento anche gli alleati del dittatore: l’Iran, Hezbollah libanese e – in misura minore – la Russia. Al governo siriano arrivano armi, finanziamenti e, soprattutto, combattenti. Nella regione di confine col Libano le forze lealiste scatenano un’offensiva che, col determinante contributo di Hezbollah, scaccia i ribelli e per la prima volta dall’inizio della rivolta li costringe sulle difensive. Quella che era nata come una Primavera Araba diventa a questo punto una “proxy war” tra Iran e Arabia Saudita, le due potenze regionali che, sfruttando l’odio intra-religioso tra sunniti e sciiti, si contendono l’egemonia sul Medio Oriente.
Il contesto: l’accordo sul nucleare iraniano e il nervosismo saudita
La lotta egemonica tra Teheran e Riad è inasprita dalla prospettiva, emersa nel 2013, di un accordo tra l’Iran e il 5+1 (gli Stati membri del Consiglio di sicurezza dell’Onu, più la Germania) sul nucleare persiano. Più che la questione atomica in sé, spaventa i Sauditi la prospettiva che l’Iran emerga come nuovo interlocutore internazionale e come potenza economica (lo sblocco delle sanzioni si stima porti alle casse iraniane oltre 100 miliardi di dollari). Inoltre preoccupa Riad anche la linea strategica che va delineando l’amministrazione Obama, di ridurre il coinvolgimento americano nello scenario mediorientale in favore di un maggior impegno nell’area dell’Oceano Pacifico. Quasi a confermare i peggiori sospetti sauditi, a settembre 2013 l’America, dopo aver minacciato che sarebbe intervenuta contro Assad se fossero state usate armi chimiche nel conflitto, evita di portare le proprie parole alle estreme conseguenze: di fronte alle prove dell’utilizzo di tali armi non convenzionali preferisce una strada diplomatica – propiziata dalla Russia – che smantelli l’arsenale chimico di Damasco ma le eviti il coinvolgimento nella guerra. Per molti analisti la Casa Bianca non ha voluto abbattere il regime di Assad in quel momento per il timore del forte elemento fanatico-islamico presente nella ribellione, e quindi per la mancanza di una exit strategy per il Paese.
Il fallimento turco
In questo contesto già confuso di proxy war tra Iran e Arabia Saudita, si inserisce poi anche la Turchia. Durante le Primavere Arabe il premier islamista, Recep Tayyip Erdogan, aveva sottolineato la vicinanza ideologica tra il proprio partito (AKP) e la Fratellanza Musulmana, e aveva quindi sostenuto quest’ultima in tutti gli Stati coinvolti dai moti rivoluzionari (Siria inclusa) coltivando l’aspirazione di avere un domani un ruolo guida nella regione. Se in un primo momento quella di Erdogan era sembrata una scommessa azzeccata – specie con la vittoria dell’islamista Mohammed Morsi in Egitto -, nel biennio 2013-14 la situazione si capovolge. In Egitto, a luglio 2013, il colpo di Stato del generale Al Sisi depone Morsi e ri-mette al bando la Fratellanza; in Libia le fazioni islamiche e quelle laiche finiscono per spaccare in due il Paese, con un governo a Tripoli (sostenuto da Ankara) e uno a Tobruk (riconosciuto internazionalmente); in Tunisia i partiti laici vincono le elezioni del 2014 sconfiggendo le formazioni islamiche. Ankara si trova così isolata e spaesata. In Siria sostiene a oltranza le formazioni vicine alla Fratellanza (e l’ESL che ne è il braccio militare), ma si scontra non solo con le forze regolari di Assad e i suoi alleati sciiti, ma anche con l’ostilità degli altri sunniti (foraggiati dalla casa reale saudita, storica nemica dei Fratelli Musulmani). Inoltre si fa sempre più pericolosa per la Turchia la situazione del Kurdistan. I curdi siriani, politicamente vicini a quelli turchi del Pkk (organizzazione terroristica per la Turchia e gli Usa), prima scacciano le forze di Assad dai propri territori, poi iniziano a scontrarsi con le fazioni islamiche, nel frattempo divenute prevalenti all’interno della ribellione. In entrambi i casi riportano importanti vittorie e iniziano ad amministrare il nord della Siria (la Rojava) come un’entità autonoma. L’incubo di Ankara è che nel caos siriano possa nascere uno Stato curdo (la maggior parte dei curdi vive in Turchia e da decenni rivendicano l’indipendenza), ideologicamente legato al Pkk.
L’ascesa dello Stato Islamico
Già durante il 2013, nel caos creato dalla frammentazione della ribellione, si fa notare un gruppo islamista – particolarmente sanguinario, composto soprattutto da stranieri e, pare, in principio foraggiato dai sauditi – che combatte contro il regime ma attacca ferocemente anche altre fazioni ribelli ritenute troppo “laiche” e filo-americane, ne uccide i comandanti e porta ai massimi storici gli scontri interni alla ribellione. Si tratta dell’Isis, una formazione nata dall’unione di ex ufficiali del regime iracheno di Saddam Hussein e fanatici islamici. Il salto di qualità arriva a giugno 2014, quando gli uomini in nero dell’Isis riescono a conquistare Mosul, seconda città dell’Iraq. Qui trovano gli ingenti armamenti di fattura americana abbandonati dall’esercito iracheno in fuga, oltre a centinaia di milioni di dollari nei caveau delle banche. Il leader religioso dell’Isis, Abu Bakr al-Baghdadi, proclama il Califfato nei territori controllati in Iraq e in Siria. Grazie alle nuove risorse acquisite, lo Stato Islamico può lanciare (sia contro i lealisti sia contro i gruppi ribelli “nemici”) una massiccia offensiva nella zona desertica orientale della Siria, e ad acquisirne il totale controllo. A fine luglio la “capitale” della sponda siriana del Califfato viene posta a Raqqa. Complice una abile strategia mediatica del terrore, e alcuni sanguinosi attentati in Occidente di “lupi solitari” che si richiamano all’Isis, lo Stato Islamico acquisisce grande visibilità. Molti jihadisti accorrono – anche dall’Europa e dal Caucaso – a ingrossarne le fila e, di contro, a settembre gli Stati Uniti si mettono alla testa di una coalizione internazionale (di cui fa parte anche l’Arabia Saudita) che ha come obiettivo la distruzione dell’Isis.
Le conseguenze dell’ascesa dello Stato Islamico
La forte presenza dell’Isis rende ancor più contraddittorio lo scenario siriano. L’Occidente, pur dichiarando a parole di volere la rimozione di Assad, finisce col favorirlo colpendo lo Stato Islamico, uno dei suoi più agguerriti nemici. Non può però eccedere nella sua azione (che infatti si limita a bombardamenti mirati dal cielo) per non favorire troppo Assad, cosa che irriterebbe i suoi alleati storici (Turchia e Sauditi) che invece mirano a far cadere il dittatore e a sottrarre così una pedina strategica al nemico iraniano. L’Occidente inoltre usa come fanteria contro lo Stato Islamico i guerriglieri curdi – gli unici ad aver dimostrato sul campo un’organizzazione efficiente contro gli uomini in nero dell’Isis -, ma non li arma quanto potrebbe (e servirebbe) per timore di logorare i rapporti con la Turchia. La guerra all’Isis va a rilento e non produce grandi risultati. Per Ankara e Riad, tuttavia, il quadro è ugualmente sfavorevole: sono entrambe tentate dall’utilizzare l’Isis contro i propri nemici (Assad e curdi) anche se sanno che la presenza dello Stato Islamico rappresenta per loro un boomerang, alienando al fronte sunnita le simpatie occidentali che, per reazione, si spostano sull’asse sciita guidato dall’Iran (ieri “asse del male”, oggi potenziale alleato contro l’Isis, in Siria come in Iraq). Di fronte a questa situazione – e alle oramai frequenti vittorie del regime e dei suoi alleati sul terreno – Turchia, Arabia Saudita e Qatar reagiscono mettendo da parte le differenze e propiziando, a inizio 2015, una riunificazione di numerosi gruppi ribelli (tra cui i qaedisti di al Nousra), escludendo lo Stato Islamico (che anzi viene formalmente considerato un nemico). La nuova coalizione ha un forte impatto sulla guerra e per la prima volta dal 2013 le forze governative sembrano in grave difficoltà: in primavera perdono Idlib e altri importanti centri, appaiono esangui (sempre meno effettivi) e sfilacciate, anche l’aiuto iraniano e russo sembra essersi ridotto, mentre quello turco e saudita ai ribelli è aumentato. Ma per Ankara le difficoltà del regime di Damasco sono una buona notizia che impallidisce di fronte a quella “brutta” della continua ascesa – militare sul terreno, e diplomatica presso l’Occidente – dei curdi siriani, impegnati nella guerra contro l’Isis. Erdogan allora rompe l’isolamento in cui era finito schierando definitivamente, nell’estate 2015, la Turchia contro l’Isis, controllando realmente la frontiera siriana, concedendo – dopo anni di dinieghi – la base aerea di Incirlik agli Usa e partecipando ai bombardamenti della coalizione (finora comunque scarsamente efficaci). In realtà diventa subito chiaro che l’obiettivo di Ankara non è tanto bombardare lo Stato Islamico quanto i curdi, in particolare il Pkk, con cui rompe la tregua che durava dal 2013.
La reazione della Russia
Dopo l’estate la situazione sul terreno vede il regime di Damasco in grave difficoltà su tutto il territorio, i gruppi ribelli (in particolare al Nousra) che espandono le proprie aree di influenza e lo Stato Islamico che – nonostante i bombardamenti della coalizione guidata dagli Usa – continua a resistere nell’area che va dall’est della Siria fino all’ovest dell’Iraq. La Russia, rimasta sempre al fianco di Assad anche se con un contributo piuttosto ridotto, di fronte al pericolo di perdere la propria base navale di Tartous (l’unica russa in tutto il Mediterraneo) e in generale la sponda dell’alleato siriano, decide di intervenire massicciamente nel conflitto. Da settembre 2015 Mosca invia caccia, navi, mezzi corazzati, armamenti pesanti e corpi speciali in Siria. Le basi russe già presenti vengono ampliate, altre nuove vengono costruite. Il pretesto – fornito anche dai tentennamenti degli Usa – è “la guerra allo Stato Islamico”, ma diventa subito chiaro che il vero bersaglio del Cremlino è l’intera ribellione, in generale chiunque si opponga ad Assad : i qaedisti di al Nousra come i moderati del ESL. I bombardamenti cominciano e le sorti della guerra siriana sembrano poter cambiare ancora una volta.
Il quadro attuale e le prospettive future
Al momento sono dunque in corso due guerre parallele in Siria. Quella della coalizione a guida Usa, con il supporto a terra dei Curdi, contro lo Stato Islamico, e quella di Russia, Iran, Hezbollah e governo siriano contro il resto della ribellione. Due imponenti offensive di terra pare siano alle porte: da ovest verso est quella a guida russa, da nord verso sud quella a guida americana. Al netto della propaganda occidentale è ovvio che il risultato di queste azioni sarà rafforzare la dittatura di Assad, e l’insistenza sulla necessità di salvaguardare la parte moderata della ribellione (perché un domani sia possibile una transizione democratica) sembra più che altro di facciata. Nei fatti, colpendo entrambi i maggiori nemici di Damasco nella guerra civile si allontana il rischio che la dittatura di Assad crolli improvvisamente, compromettendo gli interessi russi e iraniani (questo è il timore di Mosca e Teheran) e lasciando il Paese alla mercé dei gruppi fanatici islamici (timore di Usa ed Europa). Attualmente il pericolo – considerato da diversi analisti – è che l’intervento filo-sciita della Russia scateni l’ennesima contro-reazione saudita (e sunnita in generale). Riad di recente è stata molto attiva nel mercato delle armi sofisticate. Se iniziasse ad inviarle ai ribelli perché vengano usate contro obiettivi russi, il rischio di scivolare in una guerra di proporzioni ancora maggiori sarebbe dietro l’angolo. Anche la Turchia potrebbe essere fonte di tensioni: i caccia russi volano al confine con un Paese Nato e i rispettivi interessi – tanto circa la caduta di Assad, quanto circa la questione curda – vanno divergendo.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Sono cominciati da pochi giorni i raid aerei della Russia in Siria e, se dal Cremlino si diffondono notizie trionfali – 60 attacchi, 50 infrastrutture dello Stato Islamico distrutte, panico e diserzione tra gli uomini in nero del Califfo Al Baghdadi -, l’Occidente sembra innervosito e preoccupato dall’intervento di Mosca.
L’accusa che lanciano tanto la Casa Bianca quanto le cancellerie europee è che gli aerei russi stiano bersagliando più le altre componenti della ribellione siriana – gruppi islamici qaedisti, come Jabhat al Nousra, ma anche gruppi moderati – che non l’Isis. Il segretario di Stato americano, John Kerry, ha chiesto di “non confondere la lotta all’Isis con il sostegno ad Assad”; il premier britannico, Cameron, ha affermato: “i russi stanno sostenendo il macellaio Assad, peggiorando la situazione”; ancora più drastico il presidente francese Hollande, che ha chiesto direttamente a Putin che i raid in Siria abbiano come “unico obiettivo” lo Stato Islamico. Ancora più irritati con la Russia gli storici alleati sunniti dell’Occidente della regione, Arabia Saudita e Turchia in primo luogo, che da anni sostengono direttamente la ribellione siriana nella speranza di causare la caduta di Assad (e sottrarre così il Paese dall’influenza del nemico regionale sciita, la Repubblica Islamica Iraniana). Ma dietro questa apparente unità, nelle reazioni al recente coinvolgimento di Mosca, si nascondono posizioni molto diverse tra alleati. Gli Stati Uniti, in particolare, non hanno mai causato – pur potendo – la caduta di Assad, se non intervenendo direttamente almeno dando un decisivo supporto ai ribelli. La mancanza di una exit strategy e la prospettiva di uno Stato controllato da fanatici islamici hanno sempre portato la Casa Bianca a non vedere di cattivo occhio la conservazione dello status quo, in cui comunque il regime di Assad pur indebolito resiste. Anche ora, dopo l’intervento della Russia in Siria, l’atteggiamento americano non è limpido come sembra.
“Penso che la reazione americana agli attacchi aerei russi sia mista, ci sono due diverse visioni, presenti sia nell’opinione pubblica che nel dibattito politico. Nella prima, più visibile pubblicamente, prevale l’ansia per le azioni della Russia in Siria”, spiega Paul Stronski, esperto di Russia ed Eurasia della Carnegie di Washington. “Si teme che Mosca stia cercando di ricostruire in Medio Oriente la propria influenza globale, a discapito degli Stati Uniti e – in misura minore – dell’Europa. Chi sposa questa visione ritiene che i bombardamenti russi abbiano più a che fare con la volontà di Mosca di mettere pressione a Washington che non con la lotta al terrorismo islamico. La seconda visione è invece più pragmatica. I suoi sostenitori valutano come gli attacchi russi abbiano colpito anche al Nousra e altri gruppi jihadisti, il che è tanto negli interessi di Mosca che di Washington. Certo, gli Stati Uniti preferirebbero che la Russia colpisse primariamente l’Isis. Ma si ammette che, anche se la nostra strategia nel lungo periodo diverge da quella russa, nel breve l’indebolimento dei gruppi terroristi grazie agli attacchi ordinati dal Cremlino è nel nostro interesse. All’interno di questa visione “pragmatica” serpeggia comunque il dubbio se la Russia abbia in effetti la capacità di sostenere questa guerra abbastanza a lungo da sconfiggere i jihadisti e salvare Assad. Le difficoltà economiche di Mosca e la contrarietà all’intervento della maggioranza della sua opinione pubblica pesano in tal senso, e i “pragmatici” temono che se l’intervento di Putin si rivelasse poi un fallimento la situazione in Siria peggiorerebbe ulteriormente. Per questo hanno in realtà preso un atteggiamento “aspettiamo e vediamo””.
Alla mancanza di una linea univoca da parte degli Stati Uniti corrisponde la mancanza di un interesse americano abbastanza forte nell’area. “A questo punto – prosegue Stronski – penso che agli Stati Uniti interessi meno strappare la Siria all’area di influenza russa (e iraniana), che non vedere la fine della catastrofe umanitaria e dell’orrore in Siria, rispondere alla crisi dei rifugiati che sta destabilizzando altre parti del Medio Oriente e ora l’Europa, e contrastare l’estremismo islamico. Penso che i governanti americani riconoscano che storicamente la Russia ha un ruolo centrale per la Siria, e questo non è destinato a cambiare. Qualunque cosa rimanga della Siria nel futuro (magari una piccola enclave alawita governata da elementi del regime di Assad) sarà probabilmente sotto l’influenza russa. La mia sensazione comunque è che la Russia non stia conducendo questi bombardamenti da una posizione di forza, anzi. Visto il momento di debolezza del regime ha percepito il pericolo di perdere l’intero investimento fatto in Siria (installazioni militari, porti, prestiti finanziari etc). Inoltre la Russia fronteggia una minaccia terroristica derivante dalla situazione in Siria più grave degli Stati Uniti, vista la vicinanza geografica e la presenza di migliaia di foreign fighters caucasici e russofoni, che hanno giurato di portare la jihad in Russia. Mosca ha agito adesso, insomma, per evitare un tracollo dello Stato siriano a vantaggio dei gruppi jihadisti, e Putin sembra sinceramente convinto che la stabilizzazione del Paese passi inevitabilmente dal mantenimento in vita del governo attuale. Non credo sia legato mani e piedi personalmente ad Assad, ma intende quantomeno preservare le strutture del regime”.
Quella della Russia non sarebbe quindi un’offensiva ispirata da malcelate ambizioni di grandeur. “Generalmente la politica estera russa non è calibrata strategicamente sul lungo periodo, ma è principalmente tattica. Mosca se vede un’opportunità la coglie, specie se vede minacciata la propria sicurezza o i propri interessi. In Siria l’obiettivo di medio periodo credo sia rafforzare abbastanza il regime di Assad per dare tempo all’offensiva contro l’Isis – in particolare quella terrestre di Iran ed Hezbollah, in appoggio ai bombardamenti russi – di dare i suoi frutti. Se dovesse avere successo, a quel punto la Russia penso proverebbe a mantenere Assad al potere, o almeno a garantire posizioni fondamentali nell’apparato di sicurezza per gli elementi dell’attuale regime nel futuro Stato siriano”, dice ancora Stronski. Ma i possibili vantaggi nel breve periodo non sono senza un prezzo. Il Cremlino sta, con le sue azioni, logorando i rapporti con alcuni Stati con cui aveva invece da diversi anni cercato di intessere rapporti diplomatici ed economici più stretti, in particolare l’Arabia Saudita e la Turchia (i maggiori sponsor dei gruppi ribelli siriani di recente bersagliati dai caccia di Mosca). Con la prima rischiano di saltare possibili contratti sulle forniture di armi, con la seconda addirittura gli accordi sui futuri gasdotti che a Mosca si progettano per aggirare l’Ucraina. “Sono convinto che i raid russi complicheranno le relazioni con Ankara e Riad, e questo è un altro esempio del perché l’atteggiamento russo non sia sempre strategico”, conclude Stronski. “Putin ha speso anni per forgiare migliori relazioni con la Turchia, e adesso con le sue ultime azioni in Siria sta minando i suoi stessi sforzi”.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Sono cominciati i bombardamenti della Russia in Siria e, come era prevedibile, non è stato unicamente lo Stato Islamico ad esserne colpito, anzi.
Secondo quanto riferito da fonti occidentali e della ribellione siriana, sarebbero stati oggetto degli attacchi russi anche – se non soprattutto – numerose postazioni in mano all’Esercito della Conquista (Jaish al Fatah), la coalizione di fazioni ribelli (tra cui il Fronte al Nousra, legato ad Al Qaeda) nata grazie all’accordo tra Sauditi, Turchia e Qatar – gli sponsor internazionali dei vari gruppi di insorti – che negli ultimi mesi aveva inflitto cocenti sconfitte al regime (ad esempio conquistando la città strategica di Idlib). Non solo. Un ufficiale americano citato dal Wall Street Journal accusa la Russia di aver colpito un’area controllata principalmente da ribelli supportati dalla Cia e da altre intelligence occidentali. E, stando a fonti libanesi, sarebbe in preparazione una massiccia offensiva di terra contro Aleppo (città in buona parte controllata dai ribelli di Al Nousra), condotta da truppe siriane, iraniane e Hezbollah, con la copertura dell’aviazione russa. Come era ovvio strategicamente, ma nascosto dalla pesante cortina della propaganda, Putin sta concentrando lo sforzo bellico sulle forze che maggiormente minacciano la stabilità del regime di Assad. Colpisce anche lo Stato Islamico, del resto già bersagliato dalla coalizione a guida americana e dai curdi nel nord del Paese, ma la sconfitta del Califfato non è la priorità per Mosca.
Il Cremlino, infatti, grazie all’esistenza dello Stato Islamico ha avuto il pretesto per intervenire pesantemente in sostegno del suo alleato, il governo di Assad (la Siria fin dai tempi dell’Urss ospita l’unica base del Mediterraneo della marina russa), una mossa che sarebbe stata più difficile – se non quasi impossibile – quando la ribellione ancora non era stata infiltrata, e quindi dominata, da gruppi jihadisti. Sfruttando l’occasione Putin ha ampliato la propria presenza militare in Siria, garantendosi una posizione di forza nelle trattative sul futuro del Paese, e così è anche uscito – complice l’immobilismo degli Stati Uniti nello scenario mediorientale – dall’angolo in cui era stato confinato dalla comunità internazionale dopo la crisi in Ucraina. Abbattere il Califfato in Siria senza aver prima sterilizzato il resto della ribellione rischierebbe di essere controproducente per Mosca: senza un nemico peggiore di lui da combattere, Assad tornerebbe ad essere solo un dittatore spietato che l’Occidente ha interesse ad eliminare il prima possibile. È interesse del Cremlino invece che la scelta si riduca ad Assad o Isis. Inoltre alla Russia potrebbe non dispiacere che la Siria, grazie all’esistenza del Califfato, faccia da calamita per il jihadismo caucasico, drenando uomini e risorse da zone più vicine e pericolose per Mosca.
Dell’intervento russo, ovviamente, beneficia anche l’Iran. Non solo il contributo di Mosca stabilizza Assad in Siria, uno degli alleati storici e più importanti di Teheran, ma consolida la presa iraniana anche sull’Iraq, Paese a sua volta in parte occupato dall’autoproclamato Stato Islamico. Da poco è nato a Baghdad un centro di coordinamento, ufficialmente per la guerra all’Isis, tra Russia, Iran, Iraq e Siria. L’asse sciita (Iran, Siria, Hezbollah libanese) guidato da Teheran – non più “asse del male” come ai tempi di George W. Bush – è diventato geostrategicamente forte con la conquista de facto dell’Iraq (fino a Saddam Hussein dominato dalla minoranza sunnita, ora “democraticamente” finito nell’orbita sciita), con il sostegno diplomatico che è arrivato da più parti grazie alla guerra contro l’Isis (gruppo sunnita, usato in principio anche dalle potenze regionali sunnite – Sauditi in primis – proprio come corpo contundente contro gli interessi iraniani) e, soprattutto, grazie alla prospettiva di emersione dell’Iran come potenza regionale in forza dell’accordo sul nucleare trovato con Washington. Lo sblocco delle sanzioni darà a Teheran – e ai suoi alleati sciiti – enormi spazi di manovra, politica ed economica. La eccezionale vicinanza di oggi in Siria verrà probabilmente sfruttata anche un domani dal Cremlino.
L’altro lato della medaglia è rappresentato dall’Arabia Saudita. L’intervento diretto della Russia potrebbe consigliare a Riad di desistere dai propri sforzi in Siria. L’urto della macchina bellica russa contro le milizie finanziate e armate dai Saud (insieme a Turchia e Qatar) ha il potenziale per alterare il calcolo di costi/benefici del coinvolgimento saudita nella guerra civile. Proseguire uno scontro che non si può vincere, e in cui lo Stato Islamico continua a prosperare, rischia di essere più dannoso per gli interessi sauditi che non ammettere (a se stessi, non certo pubblicamente) la sconfitta e rinunciare a sottrarre – almeno per il momento – la pedina siriana dalle mani dell’Iran. L’Isis è stato negli ultimi anni una sciagura per Riad, avendo avuto l’effetto di frammentare il fronte sunnita e alienargli le simpatie occidentali, per reazione andate silenziosamente verso l’Iran e l’asse sciita. L’Arabia Saudita avrebbe il massimo interesse, nel lungo periodo, a veder scomparire l’Isis e le altre fazioni jihadiste, e tuttavia è sempre attratta fatalmente dal vantaggio di breve periodo di usare tali gruppi contro l’Iran e gli sciiti. Anche perché accettare la sconfitta dell’Isis equivarrebbe per Riad ad accettare di perdere le battaglie in corso con Teheran in Siria e in Iraq, sperando di trovarsi un domani in una miglior posizione per vincere la guerra (sempre indiretta ovviamente) con l’avversario regionale.
Su tutti questi movimenti aleggia poi l’ambiguo atteggiamento dell’America. Dopo aver a lungo tentennato sulla questione siriana, sembra che – al di là delle dichiarazioni pubbliche – la Casa Bianca si stia rassegnando a lasciare Damasco nelle mani dell’Iran e della Russia, con buona pace dell’alleato saudita. In cambio chiederebbe giusto il risultato minimo, per salvare le apparenze e la faccia, di sostituire Assad con un altro uomo, espressione però degli stessi interessi locali e regionali. Non è infatti un mistero che non esista un interlocutore, all’interno della ribellione, al contempo sufficientemente forte e sufficientemente affidabile da poter candidare alla successione del dittatore siriano (ad esempio, i ribelli “moderati” armati e addestrati con grave dispendio economico dagli Usa sono stati rapidamente annientati dal resto della ribellione islamista siriana). La transizione di cui si sta cominciando a ragionare, vista la situazione sul campo, sembra un modo per rendere “onorevole” la sconfitta dei nemici di Assad, Iran e Russia, ma non un serio preludio a significative rivoluzioni nel Paese mediorientale. Washington lo sa perfettamente e – complice forse anche la volontà di diminuire il proprio coinvolgimento nell’area del Mediterraneo e del Golfo, in favore di quella del Pacifico – non sembra al momento interessata a fare molto per impedirlo.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Negli ultimi 25 anni il Nepal, noto in Occidente per essere porta dell’Himalaya e paradiso degli hippie, ha conosciuto una straordinaria e turbolenta evoluzione politica. Dall’abbandono, nel 1991, del sistema tribale tradizionale indiano “panchayat” in favore del sistema partitico, alla decisione del Partito Maoista di iniziare la guerriglia armata nel 1996 per abbattere un sistema monarchico ancora feudale e incentrato sulle caste; dalla strage del Palazzo Reale del 2001 (quando il principe ereditario Dipendra uccise Re e Regina per poi suicidarsi ) alla svolta dittatoriale di Re Gyanendra (l’anziano zio di Dipendra, succeduto al fratello assassinato, che nel 2005 sciolse il governo e accentrò su di se il potere esecutivo per meglio contrastare i maoisti che oramai controllavano i due terzi del territorio); dalle proteste che l’anno successivo costrinsero Gyanendra a rinunciare al potere assoluto (e convinsero i maoisti a cessare le ostilità), all’abolizione della monarchia (dopo 240 anni) nel 2007 ; dalla Costituzione provvisoria del 2008 a quella definitiva, entrata in vigore lo scorso 20 settembre e votata dal Parlamento con una maggioranza di 507 favorevoli e 25 contrari.
La nuova Carta fondamentale è stata scritta da un’assemblea costituente, eletta nel 2013, composta tanto dalle forze tradizionali (in particolare il Partito del Congresso, democratico-riformista) quanto dagli ex ribelli maoisti (al contrario della precedente assemblea costituente, eletta nel 2008, dominata dai maoisti ma rivelatasi inconcludente). Un impulso fondamentale pare sia arrivato dalla necessità di dare al Paese un segnale di unità e speranza dopo il terribile terremoto del 25 aprile 2015, che ha causato oltre 8mila vittime . Nella nuova Costituzione lo Stato nepalese – in passato “regno Hindu” (religione dell’80% della popolazione) fino all’abolizione della monarchia – viene definita come una Repubblica secolare suddivisa in sette province federali. Questo è un deciso cambio di rotta rispetto alla forma di Stato unitario vigente finora, e proprio circa la suddivisione del territorio in sette parti – e sugli effetti del nuovo sistema elettorale – si sono registrate violente proteste da parte di alcune minoranze. I morti negli scontri sono stati, secondo le fonti ufficiali, quaranta.
In particolare i Tharus – gruppo etnico che vive nella regione meridionale del Terai al confine con l’India, tradizionalmente povero (addirittura “schiavizzato” negli anni ’50 con il sistema del Kamaiya, cioè sfruttamento del lavoro per debiti, da gruppi etnici appartenenti a caste superiori trasferitisi nei loro territori dopo la bonifica della malaria) – sono scontenti dell’essere divisi in due diverse province, e mischiati con altri gruppi etnici che potrebbero prevalere nel nuovo sistema elettorale. Infatti la quota di parlamentari eletti con metodo proporzionale scende al 45% (dal 58% della Costituzione provvisoria precedentemente in vigore), e questo – unito alla nuova configurazione delle sette province – rischia di essere un problema non solo per i Tharus ma per numerose minoranze che vedranno ridotta la loro rappresentanza. Anche i Madhesi, sempre stanziati nel Terai, hanno protestato contro la nuova Costituzione, in particolare per le norme che legano l’acquisto della cittadinanza da parte dei figli alla nazionalità del solo padre: da madre nepalese e padre straniero nasceranno quindi figli stranieri. Per i Madhesi, che statisticamente contraggono molti matrimoni con cittadini indiani della stesa etnia che vivono al di là del confine, questa norma è sessista e discriminatoria, e nel medio periodo porterà a una loro sottorappresentanza politica.
Il Nepal è uno degli Stati più poveri al mondo, nella società prevale ancora il modello patriarcale ed economicamente è molto arretrato. Qui ancora resistono varie diseguaglianze di stampo sessista, razzista e classista. Nel Paese coesistono – ma quasi senza mescolarsi, complice la divisione in caste – un centinaio di diverse etnie. I leaders dei partiti che hanno redatto la nuova Costituzione – maoisti inclusi – sono maschi e appartengono tutti alle caste alte. Questo elemento, unito alle problematicità sopra citate, ha ulteriormente acutizzato le preoccupazioni delle minoranze e dei gruppi di tutela dei diritti delle donne. Anche l’India ha espresso preoccupazione, temendo che le proteste violente di alcuni gruppi etnici che vivono sul confine possano travasarsi nel proprio territorio. Tuttavia, secondo quanto riporta la maggioranza dei mass media locali e asiatici, la maggioranza dei nepalesi sembra contenta per la nuova Carta. In primo luogo viene visto comunque come un successo l’aver finalmente raggiunto un traguardo inseguito inutilmente per sette anni. Poi, è la speranza dei sostenitori, la nuova Costituzione aumenterà la certezza del diritto, la stabilità del Paese e, conseguentemente, aiuterà l’economia. Infine, come viene propagandato soprattutto dai partiti che hanno votato a favore di tale Carta, si tratta comunque di una legge di carattere progressista rispetto alla situazione esistente. Particolarmente felici sono poi i rappresentanti delle comunità lesbiche, gay, bisex e transgender (LGBT) che hanno visti riconosciuti i loro diritti direttamente nella Costituzione. Delusi invece tanti ex guerriglieri maoisti che speravano di rivoluzionare lo Stato e la società nepalese, abbattendo le divisioni del passato e redistribuendo la ricchezza, e che devono invece accontentarsi di un compromesso da loro ritenuto al ribasso.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Non si arresta la scalata della Cina per diventare una super-potenza militare, oltre che economica. Secondo quanto emerge dalle ultime foto satellitari mostrate pochi giorni fa dal Center for Strategic and International Studies di Washington, la Repubblica Popolare avrebbe ulteriormente ampliato le proprie installazioni nell’arcipelago delle isole Spratly, nel Mar Cinese meridionale. Negli ultimi dodici mesi Pechino ha “costruito” sette nuove isole, su cui ha installato basi, porti ed aeroporti. Da ultimo una pista di atterraggio lunga 3 km. Questa capacità tecnica di creare isole artificiali pare abbia colto di sprovvista gli Americani, che nell’Oceano Pacifico puntano a sviluppare i propri interessi nei decenni a venire.
Se le opere di pionierismo ingegneristico dei cinesi sono una novità, non lo è però la disputa internazionale sulle Spratly . Fin dai tempi del colonialismo europeo, ma soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, questo arcipelago è conteso tra più Stati. Attualmente, oltre alla Cina, avanzano rivendicazioni il Brunei, Taiwan, il Vietnam – che ha oltre venti basi sparse tra le isole -, la Malesia e le Filippine (questi ultimi tre Paesi sono alleati degli Usa). Per decenni si sono susseguite scaramucce e anche crisi più gravi, ma negli ultimi anni Pechino sembra aver premuto decisamente sull’acceleratore. La Cina vuol portare a compimento il sogno della “Grande Muraglia di Sabbia”, cioè un cuscinetto di sicurezza attorno alle proprie coste che farebbe perno su diversi arcipelaghi: Spratly, Paracel (sottratte militarmente al Vietnam nel 1974), Pratas, Macclesfield Bank e Scarborough Shoal. Su tali isole verrebbero collocate diverse Adiz (Air Defence Identification Zone), che consentirebbero a Pechino di controllare qualunque sconfinamento nella zona cuscinetto da parte di navi o aerei stranieri. Si tratta insomma di una linea di demarcazione e di difesa che la Repubblica Popolare vuole costruire intorno a sé. Poco importa se le isole in questione sono molto più lontane dalle coste cinesi (1.100 km) di quanto non lo siano, ad esempio, da quelle filippine (240 km).

«La condotta aggressiva della Cina nasce da un progetto strategico ben definito a Pechino già a metà degli anni ’90: limitare, non potendola eliminare, la proiezione di potenza degli Stati Uniti sul proprio territorio», spiega Claudio Neri, esperto di questioni militari e direttore dell’Istituto italiano di studi strategici. «Con proiezione di potenza intendiamo la capacità di portare attacchi militari in territorio nemico e, escludendo le testate nucleari per cui vale un diverso discorso, al momento gli Stati Uniti sono l’unico Paese in grado di avere – tramite portaerei, navi di appoggio, cargo militari, aviazione etc – una tale proiezione con armi convenzionali sull’intero globo, e di poter negare a qualsiasi altro Stato la proiezione sul suolo americano», prosegue Neri. «La Cina, come dicevo, è da venti anni che sta studiando come limitare la proiezione di potenza americana sul proprio territorio: da un punto di vista tecnologico (ad esempio sviluppando capacità di cyberwarfare o, ancora, testate “anti-satellite”, per “accecare” lo strumento con cui gli Usa hanno la possibilità di individuare e colpire qualsiasi bersaglio sul pianeta), ma anche da un punto di vista geografico. Le pretese di Pechino sulle Spratly si spiegano perfettamente in questo contesto, nascono dal desiderio di aumentare la distanza minima a cui possono avvicinarsi navi o aerei americani (o di altro Paese) senza che la Cina sia in grado di reagire immediatamente».
Ovviamente il valore delle Spratly e degli altri arcipelaghi non è esclusivamente militare. Oltre ad essere – pare – ricchi di risorse naturali, sono punti strategicamente fondamentali per il controllo dei traffici marittimi, commerciali in primis, e Pechino è fortemente interessata a garantirsi una via di approvvigionamento sicura e preferenziale verso il Golfo Persico, da cui ancora dipende – e probabilmente dipenderà anche nei decenni a venire – per i rifornimenti di greggio e gas naturale. Secondo gli analisti americani, ma non solo, il centro del mondo – o quantomeno il centro degli interessi delle superpotenze mondiali – sarà in futuro sempre meno Europa e Medio Oriente e sempre più l’Oceano Pacifico.
«L’amministrazione Obama aveva teorizzato uno spostamento del baricentro di interessi americani verso il Pacifico, e contava anche di aumentare la presenza militare statunitense in quell’area», dice ancora Neri. «Le crisi in Ucraina e nel mondo arabo da un lato e, soprattutto, il rischio di “bandwagoning” – la tendenza cioè a non investire proprie risorse nell’apparato bellico in presenza di un alleato più potente che si fa carico della gestione della sicurezza nell’area ndr. – da parte degli alleati locali dall’altro, hanno però spinto gli Usa a contenere questo previsto dispiegamento dell’apparato bellico. In compenso l’America spronato gli alleati nella regione a investire maggiormente nella propria sicurezza – ad esempio è caduto il veto americano su un riarmo di stampo nazionalista del Giappone, che infatti sta modificando la propria costituzione pacifista nata dopo il secondo conflitto mondiale – per rispondere all’escalation cinese, e li ha ulteriormente rassicurati sull’intenzione di mantenere, e anzi rafforzare, la propria presenza. Non potendo replicare un modello analogo a quello della Nato – considerate la complessità dello scenario asiatico, la sua vastità e la per ora relativa mancanza di una minaccia immediata – gli Usa vorrebbero quindi», conclude Neri «creare un’alleanza (per ora informale) militare, politica ed economica coi propri partners regionali per contenere la Cina. Ad esempio ricade in questo scenario il percorso di approvazione del Transpacific Trade Agreement». La Cina non è l’Unione Sovietica, e per ora l’espansionismo di Pechino sembra limitato e di carattere difensivo. Addirittura la Repubblica Popolare potrebbe avere interesse a entrare nel Transpacific Trade Agreement, secondo una logica del “se non puoi batterli unisciti a loro”. Ma nonostante la momentanea assenza di un grave e immediato pericolo di scontro aperto nella regione, un’arena in cui cozzano gli interessi di Cina, Russia, Stati Uniti, Coree, Australia e Giappone – solo per citare gli attori principali –, e in cui sta crescendo la corsa agli armamenti, viene considerata dagli esperti un fattore di potenziale instabilità nel futuro per l’intero pianeta.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Se il mercato delle armi è da sempre fiorente in Medio Oriente, l’accordo sul nucleare con l’Iran sembra aver dato un ulteriore impulso alla corsa agli armamenti nella regione. L’Arabia Saudita, in particolare, ha aumentato a 67 biliardi di dollari la spesa militare nel 2013 (+14% rispetto all’anno precedente) e a 80,8 biliardi l’anno successivo (+17% sul 2013), diventando così – secondo quanto riportato dallo Stockholm International Peace Research Institute – tra i 15 maggiori compratori di armi del mondo quello che ha maggiormente incrementato gli investimenti nel 2014. E il 2015 dovrebbe rappresentare un nuovo balzo in avanti.
L’Arabia Saudita è da vari decenni – dalla Rivoluzione khomeinista del 1979 – in competizione con l’Iran per l’egemonia dell’Islam politico, e tanto Riad quanto Teheran alimentano lo scontro intrareligioso tra sunniti e sciiti in tutti i Paesi del Medio Oriente per cercare di guadagnare influenza a discapito dell’altro. Dalla recrudescenza delle Primavere arabe in poi questo scontro è esploso con una violenza quasi senza precedenti, e sono diversi gli Stati – Siria, Yemen, Iraq, Bahrein – che sono stati travolti dalle proxy war tra gli Ayatollah iraniani e la casa reale dei Saud. In questo scenario non era imprevedibile che Riad avrebbe vissuto come uno schiaffo la trattativa sul nucleare, condotta dal proprio storico alleato – gli Stati Uniti – insieme al proprio storico nemico – l’Iran. Fino alla recente visita di Re Salman a Washington, durante la quale il monarca saudita ha addirittura dato il proprio benestare all’accordo raggiunto con Teheran, i rapporti tra sauditi e Usa si erano significativamente raffreddati.
Nel corso della visita pare che Re Salman sia stato rassicurato sull’intenzione della Casa Bianca di non alterare il quadro delle alleanze in Medio Oriente, di monitorare strettamente l’implementazione dell’accordo sul nucleare da parte dell’Iran e di contenerne le politiche espansioniste nell’area. Di qui, oltre che dall’impossibilità di ribaltare la situazione (vista anche la solidità dei numeri su cui Obama può ora contare nel Congresso chiamato a ratificare l’accordo), il via libera all’intesa con Teheran.
Dietro le dichiarazioni ufficiali resta però l’innegabile evidenza che l’accordo con Teheran sblocca decine, addirittura centinaia, di miliardi di dollari per l’Iran precedentemente congelati dalle sanzioni. La maggior parte degli analisti ritiene che questi soldi andranno a finanziare gruppi armati sciiti in Libano, in Yemen, in Iraq, il governo di Assad in Siria e via dicendo, danneggiando così gli interessi sauditi. Inoltre tra cinque anni decadrà l’embargo sulle armi convenzionali per l’Iran. È ovvio che a Riad siano state date in garanzia più che parole da parte del suo alleato americano.
E infatti il Dipartimento di Stato americano ha annunciato poco tempo fa un accordo da 5,4 biliardi di dollari con l’Arabia Saudita per 600 nuovi missili intercettori PAC-3 Patriot. Ma non solo. Dagli Stati Uniti dovrebbero arrivare due nuove fregate e una decina di elicotteri MH-60R (utili anche contro i sottomarini); dal Canada veicoli da combattimento per 15 biliardi di dollari; con la Francia i Saud stanno trattando l’acquisto di due navi da guerra classe Mistral (originariamente destinate alla Russia); con la Germania – prima che Berlino sospendesse, per ora indefinitamente, le vendite di armi a Riad – stava valutando l’acquisto di decine di sottomarini da guerra; la corsa agli armamenti da parte dei sauditi è talmente sfrenata che starebbero pianificando affari anche con la Russia, Stato che pure supporta l’avversario iraniano e il suo alleato siriano Assad. Da Mosca potrebbero arrivare gli Iskander, micidiali missili balistici tattici a corta gittata.
Questa bulimia saudita nasce da diversi fattori. In primo luogo dall’accordo con l’Iran, che rischia di rafforzare (geopoliticamente ed economicamente) il rivale sciita a discapito di Riad. In secondo luogo dal fatto che nel dopo-Primavere Arabe l’Iran è stato abile a sfruttare lo sfaldamento dell’ordine regionale, specie nei Paesi sunniti, per guadagnare posizioni nello scacchiere mediorientale: in Iraq è il principale attore straniero nella lotta contro l’Isis, in Siria ha impedito la caduta dell’alleato Assad, in Libano controlla e rafforza Hezbollah, e in Yemen fomenta una ribellione alle porte del regno saudita. Infine aleggia su tutte le questioni il timore del progressivo disimpegno da parte dell’alleato americano, già da qualche anno intenzionato a ridurre la propria presenza nel Mar Mediterraneo e nel Golfo Persico per privilegiare l’area dell’Oceano Pacifico.
La corsa al riarmo da parte dei Saud, a cui farà probabilmente seguito quella da parte dell’Iran non appena decadrà l’embargo sulle armi convenzionali, apre a scenari con grandi rischi e grandi opportunità. I rischi sono ovviamente quelli di un’ulteriore degenerazione delle violenze in tutti gli Stati del Medio Oriente coinvolti dalla faida tra sunniti e sciiti, con pericolo di tracollo dell’intera regione e proliferazione del terrorismo di matrice jihadista. Il fatto che, come fanno notare alcuni esperti, storicamente in questa regione al riarmo non seguano scontri aperti, non è una garanzia assoluta visto il momento storico eccezionale, in cui sembra stia crollando l’ordine nato con la fine del colonialismo e qualcosa di nuovo si profili all’orizzonte.
Le opportunità nascono invece da un potenziale diverso sviluppo degli eventi: che a fronte degli insuccessi delle soluzioni militari (al momento palesi tanto in Siria quanto in Yemen, ad esempio), a fronte della sfida che il terrorismo jihadista (Isis e Al Qaeda) pone a tutti gli Stati mediorientali – Sauditi in primis -, a fronte del progressivo disimpegno statunitense, Teheran e Riad riescano a trovare un accordo che garantisca la pace della regione e, soprattutto, che spartisca le sfere di influenza, creando così un nuovo ordine garantito dagli ingenti armamenti di ciascuno degli attori coinvolti. Questo scenario sarebbe possibile solo se l’Iran, dopo l’intesa sul nucleare, riconoscesse agli Usa un ruolo di mediatore con l’Arabia Saudita nel raggiungimento dell’accordo. Ma qui si cela un’ulteriore insidia: tanto a Washington quanto a Teheran non è escluso che la linea politica cambi, e con essa qualsiasi prospettiva per il futuro del Medio Oriente.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

«Non so quanto sia esteso il coinvolgimento militare della Russia in Siria, ancora non ne è chiara la portata», ha dichiarato alla Reuters lo scorso nove settembre Amos Gilad, consigliere anziano del ministro israeliano della Difesa, Moshe Yaalon. «Non hanno ancora cominciato a operare. Per ora stanno rafforzando il loro potenziale».
L’intensificarsi della presenza di Mosca a sostegno del regime di Bashar al Assad, suo alleato storico e nel cui territorio risiede la importante base navale russa di Tartus, preoccupa Israele – che dovrà stare attenta a non colpire obiettivi russi nei suoi, ad ora sporadici e di carattere preventivo, raid contro l’esercito siriano e soprattutto contro Hezbollah – e interroga l’Occidente. Finora il Cremlino ha negato l’intenzione di intervenire militarmente in modo massiccio nella guerra civile siriana, ma ha ammesso il recente invio di armi, del resto oramai evidente. Prima indiscrezioni di stampa, poi un report della Cia, e infine anche del materiale fotografico (in parte prodotto dagli stessi militari russi) avevano confermato la presenza di carri armati BTR-82, di fanteria e corpi speciali di Mosca, nonché di installazioni per il controllo aereo da installare a Latakia. Sono poi stati segnalati movimenti di navi russe con materiale bellico diretto in Siria. A questo punto la portavoce del ministro degli Esteri Maria Zakharova ha ammesso l’intenzione di rafforzare Assad, spiegando che la consegna degli armamenti ha l’obiettivo di «scoraggiare la minaccia terroristica in Siria, giunta a un livello senza precedenti».
«L’impegno di Mosca – materiale e istruttori – in Siria non è una novità né un mistero, era già stato confermato in passato dallo stesso Putin come parte della strategia russa di lotta al terrorismo», spiega Germana Tappero Merlo, analista esperta di geopolitica e contro-terrorismo. «Nell’Isis sono infatti coinvolti sia ceceni che daghestani, e il Cremlino teme un possibile “ritorno di fiamma” nel Caucaso. Tuttavia in primo luogo il sostegno russo ad Assad è precedente all’arrivo dello Stato Islamico (Damasco veniva aiutata già nella prima fase della guerra civile, quando gli insorti erano ancora in prevalenza moderati) e, inoltre, di recente tale sostegno è sicuramente aumentato, come confermato dalle foto degli stessi soldati russi e da rilevazioni satellitari americane. Secondo fonti occidentali questa potrebbe essere una mossa di posizionamento già in ottica post-Assad per cui la Russia, blindando la propria presenza militare, si garantisce una posizione negoziale di forza quale che sia l’esito del conflitto. Ma esiste il timore – espresso anche dal Segretario di Stato americano Kerry – che ad un maggior coinvolgimento di Mosca nel conflitto faccia seguito un’ulteriore escalation delle violenze. In particolare il rischio è che ne traggano vantaggio gli estremisti islamici (Stato Islamico in primis), che aumenti ancor di più l’instabilità del Paese e che le possibilità, già scarse, di una soluzione diplomatica vengano definitivamente compromesse».
Ma, come spesso accade quando si parla di Russia, è difficile separare la propaganda (di tutte le parti coinvolte) dalla verità. «Putin sostiene che i rumors circa un prossimo intervento di Mosca in Siria siano voci per mettere in cattiva luce la Russia, e per gravarla della responsabilità dell’escalation e del peggioramento del conflitto siriano», prosegue Tappero Merlo. «Di sicuro negli Usa, e anche in Israele, chi è ostile all’accordo sul nucleare con l’Iran cerca di amplificare i pericoli legati all’aumento della presenza russa in Siria, per dimostrare che le scelte dell’amministrazione Obama hanno deteriorato la situazione sul campo e hanno aperto spazi di manovra per “l’odiata” Russia». Dall’eventuale intervento russo avrebbe da guadagnarci infatti, oltre ovviamente ad Assad, soprattutto l’Iran. «A Teheran interessa non solo la difesa del proprio alleato in Siria, ma anche rafforzare il legame con Mosca. Di recente la Russia ha venduto molti armamenti agli Stati del Golfo, avversari dell’Iran (la cosa non deve stupire vista la centralità delle esportazioni di armi nella sua economia ndr.)» continua Tappero Merlo, e conclude: «Per gli Ayatollah iraniani diventa quindi fondamentale avere un rapporto il più stretto possibile col Cremlino – anche in vista delle fine, tra cinque anni, dell’embargo sulle armi convenzionali di cui è oggetto -, per posizionarsi nel migliore dei modi nello scontro in corso (e pare destinato a protrarsi ancora per anni) con i Sauditi».
Le ragioni che tuttavia sconsigliano alla Russia di intervenire via terra in modo determinante sono le stesse che hanno fin qui frenato l’Occidente: sul territorio regna il caos, con fazioni frammentate e una situazione liquida difficile da leggere; inoltre a livello regionale la partita è tra Iran e Arabia Saudita, e Mosca – pur avendo un legame ad oggi più stretto con Teheran – non ha interesse a inimicarsi eccessivamente Riad. Intervenire militarmente significherebbe poi esporsi a pesanti attacchi, in Siria ma anche in patria, da parte del terrorismo jihadista, comprometterebbe le relazioni con la Turchia (che dalla sconfitta dell’Isis e della ribellione in generale teme possano avvantaggiarsi i Curdi, per creare un’entità autonoma ai suoi confini) e con altri attori regionali come il Qatar. Tuttavia un importante aiuto alla causa di Assad, diretto ma non eccessivamente visibile, non è da escludere. In questo caso il regime siriano guadagnerebbe un fondamentale puntello di sostegno (e Iran ed Hezbollah ne trarrebbero beneficio), la ribellione (specie nelle sue componenti estranee all’Isis) vedrebbe ulteriormente assottigliarsi le proprie chance di vittoria, e lo Stato Islamico guadagnerebbe probabilmente in popolarità (e magari anche nei finanziamenti che le provengono dagli Stati sunniti del Golfo), pur magari perdendo una fetta del territorio che attualmente controlla. In quest’ultimo caso Mosca dovrebbe comunque essere cauta nel non avvantaggiare eccessivamente i curdi, per non correre il rischio di esacerbare i rapporti con Ankara, con cui ha fondamentali legami economici e progetti per il futuro.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Dopo appena cinque mesi dall’inizio delle ostilità sono 13 milioni (su 24 milioni totali) gli yemeniti duramente colpiti dalle conseguenze della guerra civile, di cui 6 milioni in situazione di estrema difficoltà (1 milione i bambini malati e malnutriti): queste le cifre fornite dalla direttrice del Programma alimentare mondiale – un’agenzia dell’Onu – Ertharin Cousin. «Siamo al limite di un dramma umanitario – dichiara la Cousin – speriamo vivamente che le parti coinvolte nel conflitto capiscano che la gente non può attendere una soluzione politica».
E il punto è esattamente questo: una soluzione politica non è nemmeno all’orizzonte. Lo scontro tra i ribelli sciiti Houthi (supportati dall’Iran) e i sunniti, fedeli all’ex governo di Abd-Rabbu Mansour Hadi e che godono del sostanzioso aiuto dell’Arabia Saudita, non pare destinato a risolversi nel breve periodo. Questa ennesima proxy war tra Teheran e Riad sembra destinata a durare (come probabilmente anche tutte le altre) finché non emergerà un vincitore da questo scontro, e gli equilibri del Medio Oriente non verranno un’altra volta ancora decisi a tavolino, dividendo le sfere di influenza.
La ribellione degli Houthi, minoranza sciita che conta circa un terzo della popolazione, va avanti da circa un decennio. Nel corso delle Primavere Arabe, nel 2011, avevano ottenuto che fosse cacciato il presidente Saleh, sciita anch’esso ma considerato un fantoccio di Riad, e la seguente fase di transizione era stata portata avanti sotto la guida dell’Onu. Il governo di unità nazionale, nato nel 2012 e presieduto da Hadi, aveva promesso di riconoscere agli Houthi un’ampia autonomia e nei mesi successivi era stato siglato un accordo di pace tra le fazioni. La sua mancata implementazione, almeno secondo le accuse mosse dal fronte sciita, aveva portato gli Houthi a occupare la capitale Sanaa nel settembre del 2014, a mettere Hadi agli arresti domiciliari e a prendere il controllo della tv di Stato nel gennaio 2015 e infine a scatenare la guerra civile nei mesi successivi, avanzando sempre più verso Aden, la strategica città di porto nel sud del Paese dove Hadi era riparato e da cui fugge, appena prima che cada nelle mani degli Houthi, per trovare asilo a Riad. Attualmente il Paese è diviso in due aree: quella a nord-ovest in mano agli insorti, e quella centro/sud-est in mano ai lealisti (nelle vaste aree desertiche del centro del Paese è poi fortemente presente Al Qaeda).
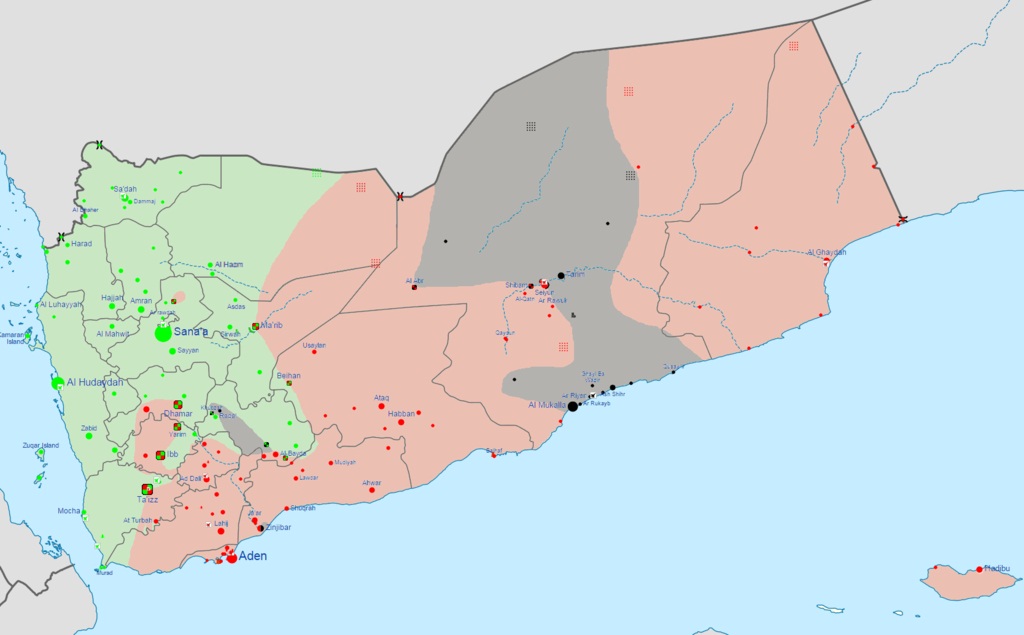
Di fronte all’avanzata degli Houthi, l’Arabia Saudita – alla guida di una coalizione di nove stati arabi – da marzo ha cominciato una campagna di bombardamenti di crescente violenza contro gli obiettivi Houthi in Yemen. Lo Yemen è infatti considerato da Riad il “giardino di casa”, occupando tutto il sud ovest della penisola arabica, e ha una fondamentale valenza strategica per il controllo del traffico marittimo da e per il Mar Rosso. Il rischio che possa cadere nelle mani degli sciiti, specialmente nel momento storico in cui all’Iran – grazie all’accordo sul nucleare – viene data legittimità internazionale e accesso alle risorse economiche fino ad ora bloccate dalle sanzioni, per i Saud è inaccettabile. Di qui un’inevitabile escalation. Grazie ai bombardamenti sauditi Aden, prima caduta nelle mani dei ribelli, è stata riconquistata dalle truppe lealiste e Hadi starebbe programmando per settembre un suo ritorno in città dopo l’esilio saudita. Attentati di diversa matrice si susseguono in tutto il Paese – non solo Houthi e lealisti, ma anche la branca locale di Al Qaeda e da marzo pure lo Stato Islamico si muovono nel caos della guerra civile – e Riad, secondo quanto affermato da fonti militari saudite, starebbe progettando di portare i propri attacchi anche nel nord del Paese, nel cuore della resistenza sciita.
A livello geopolitico sullo Yemen si scaricano le contraddizioni della politica mediorientale occidentale. Gli Stati Uniti sostengono l’Arabia Saudita nella sua campagna di bombardamenti contro i ribelli – che è il principale motivo dell’emergenza umanitaria in corso – in parte per una politica di “balance of power” rispetto all’accordo sul nucleare raggiunto con l’Iran, che ha preoccupato moltissimo l’alleato saudita (e non solo), in parte perché l’industria militare americana sta traendo enormi profitti dalla corsa agli armamenti che Riad (e non solo) sta portando avanti in risposta al rafforzamento di Teheran. Stesso discorso per la Francia: il settore dell’industria bellica francese sta facendo affari miliardari con la casa reale saudita grazie alla faida in corso tra sunniti e sciiti (link 9). Tuttavia entrambi questi Paesi fanno parte del 5+1 (gli Stati membri del Consiglio di sicurezza dell’Onu, più la Germania) che ha negoziato l’accordo sul nucleare con l’Iran, che sblocca risorse per Teheran quantificate in oltre 100 miliardi di dollari. Miliardi che, secondo gli analisti, è probabile vadano a finanziare la guerriglia sciita in tutti gli scenari di crisi in Medio Oriente: dalla Siria all’Iraq, dal Libano a, ovviamente, lo Yemen. Teheran infatti, se non può sperare di sottrarre la pedina yemenita al rivale saudita, può almeno cercare di distogliere ingenti risorse di Riad da altri scenari strategicamente più importanti per l’Iran (in particolare Siria e Iraq) per costringerla ad impiegarle in Yemen. In un modo o nell’altro l’Occidente sta quindi, di fatto, sostenendo entrambe le parti in conflitto, traendone anche un notevole beneficio economico.
In questa situazione di caos, si diceva, si muovono però anche altre attori oltre alle due fazioni principali in lotta: Al Qaeda nella Penisola Arabica (Aqap), la più pericolosa delle sigle qaedista ancora in azione (quella che ha rivendicato l’attentato a Charlie Hebdo, per esempio) e che qui controlla vaste zone di territorio, e da poco anche lo Stato Islamico. Il timore degli esperti è che possano approfittare della situazione di violenza endemica per trovare nuove reclute, nuove armi e, soprattutto, nuovi finanziamenti. Storicamente l’Arabia Saudita ha infatti dimostrato di non andare troppo per il sottile quando si tratta di finanziare gruppi armati sunniti in ottica anti sciita. Se i petroldollari di Riad finissero nelle tasche sbagliate, all’emergenza umanitaria che si scarica sulla popolazione civile yemenita, potrebbe aggiungersi presto un’emergenza terrorismo preoccupante anche per la popolazione civile occidentale.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

L’Iran ha bruscamente rotto i rapporti con Hamas. Secondo quanto riportato da fonti dell’organizzazione palestinese stessa e dalla stampa israeliana, la Repubblica Islamica avrebbe deciso di sospendere ogni finanziamento all’oramai ex alleato. Il motivo sarebbe, secondo gli analisti, l’avvicinamento di Hamas all’Arabia Saudita, grande avversario dell’Iran per l’egemonia regionale e con cui Teheran sta conducendo oramai da qualche anno una guerra per interposte fazioni (“proxy war”) in tutti gli scenari di crisi in Medio Oriente, dove passa la frattura tra sunniti e sciiti: Siria, Iraq, Yemen e Bahrein.
I rapporti tra Iran e Hamas si erano già incrinati e poi interrotti tre anni fa, quando l’organizzazione palestinese – storicamente supportata dall’Iran e dal suo fedele alleato libanese sciita Hezbollah – si era rifiutata di appoggiare Bashar al Assad in Siria . Il dittatore siriano appartiene alla minoranza alawita, riconducibile allo sciismo, ed è una pedina strategica per Teheran. I ribelli che da quattro anni provano a rovesciarlo sono in larga parte sunniti e, prima che prevalessero le componenti jihadiste, erano in buona parte legati alla Fratellanza Musulmana, come la stessa Hamas. Nel 2012 l’organizzazione palestinese scelse di stare coi ribelli, subendo così la ritorsione economica dell’Iran, e avvicinandosi all’Egitto di Mohammed Morsi, anche lui membro della Fratellanza. Tuttavia il golpe militare di Al Sisi al Cairo nel 2013, e il fallimento del progetto politico – propiziato anche dalla Turchia – di portare al potere i Fratelli Musulmani nei Paesi travolti dalle Primavere Arabe, costrinsero Hamas a tornare sui propri passi, riagganciando progressivamente i rapporti con la Repubblica Islamica nel 2014.
Da allora la leadership di Hamas ha tenuto un atteggiamento ambiguo, mantenendo i rapporti con Teheran ma flirtando – più o meno apertamente – con i Saud. Il nuovo Re Salman sembra infatti meno pregiudizialmente ostile alla Fratellanza Musulmana rispetto al suo predecessore Abullah, e la prospettiva di sottrarre all’Iran una pedina simbolicamente importante come Hamas pare aver propiziato l’atteggiamento di realpolitik dei sauditi. I rapporti si sono fatti più stretti negli ultimi mesi – fino a far circolare voci su una possibile trattativa segreta tra l’organizzazione palestinese e Israele, propiziata proprio dai Saud – e, lo scorso 15 luglio, Kalhed Meshaal, capo del braccio politico di Hamas, è atterrato a Riad per una due giorni di incontri e a metà agosto dovrebbe tornarci. L’esito, secondo quanto riportato dalla stessa organizzazione palestinese, sarebbe stato incoraggiante circa l’avvicinamento con Riad. Due settimane dopo questo meeting, e dopo un’escalation di attacchi sui media iraniani, Teheran ha deciso di interrompere nuovamente i finanziamenti ad Hamas.
Secondo gli esperti non è certo che si tratti di una scelta definitiva, ma per l’Iran un “tradimento” di Hamas con la Fratellanza Musulmana – come quello avvenuto nel 2012 – è meno pericoloso di quello in corso con i loro avversari regionali Sauditi (che sono sunniti ma nemici dei Fratelli Musulmani, in quanto wahabiti). Se l’allontanamento fosse confermato, e anzi le distanze andassero aumentando, le conseguenze sullo scenario medio orientale sarebbero potenzialmente dirompenti: l’Iran potrebbe approfittare del momento di disgelo dei rapporti diplomatici seguito all’accordo sul nucleare per cercare, quasi sicuramente in segreto, un’intesa con Israele, mantenendo Hezbollah impegnato negli scenari siriano e iracheno, e trascurando la causa palestinese. E nel medio-lungo periodo il processo di pace tra palestinesi e israeliani potrebbe beneficiarne (anche se al momento i segnali sono di segno opposto) per varie ragioni.
Innanzitutto i due principali movimenti palestinesi, Fatah e Hamas, si troverebbero ad avere sostanzialmente gli stessi sponsor internazionali (le monarchie del Golfo), e non due parti in conflitto (Iran e Saud). L’Arabia Saudita, poi, negli ultimi anni – causa l’imminente accordo sul nucleare che, eliminando le sanzioni, sblocca miliardi di dollari per il comune nemico iraniano – ha forgiato un rapporto con Israele di tacita alleanza. Nelle future trattative questo potrebbe essere secondo gli esperti un elemento importante. Inoltre Riad è alleata del Cairo, che finanzia e arma generosamente. Re Salman potrebbe convincere il generale Al Sisi ad allentare la morsa sui valichi con Gaza, alleviando così le condizioni della popolazione e consentendo ad Hamas di incassare i dividendi in termini di consenso.
Militano contro queste prospettive di ripresa del dialogo di pace sia le sempre maggiori tensioni nei territori tra palestinesi e israeliani, sia la crescente distanza tra Hamas e Fatah. Il presidente palestinese Abbas (di Fatah) ha di recente operato un rimpasto di governo che danneggia il movimento islamista, compromettendo forse definitivamente le prospettive di riconciliazione nazionale nel breve termine. Tuttavia Abbas è in una posizione sempre più isolata, anche all’interno del suo movimento, e circolano voci di sue possibili clamorose dimissioni, a settembre, dal palco dell’assemblea generale dell’Onu. I nomi sul piatto per la successione sarebbero soprattutto quelli di Saeb Erekat (delfino di Abbas) e dell’ex primo ministro Salam Fayyad. Pare che le monarchie del Golfo, in questa prospettiva, per avere una maggior presa sul prossimo presidente stiano muovendo capitali e relazioni diplomatiche, scommettendo su più cavalli contemporaneamente.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Alla svolta con cui la Turchia pare abbia abbandonato la connivenza con l’Isis – utile in funzione anti-curda e anti-Assad in Siria – per unirsi alla coalizione internazionale che combatte lo Stato Islamico, sono seguiti giorni di condotta ambigua da parte di Ankara.
Più che il Califfato sembra essere finito nel mirino dell’esercito e della polizia turchi il Pkk, il partito marxista curdo che da decenni lotta – anche tramite attentati – per l’indipendenza del Kurdistan, considerato da Turchia e Usa un’organizzazione terroristica, ma con cui erano in corso da due anni una tregua e delle trattative, fatte saltare da Ankara subito dopo l’annuncio della propria partecipazione alla guerra all’Isis. Nel corso del conflitto in Siria, tuttavia, i curdi siriani del Ypg (ala militare) e Pyd (ala politica), che sono collegati a doppio filo col Pkk, sono diventati progressivamente l’alleato più prezioso per gli Usa nella guerra all’Isis, la fanteria dell’aviazione internazionale. Indebolirli – anche tramite la creazione della “safe zone” al confine ipotizzata da Ankara, se diventasse un pretesto per stroncare sul nascere l’entità autonoma curda nel nord della Siria, la Rojava – significherebbe aiutare indirettamente lo Stato Islamico.
Il presidente turco Erdogan e il primo ministro Davutoglu sono dunque di fronte a un bivio e, secondo gli analisti, ancora non hanno preso una decisione definitiva, se dare la precedenza alla repressione dei curdi o sfruttare l’occasione della guerra al Califfato per riguadagnare centralità politica regionale e rapporti più stretti con l’Occidente. Se inseguire la linea ideologica del partito – l’islamico e sunnita Akp, vicino alla Fratellanza Musulmana – o il vantaggio strategico che potrebbe derivare dalla svolta. In attesa di capire cosa succederà sul fronte interno – dopo le ultime elezioni in cui l’Akp ha perso la maggioranza assoluta manca ancora un governo e secondo alcuni analisti Erdogan si starebbe preparando a nuove elezioni – il presidente e il premier secondo gli esperti prolungheranno un atteggiamento ambivalente in politica estera.
«La Turchia fino a poco tempo fa supportava, più o meno indirettamente, l’Isis in funzione anti-curda, per mantenere una situazione di “balance of power”», spiega Claudio Neri, direttore dell’Istituto italiano di studi strategici. «Adesso, su pressione americana e non solo, è stata trascinata nella guerra all’Isis e, non avendo ancora deciso in che direzione andare, bombarda tanto gli uomini del Califfo quanto i guerriglieri curdi, fiaccando così entrambe le fazioni e mantenendo l’equilibrio. Se si concentrasse solo su bersagli dello Stato Islamico il vantaggio per i curdi sarebbe immediato e sostanziale. Probabilmente – conclude – si vedrà nelle prossime settimane in che direzione intende andare Ankara e, oltre ai fattori interni, molto peserà l’evoluzione dei rapporti tra Usa e Iran dopo l’accordo sul nucleare».
Uno dei motivi che spingono gli analisti a ritenere che, uscita da questa fase di stallo, sia più probabile che la Turchia alla fine si concentri sullo Stato Islamico, accettando di aiutare indirettamente i curdi e anche Assad, è proprio la nuova prospettiva per le dinamiche economiche regionali con la fine delle sanzioni all’Iran: il governo turco stima tra i 35 e i 50 miliardi di interscambio economica con Teheran. La partecipazione allo sforzo bellico contro lo Stato Islamico – e un’eventuale riduzione, ovviamente ufficiosa, del supporto ai ribelli anti-Assad – potrebbe essere spesa al tavolo negoziale con l’Iran per ottenere rapporti privilegiati, e anche per discutere con Teheran della questione curda (secondo indiscrezioni di stampa l’Iran starebbe già trattando coi curdi per garantire loro una vera autonomia in cambio degli sforzi in Siria contro l’Isis, un aiuto de facto ad Assad).
Ma non c’è solo la questione iraniana a pesare. Gli Usa, che pure hanno giustificato il recente comportamento di Ankara nei confronti del Pkk anche in sede Nato (più freddi gli Stati europei, Germania in primis), non sembrano tuttavia disposti a tollerare che la Turchia esageri nel colpire i movimenti curdi, indebolendo così il contrasto all’espansione del Califfato. Fonti dell’amministrazione americana citate da Foreign Policy hanno dichiarato che non abbandoneranno al loro destino i curdi e che «non vogliamo che la situazione si complichi. I curdi siriani hanno riportato importanti successi, e non li dimenticheremo». Tra Ankara e Washington stanno poi emergendo divergenze anche sulla “safe zone” che si vorrebbe creare sul confine nord della Siria. Gli americani vorrebbero usarla come base per attaccare l’Isis, addestrando qua ribelli siriani moderati (finora il programma è stato un disastro: a fronte di 500 milioni di dollari stanziati sono stati addestrati appena 60 uomini, e alla prima prova sul campo il loro comandante e diversi altri membri pare siano stati catturati dalla formazione qaedista Al Nousra ad Aleppo. I Turchi vorrebbero – per ora, a parole, in attesa che la direzione strategica da intraprendere diventi più chiara – che qui venissero addestrati ribelli anti-Assad (e finora Ankara non si è mostrata troppo sensibile al problema dell’estremismo islamico all’interno degli insorti). Se abbandonassero la loro posizione attuale – sia sui curdi che sui ribelli jihadisti anti-Assad – potrebbero ri-forgiare migliori rapporti tanto con li Usa quanto con l’Unione europea. Mantenerla, andando in rotta di collisione con la Casa Bianca, potrebbe essere rischioso nel medio periodo, specie se la situazione sul terreno in Siria rimanesse bloccata per anni, anzi con un probabile rafforzamento di Assad grazie all’ascesa dell’Iran nella regione .
Abbandonare l’ambiguità e portare la svolta alle sue estreme conseguenze è un boccone amaro per Erdogan, che dopo le Primavere arabe tramite il supporto alla Fratellanza Musulmana in Egitto, Libia, Tunisia e Siria coltivava ambizioni neo-ottomane e ora, fallito ovunque l’esperimento, è costretto a una clamorosa retromarcia. Ma se dovesse rimanere lui al timone della Turchia questa potrebbe essere l’alternativa meno dolorosa a un’ostinata coerenza, destinata ad accrescere l’isolamento di Ankara – al cui fianco sono rimasti per puro interesse i Sauditi, che tuttavia hanno un’altra visione ideologica e ritengono la Fratellanza Musulmana un’organizzazione terroristica – e a peggiorare le sue prospettive geopolitiche per l’avvenire.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Le speranze dei ribelli siriani di sconfiggere Assad sono ridotte al lumicino. Dopo i successi di primavera, in particolare della coalizione di sigle ribelli islamiste Jaish al Fatah (tra cui l’affiliata di Al Qaeda, Jabhat al Nousra) nata grazie al coordinamento ed al finanziamento di Turchia, Qatar e Arabia Saudita, il regime sembrava in grave difficoltà.
Sia ad Aleppo (la seconda città del Paese), sia nello snodo strategico di Idlib le truppe lealiste erano state costrette ad arretrare, subendo pesanti sconfitte, le risorse del governo di Damasco – economiche, ma anche in termini di soldati impiegabili – si erano drasticamente ridotte e la coesione interna del potere alawita cominciava a dare segni di cedimento. Poi il vento è cambiato, in Siria ma anche a Vienna, dove l’Iran – finanziatore e protettore di Assad – grazie al raggiungimento dell’accordo sul nucleare potrebbe aver ottenuto accesso a risorse, finora congelate dalle sanzioni, per 100 miliardi di dollari.
Sul terreno le forze di Assad si muovono ora in un contesto tattico divenuto favorevole. Combattono contro, semplificando, due nemici: i ribelli siriani (dove, accanto al Free Syirian Army, ad oggi predomina Jaish al Fatah) e lo Stato Islamico. Grazie alle presenza di quest’ultimo si sono progressivamente affiancati a Damasco, oltre al “padrino” sciita iraniano e alla milizia libanese Hezbollah, altri inaspettati alleati. I curdi del Ypg, infatti, che sono al momento la forza militare che maggiormente si oppone al Califfato in Siria, ha – per convenienza e per necessità – una alleanza de facto con il regime, e concentra i suoi sforzi contro gli uomini in nero dell’Isis. Di recente, anche grazie all’aiuto delle milizie curde irachene, i Peshmerga, gli uomini del Ypg hanno conquistato la fascia nord della Siria quasi per intero, tagliando le linee di rifornimento dalla Turchia per lo Stato Islamico e mettendone sotto pressione la capitale, Raqqa. E sui curdi si sta scaricando la reazione, terroristica oltre che militare, dell’Isis. Ancora di recente un kamikaze ha fatto strage di giovani volontari socialisti a Suruc, cittadina sul confine turco, che volevano aiutare nella ricostruzione di Kobane.
Oltre ai curdi il regime può ora contare sull’appoggio di un altro gruppo, fino a poco fa rimasto neutrale nella guerra civile: i drusi. Questi sono una minoranza religiosa simile all’islam (ma considerata eretica dalla maggioranza musulmana) e abitano la regione a sud di Damasco, al confine con la Giordania. Dopo il recente massacro di venti civili ad opera di Jabhat al Nousra, i leader religiosi e politici della comunità hanno definitivamente abbandonato le ambiguità e invitato la popolazione drusa ad unirsi alle forze governative, ribaltando così la situazione sul campo. Se fino a quel momento infatti i ribelli avevano trovato terreno per portare un’offensiva da sud contro Damasco, conquistando alcune postazioni strategiche, da lì in poi sono entrati in una fase di stallo e, anzi, hanno poco dopo subito la controffensiva lealista che li ha ricacciati nelle posizioni di partenza.
Il problema del fanatismo islamico all’interno delle fila ribelli ha poi portato, tacitamente ma innegabilmente, anche la coalizione internazionale a guida Usa che combatte l’Isis ad essere un prezioso alleato per Assad. Secondo quanto dichiarato da un ufficiale curdo alla AFP l’aviazione americana e quella di Damasco si coordinano per combattere lo Stato Islamico. E nel momento in cui contro l’Isis combattono a terra soprattutto i curdi e dal cielo soprattutto gli americani (che colpiscono anche obiettivi mirati diversi dall’Isis, di recente un capo qaedista), il regime può limitarsi alla difesa delle proprie roccaforti nelle aree conteste col Califfato e concentrare i propri sforzi contro gli altri ribelli siriani. In questo è supportata da Hezbollah – fondamentale per puntellare il regime nella aree di confine col Libano contro l’offensiva lanciata a primavera soprattutto dagli uomini di al Nousra – e dall’Iran. Secondo recenti rivelazioni poi, a Teheran si sarebbe affiancata in modo più evidente anche Mosca, nel sostenere Assad. È infatti stato abbattuto, questo luglio, un drone russo nei cieli siriani, il che significa che il Cremlino sta, direttamente con propri uomini o avendo venduto la tecnologia a Damasco, aiutando il regime nel raccogliere dati di intelligence militare per meglio contrastare i ribelli.
Nel giro di pochi mesi Assad si è dunque trovato ad avere dalla propria parte – in modo esplicito o meno – non solo i suoi alleati storici (Iran, Hezbollah e Russia), oltretutto rafforzati dal recente accordo sul nucleare raggiunto a Vienna, ma anche gruppi con cui i rapporti erano freddi se non ostili (drusi e curdi) e, soprattutto, la coalizione internazionale anti-Isis a guida americana. Specularmente il fronte che sostiene i ribelli si va indebolendo. La Turchia, finora molto attiva nel finanziare e supportare i ribelli, sembra – secondo il parere di alcuni analisti – che stia cercando di uscire dal vicolo cieco in cui la politica estera del presidente Erdogan l’aveva portata a infilarsi. Il supporto alla Fratellanza Musulmana nel dopo-Primavere arabe si è rivelata una scommessa perdente, e la linea tenuta in Siria “piuttosto che Assad meglio l’Isis” l’ha portata a scontrarsi duramente con gli alleati occidentali, che hanno una visione diametralmente opposta, e a perdere potere negoziale nella questione curda che le sta esplodendo ai confini (l’Ypg è vicino al Pkk, considerato da Ankara organizzazione terroristica, ed ha il controllo politico-militare di una vasta area, la Rojava). Ora, complici le pressioni della comunità internazionale, la Turchia pare che stia adottando una linea più ferma contro gli uomini del Califfato, in particolare controllando il confine e non – questa l’accusa mossa in passato – lasciando passare gli uomini dell’Isis. Non solo. Dopo l’accordo tra 5+1 e Iran, Ankara stima di arrivare in breve tempo a uno scambio commerciale con Teheran intorno ai 35-50 miliardi di dollari. Segnale, secondo alcuni, di un atteggiamento di realpolitik che potrebbe portare nel prossimo futuro a un raffreddamento dell’impegno con cui Erdogan sostiene chi vuole abbattere Assad, alleato di ferro dell’Iran.
Al fronte ribelle rimarrebbe quindi il sostegno dell’Arabia Saudita, la grande sconfitta – al momento – nei rivolgimenti in corso in Medio Oriente. Il suo nemico regionale, l’Iran, grazie all’accordo raggiunto col 5+1 esce dall’isolamento diplomatico ed economico con gravi rischi potenziali per gli interessi di Riad. La risposta saudita potrebbe essere, e secondo molti esperti sarà, un innalzamento del livello di scontro in tutti gli scenari di crisi dell’area: Yemen, Iraq e ovviamente Siria. Armando e finanziando indistintamente le sigle jihaidste sunnite, Riad può sperare di sabotare una vittoria dell’asse sciita, ma non di vincere. Il risultato sarebbe una prosecuzione per un tempo indefinito di una guerra civile a bassa intensità che genera centinaia di migliaia di vittime e milioni di profughi. Ma, ed è questo l’aspetto più pericoloso per la casa reale saudita, tanto più si rafforzano lo Stato Islamico e le componenti qaediste nel fronte sunnita che si oppone all’Iran, tanto più quest’ultimo gode e godrà del sostegno della comunità internazionale. Non si può quindi escludere, questa è la tesi minoritaria tra gli esperti, che l’Arabia Saudita decida di scartare dalla propria posizione per evitare di rimanere schiacciata, e i ribelli siriani siano i primi a pagarne il prezzo.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Quando i Greci sconfissero definitivamente i Persiani di Serse a Salamina, nel 480 a.C., giocò un ruolo fondamentale la scoperta di un nuovo filone d’argento nel monte Laurion, che aveva consentito a Temistocle di creare una flotta permanente di 200 triremi da opporre al nemico in battaglia. Gli iraniani, cioè i moderni persiani, grazie all’accordo tra il 5+1 (gli Stati del Consiglio di sicurezza dell’Onu, più la Germania) e la Repubblica Islamica, potrebbero avere – secondo le stime di una fonte Usa citata dalla Reuters – 100 miliardi di dollari di guadagno dall’allentamento delle sanzioni economiche. Considerato il numero di conflitti regionali in cui è coinvolta Teheran, politici e analisti si chiedono come quelle risorse verranno impiegate nel futuro, quante “triremi” verranno armate.
Se l’intesa raggiunta dovesse funzionare – le forze ostili al compromesso sono già al lavoro, tanto a Washington quanto a Teheran, per farlo deragliare – gli equilibri strategici del Medio Oriente potrebbero conoscere una storica rivoluzione. Al di là dei dettagli tecnici sulla questione dell’atomica, grazie a questa intesa la Repubblica Islamica, uscita dall’isolamento internazionale, può tornare ad essere un attore economico, e quindi politico-militare, di primo piano nella regione. «Nel giro di cinque-dieci anni, un tempo brevissimo nella prospettiva della geopolitica, l’Iran sarà in grado di armarsi in modo convenzionale», spiega Germana Tappero Merlo, analista internazionale esperta di sicurezza e terrorismo. «La Russia sta già prendendo accordi per fornire a Teheran i propri missili S-300 e la cosa probabilmente non si femerà qui (così, anche, si spiega la felicità per l’accordo di Mosca, altrimenti danneggiata dall’immissione nel mercato del gas e del petrolio iraniano NdR.). Inoltre l’Ayatollah Khamenei questo 30 giugno ha ordinato di aumentare di circa il 30% rispetto all’anno scorso il budget per le spese militari, facendolo salire da 14 a 17 miliardi di dollari. Sicuramente questo aumento è stato dettato dalla logica del contrasto all’Isis, contro cui Teheran è impegnata sia in Siria che in Iraq, ma le monarchie del Golfo – avversari regionali sunniti dell’Iran sciita – sono preoccupate che serva anche a sostenere l’espansionismo iraniano in corso».
Dietro la lotta al Califfato infatti si sta combattendo una guerra per espandere (o difendere) le proprie sfere di influenza tra l’Arabia Saudita e la Repubblica Islamica iraniana. Questa guerra sfrutta lo scontro intra-religioso tra sunniti e sciiti, esploso con particolare violenza dopo il collasso del fragile ordine emerso in seguito alle Primavere arabe. Coinvolge in primo luogo la Siria, dove l’Iran puntella il regime alawita (l’alawismo è ritenuto oggi una minoranza dello sciismo) di Assad contro i ribelli sunniti (moderati, quelli islamisti qaedisti e quelli dell’Isis) fornendogli aiuti economici – destinati a crescere dunque – e militari, anche tramite la milizia libanese sciita dell’Hezbollah. Passa per l’Iraq, entrato di fatto oramai nella sfera di influenza iraniana, dove l’Isis gode – e godrà sempre di più in futuro – dell’appoggio delle tribù sunnite del luogo, ostili al potere centrale sciita, e dei nemici regionali di Teheran. Interessa poi lo Yemen, dove l’Iran sostiene (poco fino ad oggi, da domani potrebbe aumentare gli aiuti) i ribelli sciiti Houthi contro il governo filo-Riad, il Bahrein e, in modo più indiretto per ora, il Libano. In tutti questi scenari una immissione di ingenti risorse economiche dal lato persiano potrebbe compromettere gravemente la situazione del fronte sunnita, capeggiato da Riad, che ovviamente non rimarrebbe passivo.
«I Sauditi stanno già reagendo a questa situazione – prosegue Tappero Merlo – ad esempio intensificando come mai prima i bombardamenti sulle postazioni dei ribelli sciiti in Yemen (in seguito a tale attacco dell’aviazione le forze governative, fedeli a Riad, hanno annunciato di aver conquistato ai ribelli l’aeroporto di Aden NdR). E in tutta l’area mediorientale c’è il rischio di un inasprimento delle violenze e degli scontri. I gruppi terroristici che si oppongono agli sciiti, come tra gli altri anche lo Stato Islamico e Al Qaeda, trarranno vantaggio da questa situazione. C’è il pericolo che i Sauditi, e non solo, li vogliano sfruttare in ottica anti-Iraniana, finanziandoli e armandoli ancor più di quanto non facciano ora. Poi ovviamente anche Israele è molto preoccupato da questo accordo. Se l’Iran utilizzasse le risorse che cominceranno ad affluire nelle sue casse dall’anno prossimo per finanziare – e indirizzare contro lo Stato ebraico, di cui non ha ufficialmente smesso di propugnare la distruzione – Hamas e Hezbollah, il rischio per la sicurezza nazionale israeliana sarebbe elevatissimo. Il presidente Obama ha dichiarato di voler risolvere la questione israeliano-palestinese nei prossimi mesi, ma oramai è screditato presso troppi interlocutori, Netanyahu e monarchie del Golfo specialmente. Per le speranze di Pace in Medio Oriente – conclude l’esperta – temo che questo accordo non sia una buona notizia. Non era questo il momento più opportuno».
Secondo le analisi più ottimistiche, l’accordo potrebbe considerarsi un successo se – dopo una fase di inasprimento degli scontri nel breve periodo, data quasi per scontata, in cui tuttavia il compromesso sul nucleare non venisse violato – nel medio periodo l’Iran normalizzasse le proprie relazioni internazionali, in particolare trovando un accordo (anche segreto) con Israele per garantire la sicurezza, e un’intesa sulle aree di influenza con i Sauditi. Tuttavia la estrema complessità e liquidità dello scenario – dove anche la Turchia e l’Egitto giocano la loro partita, ai wahabiti sauditi si oppone anche la fratellanza musulmana, la questione curda sta esplodendo, e dove i conflitti in corso creano geometrie di interessi in costante evoluzione – non consente di azzardare previsioni affidabili. Quello che è certo al momento è che questa scommessa – potrà l’Iran diventare un attore responsabile con cui costruire un equilibrio di pace per il futuro? – ha una posta in gioco altissima.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Dopo il referendum tenutosi in Grecia il 5 luglio sono molti i commentatori – e anche i politici europei – che pensano Atene abbia già un piedi fuori dall’Euro. Non solo. Il timore è che una volta uscito dalla moneta unica lo Stato ellenico si trovi in una così grave difficoltà economica da sprofondare in una situazione di miseria e degenerazione politico-sociale tale da comprometterne la permanenza nell’Unione europea.
A quel punto si aprirebbero scenari da incubo, con la Grecia tentata di risollevare la propria situazione dando retta alle sirene dei poteri extra-europei e, forse addirittura, extra-occidentali (la Russia di Putin, ad esempio, sta facendo trapelare il proprio interesse ad aiutare il governo greco). Si tratta ovviamente del worst case scenario, ancora fortunatamente lontano nel tempo e scarsamente probabile. Ma questi timori stanno già iniziando a circolare e, anche con uno sguardo ad essi, si può comprendere l’insistenza dell’America nel chiedere all’Europa di farsi carico della situazione greca, quale che sia il costo economico.
Da mesi la Casa Bianca esercita una costante pressione su tutte le parti del negoziato perché un accordo venga raggiunto. Da un lato pesa il timore che la Grecia possa innescare un’altra crisi economica globale – “Sarà o no una nuova Lehman Brothers?”, si chiedono gli esperti in America – che trascini con sé prima il resto d’Europa e quindi gli Stati Uniti. Dall’altro militano soprattutto considerazioni di carattere strategico. Come spiega Marc Chandler, esperto di politica estera economica e capo delle strategie valutarie per la banca americana Brown Brothers Harriman, «i problemi economici, per quanto importanti e difficili, non devono accecare i politici sull’importanza geopolitica della Grecia. Questo è un Paese che collega nord e sud, est e ovest, come nessun altro. È il confine meridionale della Nato, e le relazioni di cui gode con Russia, Iran, Cina e altri sono uniche all’interno dell’Alleanza. Se per mantenere Atene all’interno dell’unione politica e della sicurezza europea si dovesse pagare un prezzo elevato, probabilmente varrebbe la pena pagarlo». La Grecia – pur guidata da un esecutivo di estrema sinistra – sembra consapevole di quanto le sia preziosa la Nato, tanto che – come ricorda lo stesso Chandler – «è uno dei pochi Paesi membri dell’Alleanza a rispettare gli impegni presi circa le spese militari». Spese che, invece, il resto d’Europa ha chiesto alla Grecia di tagliare per rendere sostenibile la propria situazione economica.
L’importanza strategica della Grecia è poi accresciuta dai movimenti geopolitici che investono l’area del Mediterraneo e l’Europa in generale. «Atene occupa una posizione strategica rispetto al Medio Oriente e alla crisi dell’immigrazione – spiega Judy Dempsey, esperta di politica estera della Carnegie Europe – ma non solo. Anche nell’area balcanica – afflitta da gravissimi problemi di corruzione e mancanza di trasparenza, e che di recente è stata teatro di proteste e scontri, ad esempio in Macedonia – rappresenta un baluardo dell’Unione europea e della Nato. Inoltre Paesi come Bulgaria e Romania, confine orientale dei territori sotto l’ombrello dell’Alleanza, vivrebbero malissimo un eventuale scostamento di Atene dall’Occidente». Problemi questi che sembrano affliggere molto più gli americani che non gli europei. «Secondo la percezione degli Usa – prosegue Dempsey – l’Europa fa davvero poco per la propria sicurezza. Washington non vuole che la Grecia entri in una fase di fibrillazione politica potenzialmente pericolosa. Se la crisi dovesse perdurare si aprirebbe il rischio di derive autoritarie che potrebbero portare al potere gruppi nazionalisti. Allora sì che anche l’appartenenza del Paese alla Nato diverrebbe problematica, anche se ad oggi sembra uno scenario irrealistico».
«Molto improbabile», che la Grecia possa discostarsi dall’Alleanza atlantica anche secondo il direttore dell’Istituto italiano di studi strategici, Claudio Neri. «L’ipotesi che Atene possa, in cambio di aiuti economici, concedere alla Russia una base navale nelle sue acque – o in quelle di Cipro – mi pare assurda. Verrebbe messa in discussione l’appartenenza stessa della Grecia all’Occidente. Questo non conviene ai greci in primis, che al di fuori della Nato si troverebbero privi di un sistema di sicurezza militare, ma nemmeno agli Stati Uniti, che infatti fanno una eccezionale pressione perché l’Europa trovi un accordo. La Russia dal canto suo credo voglia sfruttare tutte le pieghe in cui riesce a infilarsi. Non penso ambisca realmente a sfilare la Grecia alla Nato, missione praticamente impossibile e molto rischiosa, quanto a condizionarla, magari finanziando i movimenti populisti e anti-sistema che accrescerebbero il potere di influenza di Mosca».
E avere un interlocutore “amico” e condiscendente nella Grecia potrebbe essere fondamentale per il Cremlino di qui a qualche anno. La Russia è in una fase di sofferenza economica, per via delle sanzioni e della discesa del prezzo di petrolio e gas naturale. Da questa asfissia – voluta dagli Stati Uniti, formalmente come ritorsione per la crisi Ucraina – Mosca spera di uscire sfruttando, tra le altre cose, il bisogno di tanti Stati europei di approvvigionarsi di materie prime a prezzi convenienti. «In questo momento starebbe per partire la costruzione Turkish Stream, il gasdotto che porta il gas russo in Turchia, aggirando l’Ucraina», racconta Matteo Verda, esperto di sicurezza energetica dell’Ispi, «e sono state previste quattro linee, quando per il mercato turco una, massimo due, sarebbero sufficienti. Se le linee saranno davvero realizzate tutte, l’unica opzione credibile sarebbe raggiungere poi il mercato europeo dalla Turchia. Per farlo hanno bisogno di Stati accomodanti che consentano la costruzione di una bretella per portare il gas russo dall’Anatolia in Europa – in base al diritto comunitario non può costruirla Gazprom – e la Grecia è in posizione strategica. Atene, di fronte a una politica di sconti da parte di Mosca e alla prospettiva di incassare i diritti di transito, ha tutto l’interesse ad accettare (cosa che ha parzialmente già fatto), data la posizione di debolezza. A quel punto la Russia potrebbe non rinnovare, dopo la scadenza nel 2019, gli accordi con Kiev per il passaggio del gas diretto in UE, raggiungendo un duplice obiettivo: non dipendere più dal transito in Ucraina, indebolendone ulteriormente le posizioni, e rafforzare l’interdipendenza coi clienti occidentali, mettendo oltretutto l’agenda degli Stati europei in conflitto con quella degli Usa».
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Lo scorso 26 giugno il terrorismo islamico ha colpito duramente in Asia, in Africa e in Europa.
In Kuwait un kamikaze, un saudita pare affiliato a una cellula jihadista collegata con l’Isis, si è fatto esplodere in una moschea sciita causando una trentina di morti tra i fedeli raccolti per la preghiera del venerdì. In Somalia un commando di Shebab – miliziani delle corti Islamiche, che di recente hanno esplicitato la loro alleanza con lo Stato Islamico – ha attaccato una base militare dell’Unione Africana, distante appena 100 km da Mogadiscio, con kamikaze e lanciagranate. I morti sarebbero oltre cinquanta, tutti militari del Burundi. In Tunisia un estremista legato a gruppi salafiti ha trucidato a colpi di mitra 37 turisti occidentali sulla spiaggia di Port El Kantauoi. Il suo gesto è stato poi rivendicato dall’Isis. Infine vicino a Lione un terrorista solitario, nato in Francia da genitori maghrebini, ha prima decapitato il capo dello stabilimento di gas industriale dove lavorava come autista, e poi ha provato a far esplodere gli impianti, ma senza successo. Sul luogo del delitto è stata anche trovata una bandiera nera che parrebbe ricondurlo allo Stato Islamico.
L’insieme di questa notizie tragiche ha prodotto un grande effetto sui media e sulle opinioni pubbliche occidentali. Da un lato alcuni politici e alcune testate non hanno esitato a spargere ansie e paure per l’imminente scontro tra la civiltà europea e questo nuovo mostro del terrorismo con decine di teste ma un unico corpo. Dall’altro si sono diffuse teorie ottimistiche, secondo cui questi attentati sarebbero la risposta del Califfato al momento di difficoltà che sta attraversando in Siria (e, anche se meno, in Iraq): non potendo più contrastare sul terreno l’avanzata dei suoi nemici, porta avanti le sue ritorsioni in modo non convenzionale all’estero, rivelando però così uno stato di debolezza. Il problema è che è molto difficile stabilire quali collegamenti, e quanto intensi, ci siano tra gli attentati. Nonché quanto questi siano collegati alla situazione dello Stato Islamico a cavallo tra Siria e Iraq.
Sicuramente l’Isis è in un momento di debolezza a livello militare. L’offensiva dei curdi del Ypg gli ha tagliato le più importanti vie di rifornimento dalla Turchia e la sua capitale siriana, Raqqa, è oramai pericolosamente vicina alla linea del fronte. In questo scenario si può inquadrare l’azione di alcune decine di uomini del Califfo a Kobane – che ha portato alla morte di oltre 200 persone, quasi tutti civili, molte donne e bambini – come una risposta direttamente collegata alle difficoltà sul campo. Il terrorismo – perché di questo si è trattato, non di un’azione militare – ha sicuramente lo scopo di alleggerire la pressione su Raqqa e di segnare un punto nella guerra di propaganda. Ma per le azioni lontane dal territorio del Califfato il discorso è molto diverso.
Difficile ipotizzare che il Califfo Al Baghdadi e il suo stato maggiore abbiano deciso, per rispondere alle difficoltà in patria, di allertare una serie di cellule dormienti all’estero per scatenare il panico in tre diversi continenti. Finora non ci sono elementi per ipotizzarlo. Più probabilmente i media dell’organizzazione terrorista hanno lanciato un ordine generale sul web di attaccare e fare stragi durante il Ramadam (il mese sacro per gli islamici), e il venerdì – giorno della preghiera – è il momento più propizio. «In Francia quasi sicuramente si tratta di un lupo solitario, un fanatico isolato che si estremizza in Occidente e che a un certo punto raccoglie l’invito (che arriva da siti internet jihadisti) a compiere un attentato, anche di piccolo calibro, contro obiettivi civili europei», spiega Claudio Neri, direttore dell’Istituto italiano di studi strategici. «Da tempo questa è la strategia dell’Isis: non potendo architettare attentati in grande stile sul suolo occidentale – come invece faceva Al Qaeda, me le nostre intelligence sono diventate esperte nel prevenire che succeda – si affida all’azione di singoli, imprevedibili, che possono lanciarsi con l’auto sui passanti, accoltellare un poliziotto, fare strage in una redazione, sparare sul parlamento e via dicendo».
Più probabile che una qualche forma di coordinamento – ma, di nuovo, difficile stabilire quanto intensa – ci sia stata per gli attentati in Tunisia, Somalia e Kuwait. «Si potrebbe ipotizzare che esista una rete di ex commilitoni della guerra siriana che ora sono sparsi in diverse cellule in diversi Paesi, e che sono in grado di coordinarsi direttamente tra loro», dice ancora Neri. «Tuttavia mi sembra l’opzione meno realistica. Personalmente credo che l’Isis abbia fatto passare attraverso i suoi canali la parola d’ordine di attaccare durante il Ramadam e che vari gruppi locali abbiano aderito. Dico questo perché le sigle jihadiste locali spesso hanno agende proprie, e quindi non vogliono “padrini” a cui dover rendere conto direttamente. Inoltre sono sempre in competizione tra loro per avere la maggiore visibilità possibile, quini se dal Califfato si segnala un momento buono per gli attentati questi hanno tutto l’interesse a rispondere. Ma l’Isis è, e credo resti, un “brand”, come anche Al Qaeda in precedenza».
La peculiarità dello Stato Islamico rispetto ad Al Qaeda, almeno la più evidente, è quella di avere uno Stato territoriale (l’ospitalità che i Talebani afghani riservarono a Bin Laden fino al 2001 non è paragonabile). Questo catalizza combattenti e jihadisti da mezzo mondo, offre un luogo dove addestrarli e metterli in contatto tra loro, consente rifornimenti economici e militari. Sradicarlo come Stato non sarebbe difficile da un punto di vista bellico, ma è praticamente impossibile al momento da un punto di vista politico. Troppi attori (Sauditi, Iran, Turchia e Qatar in primis) hanno interessi divergenti o collidenti, e spesso ad avvantaggiarsene è proprio il Califfato. L’Occidente in compenso finora non ha dimostrato sufficiente forza e determinazione per agire in modo efficace, spaventato dalle possibili ripercussioni di un intervento terrestre su uno scenario regionale che è già caotico e che rischierebbe di degenerare ulteriormente. Il prezzo di questo stallo è evidente: foreign fighters e simpatizzanti dell’Isis possono sempre colpire, anche in Europa. Ma forse, prima di ipotizzare azioni drastiche, vale anche la pena ricordare che sommando tutte le vittime degli attentati di venerdì 26 non si arriva ai morti dell’ultimo attentato jihadista a Kobane.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Le delusioni d’amore, si sa, sono le peggiori. Dell’Ungheria che nel 1999 aderiva alla Nato e nel 2005 entrava festante nell’Unione europea è rimasto ben poco.
E lo stesso premier, Viktor Orban, che fu artefice dell’ingresso nella sfera occidentale – durante il suo mandato 1998-2002, quando era un conservatore sì, ma liberale – ora attacca l’euro, l’Unione Europea, gli Stati Uniti, flirta con Putin, vagheggia nuove forme di governo autoritarie, lontane dal modello delle democrazie liberali, e il ritorno di una “Grande Ungheria” dai più estesi confini territoriali. Non solo. Dopo aver ventilato l’ipotesi di reintrodurre la pena di morte, aver attaccato l’indipendenza della magistratura e della Banca Centrale Ungherese, aver modificato la Costituzione in senso ultra-conservatore (e inquietante per le minoranze rom, ebraica, musulmana, gay e in generale per chiunque non sia un “vero ungherese”), da ultimo Orban si è messo alla testa delle proteste contro la recente ondata migratoria, gonfiata dalle guerre in Medio Oriente e nel Corno d’Africa. Per chiudere la rotta balcanica dei migranti, Budapest ha dichiarato di voler costruire un muro di 175 km, alto quattro metri, sul confine con la Serbia. Pareva addirittura – ma il governo nazionalista, sotto la pressione del resto d’Europa, ha poi fatto retromarcia – che Orban volesse sospendere unilateralmente le regole europee in materia di diritto d’asilo. Ora i partiti xenofobi di tutta Europa lo incensano, confermando il fiuto del premier magiaro nell’intercettare gli umori della pancia del popolo, e l’innamoramento ungherese per il modello occidentale è un pallido ricordo.
L’estrema destra – dalle sue propaggini più marcatamente razziste e nostalgiche a quelle più “ripulite” e definite comunemente “populiste” – sta conoscendo una fase di eccezionale espansione in Europa. Dopo aver messo piede nel dibattito pubblico di molti Paesi durante gli anni della Guerra al Terrore di Bush (e della conseguente islamofobia), ha visto i suoi consensi gonfiarsi sempre più durante gli anni della crisi economica. Non solo in Ungheria ma anche in Francia, in Germania, nei Paesi Scandinavi, in Grecia: ovunque le formazioni politiche di estrema destra hanno aumentato le percentuali e, in certi casi, hanno ottenuto ruoli di governo, locale e nazionale. E non è un caso che Budapest per certi versi abbia fatti da apri-pista.
Dopo i sacrifici fatti per entrare nell’Unione Europea, invece del benessere promesso, per gli ungheresi sono arrivati altri sacrifici. Il Paese si è infatti trovato, nemmeno tre anni dopo l’ingresso nell’Europa comunitaria, travolto in pieno dalla crisi economica: crollo della moneta, crollo della Borsa, problemi di liquidità. Primo membro Ue a dover chiedere l’aiuto delle istituzioni finanziare internazionali, l’Ungheria – all’epoca guidata dai socialisti – ha ricevuto 25 miliardi di dollari da Fmi, Banca Mondiale e Ue e ha dovuto accettare il piano di riforme e sacrifici che il prestito comporta. La popolazione si è impoverita e alle elezioni del 2010 è arrivata spaventata e piena di rancore per le promesse non mantenute di “raggiungere l’Austria” e i livelli di qualità della vita dell’Europa occidentale. In questo contesto Orban (con un’inversione di 180 gradi rispetto al suo passato) si è fatto paladino della lotta alle regole comunitarie e della propaganda anti-Ue. Nelle urne è stato premiato: più della metà dei voti espressi sono andati al suo partito e ha ottenuto una maggioranza parlamentare schiacciante, con cui ha potuto cambiare la Costituzione a suo piacimento.
Grazie alla ripresa economica, più marcata in quegli anni nell’Europa centro-orientale, l’Ungheria è poi uscita dalla recessione e ha ripagato il debito (in anticipo) nel 2013. Questo ha ulteriormente galvanizzato i sostenitori, in patria e all’estero, di Orban, capace col suo nazionalismo, economico oltre che politico, di “sconfiggere e scacciare” il Fmi e gli altri creditori. Ma l’economia non è andata negli anni successivi tanto bene quanto i primi segnali di ripresa potevano far sperare. Figlia di fattori “una tantum”, secondo gli economisti, la crescita è rimasta bassa e in compenso la povertà estrema ha continuato a crescere. Con conseguenze anche politiche. Nelle elezioni del 2014 Orban ha sì rivinto con una larga maggioranza, ma ha subito un’erosione di 8 punti percentuali nelle urne, e per evitare il rischio di un’emorragia ha esasperato ancor di più i toni sciovinisti e reazionari. Questo perché i suoi voti in uscita non sono andati alla coalizione che riunisce le forze liberali, democratiche e socialiste del Paese (che ha raccolto circa un quarto dei voti), ma a un altro partito di estrema destra più marcatamente neo-fascista: il Jobbik.
Balzato sopra il 15% del 2010, nel 2014 il Jobbik è arrivato ad essere il secondo partito del Paese, con più del 20% dei voti. La sua retorica fa perno sulle paure per i diversi (i rom in primis, che rappresentano la prima minoranza etnica del Paese e che negli ultimi anni hanno subito diverse aggressioni squadriste da parte di simpatizzanti del Jobbik, ma anche immigrati, islamici, ebrei, gay, comunisti etc.), sul rifiuto delle regole economiche europee (sarebbe in corso un complotto pluto-giudaico, da sempre un grande classico della propaganda nazi-fascista), sulla lotta alla “casta” e su un nazionalismo esasperato incentrato sul culto della persona dell’Ammiraglio Miklos Horthy, il dittatore filonazista che portò l’Ungheria a fianco dell’Asse nell’ultimo conflitto mondiale e che fu complice dello sterminio degli ebrei, deportati o direttamente annegati nel Danubio. Il Jobbik aveva anche una sezione para-militare di camice brune (“La Guardia Nazionale”), sempre ispirate al passato filonazista, che però è stata sciolta nel 2009 dai giudici ungheresi.
Dal 2014, quando ha fatto il grande balzo nelle urne, il leader del Jobbik, Gabor Vona, sta provando a smussare i toni anti-semiti e più propriamente nazi-fascisti e a spostarsi più sul terreno del populismo anti-Ue e anti-casta. L’intento dichiarato è quello di intercettare un domani la fase calante della parabola di Orban (che, fiaccato da alcuni recenti scandali, potrebbe essere meno saldo al potere) e di accreditarsi come partito di governo. Lo scenario è purtroppo plausibile. Il quadro attuale, con cui l’Europa deve fare i conti, è infatti che in questo Paese (evidentemente lasciato solo e non aiutato in una fase di delicata transizione da oltre 40 anni di comunismo al libero mercato) metà della popolazione vota l’estrema destra di Orban, un quinto l’ancor più estrema destra del Jobbik, e gli altri – liberali, socialisti, democratici e chi, in generale, ancora crede nei diritti civili, nell’integrazione europea e nella convivenza – devono spartirsi quel che resta.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

L’esperimento della Rojava, la regione del nord della Siria che i curdi hanno proclamato autonoma e difeso strenuamente contro diversi nemici dallo scoppio della guerra civile nel Paese, suscita spesso una fascinazione quasi romantica. La Costituzione (“Carta del Contratto Sociale”) che hanno proclamato è laica, democratica, multipartitica, multietnica, federalista e prevede – tra le altre cose – il rispetto dei diritti umani, dell’ambiente e della parità di genere.
Nei territori della Rojava convivono curdi, arabi, turcomanni, ceceni, assiri e armeni. Nelle milizie armate (Ypg) le donne combattono al fianco degli uomini e questo, in una guerra contro i fanatici islamici del Califfato islamico, ha un impatto psicologico ancor più forte. Al di là degli ideali e della seduzione libertaria che Rojava incarna, tuttavia, c’è un dato di fatto innegabile: qui lo Stato Islamico sta incontrando le maggiori difficoltà. Qui – contrariamente a quanto successo già in Iraq e nel centro della Siria – invece di avanzare il Califfato indietreggia, e le milizie curde sono decisamente più efficaci dell’esercito regolare iracheno o siriano, e probabilmente anche dei bombardamenti mirati della Coalizione anti-Isis a guida Usa. Nelle ultime settimane in particolare l’Ypg ha conquistato diverse aree importanti al confine con la Turchia, sottraendole agli uomini in nero del Califfo Al Baghdadi. In particolare la recente vittoria dei curdi a Tel Abyad potrebbe essere un punto di svolta per il quadro strategico della Siria nel suo complesso, e per le sorti dello Stato Islamico nel Paese.
Tel Abyad è il valico di frontiera con la Turchia da dove – con la complicità di Ankara, che negli ultimi anni ha utilizzato qualsiasi mezzo, Isis incluso, nel tentativo di abbattere Assad in Siria e di contenere le spinte autonomiste curde – lo Stato Islamico faceva passare foreign fighters, armi, rifornimenti, e da cui transitavano merci e petrolio per finanziare le casse del Califfo. Ora per gli uomini in nero la via è chiusa. Le linee di rifornimento si dovranno probabilmente spostare di centinaia di chilometri con ripercussioni pesanti sulla situazione tattica sul terreno. La conquista di Tel Abyad è poi fondamentale per i curdi in quanto adesso il territorio sotto il loro controllo va da Afrin – a nord di Aleppo – , passa per Kobane (città simbolo della causa curda, uscita vittoriosa da mesi di assedio dell’Isis) e arriva fino al confine con l’area curda dell’Iraq governata da Barzani e presidiata dai Peshmerga (le milizie curde irachene), senza soluzione di continuità, mentre prima era diviso in due tronconi. Infine, altra caratteristica centrale di Tel Abyad è la sua vicinanza alla città di Raqqa, la capitale dello Stato Islamico in Siria: appena un’ora e mezza di macchina.
La vittoria delle truppe curde – supportate anche da fazioni arabe che un tempo appartenevano al Free Syrian Army, ma che dai tempi dell’assedio di Kobane combattono insieme al Ypg sotto il nome di “Burkan el Firat”, cioè “Vulcano dell’Eufrate” – è arrivata dopo settimane di logoramento dei punti di appoggio dell’Isis, in particolare le cittadine di Mebruka e Suluk. Ora alla Turchia rimane solo un piccolo tratto di confine con la Siria – vicino a Iskenderun, la antica Alessandretta – da cui far passare eventuali aiuti allo Stato Islamico. Ma qui potrebbe arrivare un’altra notizia negativa per il Califfato: le pressioni americane su Erdogan e l’esito delle elezioni turche che hanno tolto la maggioranza assoluta al partito del presidente (e anzi premiato il partito filo-curdo Hdp) potrebbero indurre Ankara quantomeno ad una maggior prudenza. Privato di rifornimenti, con il proprio alleato de facto (Turchia di Erdogan) costretto sulle difensive e con la propria capitale minacciata da vicino, lo Stato Islamico in Siria è sicuramente entrato in una fase di difficoltà dopo la simbolica e strategica conquista di Palmira. Anche nel resto del Paese sta subendo la controffensiva del governo di Assad – di recente, si dice, rafforzato da una ingente iniezione di uomini da parte dell’Iran – e nelle zone di confine col Libano (l’area montuosa del Qalamun) è sotto attacco da parte delle milizie di Hezbollah.
Tuttavia sarebbe assurdo dare per spacciato il Califfato in Siria. I curdi, abilissimi a combattere nel proprio territorio anche grazie al supporto della popolazione locale, non possono da soli sperare di avanzare più che tanto nelle aree a maggioranza araba. La Siria è poi un calderone in cui si mescolano centinaia di fazioni combattenti. Oltre all’Isis, ai curdi e alle forze governative, esistono guerriglieri legati ad Al Qaeda, altri moderati, altri ancora laici. Spesso rispondo agli interessi dei loro sponsor internazionali e quindi le alleanze tra queste forze sono in costante evoluzione. Di recente ad esempio – grazie all’aiuto e al coordinamento di Turchia, Arabia Saudita e Qatar – si è formata una coalizione di sigle islamiste (“Esercito della Vittoria”, di cui fa parte la qaedista Al Nusra) che fino a poco prima erano in lotta tra loro e ha iniziato a macinare vittorie contro il governo nella provincia di Idlib (nord del Paese). Tutto può sempre cambiare da un momento all’altro.
La vera forza del Califfato in Siria resta comunque la totale porosità del confine con l’Iraq, dove i suoi uomini controllano importanti città (Mosul, su tutte), hanno armamenti pesanti e risorse petrolifere. Nell’area desertica che collega la provincia irachena di Anbar con l’area di Deir az Zor in Siria le truppe dell’Isis sono libere di muoversi senza grossi rischi. Se un domani Raqqa fosse in pericolo, gli aiuti per il Califfato in Siria potrebbero arrivare da qui. Questa interconnessione tra due Paesi – i cui confini oramai esistono solo sulla carta – rende particolarmente importante per lo scenario siriano l’eventuale riuscita dell’operazione militare, ad ora in fase di stallo, con cui il governo iracheno sta cercando di riconquistare la provincia di Anbar e la città di Ramadi . Forse non cambierà le sorti della regione nel complesso – ancora dilaniata da troppe spinte in troppe direzioni – ma, almeno per il consolidamento definitivo della Rojava, potrebbe essere determinante.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

L’Occidente sta dimostrando un moderato disinteresse nei confronti del caos che regna in Libia. L’Italia, ex potenza coloniale, vede la sua classe politica avvitata in un dibattito provinciale sulla spartizione dei migranti, mentre alle sue porte rischia di scatenarsi il caos. L’Europa, in primis la “locomotiva” tedesca, ha lo sguardo rivolto a est, verso l’Ucraina, e non ha dimostrato finora di considerare la questione libica come una priorità. Gli Stati Uniti, fin dai tempi della rivoluzione contro Gheddafi, hanno cercato di mantenere una posizione defilata. Questa disattenzione rischia di causare danni enormi, non solo alla Libia stessa né ai soli Paesi mediterranei, ma all’intero continente europeo.
È notizia di pochi giorni fa la conquista da parte dell’Isis di alcune posizioni strategiche (in particolare una centrale elettrica) nei pressi di Sirte, città strategicamente vicina ai pozzi petroliferi e contesa da febbraio tra gli uomini in nero del Califfato e le milizie – fedeli al governo islamista di Tripoli – di Misurata. «Lo Stato Islamico sta approfittando della situazione di grave disgregazione del Paese», spiega Leandro Di Natala, ricercatore dell’European Strategic Intelligence and Security center. «Per ora incontra comunque maggiori difficoltà qui che non nello scenario siro-iracheno, perché in Libia non c’è lo scontro settario tra sunniti e sciiti di cui approfittare, e perché non avendo – ribadisco, per ora – accesso a particolari risorse economiche, quali ad esempio i pozzi di petrolio, non può distribuire servizi sociali (e mazzette) alle tribù e alla popolazione per comprarne l’appoggio». Inoltre, ma in questo la situazione non è dissimile a quella in Siria, è in corso una faida tra gruppi affiliati al Califfato e gruppi legati ad Al Qaeda. Pochi giorni fa a Derna, base dell’Isis in Libia, uomini del Califfo hanno assassinato il leader delle brigate Majlis al Shura, il gruppo qaedista con cui condividono il controllo della città, e ne sono seguiti violenti scontri con decine di morti.
Queste difficoltà se da un lato hanno rallentato l’avanzata dello Stato Islamico, dall’altro non gli hanno impedito di approfittare dell’anarchia in cui si dibatte il Paese, diviso tra il governo islamista di Tripoli (vicino alla Fratellanza Musulmana e appoggiato da Turchia e Qatar) e quello di Tobruk (riconosciuto internazionalmente e fortemente sostenuto dall’Egitto del generale Al Sisi), attraversato da scontri tribali e da una criminalità diffusa e pesantemente armata. «La saldatura tra gruppi terroristici e criminali comuni è molto pericolosa», prosegue Di Natala. «Lo Stato Islamico probabilmente già può contare, come fonte di finanziamento, sull’immigrazione clandestina, chiedendo tangenti e parte dei profitti alle organizzazioni criminali che sfruttano il traffico di esseri umani. Se i governi di Tobruk e Tripoli non troveranno un accordo in tempi rapidi la situazione potrebbe ulteriormente degenerare: la Libia potrebbe diventare un “santuario” per i terroristi, un luogo dove finanziarsi – a quel punto sì grazie al petrolio oltre che all’immigrazione –, addestrare terroristi e pianificare attacchi contro Tunisia, Egitto e anche Europa. Non si pensi però che i terroristi arrivino col barcone – ipotesi teoricamente possibile ma decisamente improbabile per i rischi della traversta e i controlli successivi -, molto più realisticamente prendono un biglietto aereo o si attivano dopo essere già in Italia ed essersi radicalizzati su internet».
Ma Tobruk e Tripoli sembrano molto lontani da un accordo. Ancora di recente, nell’ambito dei colloqui di pace svoltisi in Marocco, alcuni rappresentanti del governo internazionalmente riconosciuto hanno bocciato i termini dell’accordo proposti dal rappresentante dell’Onu, Bernardino Leon. Tobruk lamenta di essere stato penalizzato – nell’ultima bozza di accordo proposta – rispetto a Tripoli negli equilibri dei futuri organi che dovranno governare il Paese, e il generale Haftar – capo delle forze armate del governo legittimo e alleato di ferro dell’Egitto – non accetta di vedersi privato del suo ruolo che invece passerebbe a un soggetto eletto. La posizione definitiva espressa dal governo di Tobruk è comunque di aspettare la fine dei colloqui, nel frattempo trasferiti a Berlino, per prendere una posizione ufficiale.
La sensazione – secondo diversi analisti – è che intorno al caso libico si siano create, semplificando, due fazioni. La prima è quella formata principalmente dai Paesi occidentali e specialmente europei. Questi vogliono la pace per riportare sotto controllo – anche con una missione Ue a cui serve però avallo Onu, che non arriverà senza accordo tra Tripoli e Tobruk – l’immigrazione, impedire l’avanzata e il radicamento dello Stato Islamico, e reinserire nel mercato il petrolio dei pozzi libici. La seconda invece soffia sul fuoco di uno scontro tra i due governi del Paese. In questa fazione ha un ruolo predominante il Cairo – probabilmente spalleggiato dall’Arabia Saudita – che può contare sull’appoggio interno del generale Haftar. Il presidente egiziano Al Sisi ha infatti sia mire espansionistiche in Libia, sia una lotta in corso contro la Fratellanza Musulmana. La tentazione di approfittare del momento di debolezza di Erdogan – il presidente turco, grande sponsor della Fratellanza in Libia e altrove, in difficoltà sul fronte interno dopo le ultime elezioni in cui ha perso la maggioranza assoluta – potrebbe esserci. Da quel che sta emergendo dai colloqui di pace in corso sembra che la seconda fazione sia molto più determinata della prima.
«L’Occidente evidentemente non sta facendo abbastanza. Lo strumento per portare le parti ad un accordo», conclude Di Natala, «è abbastanza evidente: garantire ad entrambi i contendenti un ingente profitto economico dalla vendita del petrolio. Le esportazioni di barili sono crollate mentre le morti violente sono impennate. La fazione che vuole la pace ha abbondanza di argomenti da spendere e tuttavia sembra che prevalga il disinteresse. In questo modo si avvantaggiano i criminali e i terroristi». Il sospetto che circola nell’ambiente diplomatico è che il fronte che non vuole la pace sia molto più esteso di quanto non sembri: alcuni Stati occidentali non vogliono saperne di farsi carico della questione immigrazione intervendo in Libia, anche ci fosse un governo di unità nazionale. Altri hanno poi tali e tanto ingenti affari con i Sauditi – sponsor dell’Egitto – che potrebbero preferire sabotare le trattative piuttosto che veder sfumare miliardi di euro. Altri ancora accarezzano l’ipotesi di sostenere gli sforzi egiziani e di Haftar di annichilire il governo di Tripoli e i gruppi che lo appoggiano per avere in futuro come interlocutore una stabile, pur antidemocratica, dittatura militare. Senza un sussulto di impegno da parte delle potenze a cui la pace conviene, le speranze di pace sono insomma al lumicino.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Nelle ultime settimane l’avanzata dell’Isis tanto in Iraq, con la conquista di Ramadi, capitale della provincia sunnita di Anbar, quanto in Siria, con la presa di Palmira, ha destato grande clamore e preoccupazione in Occidente e non solo. Le stragi di civili, pare purtroppo confermate, sono state innumerevoli e timore è stato espresso anche per i meravigliosi resti archeologici che i fanatici islamici potrebbero distruggere. La mole di notizie impressionanti non deve però oscurare la realtà della situazione strategica complessiva, che non sembra essere cambiata nell’ultimo periodo.
«L’area che va dall’Iraq a buona parte della Siria, e che al momento è controllata dallo Stato Islamico, si caratterizza per un terreno piatto, dove è difficile arroccarsi. Questo consente», spiega Claudio Neri, direttore dell’Istituto italiano di studi strategici, «rapidi spostamenti, offensive e controffensive, ed è normale che la situazione sia in costante evoluzione. Gli uomini del Califfato, pur spesso molto più determinati dei loro avversari e dotati di alcune armi avanzate sottratte all’esercito regolare iracheno, non hanno comunque aviazione e consistente artiglieria pesante. Nel lungo periodo questo è un fattore determinante. Di recente hanno ottenuto alcune vittorie importanti, soprattutto grazie all’aiuto ricevuto dall’Arabia Saudita e dagli altri Paesi del Golfo – direttamente o anche solo supportando suoi alleati, come la formazione qaedista di al Nusra in Siria – ma non è una stagione destinata a durare a lungo. Riad ha ancora legami troppo stretti con gli Usa – anche se in fase di deterioramento – per restare sorda ai suoi richiami anti-terrorismo, e comunque è sprovvista di una exit strategy per la Siria. Assad non può cadere finché non emerge un attore sul territorio che possa essere in grado di prendere il controllo della situazione».
Inoltre Assad gode ancora dell’appoggio della Russia e dell’Iran. Mosca e soprattutto Teheran possono anche permettersi di lasciar avanzare l’Isis per spaventare l’Occidente, mettere nell’angolo i propri avversari che sfruttano in funzione anti-sciita il Califfato, e guadagnare spazio di manovra diplomatico e tattico. Ma non accetteranno che Assad cada o che in Iraq gli uomini in nero dello Stato Islamico minaccino la capitale. Infatti già negli ultimi giorni l’Hezbollah libanese – controllato da Teheran – ha dichiarato il proprio totale supporto alla causa di Assad in Siria, e in Iraq le milizie sciite stanno svolgendo un ruolo determinante – in quanto supplenti dell’evanescente esercito regolare iracheno – nel piano di riconquista che Baghdad ha messo a punto per la provincia di Anbar.
Nel prossimo futuro (un anno o due) dunque tanto la caduta di Assad (ancor meno quella di Baghdad) quanto la totale sconfitta dei ribelli rimangono gli scenari meno plausibili. «La cosa più probabile è che, a livello strategico, la situazione rimanga immutata per i prossimi uno-due anni», prosegue Neri. «Lo scontro in atto tra Iran e Sauditi si scarica soprattutto in questa regione a cavallo tra Siria e Iraq, e ad oggi nessuno dei contendenti sembra in posizione di poter chiudere la partita in tempi rapidi. Come dicevo, nemmeno i Saud vogliono un collasso improvviso dello Stato siriano. La recente spinta alle fazioni islamiste che combattono Assad ha probabilmente il senso di impedire all’avversario iraniano di consolidare i propri contrafforti e di riaffermare l’indispensabilità del coinvolgimento delle monarchie del Golfo in qualsiasi processo di pace – o di spartizione delle aree di influenza – possa avvenire per il Medio Oriente. Questo processo non è al momento all’orizzonte. Di solito si arriva a sedersi a un tavolo quando una delle due fazioni sta vincendo e l’altra perdendo. Attualmente Iran e Sauditi hanno ancora moltissime risorse – purtroppo anche in termini di vite umane – da poter gettare sul piatto».
Di fronte a questo violento scontro – nato dal caos del post Primavere Arabe e catalizzato dai tentativi iraniani di uscire dall’isolamento internazionale – l’Occidente non sembra avere una posizione chiara. Al di là delle dichiarazioni ufficiali, i bombardamenti della “Coalizione anti-Isis” hanno obiettivi poco chiari sulla carta (ad esempio in Siria, devono avvantaggiare Assad o i poco consistenti ribelli sunniti non legati allo Stato Islamico?) e risultati scadenti sul terreno (pur avendo, pare, colpito alcuni papaveri dello Stato Islamico non hanno impedito le recenti vittorie degli uomini del Califfo). «A livello superficiale sembra che gli Stati Uniti abbiano adottato una linea del “wait and see”, cioè di non ingerenza de facto e di attendismo nei confronti dell’evoluzione complessiva dello scenario mediorientale. Tuttavia», conclude Neri, «più in profondità l’establishment Usa sta forse cominciando ad accarezzare l’idea di allontanarsi da Riad per avvicinarsi a Teheran. Tra Stati Uniti e Iran infatti le divergenze sono di carattere ideologico ma, da un punto di vista puramente strategico, sarebbero alleati naturali».
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Gira una voce negli ambienti diplomatici e d’intelligence che si fa sempre più insistente: Israele starebbe trattando in segreto una tregua con Hamas. La notizia sembra incredibile, considerati i rapporti tra l’organizzazione – ritenuta terroristica da Israele – palestinese e il neonato governo di estrema destra di Benjamin Neanyahu. Eppure indiscrezioni di stampa parlano addirittura dei dettagli che sarebbero compresi nell’accordo: cessazione delle ostilità per 5 o 10 anni da parte di Hamas, che in cambio otterrebbe la fine del blocco su Gaza e ingenti investimenti da parte delle monarchie del Golfo nella Striscia. Il ruolo più importante in questo negoziato spetta infatti all’Arabia Saudita, ed è guardando all’evoluzione della sua linea strategica che si capisce la verosimiglianza delle indiscrezioni che circolano.
Agosto 2014, Israele bombarda Gaza e il precedente monarca saudita, Abdullah, addossa pubblicamente la responsabilità delle violenze ad Israele (niente di nuovo) ma anche ad Hamas (inedito nella propaganda araba). Da sempre Riad ha avuto rapporti poco idilliaci col movimento palestinese, di cui sostiene il rivale moderato Fatah. Hamas era infatti molto vicina – prima delle primavere arabe – all’Iran e alla Siria di Assad, entrambi avversari dei Saud. Dopo le primavere arabe la situazione, dal punto di vista dei sauditi, non era migliorata: Hamas si era infatti sì allontanata da Assad in nome della comune lotta coi ribelli sunniti (il dittatore siriano è invece alawita), ma solo per finire tra le braccia della Fratellanza Musulmana, sponsorizzata da Qatar e Turchia e da sempre considerata alla stregua di un’organizzazione terroristica da parte dell’Arabia Saudita. Di qui la freddezza del Re Abdullah, nemmeno un anno fa, di fronte alla guerra a Gaza. Adesso, con il nuovoo Re Salman, la svolta: Riad sarebbe disposta a farsi portavoce delle istanze di Hamas e ad agevolarle nel corso di una trattativa segreta con Israele. Come nasca questa inversione di 180 gradi e perché sia credibile è una questione che affonda le radici nella profonda paura che i Saud hanno in questo momento per l’ascesa del nemico regionale, l’Iran, unita ai timori per l’allontanamento (attualmente contraccambiato) dell’alleato americano.
Da quando Teheran è uscito dall’isolamento internazionale grazie alla trattativa sul nucleare con le potenze del 5+1 (gli Stati del Consiglio di sicurezza dell’Onu, più la Germania) e, approfittando degli smottamenti post primavere arabe, ha conquistato posizioni nello scacchiere mediorientale (in Iraq specialmente), i Saud sono preoccupati di perdere il primato economico e politico che hanno ricoperto negli ultimi decenni nel mondo islamico. Anzi, si può forse dire che lo sono stati fino a non molto tempo fa, e da poco hanno preso l’iniziativa per contrastare le mosse iraniane.
L’ultima pedina che Riad e Teheran si stanno contendendo – più per l’alto valore simbolico presso le opinioni pubbliche musulmane che per una reale importanza strategica – è appunto Hamas. A marzo il presidente del parlamento iraniano Larjani ha incontrato a Doha, in Qatar, Meshaal, il leader in esilio del movimento palestinese. Complici gli sviluppi interni al campo profughi palestinese di Yarmuk in Siria, diversi analisti hanno successivamente ritenuto che fosse in corso un riavvicinamento tra Hamas e il regime siriano di Assad, propiziato proprio da Teheran. Questo sviluppo è doppiamente minaccioso per i Sauditi: da un lato rischia di accrescere la popolarità dell’Iran agli occhi del mondo islamico come difensore della causa palestinese, dall’altro potrebbe avere ripercussioni sullo scenario siriano dove da poco i Saud sono passati all’offensiva. Una tale emergenza potrebbe aver spinto il nuovo Re – già dimostratosi nel caso tunisino meno ostile alla Fratellanza Musulmana del suo predecessore – all’inversione di marcia.
Se questo fosse il caso, Hamas si troverebbe in una situazione potenzialmente molto interessante. A differenza dell’ex alleato iraniano, i Sauditi hanno ottimi rapporti – specie in questo momento – con Israele e possono credibilmente svolgere il ruolo di mediatore. Tanto Riad quanto Tel Aviv sono infatti in prima linea contro l’Iran ed entrambi sono in una fase di freddezza con gli Stati Uniti. Inoltre l’Arabia Saudita è già una potenza economica che non ha mai fatto mistero di essere pronta a regalare miliardi di dollari a chi sia disposto ad assecondarne i desideri, mentre l’Iran starebbe – forse – per uscire solo ora da anni di sanzioni economiche e conseguente indebolimento. Riad ha poi ottimi rapporti – e potenti leve economiche – con l’Egitto di Al Sisi. Proprio il presidente egiziano, con la sua linea dura nel chiudere i valichi tra Egitto e Gaza, ha inferto uno dei colpi più duri ad Hamas. Se i sauditi lo ammorbidissero sarebbe una boccata d’ossigeno per la Striscia e un importante risultato per il movimento palestinese. Ultimo, ma non meno importante, in questo scenario Hamas costringerebbe il rivale Fatah nell’angolo e potrebbe anche scavalcarlo come interlocutore a livello internazionale.
Dall’altro lato della barricata, anche a Israele un simile accordo potrebbe non dispiacere, se avesse sufficienti garanzie. Una maggiore sicurezza interna sarebbe esattamente quello che serve a Netanyahu per consolidare la propria popolarità. Inoltre, più che i palestinesi, sembrano preoccupare il premier israeliano gli iraniani: recidere i rapporti tra questi (e i loro alleati di Hezbollah) e Hamas potrebbe garantire maggior tranquillità a Tel Aviv. Altra valida ragione per cui l’attuale governo israeliano potrebbe volere l’accordo – e tentazione inconfessabile – è poi che una trattativa segreta con Hamas lascia le mani molto più libere che non un negoziato alla luce del sole con Fatah. Se Netanyahu volesse un domani rallentare o congelare il processo di pace, la prima opzione sarebbe la più adeguata. Anche perché un accordo segreto si può sempre smentire.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Così, ad esempio, dietro le recenti vittorie dei ribelli e le sconfitte del regime (tanto gravi da non poter essere negate nemmeno da Assad) si intuiscono i movimenti degli attori regionali e i loro cambi di strategia. Costretti sulle difensive dall’espansionismo iraniano – e ancor più dalla sua legittimazione, con l’accordo sul nucleare che pare in dirittura d’arrivo – l’Arabia Saudita da un lato e Qatar e Turchia dall’altro hanno sepolto le precedenti divergenze (Qatar e Turchia sostengono fortemente la Fratellanza Musulmana, mentre la casa reale dei Saud la considera un nemico giurato) per propiziare la nascita lo scorso 24 marzo di una coalizione di gruppi ribelli islamisti, Jaish al-Fatah (l’Esercito della Conquista). Questa nuova coalizione a pochi giorni dalla sua nascita ha strappato Idlib, importante città dell’entroterra siriano, alle truppe governative e nelle settimane successive ha espanso l’area sotto il proprio controllo, arrivando a Jisr al-Shughour, cittadina che presidia la strada per Latakia (importante città di porto della parte alawita del Paese).
Di contro il regime attraversa un momento di difficoltà: il suo esercito è dissanguato, pare gli uomini a disposizione siano stati dimezzati dagli anni di conflitto e c’è difficoltà a rimpolpare le fila dei reggimenti visto che è rischioso attingere leve dalla maggioranza sunnita del Paese. Inoltre sembra che serpeggi del malcontento nell’apparato militare siriano per l’eccessiva libertà di manovra che viene lasciata ad Hezbollah, la milizia sciita libanese che – su ordine dell’Iran – è intervenuta nel conflitto siriano per puntellare Assad. Hezbollah, è questa l’accusa che gira tra i papaveri del regime di Damasco, si preoccuperebbe di presidiare giusto la zona di confine col Libano, trascurando di aiutare gli alleati nel resto del Paese. E anche questa mossa sarebbe figlia di una strategia “straniera”, quella cioè dell’Iran. Teheran ha infatti interesse a garantire la sopravvivenza del regime e la sicurezza delle zone abitate da sciiti e alawiti. È su queste aree e sulla capitale che concentra la propria attenzione ma non vuole (o, anche considerato il parallelo impegno in Iraq, non può) svenarsi per combattere i ribelli in tutto il Paese.
L’attuale situazione è in ogni caso temporanea: le divergenze tra l’agenda per la regione dei Sauditi da un lato e quella di Turchia e Qatar dall’altro sono destinate a riemergere, inoltre la presenza della sigla qaedista di Jabhat al Nusra all’interno della coalizione ribelle è un fattore di forte preoccupazione per l’Occidente. Oggi impedisce che vengano inviate armi ai ribelli (per timore che finiscano nelle mani sbagliate), un domani potrebbe portare addirittura ad accordi sotto banco col regime. Sulla paura del jihadismo Assad ha già giocato d’astuzia con l’Isis nel recente passato, è probabile che lo rifaccia – ora che il Califfato sta defluendo principalmente verso l’Iraq – anche con altre sigle. Secondo quanto riportato dallo Spiegel – venuto in possesso di documenti segreti sulla nascita dello Stato Islamico – il regime di Damasco avrebbe giocato opportunisticamente di sponda con l’Isis per anni, attaccandolo a parole ma non con le armi, e anzi concentrando il suo sforzo bellico contro la parte laica e moderata della ribellione. Il motivo è semplice: avere per nemico qualcuno peggiore di sé agli occhi dell’Occidente. Il piano ha funzionato tanto bene in passato che è probabile venga riproposto anche in futuro.
La questione dello Stato Islamico è comunque un’altra variabile esterna che complica la situazione in Siria. Nato dalla mente di Samir Abd Muhammad al-Khlifawi (militare, laico, ex ufficiale dei servizi segreti di Saddam Hussein) l’Isis avrebbe – sempre secondo quanto riportano i documenti diffusi dallo Spiegel – approfittato del caos in Siria per un certo tempo, ma da sempre ha come obiettivo la presa del potere in Iraq, quantomeno nelle zone a maggioranza sunnita. Il fanatismo religioso (come fin dai tempi delle crociate) e la lotta all’oppressore siriano sono stati solo lo specchietto per le allodole per avere più carne da cannone da gettare nel conflitto. “All’Isis non interessa abbattere Assad. Il suo obiettivo primario è Baghdad, non Damasco”, spiega il direttore dell’Istituto Italiano di studi strategici, Claudio Neri. Intanto però la Siria è invasa da migliaia di foreign fighters, attratti dal richiamo della jihad.
E la presenza del Califfato nel Paese ha una serie di altre conseguenze, che – oltre che i rapporti con le potenze mondiali, Stati Uniti in primis – interessano anche gli Stati limitrofi. Secondo recenti rivelazioni, la Giordania – che con Turchia, Qatar e Sauditi coordinati dagli Usa dovrebbe contribuire all’addestramento di ribelli siriani “moderati” – avrebbe deciso di concentrare i propri sforzi (e di spendere il proprio capitale di relazioni con le tribù siriane) nel formare combattenti votati più che alla cacciata di Assad al contenimento dell’estremismo jihadista. Così facendo da un lato si allontana dagli Stati del Golfo e dalla Turchia, che avrebbero voluto avere come priorità l’abbattimento del regime siriano, dall’altro asseconda i desiderata degli Stati Uniti, sempre più freddi circa la possibilità di dare aiuto (militare e di intelligence) agli insorti, viste le pesanti infiltrazioni del fanatismo islamico. L’impegno congiunto di Ankara, Riad e Doha a favore del “Esercito di Conquista” nascerebbe quindi anche come reazione alle esitazioni americane.
“La verità inconfessabile è che a tutti conviene che in Siria prosegua la guerra civile a bassa intensità a cui abbiamo assistito negli ultimi anni: lì si scaricano tensioni e conflitti che altrimenti rischierebbeo di tracimare altrove”, dice ancora Claudio Neri. “Gli Stati Uniti non possono permettere che vincano i fanatici sunniti, Isis o Al Nusra che sia, né possono scontentare troppo gli alleati della regione, già spaventati per le aperture all’Iran. Israele per ora sta alla finestra ma, se da un lato la sua sicurezza è minacciata sulla carta anche dal fanatismo islamico sunnita, dall’altro non può nemmeno lasciare che Hezbollah guadagni troppo potere politico e militare. L’Iran poi non è disposto – e nemmeno la Russia – ad abbandonare Assad, e specularmente Sauditi, Turchia e Qatar non possono desistere dal tentativo di rovesciarlo. Insomma, a nessuno degli attori principali coinvolti conviene la pace. Purtroppo – conclude – temo che per la Siria si prospetti un futuro di anni, forse decenni, di guerra costante”.
@TommasoCanetta
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Il principio della dinamica secondo cui “ad ogni azione corrisponde una reazione uguale ed opposta” è spesso applicabile alle relazioni internazionali. Dall’alba della civiltà – si pensi agli Egizi con gli Hittiti – niente si è dimostrato stimolante come sapere che il nemico si sta muovendo. Nello scacchiere mediorientale era facile pronosticare che la recente ascesa dell’Iran avrebbe causato la replica del suo principale avversario per l’egemonia regionale, l’Arabia Saudita. Finora, complice la fase di transizione dal precedente monarca Abdullah (morto lo scorso gennaio) a quello attuale Salman, i contorni di questa reazione erano tuttavia molto sfocati e – pur dietro una miriade di iniziative diplomatiche e di intelligence – si faticava a intuire una strategia complessiva. Adesso la situazione sembra delinearsi con maggior chiarezza.
Il nuovo monarca ha appena fatto un repulisti senza precedenti del passato establishment. Gli avvicendamenti più significativi sono agli Esteri – dove Al Faisal (era lì dal 1975) viene rimpiazzato dall’ex ambasciatore a Washington Al Jubeir – e nella linea di successione. Abdica “spontaneamente” il principe-fratello Muqrin dal ruolo di erede designato, gli succederà prima il principe-nipote Nayef, attuale ministro dell’Interno e uomo di punta dell’antiterrorismo saudita, e poi il figlo di Re Salman, l’attuale ministro della Difesa Mohammad Bin Salman. Il significato di questi cambiamenti – secondo diversi analisti – è chiaro: passare ad una politica estera più muscolare, in paricolar modo nei confronti dell’Iran. Per farlo è fondamentale mantenere ottimi rapporti con l’alleato americano ed avere un nucleo decisionale unito intorno al medesimo obiettivo. Qui sta però uno dei problemi di questa infornata di nuove nomine: finora il potere era stato largamente spartito tra i vari rami della famiglia reale saudita, ora non più, e “gli Stati Uniti dovrebbero essere preoccupati che le mosse in corso a Riad possano portare a una lotta interna per il potere”, spiega Simon Henderson, specialista dell’area del Golfo per il Washington Institute for Near East Policy.
Se tuttavia la monarchia reggesse senza gravi contraccolpi, il nuovo gruppo di potere potrebbe portare avanti la sua visione strategica che, per quando si riesce ad oggi a intuire, corre su un doppio asse. Il primo prevede che l’Arabia Saudita si ri-accrediti come alleato fondamentale e degno di fiducia per l’Occidente nella regione. In questo modo si toglierebbe spazio di manovra all’Iran, che negli ultimi tempi ha saputo approfittare dell’allontanamento degli Stati Uniti da alcuni suoi partner strategici dell’area.
Avendo in mente l’obiettivo di frenare l’avanzata di Teheran, si spiega l’accento posto da Riad (anche con la nomina di Nayef) sulla lotta al terrorismo islamico – Isis e Al Qaeda in primis – e il supporto economico e bellico a quegli Stati, come l’Egitto e la Giordania, al momento impegnati nel contrastare l’espansione del Califfato e di altre sigle jihadiste in Medio Oriente e in Nord Africa. L’Iran ha finora infatti beneficiato dell’essere uno dei principali avversari dell’Isis, in quanto Paese sciita, e di essersi quindi trovato dallo stesso lato della barricata degli Usa e dei loro alleati (ad esempio in Iraq). Se svanissero le ombre sui possibili aiuti che da certi Stati sunniti (Sauditi, Turchia, Qatar) sarebbero arrivati all’Isis e, anzi, proprio gli Stati sunniti si rivelassero affidabili nel contrastare il Califfato, ancora una volta lo spazio di manovra diplomatico di Teheran verrebbe compresso.
Poco tempo fa, inoltre, l’Arabia Saudita ha finanziato ingenti acquisti di armi da parte del Libano. Ufficialmente per contrastare l’Isis, che dalla Siria rischia di sconfinare, in realtà anche per contrastare l’espansionismo iraniano che nel Paese dei cedri può contare sulla solida alleanza con la fazione paramilitare sciita di Hezbollah. E qui arriviamo al secondo asse della politica estera saudita: il contrasto all’Iran non più diplomatico ma sul terreno.
Gli scenari caldi per Riad sono soprattutto lo Yemen e la Siria. In Yemen l’aviazione saudita sta bombardando da oltre un mese i ribelli sciiti Houthi (pare supportati dall’Iran) che hanno rovesciato il governo filo-saudita e stanno estendendo il loro controllo sulla maggior parte del Paese. Secondo quanto riportato dalla Reuters, negli ultimi giorni i bombardamenti avrebbero raggiunto un nuovo picco di intensità e si sarebbero anche registrati scontri a terra tra insorti sciiti e truppe di Riad al confine con l’Arabia Saudita. A complicare lo scenario c’è poi la presenza dell’Isis: “un gruppo legato allo Stato Islamico ha rilasciato un video con l’uccisione di 14 soldati yemeniti”, riporta ancora l’agenzia stampa. Sunniti, ma ostili alla casa reale saudita, i fanatici islamici legati ad Al Qaeda o al Califfato rischiano di trarre un enorme vantaggio dal caos e dalla guerra di religione che si sta scatenando nel Paese.
Anche in Siria la situazione sta evolvendo velocemente, e in modo ancora più complesso. Dopo quasi due anni di vittorie per il regime di Assad nelle ultime settimane si è registrata una parziale inversione di tendenza. A fine aprile una coalizione di fazioni ribelli islamiste – tra cui, secondo quanto riferisce Foreign Policy, anche il gruppo qaedista di Jabhat al Nousra – ha preso il controllo della cittadina di Jisr al-Shughou, a metà via tra Idlib (importante centro conquistato dai qaedisti a fine marzo, e dove ora pare viga la sharia) e Latakia, porto strategico nella zona alawita (la minoranza religiosa cui appartengono gli Assad). Questa accelerazione è figlia, secondo quanto rivela il Washington Post, di una maggiore cooperazione tra i “padrini” stranieri dei ribelli: Qatar, Turchia e Arabia Saudita. Minacciati dall’espansionismo iraniano, preoccupati per il riconoscimento internazionale di Teheran seguito all’accordo sul nucleare (pur non ancora definitivo), queste tre potenze regionali pare abbiano saputo, nelle ultime settimane, mettere da parte le proprie divergenze in Siria per sferrare un duro contrattacco al regime.
Ma qui emergono i limiti di questa operazione. Turchia e Qatar sono vcini, a livello strategico e ideologico, ai Fratelli Musulmani e alle fazioni che ad essi si ispirano in Siria. I Sauditi – che appartengono alla minoranza wahabita del sunnismo, da sempre in lotta con la Fratellanza – li considera nemici, e in passato pare abbia finanziato tanto fazioni laiche quanto estremistiche (probabilmente al Nousra, forse anche l’Isis) proprio in funzione di contrasto ai Fratelli Musulmani in Siria. Con l’Iran in fase di aggressiva espansione e con il suo alleato Assad in posizione di forza, mettere da parte i contrasti può essere stato relativamente facile. Ma se un domani le sorti del conflitto dovessero riportare i ribelli in posizione di vantaggio, non sarebbe difficile immaginare uno sfarinamento delle attuali coalizioni e un riproporsi degli scontri settari, figli delle diverse agende delle potenze regionali coinvolte.
Ulteriore complicazione, anche in Siria – e anzi molto più che in Yemen – è presente lo Stato Islamico. Questo elemento è particolarmente spinoso per Riad: tra asse sciita (Iran, Assad, Hezbollah) e Califfato l’Occidente preferisce sicuramente sostenere il primo. È in questo rompicapo strategico che rischia di impantanarsi il nuovo corso della politica estera dell’Arabia Saudita: deve combattere tanto ferocemente il proprio nemico (l’Iran) quanto il nemico del proprio nemico (il Califfato) con cui invece converrebbe fare accordi. Se infatti non contrasterà a sufficienza lo Stato Islamico, l’Occidente aiuterà l’Iran nel farlo. Ma se lo contrasterà in modo efficace, saranno soprattutto i nemici di Riad (Assad in Siria e le milize sciite in Iraq) a trarne beneficio.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

A livello diplomatico ha ottenuto che la Russia – sua alleata in Siria – riuscisse a rimuovere l’embargo sulla vendita di missili anti-aerei. Ha poi costretto sulle difensive la Turchia – la potenza regionale che dopo le Primavere arabe aveva eroso il potere di Teheran in Siria, Libano, Palestina e Iraq – tanto che Erdogan, pur rimanendo formalmente alleato dei Sauditi nello scontro sunniti-sciiti, ha di fatto sdoganato un atteggiamento pragmatico nei confronti della Repubblica islamica. Ma non solo. Grazie alla necessità di contrastare l’Isis – sunnita e nemico degli amici di Teheran in Siria e Iraq – l’Iran ha guadagnato peso e spazio di manovra, tanto che non è più un mistero il coordinamento de facto con gli americani in quello scenario per contrastare gli uomini del Califfato. La chiave di volta, che permetterebbe all’Iran di cristallizzare questa situazione vantaggiosa, e anzi anche migliorarla, è ovviamente l’accordo sul nucleare con il 5+1 (gli Stati del Consiglio di sicurezza Onu, più la Germania).
Di recente si sono registrate alcune marce indietro da parte degli Ayatollah sull’accordo raggiunto e gli analisti si interrogano se sia solo una strategia per guadagnare qualcosa nella trattativa sui dettagli tecnici che dovrebbe scadere a fine giugno, o se nasconda il timore dell’establishment conservatore iraniano che un’apertura verso l’esterno non rischi di accelerare lo sfaldamento della Repubblica islamica (un’istituzione a cui i giovani – la maggior parte del Paese – sembrano volersi ribellare sempre più). Resta il fatto che qualora venisse definitivamente varato l’accordo non sarebbe solo la questione nucleare a esserne coinvolta, ma l’intera economia e geopolitica della regione, con un’affermazione dell’Iran come potenza riconosciuta a livello globale. E il merito di questa svolta sarebbe, in buona parte, degli Stati Uniti guidati da Obama.
«Quella degli Stati Uniti non è propriamente un’inversione di rotta, si tratta più che altro di un “aggiustamento” figlio di una scelta obbligata: avendo meno risorse a disposizione non possono più svolgere il ruolo di “poliziotti del mondo” come in passato, e sono costretti a scegliere le aree dove impegnarsi maggiormente», spiega Claudio Neri, direttore dell’Istituto italiano di studi strategici. «Ad oggi gli Usa sembrano aver scelto di prediligere l’area del Pacifico, riducendo – ovviamente non azzerando – il proprio ruolo nel Medio Oriente. Qui pare abbiano optato appunto per un “aggiustamento” della loro linea, cercando una soluzione che garantisca il “balance of power” tra gli attori regionali. Così si spiega a mio avviso la volontà di riportare nell’alveo della comunità internazionale un Paese come l’Iran».
Agli Usa serviva più spazio di manovra per questa operazione di quanto non gliene consentisse lo status quo dei rapporti con i propri alleati regionali. Un certo raffreddamento delle relazioni è stato quindi ritenuto un prezzo ragionevole da pagare, e non solo. Ignorare – pur parzialmente – la reazione negativa di Israele serve a Washington per dimostrare che il deterioramento dei rapporti causata dalla linea del governo Netanyahu è un coltello che taglia da ambo i lati. Quanto agli alleati arabi, la nuova ondata di terrorismo sunnita – dopo Al Qaeda ora è l’Isis il “brand” del terrore più forte sul terreno – ha facilitato la decisione di spostarsi relativamente più vicini a Teheran. Per controbilanciare questi “schiaffi” diplomatici, nel complesso, gli Usa hanno comunque rassicurato i propri partner regionali, e non solo a parole.
All’Arabia Saudita stanno inviando armi e munizioni per la guerra in Yemen contro i ribelli sciiti Houthi, sostenuti dall’Iran, oltre a fornirgli assistenza logistica e di intelligence. All’Egitto hanno di recente sbloccato gli aiuti militari – sospesi dopo il golpe che depose il presidente eletto Mohammed Morsi e lo sostituì col generale Al Sisi – per centinaia di milioni di dollari, rifornendo il Cairo di caccia, carri armati e missili. Israele poi è stata rassicurata sia sulla determinazione degli Stati Uniti nel voler continuare a tutelarne la sicurezza che sulla continuità del flusso miliardario di aiuti militari che Washington destina a Tel Aviv. Gli Stati Uniti infatti, pur volendo riequilibrare i rapporti nella regione, non possono permettersi né di perdere Israele – strategicamente fondamentale -, né di irritare troppo i Sauditi: il rischio potrebbe essere addirittura quello di una corsa agli armamenti atomici nell’area.
«L’ascesa dell’Iran come potenza regionale, qualora l’accordo col 5+1 andasse a buon esito, porterebbe a un inevitabile aumento delle tensioni regionali. Secondo me sarà in particolar modo la Siria il teatro dove si scaricheranno con maggior virulenza», prosegue Neri. «Qui gli Stati arabi, Riad in testa, non possono accettare di perdere un’altra pedina fondamentale sullo scacchiere mediorientale a vantaggio di Teheran. Piuttosto penso fomenterebbero l’instabilità e la guerra continua, trasformando il Paese in una sorta di Libano degli anni ’80. In questo scenario – conclude – a trarne vantaggio sarebbero l’Isis e le altre organizzazioni terroristiche sunnite». E, indirettamente, i suoi più agguerriti rivali. Cioè ancora una volta l’Iran e l’asse sciita.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Il campo profughi di Yarmuk, “capitale” della diaspora palestinese, città nella città a Damasco, da anni soffre per gli scontri tra truppe lealiste del dittatore siriano Bashar al Assad – fiancheggiate da alcuni gruppi armati palestinesi – e miliziani palestinesi di Hamas filo-ribelli.
Tuttavia, pur provata – nelle parole del corrispondente Ansa, Lorenzo Trombetta – da un “assedio medievale” di Damasco dal 2013, con morti di fame e di stenti, fino all’arrivo dell’Isis questo inizio aprile non aveva ancora dovuto sopportare una simile esplosione di violenza: oltre mille morti in pochi giorni, secondo quanto denunciato dal deputato arabo-israeliano Ahmed Tibi, molti i bambini. E molti di più rischiano di morire nell’immediato futuro. L’Unicef l’ha ribattezzata una “nuova Srebrenica”, la cittadina bosniaca teatro di un orribile genocidio nel 1995.
Andando oltre l’immane tragedia umanitaria, i recenti sviluppi a Yarmuk sono tuttavia anche indicativi di un’evoluzione in corso nello scenario medio-orientale che segna un altro punto – in attesa si concretizzi definitivamente la trattaiva sul nucleare – a favore dell’Iran.
Le fazioni palestinesi – quelle “laiche” rimaste fedeli ad Assad e quelle filo-islamiche, riconducibili ad Hamas – avrebbero infatti smesso di farsi guerra tra di loro e, anzi, starebbero combattendo insieme ai lealisti del regime siriano (alleato di ferro di Teheran) contro gli uomini in nero del Califfato. Questi ultimi pare siano riusciti a prendere il controllo di vaste aree del campo profughi grazie all’alleanza col gruppo qaedista di Jabaht Al Nousra (sembra sostenuto indirettamente dalle monarchie arabe del Golfo), diventato popolare anche tra i palestinesi negli ultimi anni di guerra civile siriana.
Questo riposizionamento di Hamas, oltre a rispondere a un’esigenza “militare” del momento, sarebbe anche politico. “Sullo sfondo – riporta sempre Trombetta, citando fonti locali e di intelligence – c’è stato il riavvicinamento tra la leadership in esilio di Hamas, guidata da Khaled Meshaal, e l’Iran, principale sponsor di Damasco. Il recente incontro a Doha, in Qatar, del presidente del parlamento iraniano Ali Larijani con Meshaal ha segnato una svolta nel disgelo tra Hamas e l’asse Damasco-Teheran“.
Non è un caso dunque che le “barrel bomb”, ordigni primitivi ma devastanti utilizzati dall’aviazione del regime siriano, negli ultimi giorni stiano colpendo solo le postazioni dell’Isis e di Al Nusra, senza sfiorare quelle delle fazioni palestinesi “nemiche” fino a poco tempo fa.
Hamas, forza sunnita, vicina alla Fratellanza Musulmana e simbolo – presso molte opinioni pubbliche islamiche – della resistenza a Israele, sarebbe una pedina preziosa nelle mani dell’Iran, capofila dell’asse sciita, in un momento di scontro col mondo sunnita. “Si tratterebbe di un ritorno all’antico”, spiega Mattia Toaldo, analista dell’European Council on Foreign Relations ed esperto di politica palestinese. “Fino allo scoppio della guerra civile in Siria, Hamas era molto vicina al regime di Assad. I suoi uffici addirittura erano ospitati a Damasco. Poi, con lo scoppio della Primavera araba, Hamas si è progressivamente allontanata da Assad – per l’imbarazzo causato dalle stragi di sunniti ad opera del regime e per le pressioni dei suoi sponsor internazionali, il Qatar e l’Egitto guidato all’epoca da Morsi – fino a diventarne nemica. Poi in Egitto c’è stato il colpo di Stato e Hamas ha perso la sua sponda politica ed economica più importante. Di recente, a inizio anno, anche il Qatar è stato “riportato nei ranghi” dall’Arabia Saudita – altra potenza ostile alla Fratellanza Musulmana – e Hamas si è trovata isolata e senza soldi. Ora potrebbe tornare tra le braccia dell’Iran, a ricreare quell’asse con l’Hezbollah libanese e il regime di Assad in Siria che aveva retto fino allo scoppio della Primavera araba”.
Questa inedita alleanza sunniti-sciiti in funzione anti-Isis è comunque figlia della particolarità della situazione palestinese e difficilmente sarà replicabile altrove.
“Non credo sia possibile che le forze sunnite sostenute dai Sauditi – ad esempio in Siria il Free Syrian Army – possano stipulare alcuna collaborazione con le forze sostenute dall’Iran” spiega ancora Toaldo. “Anche vista la mai così marcata vicinanza tra Sauditi e Israele in questo momento storico. La prima vittima, anzi, di questa mossa di Hamas rischia di essere proprio la causa palestinese. Al Fatah – il partito di governo di Abu Mazen – è sostenuta in modo determinante da Riad. Ora che Hamas sembra riavvicinarsi a Teheran le chance di una riunificazione – dopo la rottura del 2007 – del movimento palestinese credo si riducano”.
L’Isis si conferma comunque una spina nel fianco per l’asse sunnita: dopo aver consegnato l’Iraq nelle mani dell’Iran o quasi – è difficile per qualunque avversario di Teheran finanziare il Califfato in ottica anti-iraniana, viste anche le pressioni occidentali -, aver rafforzato il regime siriano nei confronti dei ribelli – isolati a livello internazionale a causa delle infiltrazioni del fanatismo islamico – e, in generale, aver reso impopolare la causa sunnita agli occhi del mondo, adesso si pongono in aperto conflitto coi Palestinesi, “popolo martire” per la maggior parte delle opinioni pubbliche islamiche. Schiacciando così l’Arabia Saudita e i suoi alleati tra l’inconfessabile desiderio di armare il Califfato in ottica anti-iraniana e la volontà di contrastarlo per riguadagnare posizioni nei rapporti con l’Occidente.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Il negoziato sul nucleare tra il 5 + 1 (gli Stati del Consiglio di sicurezza Onu, più la Germania) e l’Iran è considerata dalla maggior parte degli analisti come un potenziale punto di rottura per gli equilibri dell’intero Medio Oriente. Se la Repubblica Islamica ottenesse – al di là dei dettagli tecnici dell’accordo – il riconoscimento del proprio ruolo di potenza regionale, uscendo dall’isolamento internazionale ed inaugurando una nuova fase di rapporti con l’Occidente, tutte le geometrie dell’area sarebbero destinate a cambiare.
Principali vittime di questa eventuale svolta sarebbero gli attuali alleati regionali degli Usa, in primis Arabia Saudita e Israele. La prima è da anni impegnata in uno scontro senza frontiere con Teheran – le recenti tensioni in Yemen e Iraq sono solo gli ultimi episodi di una faida che dura da decenni e che si alimenta dell’odio intrareligioso tra sunniti e sciiti – mentre Israele, specialmente con Benjamin Netanyahu al potere, non ha mai nascosto di considerare l’Iran come la principale minaccia alla propria sicurezza.
Secondo le rivelazioni del Wall Street Journal i servizi segreti israeliani avrebbero spiato il negoziato, prendendo di mira anche obiettivi statunitensi, e avrebbero poi passato le informazioni ottenute a quei membri repubblicani del Congresso Usa ostili all’accordo, allo scopo di sabotarne il raggiungimento. Nonostante la smentita israeliana, sono pochi i dubbi sulla veridicità dell’accusa. «È una notizia che non meraviglia, anzi sarei rimasto stupito del contrario», commenta Claudio Neri, direttore scientifico dell’Istituto italiano di studi strategici ed esperto di intelligence. «Storicamente Israele e gli Stati Uniti si spiano a vicenda, non c’è nulla di nuovo. In questa occasione addirittura sembra che gli Stati Uniti abbiano scoperto di essere stati spiati, spiando a loro volta obiettivi israeliani. Tutti spiano tutti, alleati inclusi: questa è la regola. Comunque tra Israele e Usa già negli anni scorsi erano emersi episodi analoghi, anche se su questioni meno scottanti. È risaputo, nell’ambiente del controspionaggio americano, che la maggior minaccia spionistica per gli Stati Uniti arriva proprio da Israele».
La storia dello spionaggio incrociato tra Washington e il suo più stretto alleato in Medio Oriente risale addirittura alla nascita di Israele, quando attivisti sionisti cercavano in America fondi e sostegno per la loro causa. Negli anni successivi l’attività spionistica incrociata è andata avanti senza grossi sussulti fino all’esplosione del caso Pollard del 1987. In quell’occasione gli Usa arrestarono John Pollard, analista della marina militare americana e al contempo spia israeliana, con l’accusa di aver passato informazioni di rilievo per la sicurezza nazionale a Israele, e lo condannarono all’ergastolo. Da allora, ma ad oggi senza risultato, Israele continua a chiederne la scarcerazione. Secondo quanto riportato dal libro “Clinton Inc.” – un approfondimento sugli scandali della presidenza Clinton – per ottenere la liberazione di Pollard nel 1998 l’allora premier Netanyahu avrebbe addirittura ricattato la presidenza americana con del materiale riguardante i rapporti tra Bill Clinton e Monica Lewinsky. Anche durante la presidenza di George W. Bush lo scontro è andato avanti: nel 2001 vennero arrestati 200 giovani israeliani con l’accusa di portare avanti attività di spionaggio sul suolo americano, e tre anni dopo il “Caso Franklin” portò sul banco degli imputati esponenti di rilievo dell’Aipac, la più importante lobby filo-israeliana degli Usa. Con l’arrivo di Obama – con cui il premier Netanyahu ha pessimi rapporti – l’attività di intelligence dei servizi segreti a scopo di lobbying pare essersi ulteriormente intensificata.
«Non c’è niente di strano nel fatto che le informazioni recuperate dal Mossad – immagino previamente “sgrezzate” secondo necessità – siano state usate per esercitare pressioni politiche sugli Stati Uniti», prosegue Neri. «A livello militare e tecnologico i due alleati condividono già praticamente tutto, quindi lo spionaggio industriale o economico è meno rilevante che per altri attori. Lo spionaggio a scopo di lobbying – e mi pare che questo sia il caso in discussione – è invece fondamentale per Tel Aviv ed è normale che lo porti avanti. Israele vuole impedire a tutti i costi il raggiungimento dell’accordo con l’Iran e non si farà scrupoli per influenzare il processo decisionale americano».
Se agli esperti quanto è successo non sembra nulla di eclatante, la Casa Bianca sembra invece aver preso molto negativamente la notizia. Almeno in pubblico. «Informazioni di questo tipo non trapelano mai a caso» spiega ancora Neri. «Di solito o c’è uno scontro tra fazioni all’interno dell’intelligence, oppure si tratta di “triangolazioni”: non potendo dire direttamente il governo certe cose – se muovesse accuse tanto gravi dovrebbe per forza attuare delle ritorsioni, e il prezzo in termini diplomatici sarebbe troppo alto – le fa uscire in modo anonimo sulla stampa». Ma allora perché far trapelare una notizia di fronte a cui poi si reagisce con indignazione?
Obama da sempre non vanta rapporti idilliaci con Netanyahu ma di recente sono arrivati al loro minimo storico. La campagna elettorale israeliana ha lasciato pesanti strascichi: il discorso di Netanyahu di fronte al Congresso a maggioranza repubblicana – dove non era stato invitato dal Presidente – è stato considerato uno sgarbo istituzionale, e le pesantissime parole del premier israeliano sulla nascita dello Stato Palestinese e sugli elettori arabo-israeliani hanno portato Obama a reagire duramente. Forse si spiega così la decisione di far uscire la notizia sullo spionaggio israeliano: dovendo il presidente americano far digerire al suo Paese un’inedita linea più che dura contro lo storico alleato, meglio poterlo attaccare su un argomento unificante come la difesa della sicurezza nazionale americana che non su uno divisivo come la questione israelo-palestinese.
@TommasoCanetta
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

«Speculazioni sulla successione dopo la notizia che Khamenei è stato ricoverato in serie condizioni», titolava a inizio marzo il Jerusalem Post. «Khamenei soffre di un cancro alla prostata – proseguiva l’articolo – che si racconta si sia diffuso in tutto il corpo».
Dopo smentite ufficiali e voci sulla presunta gola profonda – il team di medici russi appositamente chiamati per curarlo – lo stato di salute della Guida Suprema dell’Iran rimane avvolto nel mistero. Le conseguenze di una improvvisa morte dell’Ayatollah sarebbero molto importanti e su diversi scenari: la trattativa in corso sulla questione nucleare con il 5+1 (Gli Stati membri del Consiglio di sicurezza dell’Onu, più la Germania), i rapporti con Israele, non ultimo lo scontro in corso tra Teheran e Riad che, seguendo la faglia lungo cui si scontrano sunniti e sciiti, attraversa molti Stati del Medioriente.
«Gli allarmismi di questi ultimi giorni sono eccessivi. Si tratta di una strategia, a mio parere, per influenzare la trattativa sul nucleare in corso», racconta Pejman Abdolmohammadi, docente di studi mediorientali in Italia e all’estero e profondo conoscitore dell’Iran. «Si vuole far credere che con la scomparsa, ormai prossima, di Khamenei l’Iran sarebbe ancora più aperto al dialogo verso l’Occidente, per incentivare la conclusione positiva del negoziato in corso. Questo mi pare il piano di una parte dell’establishment persiano: cercare di consolidare la Repubblica Islamica – attraversata da scricchiolii sempre più forti – facendola uscire dall’isolamento internazionale e rilanciando, grazie alla fine delle sanzioni, l’economia. Questa parte, la “opposizione di velluto” riconducibile al presidente Rohani e all’ex presidente Rasfanjani, ha un approccio più pragmatico e meno ideologico dei “falchi” vicini a Khamenei, ma hanno l’obiettivo comune di preservare la teocrazia e spesso fanno un gioco delle parti».
Non tutti sono però convinti che quelle sulla malattia di Khamenei siano esagerazioni. In ambienti diplomatici italiani alcuni ritengono che le varie correnti della Repubblica Islamica non stiano affatto giocando a rimpiattino con le diplomazie occidentali ma, al contrario, affilando le armi in vista del prossimo scontro. Il rischio, o l’opportunità a seconda del punto di vista, sarebbe che invece di incentivare il negoziato sul nucleare mostrando un volto meno minaccioso al mondo, la tensione tra fazioni iraniane si scarichi sulla trattativa facendola naufragare. Anche la notizia dell’elezione, dopo mesi di vacanza, a capo dell’Assemblea degli esperti – l’organismo che elegge la Guida Suprema – dell’ayatollah ultraconservatore Mohammad Yazdi è secondo alcuni un indizio: la fazione dei falchi ha voluto mettere in una posizione strategica una propria pedina proprio in vista dell’eventuale morte improvvisa di Khamenei. Non avrebbe avuto senso forzare la mano, considerato che l’Assemblea verrà rinnovata l’anno prossimo, se non ci fossero state delle serie preoccupazioni di un improvviso vuoto di potere al vertice. Un analista che conosce da vicino la struttura politica dell’Iran, citato dal Guardian a condizione dell’anonimato, già alcuni mesi fa spiegava: «Non si può sottovalutare l’importanza dell’Assemblea degli esperti. Alla fine sono proprio loro che decidono la prossima Guida Suprema, a meno che non ci sia un colpo di Stato. Chi succederà a Khamenei dipenderà da chi sarà più forte nell’assemblea al momento della sua morte, e quali forze avranno il potere a Teheran». Accenno quest’ultimo ai Pasdaran (le guardie rivoluzionarie – tradizionalmente conservatrici – potenza militare ed economica del Paese), al clero sciita e alle altre forze organizzate del Paese.
Ma non è solo sul fronte iraniano che la situazione è in fase di evoluzione. Negli Stati Uniti 47 senatori repubblicani su 54 hanno firmato una lettera indirizzata a Teheran – un fatto senza precedenti – per smentire la linea dialogante del Presidente Obama e sottolineare come eventuali impegni presi non sarebbero vincolanti per il suo successore. Questo a distanza di pochi giorni dall’aver invitato il premier israeliano Netanyahu – storicamente molto duro con l’Iran – a tenere un discorso al Congresso. Mosse tese a sabotare la trattativa Washington-Teheran – che potrebbe avere improvvise accelerazioni nelle prossime settimane e su cui è difficile prevedere come potrebbe impattare un’eventuale scomparsa di Khamenei – e a posizionarsi in una prospettiva di medio periodo.
«Il punto, secondo me, è proprio questo: non penso ci sarà una prossima Guida Suprema in Iran dopo Khamenei», afferma ancora Abdolmohammadi. «Magari Obama e Rohani riusciranno anche a concludere un accordo sul nucleare nelle prossime settimane, ma questo non impedirà il crollo della Repubblica Islamica in un periodo che si può collocare tra il 2017 e il 2022. In primo luogo il prossimo presidente americano è probabile, in caso di vittoria repubblicana o anche di Hillary Clinton, che torni alla politica del “regime changing” per l’Iran. Poi la situazione geopolitica regionale è destinata a cambiare nei prossimi anni: finora, e forse ancora per un po’, l’Iran ha avuto il vento nelle vele per via della guerra all’Isis – nemico comune con l’Occidente – che gli ha consentito di guadagnare terreno e simpatie internazionali, per la situazione di caos in cui si sono trovate diverse potenze regionali dopo le Primavere Arabe (Egitto in primis) e per il conseguente appannamento del rivale regionale saudita. Infine, e secondo me fattore più importante, il regime potrebbe cadere per fattori interni: la generazione degli attuali trentenni arriverà in molti gangli del potere nei prossimi anni, e questi giovani sono in molti casi già andati oltre la Repubblica Islamica e in generale l’Islam politico. Adesso siamo nel primo tempo», conclude con una metafora sportiva Abdolmohammadi, «e sembra che Rohani con la sua “opposizione di velluto” stia vincendo la partita, ma credo che nel secondo tempo le cose siano destinate a cambiare drasticamente».
@TommasoCanetta
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

«Riuscirà Ankara a riprende il suo potere nel Vicino Oriente?», si interrogava nel 2011 Hamze Jammoul, giurista libanese ed esperto nella gestione dei conflitti internazionali. Allora le recenti primavere arabe avevano aperto grandi spazi di manovra per la Turchia di Erdogan, vicina politicamente a quella Fratellanza Musulmana che andava conquistando il potere negli Stati travolti dalle rivoluzioni.
«In passato il grande sogno turco affrontava degli ostacoli rappresentati dal continuo ruolo strategico dell’Iran in Libano, Siria e Iraq, e della solida alleanza tra i due paesi Arabi più influenti: Arabia Saudita ed Egitto», spiegava ancora Jammoul, ipotizzando un futuro più favorevole alle aspirazioni neo-ottomane di Erdogan. In Egitto erano da poco al potere i Fratelli Musulmani, e così in Tunisia. In Siria Assad sembrava destinato a seguire la sorte di Mubarak in Egitto – se non di Gheddafi in Libia –, privando l’Iran del suo principale alleato, e l’Arabia Saudita non pareva ostile agli sviluppi in corso. Il Qatar, monarchia del Golfo piccola ma molto ricca, e influente grazie al suo canale tv Al Jazeera, faceva gioco di squadra con Ankara per sostenere la Fratellanza Musulmana dove possibile, cercando di ritagliarsi un ruolo nello scacchiere regionale. Nel 2015 si può dire che del sogno turco restano giusto i cocci.
In Egitto un golpe militare ha spodestato il presidente Mohammed Morsi, della Fratellanza, per mettere al potere l’ex generale Al Sisi. In Tunisia alle ultime elezioni ha vinto il partito laico Nidaa Tounes, dopo i primi anni di governo di Ennahda (Fratelli Musulmani). In Libia è scoppiata una guerra civile, con due governi (uno riconosciuto internazionalmente, laico, e con sede a Tobruk; un altro, sostenuto da Turchia e Qatar, islamista, con sede a Tripoli) e le infiltrazioni dello Stato Islamico. In Siria e Iraq, proprio la nascita dello Stato Islamico e il crescente peso delle componenti estremiste nella ribellione, hanno portato a un rafforzamento diplomatico di Assad e del suo alleato-protettore iraniano. Inoltre Teheran ha approfittato del caos creato dal fanatismo islamico sunnita nell’area per guadagnare appoggio internazionale (se l’asse sciita è nemico dell’Isis, e i nemici dei nostri nemici sono nostri amici, Teheran e Damasco non sono mai state tanto inconfessabilmente apprezzate dall’Occidente) e terreno in Iraq.
Di fronte a queste evoluzioni l’Arabia Saudita – avversario regionale dell’Iran – non è rimasta immobile. Dopo aver frenato l’interventismo del vicino Qatar – con anche gravi tensioni diplomatiche lo scorso marzo – a sostegno dei Fratelli Musulmani, ha rinsaldato l’asse con l’Egitto guidato dai militari (tornando così all’assetto precedente le primavere arabe) e sta cercando la sponda dell’Occidente (anche di Israele, con cui condivide molti obiettivi di breve e medio termine) per evitare che Teheran riesca a uscire dall’isolamento internazionale e a riguadagnare un ruolo geopolitico strategico nell’intera regione. Così stando le cose la Turchia si trova ad essere isolata e sulle difensive, schiacciata tra l’alleanza Cairo-Riad da un lato e l’asse sciita dall’altro, con la questione curda esplosa (grazie al conflitto con l’Isis) ai propri confini e con rapporti mai così freddi con l’Occidente. Ma proprio passando da una strategia di espansione a una di contenimento, Ankara può ora ritagliarsi un ruolo nella soluzione di diverse crisi regionali.
«In Libia la situazione attualmente è molto complicata per la Turchia, che con il Qatar sostiene il governo islamista di Tripoli. La settimana scorsa il governo di Tobruk ha annunciato la cancellazione dei contratti in essere con imprese turche – secondo quanto dichiarato l’anno scorso dall’associazione delle imprese costruttrici turche gli investimenti attualmente congelati per gli scontri tra fazioni ammontano a 19 miliardi di dollari – scatenando la reazione diplomatica turca», spiega Leandro Di Natala, analista dell’European Strategic Intelligence and Security Center. «Ma senza un accordo tra i due governi sarà l’Isis ad approfittarne, quindi – come anche suggerito dall’Onu – la via diplomatica resta quella principale, e qui sicuramente la Turchia potrà far valere il proprio peso. Molto più complessa la situazione sul fronte Iraq-Siria. L’Isis è stato, de facto, un alleato prezioso per la Turchia, facendo guerra contemporaneamente a tre nemici di Ankara: i curdi, il governo di Assad e le milizie sciite irachene. Ora però, per uscire dall’isolamento internazionale e per assecondare le pressioni degli alleati, la Turchia è costretta a schierarsi contro lo Stato Islamico. Non a caso il premier turco Erdogan ha annunciato il progetto di addestrare, insieme agli Usa, combattenti siriani in ottica anti-Isis (e, secondo i desiderata di Ankara, anche anti-Assad). Questo avrà probabilmente un prezzo pesante per Ankara, che ha nel suo territorio diverse cellule dell’Isis che potrebbero compiere azioni terroristiche in ritorsione (l’attentato kamikaze di una donna del Daghestan, vedova di un foreign fighters norvegese, a una stazione di polizia di Istanbul è un precedente inquietante). La decisione della Turchia di rimpatriare i 40 soldati che proteggevano la tomba di Suleyman Shah, e la tomba stessa, dal territorio siriano è da leggere come una mossa preventiva».
La prospettiva della Turchia su questo fronte è dunque necessariamente di medio periodo. Nel breve probabilmente non parteciperà con soldati sul terreno all’offensiva di primavera che le forze regolari irachene e i guerriglieri curdi lanceranno, col sostegno degli Stati Uniti, contro lo Stato Islamico per riconquistare Mosul. Quando saranno pronte le milizie siriane addestrate da Ankara – 5 mila a fine anno, 15 mila in un triennio –, riconducibili a forze politicamente vicine ai Fratelli Musulmani, lo scenario potrebbe però cambiare. Nell’eventualità che lo Stato Islamico venga infatti sconfitto, o comunque drasticamente indebolito, Assad non sarebbe più un alleato di fatto dell’Occidente contro l’Isis e la Turchia potrebbe cercare un ruolo di regia nella guerra civile delle fazioni islamiche a lei più vicine.
«Quello che la Turchia deve risolvere ora è un dilemma strategico: correre il rischio che, dagli sviluppi di una guerra allo Stato Islamico, nasca uno Stato curdo ai suoi confini è contrario alla tradizionale linea di Ankara», prosegue Di Natala. «Tuttavia, avendo Erdogan abbandonato la politica del “nessun nemico ai confini” – Siria, Iraq e Iran sono oramai ostili, oltre ad Egitto, Giordania, Emirati e Sauditi – per uscire dall’isolamento internazionale ha bisogno della sponda dell’Occidente. Qualche concessione agli alleati Nato dovrà farla, in materia di contrasto al terrorismo e forse anche sui curdi – conclude Di Natala -, ma almeno giocherebbe la partita con degli interlocutori aperti al dialogo, specie in un periodo di forte tensione con la Russia».
@TommasoCanetta
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Dopo le azioni militari della Giordania contro l’Isis in Siria e Iraq sono arrivati anche i bombardamenti contro l’Isis in Libia. Due Paesi arabi e sunniti, l’Egitto e la Giordania, storicamente alleati dell’Occidente nella regione. E se il Cairo sembrava essersi allontanato con l’avvento dei Fratelli Musulmani e la presidenza di Mohammed Morsi, da quando sono tornati al potere i militari con Al Sisi il riavvicinamento è cominciato.

La Libia è l’ultimo capitolo, che segue però la repressione del terrorismo islamico in patria, al confine col Sinai ma non solo, la difesa a oltranza dei cristiani, i buoni rapporti con Israele e i tentativi di accreditarsi un ruolo nella soluzione del caos siriano.
«È improprio parlare di Isis in Libia», spiega Claudio Neri, direttore dell’Istituto Italiano di studi strategici. «In parte come già successo nel passato con Al Qaeda, Isis è diventato un “brand” che altre sigle prendono in prestito per ottenere maggiore visibilità mediatica. I gruppi terroristi in Libia esistono da anni, non sono certo arrivati con la nascita del Califfato islamico». Questi gruppi – in primis Ansar Al Sharia, alleato e in parte origine del neonato Isis libico – stanno guadagnando posizioni grazie allo scontro interno alla Libia tra il governo riconosciuto internazionalmente, che è dovuto fuggire a Tobruk e che può contare sull’appoggio di buona parte dell’apparato militare, specialmente del generale Khalifa Haftar, e il governo sostenuto dalle fazioni islamiche vicine ai Fratelli Musulmani che ha sede a Tripoli.
Negli ultimi giorni l’Egitto ha approfittato del grande clamore che hanno creato le bandiere nere dell’Isis a pochi chilometri dalle coste europee, e dello sdegno suscitato dalla barbara esecuzione di 21 prigionieri egiziani copti, per chiedere all’Onu di intervenire con la forza a sostegno del governo legittimo di Tobruk, il cui premier Al Thani ha ventilato il rischio che «se il Mondo non interviene l’Isis arriverà in Italia». Per ora l’Onu continua a indicare la via diplomatica ma, come spiega Mattia Toaldo, analista dell’European Council on Foreign Affairs, «l’attuale embargo Onu sull’invio di armi in Libia è già di fatto aggirabile. È stato riconosciuto all’Egitto il diritto di colpire l’Isis in territorio libico con il supporto dell’aviazione del generale Haftar, non serve insomma nessun passaggio formale per autorizzare quel che già sta avvenendo».
Le mosse del Cairo si spiegano come indirizzate verso una molteplicità di obiettivi: innanzitutto a fini di stabilità interna il governo di Al Sisi ha un forte interesse a colpire duramente le fazioni estremiste islamiche. In secondo luogo nella sua rincorsa a riaccreditarsi come attore regionale di primo piano avrebbe molto da guadagnare se in Libia venisse instaurato un regime militare “fratello”. «Gli oppositori del governo di Tobruk, e del suo alleato egiziano, parlano di una “restaurazione”, di un ritorno al regime gheddafiano pre-primavere arabe», racconta ancora Toaldo. «Ma questa è una ricostruzione imprecisa: è vero che alcuni soggetti sono stati legati in passato al regime di Gheddafi, ma il leader libico era un paria regionale, un eventuale regime militare legato all’Egitto sarebbe una cosa assolutamente diversa».
C’è poi un terzo obiettivo che interessa l’Egitto ma ancor di più le monarchie del Golfo, che stanno finanziando il Cairo in ottica di contrasto alla Fratellanza Musulmana e supportando il nuovo corso di Al Sisi. Da quando le primavere arabe sono fallite ed è esploso il caso Isis, nella regione mediorientale ha guadagnato molte posizioni – soprattutto a livello diplomatico ma non solo – il cosiddetto “asse sciita”, riconducibile a Teheran, avversario regionale di Riad. In Iraq, in Siria, in Yemen gli sciiti hanno guadagnato posizioni sul terreno ma, fatto più preoccupante per i Sauditi, essendo i più efficaci nemici dell’Isis hanno anche ottenuto consenso internazionale. Il nuovo corso in Iran impresso dal presidente Rohani era stato da molti visto come una mano tesa verso l’Occidente, per cercare di ottenere un riconoscimento formale del proprio ruolo di potenza regionale, uscendo così dall’isolamento internazionale. Prospettiva questa che spaventa molto i sauditi e non solo. L’affermazione di responsabilità dell’Egitto e delle monarchie del Golfo in Libia – subito dopo quella della Giordania in Siria e Iraq – ha allora anche il senso di volersi riaffermare nel lungo periodo come gli alleati più affidabili per l’Occidente, evitando il rischio di una svolta favorevole all’Iran e ai suoi alleati (in primis Assad in Siria).
«Il rischio – conclude Toaldo – è però che le forze armate egiziane vadano in over-stretch. Essendo impegnate su troppi fronti, dal Sinai alla Libia, non riescano cioè a reggere nel medio periodo. Questa è inoltre una prospettiva che probabilmente preoccupa anche Israele, che vedrebbe indebolito il contrasto alle fazioni fanatiche islamiche sul confine con l’Egitto».
«Il destino della Libia mi pare molto legato anche a quelle che saranno le decisioni dell’Occidente», afferma Neri. «E da quelle decisioni avremo un’indicazione sullo stato di salute delle potenze alleate. Se dovessero prevalere le divisioni e l’indecisione rischieremmo davvero di lasciare troppo spazio di manovra ai fanatici islamici, dando anche un’inquietante segnale di debolezza. Pesa per ora l’assenza degli Stati Uniti nel dare una visione strategica per l’area, ma gli Stati europei dovrebbero in ogni caso decidere una linea comune a cui attenersi». Anche considerando che la Russia, con cui dal crollo dell’Urss i rapporti non erano così tesi, è pronta a infilarsi nelle crepe dello schieramento occidentale per guadagnare posizioni: con l’Egitto di Al Sisi già intrattiene buoni rapporti, così come con il governo libico di Tobruk. Pezzi di una scacchiera su cui sembra ufficialmente ricominciato il Grande Gioco che non possono essere abbandonati all’influenza dell’avversario.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Le notizie che arrivano dallo Yemen non hanno solo una portata locale. Se lo Stato dovesse definitivamente collassare si aprirebbero enormi praterie per i gruppi terroristi, in particolare per Al Qaeda nella Penisola Araba, la sigla che ha – ad esempio – rivendicato gli attentati di Parigi a Charlie Hebdo.

Si creerebbe un altro santuario per il fanatismo islamico, dopo il Califfato in Iraq e Siria, dove i jihadisti possono nascondersi, addestrarsi, armarsi e pianificare attentati sul suolo occidentale e non solo. Ecco perché diventa fondamentale capire cosa sta succedendo in queste ultime ore nello Stato sud-occidentale della Penisola Araba.
Dopo aver occupato il palazzo presidenziale, sparato sulla residenza del presidente, aver occupato la televisione pubblica e la più grande base militare del Paese, i ribelli sciiti in Yemen, gli Houthi, hanno fermato la lama del golpe a pochi centimetri dalla gola dello Stato, presieduto dal sunnita Abd-Rabbu Mansour Hadi. La minaccia però rimane. I ribelli sostengono di essere disposti a prendere qualunque misura necessaria per ottenere il riconoscimento nella nuova costituzione dei loro diritti. Questo era stato promesso nell’accordo di pace siglato lo scorso settembre, dopo che gli Houthi avevano di fatto occupato la capitale Sanaa, e niente meno di questo verrà accettato.
La ribellione degli Houthi va avanti da oltre un decennio oramai. Dopo aver preso il controllo del nord dello Yemen, dove abita una popolazione a maggioranza sciita, sono riusciti negli ultimi anni a conquistare altre aree e diversi quartieri della capitale. Nel corso delle primavere arabe, 2011, hanno ottenuto la cacciata del presidente Saleh – sciita anch’esso ma ben visto da sauditi e americani, e quindi a loro inviso – e si aspettavano un ampio riconoscimento della loro autonomia (e quindi una consistente fetta di potere) da parte del governo di unità nazionale presieduto da Hadi. Ma qualcosa nel percorso immaginato si è inceppato e le frizioni crescenti dell’ultimo periodo rischiano di scatenare un incendio che non lascerebbe speranze di vita alla fragile autorità statale yemenita.
“Quello che sta accadendo va inserito nel contesto del Grande Gioco in corso tra Arabia Saudita e Iran nell’intero Medio Oriente”, spiega Leandro Di Natala, analista dell’European Strategic Intelligence and Security Center di Bruxelles. “Come in Iraq, in Siria, in Libano, in Bahrein e via dicendo, anche in Yemen gli sciiti e i sunniti vengono armati gli uni contro gli altri per le logiche di potere delle due potenze regionali. Gli Houthi sono sicuramente sostenuti dall’Iran: nel gennaio 2013 ad esempio era stata sequestrata una nave secondo Sanaa riconducibile a Teheran, la Jihan 1, ricolma di armi (anche pesanti, come missili terra-aria) destinate ai ribelli sciiti. Allo stesso modo i Sauditi cercano di sostenere il governo, che gli è amico, e gli attori locali sunniti ostili agli Houthi”.
Considerata la complessità della situazione yemenita è comunque difficile suddividere il campo in solo due schieramenti, aggiunge Di Natala. La terza parte – la più pericolosa per l’Occidente – è costituita dai gruppi terroristi riconducibili ad Al Qaeda ed al jihadismo, che qui sono particolarmente forti e radicati. In Yemen risiede ad esempio Nasser bin Ali al-Ansi, ideologo qaedista che pochi giorni fa ha nuovamente incitato i suoi seguaci a fare attentati individuali in Europa. Anche Al Asiri, lo specialista di esplosivi più ricercato e pericoloso del terrorismo islamico, pare si nasconda in Yemen. Ma oltre ai terroristi di Al Qaeda esistono numerose altre sette fanatiche, gruppi sunniti secessionisti (Al Hirak), e gli scontri spesso rispondono a logiche tribali oltre che religiose o politiche.
“Sarebbe sbagliato pensare che quello che succede in Yemen, o in generale negli altri Stati periferici rispetto alle due potenze, iraniana e saudita, sia sempre frutto di una spinta da parte di queste ultime. Talvolta è il contrario: sono i Paesi piccoli e i loro gruppi che riescono a coinvolgere Teheran e Riad nel sostenerli politicamente e nell’armarli”, afferma Simone Pasquazzi, docente di relazioni internazionali e analista digeopolitica per enti pubblici e privati. “Nel caso dello Yemen, poi, ovviamente le due potenze sono molto coinvolte. Gli Iraniani hanno la prospettiva di piantare una loro bandierina sul confine sud del nemico saudita, provocandone un accerchiamento e controllando di fatto anche l’altro canale marittimo che dà a Riad lo sbocco sull’Oceano, oltre allo stretto di Hormuz, già sotto tutela iraniana. Riad per contro cerca in tutti i modi di evitare questo accerchiamento e una presenza ostile sciita nel versante sud della penisola Araba”. E forse è stata proprio la contrarietà dei sauditi a concedere troppo potere agli Houthi che potrebbe aver portato al ristagno della situazione prima ed al suo precipitare attuale.
“Per evitare che la situazione precipiti – con gravi ripercussioni per la sicurezza anche dei Paesi occidentali – servirebbe che l’Arabia Saudita riconoscesse il ruolo degli Houthi in Yemen, e quindi dell’Iran nel Paese. A quel punto potrebbero unire gli sforzi contro la minaccia qaedista e dell’Isil, che sono entrambi loro comuni nemici”, prosegue Di Natala. “Purtroppo questo è lo scenario più improbabile. Considerato lo scontro in corso tra Teheran e Riad in Siria, Iraq, Libano e in generale in tutta l’area, è assai più probabile che continuino a combattersi, indebolendo così le strutture dello Stato a tutto vantaggio delle organizzazioni terroristiche e qaediste. Se si dovesse arrivare a un golpe vero e proprio da parte degli Houthi – conclude Di Natala – nell’anarchia conseguente si rafforzerebbero i gruppi legati alla jihad islamica”.
Se dovesse perdere il proprio interlocutore “ufficiale” in Yemen, cioè il governo, l’Arabia Saudita potrebbe decidere di destinare i propri aiuti economici e militari anche ad altri soggetti. Secondo HashemAhelbarra, per anni corrispondente di Al Jazeera da Sanaa, “l’ex presidente Saleh ha ancora la fedeltà di molti reparti della Guardia Repubblicana e la sua influenza sarebbe ancora forte sulle tribù sciite del nord, di cui pure gli Houthi fanno parte”. Ma non solo. Armi e soldi potrebbero finire anche in mani peggiori. “E’ già successo in passato”, conferma Pasquazzi. “I sauditi potrebbero armare gruppi fanatici sunniti in ottica anti-sciita ma senza averne un controllo sufficiente. Non dico per forza in Yemen, dove Al Qaeda può essere una spina nel fianco anche per i Saud, che quindi potrebbero essere più prudenti. Ma potrebbero ad esempio attuare la loro retaliationcontro obiettivi sciiti in Siria, in Libano o in Iraq. A quel punto le loro risorse potrebbero finire nelle mani sbagliate. E l’Occidente avrebbe ancor più di che preoccuparsi”.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Sono passati pochi anni da quando il cyberspazio ha ufficialmente affiancato la terra, il mare, l’aria e lo spazio come quinto scenario bellico possibile.

Da allora abbiamo scoperto virus-spia in grado di infettare intere nazioni, gruppi di sedicenti hacker legati a Stati canaglia che usano il cyberspazio per azioni propagandistiche e di sabotaggio, armi cibernetiche che possono causare gravi danni a impianti nucleari, sistemi di controllo capaci di raccogliere immense quantità di dati dai singoli apparecchi elettronici usati quotidianamente da ignari cittadini ed elaborarli rapidamente, e via dicendo. Questi fenomeni, secondo gli esperti, sono destinati ad aumentare sempre più nel futuro e con un impatto sempre maggiore sulla vita delle persone.
Il rapporto di novembre 2014 pubblicato da McAfee Labs prevede che nel 2015 sia le azioni di warfare che quelle di intelligence nel cyberspazio andranno in crescendo. In particolare ci saranno sempre più intrusioni allo scopo di sottrarre dati e informazioni, gli attori già presenti da tempo in questa competizione diventeranno ancora più abili e invisibili, mentre i nuovi arrivati cercheranno di competere e di danneggiare i “vecchi” concorrenti.
Gli Stati già forti nel cyberspazio poi, sempre in base a questo rapporto, miglioreranno ulteriormente la propria abilità di infettare i sistemi delle proprie vittime senza essere scoperti. Non solo. Altri Stati – finora estranei a questo “Grande Gioco cibernetico” – diventeranno attori rilevanti e anche organizzazioni terroristiche.
“Le “superpotenze” nel cyberspazio sono rimaste – e rimarranno nell’immediato futuro – le stesse degli scorsi anni: Stati Uniti, Israele, Cina e Russia», racconta Stefano Mele, Coordinatore dell’Osservatorio Infowarfare e Tecnologie Emergenti dell’Istituto Niccolò Machiavelli ed esperto ascoltato in ambito Nato. “Sono in crescita anche le capacità di numerosi Stati europei come Uk, Francia, Germania e Olanda. Si hanno poi notizie di un grande attivismo da parte della Siria, della Nord Corea e dell’Iran, anche se il loro livello è ancora inferiore a quello degli altri attori”. Sembra comunque evidente che sia in atto una “corsa agli armamenti cibernetici” anche da parte degli attori nazionali che finora meno avevano investito in questo ambito. “Il principale utilizzo degli strumenti di cyberwarfare – prosegue Mele – è quello di facilitare gli attacchi cinetici tradizionali: ad esempio se devo bombardare un obiettivo nemico mi sarà molto utile poter disattivare i radar utilizzando un malware. Ovviamente è più facile infettare gli obiettivi nemici in tempo di pace piuttosto che in tempo di guerra, quindi proprio in questo momento – in cui per altro manca ancora una legislazione internazionale in materia – gli Stati stanno probabilmente portando avanti azioni offensive e difensive di questo genere”. Insomma, anche solo per difendersi da potenziali minacce esterne, sta diventando sempre più indispensabile avere capacità militari e di intelligence anche nel cyberspazio.
“Nell’ambito cyber i rapporti di forza tradizionali contano meno”, spiega Corrado Giustozzi, esperto di cybersecuirty e dal 2010 membro del “Permanent Stakeholders’ Group” di ENISA, l’agenzia europea per la sicurezza delle informazioni e le reti. “Tre persone in gamba con una connessione internet sono già in grado di fare danni rilevantissimi. Inoltre di recente c’è stata un’esplosione delle comunicazioni che rende più facile portare attacchi: la capacità di connettere qualunque cosa si è trasformata in un “allora connettiamo qualunque cosa”. Mi spiego. Il software – ad esempio di controllo di un missile o di una portaerei – è tradizionalmente sempre stato costruito con l’obiettivo che fosse affidabile ma non che potesse resistere ad attacchi deliberati di – uso un termine improprio – “hackeraggio”. Un tempo questi software erano manipolabili solo avendo un accesso fisico all’oggetto. Adesso invece, visto che spesso tutti questi sistemi sono collegati, è possibile controllarli (e quindi teoricamente anche manometterli) da remoto. Questo processo è avvenuto molto in fretta e solo da circa cinque anni abbiamo cominciato a porci il problema. Adesso – e questa sarà secondo me una tendenza destinata a durare nell’immediato futuro – è cominciata una corsa da parte delle strutture militari a valutare la sicurezza e la vulnerabilità dei propri software. Continuerà insomma lo scontro tra chi attacca e chi difende, e il numero di tentativi di infiltrazione”.
Ma non sono solo gli Stati a doversi preoccupare dello spionaggio, anzi. Spesso i sistemi governativi sono i più difficili da violare e non i soli a detenere informazioni strategiche. Ad esempio le grandi multinazionali che ottengono appalti nel settore Difesa, o gli operatori del settore bancario e finanziario, sono bersagli altrettanto appetibili. La crescente consapevolezza dei rischi sta comunque portando anche i privati a investire in sistemi di difesa contro gli attacchi cibernetici (anche se non basta mai, come emerso nel recente caso-Sony). “Il tallone d’Achille del sistema sono le piccole e medie imprese, che costituiscono la stragrande maggioranza delle aziende in Italia e in tutta Europa”, spiega ancora Stefano Mele. “Queste spesso sono poco consapevoli dei rischi legati alla cybercriminalità e non hanno adeguati sistemi difensivi. Non bisogna commettere l’errore di sottovalutare il pericolo: non è solo la criminalità “comune” che può avere interesse a colpire le Pmi. Anche grandi organizzazioni – o addirittura Stati – potrebbero individuare in piccole società che fanno parte di gruppi più vasti (e che magari collaborano sul medesimo progetto) il punto debole dove andare a sottrarre dati e informazioni”.
Che il fenomeno del cybercrimine sia destinato ad aumentare lo prevede anche il sopra citato rapporto di Mc Afee Lab. In particolare evidenzia il rischio che aumenti il fenomeno del “ransomware”, cioè quando un virus “sequestra” il computer e non c’è modo di sbloccarlo se non pagando un riscatto per ottenere un apposito codice. La criminalità, insomma, inventa sempre nuovi modi per sfruttare il cyberspazio, facendo leva sulla ancora scarsa consapevolezza dei rischi di moltissimi utenti. Quando poi il livello qualitativo degli attacchi si alza, riconoscere anche solo la tipologia dei responsabili – criminali comuni, organizzazioni, intelligence straniere, Stati ostili etc – diventa ancora più difficile. Dietro l’anonimato e le infinite triangolazioni che la Rete permette potrebbe nascondersi chiunque. E inoltre non è raro che i governi usino i criminali cibernetici per i propri fini. È noto il caso della Russia che, potendo ricattare gli hacker che ha individuato, li può costringere a collaborare con l’intelligence per particolari operazioni. La Cina poi pare avesse addirittura convinto (o costretto) dei suoi ricercatori all’estero a tentare di violare la rete dei centri dove erano ospiti per sottrarre informazioni protette di grande valore..
“Il ricorso a queste tecniche “manuali” mi sembra personalmente più usuale per i Paesi asiatici. L’Occidente ricorre maggiormente alle tecnologie automatiche da remoto quali malware specializzati”, afferma Giustozzi. “In ogni caso lo spionaggio c’è sempre stato e non è per quello che scoppiano le guerre. Anzi, è normale anche spiarsi tra alleati, come emerso con lo scandalo Datagate. Non penso – conclude l’esperto – che gli Usa abbiano smesso di esercitare quel tipo di controllo pervasivo, né che abbiano ceduto alle pressioni degli alleati per condividere le informazioni raccolte in quel modo. Anche nel futuro lo spionaggio su vasta scala proseguirà”.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
La questione curda nasce al termine della prima guerra mondiale, quando dal disfacimento dell’Impero Ottomano sembrava sarebbero dovuti nascere due nuovi Stati: l’Armenia e il Kurdistan.
Il trattato internazionale che lo prevedeva non venne tuttavia mai ratificato e la riscossa turca guidata da Kemal Ataturk spense le pretese indipendentiste.
Tuttavia nel corso dei decenni successivi i curdi – pur perseguitati duramente – hanno sempre mantenuto una forte identità nazionale, benché dispersi tra quattro Stati: Turchia, Iran, Iraq e Siria.

Ora che Siria e Iraq – composti da popolazioni diverse, con fedi e costumi diversi – pare stiano crollando sotto i colpi della faida tra sciiti e sunniti (sobillati da Iran e Sauditi), la nazione curda potrebbe forse finalmente affermarsi come Stato.
Pur essendo i curdi, da un punto di vista religioso, musulmani sunniti, essi non rientrano nelle logiche dello scontro intra-religioso in corso negli ultimi anni nei Paesi islamici. Storicamente sono infatti stati fortemente influenzati (e laicizzati) dal marxismo e, all’epoca, dall’Unione Sovietica. Ad esempio in Siria nel Ypg – il braccio armato del Pyd, legato al Pkk di Ocalan – combattono anche numerose donne.
Ovviamente esistono molte fazioni curde nei vari Stati in cui il Kurdistan è diviso, e alcune oggi godono dell’appoggio occidentale (a differenza del Pkk, considerato dall’Occidente – alleato della Turchia – un’organizzazione terroristica). Ad esempio il Pdk – nazionalista, conservatore e liberale – in Iraq è stato sostenuto fortemente dagli Usa, specie all’indomani della guerra contro Saddam Hussein.
La litigiosità tra fazioni è stata a lungo uno degli ostacoli che ha rallentato il cammino del Kurdistan verso l’indipendenza, ma non il principale. La peggior sfortuna per i curdi è stata infatti quella di abitare un territorio ricco di risorse, in particolare di petrolio, a cui nessuno tra Turchia, Iran, Iraq e Siria è mai stato disposto a rinunciare.
Tuttavia i recenti sconvolgimenti in Medio Oriente hanno dato il via a un mutamento rispetto al passato. Nella comune lotta contro l’Isis e le fazioni estremiste in Siria e Iraq i curdi dei vari Stati (ad eccezione forse di quelli iraniani) hanno trovato un’unità senza precedenti. E gli interlocutori – potenze internazionali e regionali, e i leader degli Stati coinvolti – si sono trovati a dover trattare coi curdi per contrastare il nemico comune del fanatismo islamico sunnita.

Il primo importante passo per il riconoscimento del Kurdistan si può dire sia avvenuto con la guerra di George W. Bush contro l’Iraq di Saddam. Ai curdi iracheni, che furono sterminati col gas dopo la prima Guerra del Golfo e che durante la guerra del 2003 schierarono decine di migliaia di Peshmerga (le loro milizie) contro il regime, venne riconosciuta un’ampia autonomia all’interno del nuovo Stato federale iracheno.
Nel 2012 si parlava addirittura della costruzione di un “oleodotto curdo” per esportare petrolio in Turchia, scavalcando così l’autorità centrale di Baghdad con cui la regione curda aveva avuto delle dispute in materia di vendita del greggio.
“Di recente sul punto è stato trovato un accordo, grazie anche alla mediazione di Ankara, che accontenta entrambe le parti”, spiega Mattteo Verda, ricercatore dell’Ispi specializzato in sicurezza energetica.
“Baghdad non perde – come temeva – il controllo sulle esportazioni e ai curdi iracheni sono garantiti una percentuale vantaggiosa e rifornimenti in armi per i Peshmerga. Viene insomma mantenuto lo Stato federale iracheno, che non sprofonda nell’anarchia, e si arma la fazione che in questo momento sta combattendo l’Isis. Quanto all’atteggiamento della Turchia non deve stupire. Sicuramente trae vantaggio dall’importare greggio dal Kurdistan iracheno in termini economici, ma il fattore più importante è l’accordo politico. Ankara vuole avere una garanzia concreta, non a parole, di una propensione alla collaborazione strutturale da parte dei curdi iracheni”.
I curdi iracheni e il Pkk – che spesso compie attentati agli oleodotti turchi – rischiano di trovarsi dunque su fronti opposti. Se da un lato è anche questo l’obiettivo della Turchia dall’altro accresce le preoccupazioni sulla tenuta dell’accordo, anche considerata la collaborazione militare tra Peshmerga e Ypg in Siria.
Il secondo importante smottamento, dopo il crollo della dittatura baathista in Iraq, è infatti arrivato con la guerra civile in Siria. In un primo momento le forze curde – in particolare le milizie del Ypg– hanno combattuto tanto contro il regime quanto contro i ribelli, ottenendo un’indipendenza de facto dal resto del territorio siriano per le aree a maggioranza curda.
Con l’accentuarsi della presenza di fazioni fanatiche-islamiche (e forse con un accordo sottobanco col governo di Damasco) si sono però intensificati gli scontri con gli islamisti di Al Nousra prima e dell’Isis poi. Fino alla caduta di Mosul in Iraq (giugno scorso) e alla nascita del Califfato le forze curde erano riuscite a ottenere numerose vittorie e ad esercitare il controllo sulla propria area. Ma quando i combattenti dello Stato Islamico sono riusciti a sottrarre all’esercito regolare iracheno – discioltosi nel nord-ovest senza combattere – artiglieria e mezzi corazzati, le sorti del conflitto sembravano destinate a cambiare.
Nonostante i bombardamenti – iniziati durante l’estate – della coalizione internazionale guidata dagli Usa contro l’Isis, nell’offensiva di settembre/ottobre i combattenti dello Stato Islamico sono riusciti a conquistare numerosi villaggi tra Iraq e Siria e a spingersi fino al confine con la Turchia dove hanno messo sotto assedio la cittadina curda di Kobane.

È in questo momento di difficoltà che qualcosa di nuovo pare si sia mosso sotto traccia. Lo scorso ottobre i Peshmerga iracheni vengono mandati da Masud Barzani, presidente della regione del Kurdistan iracheno e capo del Pdk, ad aiutare i guerriglieri del Ypg nella cittadina assediata.
Secondo alcuni esperti, come la giornalista di Al Arabyia Ceylan Ozbudak, i Peshmerga sarebbero andati “malvolentieri”, e “a causa di una pressione particolarmente forte da parte degli Stati Uniti sul governo regionale del Kurdistan iracheno”. Infatti tra Pdk e Ypg non corre buon sangue: “Il Pdk è ideologicamente più affine ai partiti arabi dell’area e le istanze del Ypg sono considerate controverse anche tra i curdi. I Peshmerga non erano entusiasti – conclude Ozbudak – di andare a Kobane, in parte per le differenze ideologiche tra Pdk e Ypg, in parte per lo scarso numero di civili curdi rimasti nella cittadina”.
Ma il fatto rimane. Anzi, che Pdk e Pkk/Ypg – rivali nel contendersi l’influenza sul Kurdistan siriano – stiano lavorando assieme è particolarmente rilevante.
Lo spettatore più preoccupato – e certo non inerte – di queste evoluzioni è ovviamente il governo di Ankara. Come sopra detto la Turchia non ha avuto problemi ancora di recente a trattare sul greggio con il governo regionale curdo-iracheno, ma non può accettare un rafforzamento strategico del Pkk (e delle sue propaggini siriane), che non ha rinunciato alle pretese indipendentiste e alla lotta armata.
“La minaccia strategica per la Turchia non è l’Isis ma la possibile nascita di uno Stato curdo”, racconta Claudio Neri, direttore scientifico dell’Istituto Italiano di studi strategici. “Anzi, non è assurdo ipotizzare che Ankara abbia tentato di usare l’Isis contro i curdi, anche se la strategia ha funzionato solo in parte. Adesso Erdogan evita di intervenire contro l’Isis sostenendo che i raid aerei siano inutili, ma sapendo bene che gli Usa non vogliono inviare truppe di terra e che, nel caso, sarebbero soprattutto i militari turchi ad essere coinvolti. In questo modo Ankara avrebbe modo di controllare il territorio ed evitare che il Pkk si rafforzi o addirittura nasca uno Stato curdo ai suoi confini”.

In questo quadro gli Stati Uniti stanno mantenendo un ruolo di spettatori e poco più. “Il loro principale interesse – conclude Neri – è evitare che l’ordine regionale possa saltare bruscamente. Tutta l’area geopolitica medio-orientale è in fase di riassestamento. I vari attori regionali hanno modificato il loro potere relativo e le dinamiche interne sono fortemente correlate le une con le altre, quindi intervenendo si rischierebbe un effetto domino”.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Dietro le notizie di conflitti, crisi e violenze che arrivano da numerosi Stati del Medio Oriente è facile vedere il filo rosso dello scontro interno all’Islam tra sunniti e sciiti. Questa faida intra-religiosa non è altro che lo schermo dietro cui le due potenze regionali, Iran e Arabia Saudita, mascherano il loro Grande Gioco per l’egemonia sull’area.

Dai tempi della loro ascesa al potere nella penisola arabica, i Saud tentano di imporre la propria guida al mondo islamico-sunnita e tuttavia, essendo appartenenti “sotto-categoria” religiosa dei wahabiti, da sempre incontrano difficoltà e ostacoli. La Fratellanza Musulmana – altra espressione del mondo sunnita – è storicamente ostile alla casa regnante di Riad e questa frattura ha di recente prodotto molti danni per gli uni e per gli altri.
All’indomani delle Primavere Arabe la Fratellanza Musulmana sembrava aver guadagnato spazio e consenso, specialmente con l’ascesa alla carica di Presidente dell’Egitto di Mohammed Morsi. La Turchia di Erdogan – e in parte anche il Qatar – si erano ritagliati il ruolo di “padrini” e finanziatori di questa nuova fase, mentre l’Arabia Saudita si era tenuta su una posizione ambivalente, temendo il dissenso interno e l’ascesa dei Fratelli Musulmani. Pare addirittura che Riad abbia finanziato in Siria sia gruppi laici sia fanatici islamici (Jabhat al Nusra probabilmente, e forse anche l’Isis) interni alla ribellione pur di impedire una vittoria della fazione sostenuta dalla Fratellanza . «In quel periodo l’Arabia Saudita (e non solo) temeva anche un allontanamento dell’alleato americano», spiega Claudio Neri, direttore dell’Istituto Italiano di studi strategici. «L’amministrazione Obama – prosegue Neri – pianificava di disimpegnarsi il più possibile da Europa e Medio Oriente per dedicare i propri sforzi allo scenario Pacifico. Forse anche per questo all’Arabia Saudita non è dispiaciuto dare un contributo perché l’esperimento di pacificazione dopo le Primavere Arabe deragliasse».
Quando le Primavere Arabe hanno avuto la loro fase di riflusso – con la restaurazione in Egitto, il caos in Libia, l’arretramento dei ribelli e la loro frantumazione in Siria e la degenerazione degli scontri in Iraq – i Saud hanno infatti provato a trarne beneficio e posizioni di potere, ad esempio finanziando il nuovo Presidente egiziano Al Sisi, e costringendo il Qatar a espellere diversi leader dei Fratelli Musulmani. Ma nel caos degli ultimi anni aveva intanto fatto tempo ad emergere come rafforzato – e favorito dalla contingenza – lo storico avversario, la Repubblica Islamica Iraniana.
Dopo il periodo di isolamento e crisi durante i due mandati presidenziali di Mahmud Ahmadinejad, con l’instabilità interna esplosa nell’Onda Verde del 2009, l’Iran ha dato un importante segnale con l’elezione del moderato Hassan Rohani nel maggio 2013. «La Guida Suprema, l’Ayatollah Khamenei, ha intuito che ai fini della pacificazione interna era preferibile dare una valvola di sfogo alla popolazione irrequieta lasciando vincere, non un rivoluzionario e nemmeno un riformista, ma almeno un moderato», racconta Pejman Abdolmohammadi, docente di Storia e istituzioni dei paesi islamici all’Università di Genova. «Anche per uscire dall’isolamento internazionale una figura come Rohani, col suo ministro degli Esteri Mohammad Javad Zarif (entrambi hanno studiato in Occidente in gioventù), è ideale. Questo ha già consentito un ritorno favorevole per l’economia del Paese, grazie ad un parziale allentamento delle sanzioni durante il periodo per cui durerà la nuova fase di negoziato sul nucleare di Teheran, con effetti di stabilizzazione per il sistema teocratico». E potrebbe avere un impatto a livello geopolitico ancora più profondo.
Se l’Iran uscisse dal cono d’ombra in cui è stato confinato a partire dalla rivoluzione Khomeinista del 1979, considerato il momento di crisi e destrutturazione dell’ordine mediorientale degli ultimi decenni, avrebbe uno spazio di manovra enorme. Già ora è diplomaticamente molto attivo in tutti i teatri di crisi, dalla Siria all’Iraq, dallo Yemen al Libano. Se venisse legittimato dalla comunità internazionale, l’intero scacchiere mediorientale ne risentirebbe in termini di un ribilanciamento degli attuali equilibri a favore di Teheran.
Questa eventualità fa paura soprattutto a Riad ma non solo. Israele, specie se dovesse essere confermata la linea dell’attuale premier Netanyahu, potrebbe non accettare un’ascesa iraniana. Anche la Turchia vedrebbe compresso il suo attuale ruolo di mediatore e perfino la Cina e la Russia, formalmente favorevoli al buon esito del negoziato con Teheran, avrebbero molto da perdere. «Pechino perderebbe l’esclusiva sulle esportazioni di petrolio iraniano – dice ancora Pejman – e Mosca si troverebbe ad avere un agguerrito concorrente in più, la cui immissione di gas nel mercato svaluterebbe oltretutto le riserve russe». Secondo gli analisti esiste tuttavia anche la possibilità che sia Teheran a non voler concludere alcun accordo sul nucleare ma che anzi voglia solo guadagnare tempo.
In questo caso non sarebbe la via diplomatica quella scelta dalla Repubblica Islamica per guadagnare peso e potere nello scontro con l’Arabia Saudita, ma la via delle armi. Difficile immaginare che si possa arrivare a uno conflitto diretto tra i due Stati (a questo link si può esplorare la consistenza dei rispettivi apparati bellici http://militaryedge.org/#personnel). Più probabilmente proseguirebbe, e si intensificherebbe, lo “scontro mediato” nella faida tra sunniti e sciiti che già ora sta facendo centinaia di migliaia di vittime all’anno nei vari Stati in cui è esploso.
In Iraq l’Isis non avrebbe infatti potuto guadagnare il consenso e il potere che attualmente detiene se le tribù sunnite della provincia di Anvar non fossero state spinte tra le sue braccia dalle politiche esclusive e settarie del precedente premier sciita, Nuri al Maliki, che dopo il ritiro americano fece arrestare diversi leader della comunità sunnita (tra cui il Vicepresidente dell’Iraq, Hashemi). Specularmente l’attuale controffensiva di Baghdad si avvale in modo massiccio dell’aiuto delle truppe inviate dall’Iran e delle milizie sciite di Moqtada al Sadr. In Siria la riscossa del regime della primavera 2013 è figlia dell’intervento diretto delle altre forze sciite dell’area, in particolare le Brigate Al Quds iraniane e gli Hezbollah libanesi (a loro volta foraggiati e comandati da Teheran), e anche qui le fortune dell’Isis sono legate a doppio filo con l’isolamento che ha subito la comunità sunnita da quando si è sollevata contro il presidente alawita Bashar Assad. Anche dietro le violenze in Yemen – che potrebbero preludere allo scoppio di una guerra civile – ci sarebbe Teheran, pronta ad armare e finanziare la minoranza sciita degli Houthi, in rivolta contro il governo centrale di San’a’ e contro i gruppi sunniti affiliati ad Al Qaeda. Addirittura nel piccolo emirato del Bahrein c’è una pericolosa tensione tra la monarchia sunnita, supportata da Riad, e la popolazione sciita, fomentata da Teheran.
In questa situazione l’Iran si trova opportunisticamente schierato contro i “cattivi” per eccellenza dell’Isis. Ma il Califfato islamico è una contingenza di breve periodo e gli analisti temono soprattutto le possibili evoluzioni nel lungo. Si spiega anche così l’esitazione degli Stati Uniti in politica estera mediorientale: esiste il timore che nel quadro attuale l’Iran possa guadagnare troppo potere senza essere costretto a concedere nulla o quasi all’Occidente. «Anche in Siria gli Usa si trovano di fronte al problema di dover contrastare l’Isis senza poter aiutare esplicitamente il suo diretto avversario, cioè Assad», conclude Claudio Neri. «Con il rischio, inoltre, che tanto più l’Arabia Saudita si sente abbandonata dall’alleato americano, tanto più è storicamente generosa nel finanziare gruppi terroristi su cui ha già dimostrato in passato di non essere in grado di esercitare il controllo».
Inserendo il codice che hai trovato nel numero cartaceo del nuovo numero di eastwest puoi scaricare anche la versione digitale in PDF gratis









