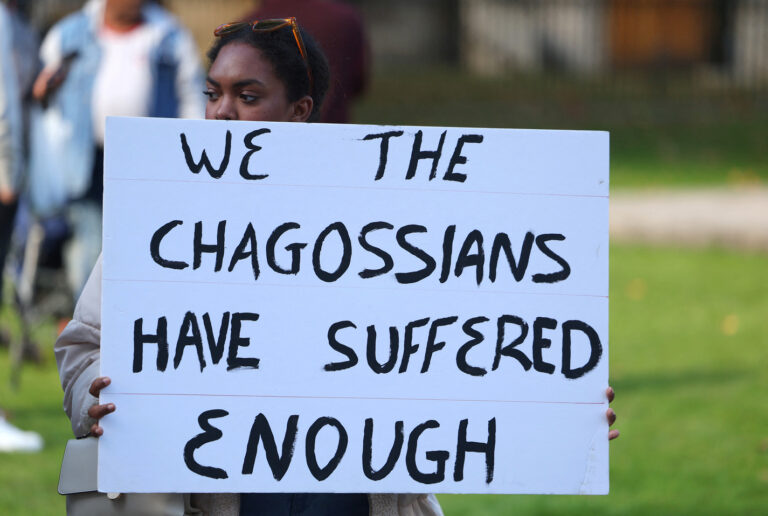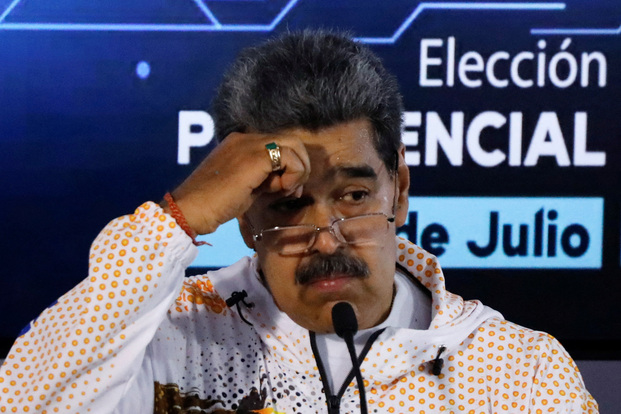[BUENOS AIRES] Giornalista e docente italo-argentino. Collabora con Limes, Il Manifesto e altri. Membro dell’Istituto di relazioni internazionali dell’Università Nazionale di La Plata. Il suo ultimo libro è “Liberlandia. Come l’estrema destra si è presa l’Argentina”, (People 2024)