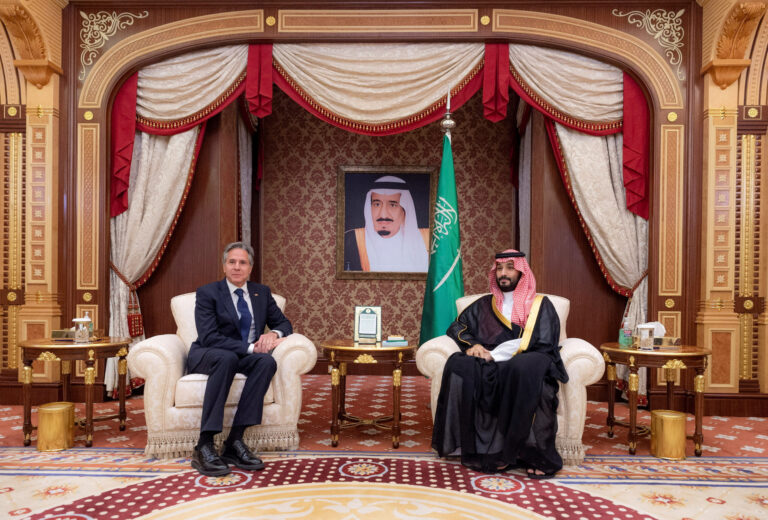[GERUSALEMME] Corrispondente per diverse testate, dopo 6 anni in India e 5 in Cina per Ansa. Autore e conduttore di Radio 3, è esperto di Asia e Medio Oriente.

[GERUSALEMME] Corrispondente per diverse testate, dopo 6 anni in India e 5 in Cina per Ansa. Autore e conduttore di Radio 3, è esperto di Asia e Medio Oriente.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Già a febbraio la Knesset aveva votato una risoluzione simile che però si riferiva alla creazione unilaterale dello stato palestinese. All’epoca molti stati, soprattutto europei, avevano cominciato a dichiarare il loro sostegno alla nascita unilaterale dello stato e promettevano che avrebbero riconosciuto lo stesso, pertanto la Knesset votò contro la possibilità che i Palestinesi creassero uno stato senza una fase di negoziato con Israele. Stavolta invece, si tratta di respingere del tutto l’idea della creazione dello stato palestinese, cosa che mette ancora di più Israele in un angolo.
Dopotutto, che nei Territori palestinesi ci sia una occupazione di fatto, è un dato notorio. Come pure che gli accordi di Oslo, che misero fine al conflitto e permisero la nascita dell’Autorità Nazionale Palestinese che avrebbe controllato i territori di area A nella divisione degli stessi con Israele, nel documento non c’è alcuna menzione alla nascita dello stato palestinese.
Anche perché uno degli aspetti fondamentali riguarda i confini dello stesso e la sua capitale. I Palestinesi insistono sul fatto che debbano essere quelli del 1969, cioè antecedenti alla Guerra dei Sei Giorni, e la capitale Gerusalemme. Questo non solo creerebbe problemi ad Israele, ma renderebbe nulle le conquiste ottenute nella guerra di giugno, con i territori che Israele ha conquistato da Giordania, Egitto, Siria, Libano e in parte restituiti con accordi di pace bilaterali.
La difficoltà di portare avanti un processo per la nascita del nuovo stato (anche se Arafat lo dichiarò nato nel 1988) è sia attribuita all’occupazione israeliana che alla incapacità o non volontà dello stesso governo dell’Anp, che ha molti problemi interni legati anche alle divisioni delle sue fazioni.
Non solo: per come sono i confini, il nuovo Stato palestinese si troverebbe ad essere una enclave all’interno di Israele senza confini se non quelli dello stato ebraico (a meno che non vengano ceduti territori ai confini con la Giordania, ipotesi molto difficile) e con l’unico eventuale sbocco diverso, quello di Gaza, anche marino, il cui destino però deve essere scritto non solo a causa della guerra, ma anche delle divisioni tra i Palestinesi. Niente confini, significa impossibilità di importare merci o beni o servizi senza essere gravati da tasse e dazi israeliani.
Non a caso, negli ultimi anni, anche in ambienti palestinesi o israeliani moderati, si è fatta avanti la possibilità della nascita di una nazione palestinese autonoma all’interno dello Stato d’Israele. Ipotesi avversata dai fondamentalisti di entrambi gli schieramenti che temono di essere soverchiati visti i ritmi di crescita per nascite delle comunità ortodosse e dei coloni e quelle dei musulmani.
“La creazione di uno Stato palestinese nel cuore della Terra d’Israele – si legge nel provvedimento – costituirebbe una minaccia esistenziale per lo Stato di Israele e i suoi cittadini, perpetuerebbe il conflitto israelo-palestinese e destabilizzerebbe la regione”. La risoluzione è stata presentata dal partito di destra all’opposizione New Hope-United Right, dell’ex delfino di Netanyahu Gideon Sa’ar, e ha visto il voto favorevole di tutti i partiti di destra al governo e all’opposizione, compreso il sostegno del partito Unità Nazionale dell’ex componente del gabinetto di Guerra Benny Gantz e dei suoi. Al momento del voto, i centristi di Yesh Atid del leader dell’opposizione Yair Lapid hanno lasciato l’aula per non sostenere il provvedimento, anche se Lapid si è sempre espresso a favore di una soluzione a due Stati. Contrari, nove parlamentari, tra laburisti e gli arabi di Ra’am e Hadash-Ta’al. “Sarà solo questione di breve tempo prima che Hamas prenda il controllo dello Stato palestinese e lo trasformi in una base terroristica islamica radicale, lavorando in coordinamento con l’asse guidato dall’Iran per eliminare lo Stato di Israele”, è scritto nella risoluzione. “Promuovere l’idea di uno Stato palestinese in questo momento sarà una ricompensa per il terrorismo e non farà altro che incoraggiare Hamas e i suoi sostenitori a vedere questo come una vittoria, grazie al massacro del 7 ottobre 2023, e un preludio alla presa del potere dell’Islam jihadista in Medio Oriente”.
Il voto, motivato quindi con timori che Hamas o altri fondamentalisti possano prendere il controllo del futuro stato palestinese ponendo una minaccia ad Israele, è stato espresso a pochi giorni dalla partenza di Netanyahu per Washington, dove incontrerà Biden (anche se ci sono timori, visto che il presidente è risultato positivo al Covid) e parlerà al Congresso. Questo voto, anche se non partito direttamente da Netanyahu, potrebbe ancora di più raffreddare i rapporti tra il governo israeliano e l’inquilino della Casa Bianca e il partito Democratico, che più volte si sono detti aperti alla nascita dello stato palestinese e alla soluzione a due stati per il conflitto israelo-palestinese.
Il voto della Knesset che si oppone alla nascita dello stato palestinese, come dicevamo, mette Israele ancora di più in isolamento, visto che la soluzione a due stati per la risoluzione del conflitto è ampiamente richiesta da pressoché tutti i paesi del mondo, anche se non tutti riconoscono la Palestina attualmente.
Sono 145 i paesi su 193 membri dell’Onu che lo fanno. I primi riconoscimenti sono avvenuti il quindici novembre del 1988, quando Yasser Arafat, allora leader dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina, dichiarò la nascita dello stato palestinese. Dallo stesso giorno e nei giorni seguenti, fino alla fine di novembre, furono 63 i paesi a riconoscere la Palestina. Tra i primi, Algeria, Indonesia, Libia e Turchia. Per il primo periodo furono per lo più paesi arabi, insieme alla Russia, Cuba, Serbia, India e Cina tra gli altri.
I primi europei furono, in quel mese di novembre, Cipro, Slovacchia, Bulgaria e Romania, che all’epoca non erano nell’Unione Europea. Anche il Vaticano riconosce la Palestina, mentre gli ultimi paesi ad averla riconosciuta sono Irlanda, Norvegia, Spagna, Slovenia e Armenia tra maggio e giugno scorsi. Tra i paesi che non riconoscono la Palestina, ci sono Germania, Francia e Italia, il Regno Unito, gli Stati Uniti, il Canada e l’Australia.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Il conflitto di Gaza ha visto emergere nuovi attori nella ricerca di una soluzione diplomatica, risultato del cambiamento significativo nella geopolitica del Medio Oriente, con l’asse delle influenze che si sta spostando. Le potenze regionali stanno assumendo un ruolo sempre più importante, con l’Arabia Saudita e l’Egitto che cercano di contrastare l’influenza del Qatar nella regione. Inoltre, la Cina sta emergendo come una potenza asiatica sempre più influente, aumentando il proprio coinvolgimento nella regione. Lo spostamento dell’asse delle influenze ha anche portato ad un declino dell’influenza occidentale nella regione, con gli Stati Uniti che stanno riducendo il loro coinvolgimento e lasciando spazio per altre potenze regionali ed extra-regionali.
La fine del dominio degli Stati Uniti sulla politica del Medio Oriente ha segnato un cambiamento significativo nel panorama geopolitico della regione. Dopo decenni di influenza e intervento statunitense, si sono ora manifestati nuovi attori e mediatori emergenti che cercano di riempire il vuoto lasciato dalla diminuzione del potere americano. Questo cambiamento è stato innescato da una serie di fattori, tra cui la percezione crescente di un coinvolgimento eccessivo degli Stati Uniti nella regione e la conseguente reazione dei paesi mediorientali che hanno iniziato a cercare alternative.
L’approccio unilaterale degli Stati Uniti e la loro politica estera spesso controversa hanno contribuito a minare la loro influenza nella regione. Inoltre, le conseguenze delle guerre in Iraq e in Afghanistan hanno indebolito l’immagine degli Stati Uniti come forza stabilizzatrice e hanno portato a una maggiore diffidenza verso il loro coinvolgimento nella politica del Medio Oriente. In risposta a ciò, stati come i Paesi del Golfo Persico, la Turchia e la Cina stanno emergendo come nuovi attori che cercano di influenzare gli sviluppi politici ed economici nella regione, affiancandosi a paesi come Russia e Iran che hanno sempre giocato un ruolo predominante nell’area, anche attraverso il sostegno a gruppi e operazioni non propriamente democratici e pacifisti. Questo nuovo equilibrio di potere potrebbe portare a cambiamenti significativi nel futuro della politica del Medio Oriente, con possibili implicazioni per la stabilità e la sicurezza della regione.
Tra gli attori più rilevanti c’è senza dubbio la Turchia, che si è proposta come mediatore tra Israele e Hamas. Questo ruolo di mediazione turca è stato favorito dalle relazioni che Ankara ha con entrambe le parti in causa, nonché dalla sua posizione geografica strategica nel Mediterraneo orientale. La Turchia ha con Israele un rapporto burrascoso, giocano al gatto con il topo, ma è indubbia la sua influenza e, soprattutto, i suoi interessi nell’area, sia sotto l’aspetto economico che politico. Il Paese ha una posizione geografica strategica, che lo rende un ponte tra l’Europa e l’Asia e la sua forte economia e un esercito ben equipaggiato, le permettono di giocare un ruolo di primo piano nella regione. La politica estera turca si è orientata verso una maggiore indipendenza dagli Stati Uniti e verso una maggiore cooperazione con i paesi del Golfo Persico, in particolare l’Arabia Saudita e il Qatar.
La Turchia ha anche migliorato le relazioni con la Russia, che rappresenta un altro importante attore nella regione. Il presidente turco Erdogan ha inoltre svolto un ruolo attivo nella crisi siriana, sostenendo i ribelli anti-Assad e offrendo rifugio ai profughi siriani. Tuttavia, la politica estera turca ha anche suscitato preoccupazioni tra alcuni Paesi della regione, in particolare Israele e l’Egitto, che vedono la Turchia come una minaccia alla loro sicurezza nazionale. Inoltre, le recenti tensioni tra la Turchia e gli Stati Uniti a causa dell’acquisto di armi russe da parte turca, hanno messo in dubbio la stabilità delle relazioni tra i due Paesi.
Nonostante le sue dimensioni ridotte, il Qatar ha dimostrato una notevole capacità nel promuovere i propri interessi e nel mediare tra le parti coinvolte nel conflitto di Gaza. Il paese ha svolto un ruolo significativo nell’offrire assistenza umanitaria e finanziaria alla popolazione palestinese, contribuendo a lenire le sofferenze causate dalla guerra, ma anche al rilascio degli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas, che sostiene politicamente ed economicamente. Questo ha creato tensioni con altri attori regionali, come l’Arabia Saudita e l’Egitto, che considerano Hamas una minaccia per la stabilità della regione. Nonostante ciò, il Qatar ha continuato a sostenere Hamas, sfruttando la sua influenza economica e diplomatica per rafforzare la posizione del movimento.
L’emergere del Qatar come nuovo attore nella geopolitica del Medio Oriente rappresenta una sfida per le potenze regionali tradizionali e per l’influenza occidentale nella regione. Il paese sta cercando di costruire relazioni con altri attori emergenti, come la Cina, che sta rapidamente guadagnando potere ed espandendo la sua influenza nel Medio Oriente. Questa nuova dinamica geopolitica ha implicazioni significative per la stabilità e la sicurezza della regione, poiché i tradizionali equilibri di potere vengono messi in discussione.
L’ascesa della Cina ha avuto un impatto significativo sulla situazione in Medio Oriente proponendosi come mediatrice nel conflitto israelo-palestinese. Non solo ha mantenuto relazioni diplomatiche con entrambe le parti (seppur più spostate verso la Palestina, per l’opposizione soprattutto americana ad un ingresso cinese in Israele), ma ha anche proposto un piano di pace alternativo all’iniziativa degli Stati Uniti. Inoltre, la Cina ha aumentato la sua presenza economica nella regione, diventando uno dei principali partner commerciali di molti paesi del Medio Oriente. Questo ha portato ad una maggiore influenza politica e strategica cinese nella regione, che può essere vista come una sfida alla tradizionale egemonia occidentale. E’ indubbio che l’ascesa cinese non è per pura filantropia, ma riguarda sicuramente il raggiungimento dei propri obiettivi economici e politici, come lo scambio commerciale e il trasporto di merci, visto che la rotta mediorientale è una delle più rapide verso l’Europa, senza considerare la ricchezza di risorse, cosa che ha già spinto ingenti investimenti cinesi in Africa.
Negli ultimi anni, si è assistito a un crescente aumento dell’influenza dei Paesi del Golfo Persico nella politica del Medio Oriente. Paesi come l’Arabia Saudita, il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti hanno giocato un ruolo sempre più rilevante nella regione, sia dal punto di vista politico che economico. Questi paesi hanno sfruttato la loro ricchezza derivante dalla produzione di petrolio per esercitare una maggiore influenza sugli affari regionali. Ad esempio, l’Arabia Saudita ha giocato un ruolo chiave nella formazione della coalizione araba che ha combattuto contro i ribelli Houthi nello Yemen. Inoltre, i Paesi del Golfo hanno anche sostenuto finanziariamente diversi gruppi ribelli in Siria, cercando di influenzare l’esito della guerra civile in corso.
L’influenza dei Paesi del Golfo Persico non si limita solo alla politica e al conflitto armato, ma si estende anche all’economia e alla cultura. Gli investimenti dei paesi del Golfo in settori come l’energia, l’edilizia e il turismo hanno contribuito a stimolare la crescita economica nella regione. Allo stesso tempo, questi paesi hanno promosso la loro visione conservatrice dell’Islam attraverso il sostegno finanziario a istituzioni religiose e la diffusione dei media, sollevando interrogativi sulle implicazioni a lungo termine per la stabilità e l’equilibrio della regione.
Arabia Saudita ed Egitto, con le loro visioni politiche e religiose, oltre che alleanze opposte nella regione, rivendicano e fanno pesare non solo la loro influenza, ma soprattutto il loro peso politico nella soluzione del conflitto, derivante da anni di coinvolgimento e sostegno. Inoltre, l’Arabia sarebbe anche pronta ad allacciare i rapporti con Israele, in cambio dello stato palestinese, cosa che, ovviamente, metterebbe Riad in cima ai protettori di Ramallah, nonostante la “pugnalata nella schiena” per l’amicizia con gli israeliani.
Negli ultimi anni, si è assistito a un declino dell’influenza occidentale nella geopolitica del Medio Oriente. Questo è dovuto principalmente alla crescente disillusione dei paesi della regione verso l’Occidente, che spesso è visto come un attore esterno che interferisce con gli affari interni dei paesi del Medio Oriente. Inoltre, la mancanza di una politica estera coerente da parte degli Stati Uniti e dell’Unione Europea ha portato a un indebolimento del loro ruolo di mediatori nei conflitti regionali.
Il nuovo corso americano post Trump ha spostato l’interesse geopolitico verso il Pacifico, lasciando in Medioriente gli spazi ai russi e cinesi.
Tuttavia, il declino dell’influenza occidentale non significa necessariamente una maggiore stabilità nella regione. Il cambiamento di paradigma geopolitico ha portato ad una frammentazione politica e sociale sempre più evidente, con nuovi attori che cercano di promuovere i propri interessi a scapito della stabilità regionale. Questo scenario complesso e mutevole rende ancora più difficile trovare una soluzione duratura al conflitto di Gaza e agli altri problemi che affliggono il Medio Oriente.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
L’ascesa dei Paesi del Golfo come attori di rilievo nella scena internazionale è un fenomeno che spesso è stato sottovalutato e mal compreso, soprattutto in ambito europeo. Questo nonostante la nuova visione strategica adottata da questi Paesi, che hanno abbracciato la multipolarità come pilastro della loro politica estera.
La nuova visione dei Paesi del Golfo si basa sulla strategia della costruzione di relazioni bilaterali con diversi attori internazionali per diversificare le fonti di sostentamento economico e politico, permettendo loro di allontanarsi dalla dipendenza dagli Stati Uniti e dall’Europa, aprendo nuove opportunità di cooperazione con paesi come la Cina, l’India e la Russia. La multipolarità è stata adottata anche come strategia per contrastare l’influenza iraniana nella regione, cercando di creare un equilibrio tra i diversi attori regionali e internazionali. Inoltre, la multipolarità ha permesso ai Paesi del Golfo di rafforzare la loro posizione negoziale nei confronti degli altri paesi, siano essi vicini o lontani.
Nonostante ciò, la strategia della multipolarità presenta alcune criticità, come la possibilità di creare squilibri nella distribuzione del potere e di favorire l’emergere di alleanze instabili. Vedi infatti il ritorno dell’Iran in questo contesto, che sicuramente rappresenta, in particolare in questo preciso momento storico, una fonte di disturbo nelle relazioni con l’Occidente. Tuttavia, la nuova visione dei Paesi del Golfo sembra puntare su una maggiore flessibilità e adattabilità alle mutevoli dinamiche globali, cercando di rimanere al passo con le nuove sfide che il mondo sta affrontando.
La politica estera multilaterale adottata dai paesi del Golfo ha giocato un ruolo cruciale nel loro successo regionale e internazionale. Uno dei principali vantaggi di questa politica estera è stato il consolidamento delle relazioni economiche, con numerosi investimenti in patria e all’estero, diventando attori importanti e globali sul panorama economico e politico. La chiave di accesso è sempre rappresentata dalle partnership strategiche in settori come l’energia e la finanza.
I leader del Golfo hanno svolto un ruolo di mediazione in conflitti regionali, promuovendo il dialogo e la diplomazia come strumenti per risolvere le tensioni. La loro partecipazione attiva in organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite e l’Organizzazione per la Cooperazione Islamica ha permesso loro di influenzare l’agenda globale e difendere i propri interessi. Anche l’utilizzo di strumenti di “soft power”, come l’organizzazione e l’ospitalità di eventi sportivi o sociali mondiali, per l’assegnazione dei quali questi paesi hanno investito somme impossibili ad altri, va verso questo indirizzo, influenzando di fatto le scelte e gli orientamenti.
I Paesi del Golfo hanno costruito le loro economie sulla vendita di petrolio e gas naturale, ma stanno ora attraversando un periodo di trasformazione economica significativa anche verso manifattura e turismo, cercando così di diversificare i loro settori produttivi per evitare la dipendenza dalle risorse energetiche. Tuttavia, queste nuove opportunità spesso vengono sottovalutate o ignorate dall’Europa, che tende a focalizzarsi solo sulle risorse energetiche della regione.
Alcuni Paesi del Golfo, come gli Emirati Arabi Uniti, hanno già fatto grandi progressi nel settore manifatturiero, specializzandosi in prodotti come l’elettronica, i prodotti chimici e l’aerospaziale. Ma ci sono ancora sfide da affrontare, come la necessità di formare una forza lavoro altamente qualificata e di promuovere la ricerca e lo sviluppo tecnologico.
L’incomprensione europea nei confronti dei paesi del Golfo è spesso alimentata da una serie di fattori, tra cui l’applicazione di doppi e tripli standard e la competizione interna tra gli Stati membri. Mentre l’Europa predica valori come la democrazia e i diritti umani, spesso sembra applicare tali principi in modo selettivo. Questo doppio standard si riflette nella politica estera europea verso i paesi del Golfo, dove le critiche vengono spesso rivolte solo a determinate nazioni, mentre altre vengono ignorate o trattate con indulgenza. Inoltre, la competizione interna tra gli Stati membri dell’Unione Europea può contribuire all’incomprensione e alla sottovalutazione dei paesi del Golfo. Ogni paese europeo cerca di promuovere i propri interessi economici e politici nella regione, spesso a scapito di una visione comune e coesa.
La politica internazionale dei paesi del Golfo è stata oggetto di molte discussioni e analisi negli ultimi anni, in particolare la visione saudita ha suscitato l’attenzione degli esperti. La politica estera della monarchia saudita si basa su una serie di principi, tra cui la difesa dei valori islamici, la promozione della stabilità regionale e la lotta contro il terrorismo. Non è da dimenticare che la politica saudita abbia anche effetti negativi sulla regione e sul mondo intero, come ad esempio il sostegno a gruppi estremisti e l’intervento militare nello Yemen. La recente crisi diplomatica con il Qatar ha evidenziato le tensioni all’interno della regione del Golfo.
Nonostante ciò, la politica internazionale della monarchia saudita continua ad avere un impatto significativo sulla regione e oltre. Il sostegno economico e politico fornito dalla monarchia saudita ai paesi arabi circostanti ha contribuito alla creazione di una rete di alleanze strategiche, anche se pare più votata ad interessi egoistici piuttosto che alla promozione del benessere regionale.
L’incomprensione delle politiche estere dei Paesi del Golfo ha portato a una mancanza di collaborazione con l’Occidente su questioni importanti come la sicurezza regionale e la lotta al terrorismo. I Paesi del Golfo, guidati principalmente dalla monarchia Saudita, hanno cercato di promuovere la loro idea politica nella regione attraverso vari mezzi, come finanziamenti e supporto politico a movimenti e governi che sostengono i loro interessi. Tuttavia, questa strategia solleva interrogativi sulla sincerità delle intenzioni dei Paesi del Golfo nel promuovere la democrazia, considerando le critiche che spesso ricevono per le loro stesse pratiche interne. La mancanza di trasparenza e accountability all’interno dei Paesi del Golfo solleva dubbi sulla loro reale volontà di adottare principi democratici.
Negli ultimi decenni, le relazioni tra l’Europa e i Paesi del Golfo hanno subito una serie di incomprensioni che hanno portato a un distanziamento reciproco. Questo fenomeno può essere attribuito a diversi motivi politici ed economici, che hanno contribuito a creare un clima di sfiducia e disinteresse tra le due parti.
Una delle ragioni principali per cui l’Europa non ha capito le nuove politiche dei Paesi del Golfo è stata la mancanza di conoscenza e comprensione delle dinamiche interne di queste nazioni. Spesso, l’Europa ha guardato a questi paesi attraverso una lente occidentale, senza tener conto delle loro specificità culturali, politiche ed economiche. Di conseguenza, le politiche e le scelte dei Paesi del Golfo sono state percepite come “strane” o “incomprensibili” dagli europei, che hanno preferito snobbare tali nazioni anziché cercare di capirle.
Inoltre, le differenze politiche tra l’Europa e i Paesi del Golfo hanno contribuito a creare ulteriori incomprensioni. Mentre l’Europa si basa su principi democratici e sulla difesa dei diritti umani, molti Paesi del Golfo hanno un sistema politico autoritario e limitazioni significative in materia di diritti umani. Questa differenza di valori ha reso difficile per l’Europa comprendere e accettare le scelte politiche dei Paesi del Golfo, portando a un’ulteriore distanza tra le due parti.
Dal punto di vista economico, il petrolio ha svolto un ruolo centrale nelle dinamiche tra Europa e Paesi del Golfo. L’economia dei Paesi del Golfo è fortemente dipendente dai ricavi petroliferi, che hanno consentito loro di accumulare ingenti riserve finanziarie. Al contrario, l’Europa ha cercato di diversificare la sua economia e di ridurre la dipendenza dal petrolio. Questa differenza di interessi economici ha portato a una mancanza di interesse reciproco, da qui la scelta dei paesi del Golfo di guardare a quelle realtà, come India e Cina che, rappresentando ancora le “fabbriche del mondo”, basano la loro economia sull’utilizzo di una buona percentuale di carburanti fossili.
Infine, la politica internazionale ha giocato un ruolo significativo nelle incomprensioni tra Europa e Paesi del Golfo. Mentre l’Europa ha cercato di svolgere un ruolo attivo nella risoluzione dei conflitti regionali e di promuovere la democrazia, molti Paesi del Golfo hanno preferito un approccio più conservatore e pragmatista. Questa differenza di approcci ha creato tensioni e incomprensioni tra le due parti, impedendo una cooperazione più stretta.
L’Arabia Saudita ha lanciato il programma Vision 2030, con investimenti miliardari, che mira a diversificare l’economia del paese attraverso investimenti in nuovi settori come il turismo, l’energia rinnovabile e la tecnologia dell’informazione. Ciò non solo aiuterà a creare nuovi posti di lavoro e a ridurre la dipendenza dal petrolio (che rappresenta ancora la maggioranza delle entrate), ma anche a migliorare la qualità della vita per i cittadini sauditi.
La ‘Vision’ è una visione a lungo termine per lo sviluppo economico e sociale, che si concentra sull’innovazione tecnologica e sull’investimento nella formazione e nell’istruzione. L’Occidente ha spesso guardato con sospetto questa visione, considerandola come un modo per nascondere i problemi sociali e politici dell’area, anche se rappresenta una grande opportunità per questi paesi di superare le sfide del futuro. Opportunità che l’Europa non deve lasciarsi scappare, bilanciando politiche di cooperazione con la necessità di salvaguardare ambiente e diritti umani.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
L’Iran ha scelto: Masoud Pezeshkian è il nono presidente della repubblica islamica. Ha vinto la tornata di ballottaggio con il 53,3% dei voti con tre milioni di voti in più (16,3 contro 13,5 milioni) rispetto all’altro candidato, il conservatore Saeed Jalil, che ha avuto il 44,3% dei consensi. A votare, il 49,8% degli oltre 61 milioni di elettori.
Pochi quelli che hanno votato, anche se maggiore di dieci punti percentuali rispetto a coloro che avevano votato al primo turno il 28 giugno, quando si è registrato il risultato più basso della storia repubblicana. Manifestazioni di giubilo si sono registrate per le strade di Teheran e di altre città. Video che sui social si sono alternati e hanno sostituito le immagini dei seggi vuoti e gli appelli, soprattutto di giovani, a non votare, utilizzando l’hashtag “minoranza traditrice”.
Che gli iraniani non abbiano avuto voglia di votare, che ci sia disaffezione rispetto al regime degli Ayatollah, soprattutto per quello che riguarda la condizione economica e quella dei diritti civili, è un fatto. Come quello che il riformismo che si riferisce al neo presidente sia più di facciata che di altro, in una tornata elettorale comunque decisa e gestita dai leader sciiti, in un regime che non mostra segni di cambiamento.
Dopotutto, Pezeshkian non è così lontano dalle idee di chi, l’Ayatollah Ali Khamenei, davvero decide le sorti del paese. Che, con la sua influenza, ha deciso chi si poteva candidare o no. Lo stesso neo presidente ci ha provato due volte. Il presidente in Iran ha un ruolo minoritario rispetto a quello del leader religioso, che gestisce e decide tutto. Ma serve, il nuovo presidente ”riformista”, per dare una immagine diversa del paese soprattutto all’estero, paventando aperture che siano destinate soprattutto all’alleggerimento delle sanzioni che hanno portato ad una disastrosa situazione economica.
Il neo presidente non è un neofita della politica. Cardiochirurgo sessantanovenne, è deputato al Parlamento dal 2008, del quale è stato anche vicepresidente. È stato per molto tempo membro della commissione sanitaria del parlamento iraniano e ministro della sanità all’inizio degli anni 2000 sotto l’ex presidente Mohammad Khatami. È vicino alle posizioni dell’ex presidente Rouhani, e ha cercato di raccogliere il voto dei moderati, dei riformisti ma soprattutto dei molti giovani che protestano da anni nel paese. “Se indossare certi vestiti è un peccato, il comportamento nei confronti delle donne e delle ragazze è 100 volte più grave. Da nessuna parte nella religione è consentito affrontare qualcuno a causa dei suoi vestiti”, ha detto, criticando apertamente i metodi brutali portati avanti dalle autorità religiose intransigenti, attraverso la polizia morale, che hanno portato ad arresti, percosse e alla morte di Mahsa Amini, nel settembre di due anni fa, mentre era in custodia della polizia. Lo stesso Rouhani, parlando dopo le elezioni, aveva annunciato aperture verso una società iraniana più inclusiva delle donne e nei suoi due mandati mostrò qualche piccolo segno di apertura in tal senso.
Pezeshkian ha annunciato di voler favorire la crescita economica in stallo anche a causa delle sanzioni internazionali; mentre ha promesso di aprire di più l’Iran al mondo, soprattutto occidentale e di ascoltare le istanze di tutti, con riferimento alle minoranze (egli stesso appartiene alla minoranza azera), alle proteste in particolare dei giovani contro le azioni della polizia morale, Pezeshkian nella sua campagna elettorale non ha promesso cambiamenti radicali rispetto allo stile di vita imposto dalla teocrazia sciita iraniana e ha riconosciuto l’autorità suprema dell’Ayatollah Ali Khamenei, l’arbitro finale di tutte le questioni di stato nel paese. Difficile quindi che si possa vedere un Iran diverso.
Contro, nel ballottaggio, si è trovato Saeed Jalili, ex segretario del Consiglio supremo di sicurezza nazionale del quale fa parte e negoziatore nucleare sotto l’ex presidente intransigente Mahmoud Ahmadinejad. Jalili aveva promesso di ridurre l’inflazione a una sola cifra e di stimolare la crescita economica almeno all’8%, oltre a combattere la corruzione e la cattiva gestione. Sostiene una posizione più dura contro l’Occidente e i suoi alleati. Jalili, conosciuto come intransigente in ambienti diplomatici dopo i suoi discorsi nei negoziati per il nucleare, e chiamato “il martire vivente”, per aver perso una gamba nella guerra con l’Iraq, avrebbe, secondo molti analisti, probabilmente vinto se il voto dei religiosi e conservatori non si fosse diviso per tre candidati nella prima fase elettorale.
Tra l’altro, la vittoria di Pezeshkian ai danni di Jalili non è stata schiacciante e questo fa si che il regime, l’intransigenza, il clero, non perdano potere o influenza, anche su questioni importanti come i rapporti con gli Usa, la guerra tra Israele (verso il quale Pezeshkian ha detto di non voler fare aperture) e Hamas (gruppo sostenuto dall’Iran, come Hezbollah, gli Houthi e gli altri coinvolti) o sull’arricchimento dell’uranio a livelli prossimi a quelli di un’arma militare.
Se in molti ricordano le critiche che ha espresso il neo presidente in occasione delle diverse repressioni, nessuno dimentica che è stato tra i fautori dell’hijab obbligatorio tanto da guidare, ai tempi dell’università, gruppi di studenti che attaccavano le ragazze che non rispettavano i costumi. Se ha promesso aperture verso l’Occidente, dall’altro lato ha indossato con orgoglio la divisa delle Guardie rivoluzionarie lodandole quando hanno abbattuto un drone americano.
Per molti, la sua candidatura, visto anche il suo spessore politico non di primo piano, sarebbe una mossa di Khamenei per avere un candidato ”riformista” di facciata, in particolare per l’estero. La differenza notevole con Jalili è una cartina di tornasole di questa idea. Non a caso Pezeshkian ha preso come consigliere quel Javad Zarif che, come ministro degli Esteri di Rouhani, fu artefice di un riavvicinamento con gli Usa.
Non solo: il presidente avrà un importante peso nella scelta del successore dell’ottuagenario Ayatollah, che spera che il suo secondogenito Mojtaba possa prendere il suo posto.
La tornata presidenziale è stata convocata dopo che il 19 maggio un elicottero che trasportava il presidente Ebrahim Raisi e altri sette alti esponenti dell’establishment iraniano, tra i quali il ministro degli Esteri Hossein Amir-Abdollahian, è caduto, pare causa maltempo, nei pressi del villaggio di Uzi, vicino al confine con l’Azerbaijan, da dove il velivolo volava in direzione di Tabriz.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Incombe sempre di più il rischio dello scoppio di una guerra tra Israele e il Libano, per l’offensiva di Hezbollah. Il confine tra i due paesi è caldissimo. Dallo scoppio della guerra a Gaza, la milizia sciita del paese dei cedri, sostenuta da Teheran, non ha mai smesso di colpire Israele dalle sue basi libanesi e siriane che, in risposta, ha messo nel mirino basi del gruppo in tutti i paesi limitrofi e responsabili.
Israele si è spinto fino a Beirut, dove ha ucciso un alto esponente di Hamas, ma ha portato attacchi soprattutto nella regione di Baalbek. Di contro, il movimento sciita risponde con continue raffiche di missili inviati verso Israele, in particolare verso la regione della Galilea, anche con l’uso di droni. Due di questi, il mese scorso, uccisero un militare italo-israeliano.
L’allerta è massima e c’è chi dice che, di fatto, la guerra tra il paese ebraico e quello dei cedri è già in corso. Il timore tuttavia resta quello di un’escalation sempre maggiore che possa ampliare il conflitto a livello regionale. L’attacco potrebbe essere imminente tanto più dopo che l’esercito israeliano ha fatto sapere che i piani operativi sono stati già approvati.
Non è dunque da escludere che Israele possa cominciare a breve a spostare sempre più sue truppe a nord in previsione di un conflitto più esteso e strutturato. Ma quello che in molti si chiedono è se per Israele sia sostenibile gestire in contemporanea due fronti, quello con il Libano e quello, ancora apertissimo, con Gaza, oltre al fatto che Hezbollah conta su molti più armamenti di Hamas.
L’ipotesi della fine della guerra con il gruppo di Gaza appare molto lontana. Nessun accordo è stato raggiunto, senza contare che il premier Netanyahu ha ribadito, per l’ennesima volta, che senza aver riportato a casa tutti gli ostaggi (vivi o morti che siano) e distrutto Hamas, a casa non si va.
Intanto però le intenzioni di Hezbollah appaiono particolarmente bellicose. Il suo capo, Hassan Nasrallah, ha dichiarato che “nessun luogo in Israele sarà risparmiato in caso di guerra totale” e ha minacciato anche Cipro se aprirà i suoi aeroporti a Israele. “Aprire gli aeroporti e le basi cipriote al nemico israeliano per colpire il Libano significherebbe che il governo cipriota è parte della guerra e la resistenza lo affronterà come parte della guerra”, ha minacciato il leader sciita. Israele deve aspettarsi “di vederci per terra, per mare e per aria”, ha detto.
Minacce reciproche, se si pensa che poco prima era stato il ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz, a dichiarare che in caso di guerra, Hezbollah sarebbe stato distrutto totalmente.
La guerra, però, non è nel mirino di nessuno. Ognuno degli attori in gioco sa che la posta è molto alta, anche in considerazione del fatto che gli stessi Usa potrebbero entrare in gioco se l’Iran si facesse sentire o l’Unione Europea e di nuovo gli americani, in caso di un attacco a Cipro come minacciato da Hezbollah. E’ più probabile che si continui con la ”bassa intensità” o attacchi mirati per tenere alta la tensione.
L’ipotesi di una guerra tra Israele ed Hezbollah preoccupa non poco gli Stati Uniti che hanno mandato un loro inviato, Amos Hochstein (lo stesso che già nel 2002 era intervenuto in una mediazione sui confini marittimi tra Israele e Libano) nella regione. Hochstein, che si è recato prima in Israele per poi spostarsi in Libano, ha cercato di far passare, per entrambi i paesi, un messaggio chiaro, circa la necessità di non andare oltre e anzi di compiere una de-escalation. Sembra anche, secondo quanto riportano alcune fonti di stampa, che Hochstein avrebbe informato il Libano della opportunità di una soluzione diplomatica in quanto Israele potrebbe lanciare un attacco limitato e mirato anche con l’appoggio degli Stati Uniti.
Il messaggio è: “Non fare nulla nel Nord – ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato americano, Matthew Miller – non vogliamo affatto vedere un’escalation nel Nord, lo abbiamo chiarito direttamente al governo israeliano”.
Hezbollah intanto nei giorni scorsi ha pubblicato un video di circa 10 minuti preso da uno dei suoi droni da ricognizione che sorvolavano il nord di Israele, compreso il porto di Haifa. Una chiara minaccia contro il paese ebraico.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Benjamin Netanyahu, il premier più longevo della storia d’Israele, è in un angolo. Da vecchio pugile, incassa da tutti: la guerra con Hamas non sta portando i risultati sperati; le famiglie degli ostaggi lo accusano di perseguire propri interessi e non la liberazione degli ostaggi a Gaza; il presidente Biden lo tiene quanto più a distanza possibile; riceve critiche da tutto il mondo; il procuratore della Corte penale ha chiesto per lui l’arresto; alcuni membri del suo gabinetto di guerra lo avversano apertamente; nella politica israeliana sono ben due i tentativi di porre fine alla sua premiership che, dato il disastro del 7 ottobre, significa fine della sua vita politica.
Il fronte interno non deve essere sottovalutato, soprattutto le critiche dall’interno del suo gabinetto di guerra. Yoav Gallant, il ministro della difesa e destinatario come Netanyahu della richiesta di arresto da parte della Cpi, è dello stesso partito del premier. Ma questo non gli ha impedito di essere uno dei più critici nei confronti del primo ministro.
Non da ora. A marzo dell’anno scorso, il paese era attraversato da proteste per la riforma sulla giustizia fortemente voluta da Netanyahu. Il quale annunciò il licenziamento del capo della difesa, “colpevole” di averlo avvertito che il suo piano di riforma della giustizia (che mira a ridimensionare i poteri della magistratura) stava iniziando a rappresentare una minaccia diretta alla sicurezza di Israele.
Con un numero crescente di riservisti che avvertivano che non avrebbero prestato servizio nell’esercito di un paese che non era più da considerarsi democratico, Gallant aveva esortato Netanyahu a mettere quantomeno in stand by la riforma almeno fino alla festa nazionale del 26 aprile, dopo la pasqua ebraica, e a convocare il gabinetto di sicurezza. Un consiglio che non solo Netanyahu ha scelto di non seguire ma che lo spinse a mandare via Gallant dal Governo. Per poi farlo rientrare.
Il 7 ottobre sembrava aver sancito la pace tra i due. Ma Gallant qualche settimana fa ha criticato Netanyahu per la mancanza di un piano post Hamas a Gaza, soprattutto per la paventata presenza nella Striscia dell’esercito, ipotesi verso la quale il ministro della difesa è contrario. E non ha fatto nulla per nascondere la propria opposizione e irritazione.
L’altro ex generale e ministro della difesa, Benny Gantz, è entrato nel gabinetto di guerra, pur se in passato ha subito un forte torto da Netanyahu. Si era alleato con lui e gli accordi erano che fossero primo ministro a turno; ma quando è arrivato il momento di Gantz, Netanyahu lo ha estromesso. E’ entrato nel gabinetto di guerra per rispetto al paese, mentre gli altri dell’opposizione, come Yair Lapid, si sono rifiutati.
Questo però non gli ha impedito di essere critico nei confronti di Netanyahu. Anzi: qualche giorno fa, considerando la pochezza di visione del premier, che non ha un piano né per la guerra (il solo “distruggeremo Hamas”, non basta più) né per il dopo, ha annunciato che, persistendo l’assenza, l’8 giugno lascia l’esecutivo. Critiche al gabinetto anche dall’altro generale, Gabi Eisenkot, membro dello stesso partito di Ganzt, che a Gaza ha perso un figlio nei combattimenti.
Nel frattempo, il loro partito ‘Unità Nazionale’ ha presentato una proposta di legge per sciogliere il Parlamento israeliano e indire elezioni anticipate entro il mese di ottobre, a un anno dalla strage del 7 ottobre. Il partito non ha la maggioranza per sciogliere la Knesset, poiché la coalizione Netanyahu ha i numeri per continuare con il suo governo. Tuttavia, scrive Haaretz, ciò indica la grande spaccatura nella coalizione.
Per aggiungere altra carne al fuoco, tre membri dell’opposizione (il leader centrista Yair Lapid, il capo del partito russofono Avigdor Liberman e l’ex delfino di Netanyahu Gideon Sa’ar), si sono riuniti e hanno sottoscritto un patto per presentare un governo di alternativa a quello Netanyahu. Neanche loro hanno voti e numeri per sovvertire Bibi, ma questa è la cartina di tornasole del difficile momento politico del premier israeliano.
Che è anche oggetto delle feroci critiche di una parte dei familiari degli ostaggi detenuti a Gaza, i quali vorrebbero un accordo ad ogni costo. Netanyahu invece non vuole mettere a repentaglio la sicurezza nazionale, per cui non accetterà di ritirare le truppe.
Il consigliere israeliano per la sicurezza nazionale, Hanegbi, molto vicino a Netanyahu, parlando con le famiglie degli ostaggi ha ribadito che il governo non accetterà di finire la guerra in cambio del rilascio degli ostaggi, perché ne va della sicurezza del paese.
E così aumenta la distanza tra i familiari degli ostaggi e il governo israeliano colpevole quest’ultimo, secondo i primi, di aver deciso di sacrificare i loro cari. Le manifestazioni anti Netanyahu sono continue.
Ed è certo questo, un monito importante per Bibi, anche se nell’ultimo sondaggio è ritornato in testa alle preferenze come premier, scavalcando Gantz che, forse, paga l’ultimatum. Confusione, incertezze, veti e colpi incrociati che, in un momento difficile come questo, certo non aiutano la gestione della guerra e del paese.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Con l’inizio dell’operazione dell’esercito israeliano a Rafah, anche se i militari parlano di una azione “limitata”, i rapporti di Israele con gran parte del mondo occidentale si sono deteriorati, per la preoccupazione sulla sorte delle centinaia di migliaia di rifugiati che nella città meridionale della Striscia da mesi sono ospitati. Ma l’occupazione del valico della stessa città, porta d’ingresso e uscita da e verso l’Egitto, ha messo in dubbio una pace che regna, seppur “fredda” da decenni. Una pace che l’Egitto ha minacciato di rompere, cancellando il trattato sottoscritto nel 1979, il primo del paese ebraico con uno arabo, e richiamando l’ambasciatore da Tel Aviv.
Per il Cairo, l’occupazione del valico e l’operazione a Rafah sono limiti invalicabili. Gli egiziani hanno anche rifiutato l’offerta israeliana di gestire la via d’accesso alla Striscia dall’altro lato dell’Egitto. Spetta ai palestinesi, hanno detto, ma Israele non vuole lasciare la cosa in mano ad Hamas. Per cui pensa ad una società privata americana.
Il confine tra i due paesi, seppur in pace, è militarizzato. Questo perché, non è un mistero, il Sinai egiziano è lungi dall’essere sotto il controllo diretto dell’esercito e delle autorità centrali del Cairo. Bande di beduini controllano i traffici, soprattutto illeciti della zona. E’ da lì che passano droga e armi per Israele e Cisgiordania, ma soprattutto armi e soldi per Gaza. Il corridoio Philadelphia, la zona cuscinetto al confine tra Egitto e Gaza, 14 km dal mare al confine con Israele, è gestito dall’Egitto, dopo che Israele lo ha ceduto in seguito all’uscita da Gaza nel 2005. Da allora, nonostante le promesse egiziane e l’impegno di una missione europea (EUBAM Rafah), il confine non ha impedito il passaggio di tutto sia verso la Striscia di Gaza, grazie ai tanti tunnel, che verso Israele.
Non senza problemi. A giugno dell’anno scorso, ad esempio, un soldato egiziano uccise tre militari israeliani, disse che li aveva scambiati per contrabbandieri. Cosa che è successa sui due fronti più volte. Dopotutto, se Gaza si riesce ad armare, difficile che avvenga tramite Israele. Si sa dell’esistenza di molti tunnel tra la Striscia e l’Egitto.
“Dubito fortemente – spiega l’ex ambasciatore israeliano Jeremy Issacharoff, che è stato membro di diversi gruppi di negoziatori sugli accordi di normalizzazione con l’Egitto – che il governo egiziano sia implicato o connivente con i contrabbandieri di armi e altro. I quali sono un pericolo anche per il Cairo, perché alimentano un commercio illegale in un’area già complicata”.
“C’è molta preoccupazione per la situazione umanitaria e per il passaggio delle forniture umanitarie. Sono preoccupati che se la situazione a Rafah si destabilizzasse, ci sarebbero 1,4 milioni di palestinesi. Gli egiziani – continua il diplomatico – sono preoccupati e osservano molto attentamente fino a che punto le cose diventeranno instabili al punto che all’improvviso i palestinesi proveranno ad attraversare il confine con l’Egitto. Preoccupazione, che li ha spinti ad inviare messaggi piuttosto diretti a Israele a questo riguardo”.
“Negli ultimi mesi, in particolare negli ultimi giorni, molti egiziani sono preoccupati per quello che sta succedendo a Gaza. E, questo, non è qualcosa di nuovo nell’agenda bilaterale. Sapete, nel corso degli anni ci sono stati molti scontri tra Hamas e Israele. E in generale, direi che l’Egitto ha svolto un ruolo molto positivo nel tentativo di stabilizzare la situazione e fermare le ostilità. E penso che l’ultima possibilità di andare a Rafah e di svolgere lì un’operazione militare aumenti ovviamente la preoccupazione egiziana. Dall’inizio della guerra, il 7 ottobre, da parte egiziana c’era già una tremenda preoccupazione per il fatto che un certo numero di palestinesi potesse affluire nel Sinai. E ci sono state anche alcune dichiarazioni che lasciavano intendere che se ciò fosse accaduto o se Israele avesse permesso che accadesse, il trattato di pace sarebbe stato in pericolo. Ma per essere sincero non credo che queste preoccupazioni siano autentiche. Tra Egitto e Israele – spiega il diplomatico – potrebbe non essere una pace calda, ma è una pace molto strategicamente importante. Ed è qualcosa che cattura e incarna anche molti interessi di sicurezza reciproci. Quindi penso che anche se ci saranno preoccupazioni, potrebbero esserci tensioni, ma le relazioni non si rovineranno del tutto. L’Egitto ha anche un importante ruolo di mediazione per la liberazione degli ostaggi. E’ vero, si sono uniti a questo caso presso la Corte internazionale di giustizia dell’Aia con la Turchia e Sudafrica. Ma questo è il genere di cose che si possono fare nelle organizzazioni internazionali, ma credo che saranno molto cauti prima di infrangere il trattato di pace”.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Si è spostato anche sul piano economico il dissidio tra Turchia e Israele che va avanti da anni ma che, dopo il massacro del 7 ottobre e la conseguente azione militare israeliana a Gaza, si è acutizzato. Il presidente turco Erdogan, infatti, ha annunciato che il paese bloccherà tutti i commerci con Israele, in solidarietà con il popolo palestinese e per spingere, motiva, lo stato ebraico ad accettare il cessate il fuoco nella Striscia.
Un danno non da poco per l’economia turca, visto che viene considerato in circa 7 miliardi di dollari il valore delle relazioni commerciali con Israele. E non tutti sono d’accordo. Per il presidente degli esportatori turchi, Mustafa Gutelpe, il paese probabilmente rivedrà il suo obiettivo di esportazioni di fine anno da 267 miliardi di dollari a 260 miliardi di dollari se la questione commerciale con Israele non verrà risolta entro un paio di mesi.
Gli esportatori riferiscono ad Al Jazeera che non sarà affatto facile riuscire a compensare le perdite attraverso l’incremento di altri mercati. Israele è stato il 13° mercato di esportazione più grande per la Turchia nel 2023, ricevendo lo scorso anno il 2,1% delle esportazioni turche. Lo scorso anno Ankara è stata la quinta partner commerciale per le importazioni di Gerusalemme, come rivelano i dati dell’ufficio di statistica israeliano.
Alla decisione turca hanno ovviamente risposto gli israeliani che, tramite il Ministro del Commercio e quello degli Esteri, hanno annunciato proteste e ricorsi in sedi internazionali, a partire dall’Oecd o Ocse, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.
Le relazioni turche con Israele hanno avuto alti e bassi. Sono state ristabilite ad agosto del 2022 dopo un decennio di tensioni nate non solo sulla questione palestinese, ma dopo che nel 2008 ci fu l’assalto dei militari israeliani alla Mavi Marmara, una nave di attivisti che cercava di forzare il blocco di Gaza, durante il quale morirono dieci turchi. Si arrivò al ritiro degli ambasciatori nel 2010.
Le relazioni sono riprese sia perché Netanyahu non era più al potere, sia perché i due paesi condividono forti interessi economici in comune, a cominciare dai giacimenti di gas dinanzi alle loro coste nel Mediterraneo.
La guerra a Gaza ha però di nuovo creato una frattura tra i due.
A luglio dell’anno scorso Erdogan riunì ad Ankara, in un raro incontro, Ismail Haniyeh e il presidente palestinese Abu Mazen, in un tentativo di riappacificazione, che lo ha accreditato ancora di più come amico del popolo palestinese. In quel periodo era stato fissato anche un incontro con Netanyahu, ma il premier si dovette sottoporre ad un intervento chirurgico e rimandò. Incontro che non è mai avvenuto.
Il 20 aprile scorso, invece, a Istanbul il presidente turco ha ospitato il capo dell’ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh. In Turchia, il gruppo che controlla Gaza ha già una sede dal 2011, vi sono ospitati diversi suoi leader ai quali Erdogan ha anche concesso il passaporto turco.
Hamas sta subendo la pressione del Qatar, che ospita il suo ufficio politico, ad accettare l’accordo con Israele, qualcuno dice dietro minaccia di espulsione. Dopotutto, a fare pressioni su Doha, sono gli americani che nella città dell’emirato hanno la più grande base militare dell’area.
Erdogan ha proposto quindi ad Hamas di trasferirsi in Turchia e il capo politico del gruppo di Gaza, tornato solo dopo due settimane a Gaza, si starebbe lasciando convincere, anche se altri esponenti di Hamas hanno detto che si trasferirebbero in Giordania.
Negli incontri con Haniyeh, Erdogan si è accreditato come strenue difensore dei palestinesi, accusando Israele di tutte le nefandezze, paragonando Netanyahu a Hitler.
“Lotterò per la causa palestinese e sarò la voce del popolo palestinese oppresso anche se sarò lasciato solo”, paragonando Hamas ai combattenti che cento anni fa liberarono il paese dalle potenze straniere, facendo nascere la Turchia.
Non è mistero che a Erdogan, nel suo processo di islamizzazione, non dispiacerebbe il controllo del terzo luogo più sacro dell’Islam, la Spianata delle Moschee e rinverdire così i fasti dell’Impero Ottomano che a Gerusalemme ha regnato per quattro secoli.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
L’attacco iraniano contro Israele di sabato 13, pone più di un interrogativo e invita a diverse riflessioni. Soprattutto dopo la risposta di venerdì 19 sulla quale i dubbi sono ancora molti.
Le autorità israeliane non si sono espresse, da Teheran minimizzano e parlano di tre droni partiti dall’interno del territorio iraniano, da infiltrati, nessun velivolo arrivato dall’esterno. Danni irrisori, vita normale a Isfahan, dove si trova una base dell’aviazione oggetto dell’attacco dei droni e delle fabbriche militari oltre a un centro legato al programma nucleare iraniano. Ora si attende di sapere che faranno da Gerusalemme e da Teheran.
Se quella che dovrebbe essere la risposta israeliana all’attacco di sabato con oltre 350 missili e droni verso Israele è stata una azione dimostrativa, quello di sabato è stato un atto imponente in termini numerici e di qualità, non una semplice azione dimostrativa. Derubricarlo, non rende giustizia né alla pericolosità dello stesso, né alle capacità difensive del paese ebraico. L’utilizzo di missili ipersonici, intercettati da uno dei due sistemi di difesa aerea israeliani, dimostra proprio l’intenzione di Teheran di infliggere un colpo. Il fatto che l’attacco sia stato ampiamente annunciato, anche se non nei tempi e nei modi, non lo derubrica certamente, dal momento che è una sorta di prassi consolidata.
L’eccezionalità dell’atto sta però nel suo obiettivo: Israele direttamente. Quando il 3 gennaio del 2020 fu ucciso nel raid di un drone a Baghdad il generale iraniano a capo delle Forze Quds delle Guardie Rivoluzionarie, Qasem Soleimani, gli iraniani accusarono Israele dell’accaduto per poi virare sugli Usa. Contro i quali, cinque giorni dopo, lanciarono una offensiva verso una loro base militare in Iraq. Quella sì, telefonata (erano state informate le autorità irachene che avvisarono quelle americane) e dimostrativa, che infatti fece qualche danno risolvibile con una passata di pittura (in verità ci furono anche decine di militari e personale ferito, seppur in maniera non grave).
Lo scorso gennaio, alla commemorazione dell’anniversario della morte dello stesso generale, un attentato fece oltre cento vittime. Anche in quel caso le autorità iraniane accusarono Israele, per poi scoprire si è trattato di un attentato dell’Isis-k e si accanirono contro alcuni di loro.
A differenza però della risposta al raid che ha ucciso Soleimani, l’Iran ha attaccato direttamente Israele. E’ difficile dire se avesse puntato contro le basi militari soltanto, anche perché i missili sono stati intercettati sul territorio israeliano, mentre droni e altri razzi ancora prima che entrassero nello spazio israeliano grazie alla collaborazione di Giordania, Stati Uniti, Regno Unito e forse Francia.
Certamente, l’Iran avrebbe potuto fare di più. Nel suo arsenale c’è anche altro, forse anche qualche arma atomica, dal momento che l’Aiea non ha potuto visitare le centrali da tempo e indiscrezioni danno Teheran ad un passo dalla bomba. Qualche analista ritiene che l’attacco iraniano sia servito al regime degli Ayatollah per testare le proprie capacità belliche e quelle difensive israeliane, in previsione di qualcosa di diverso nel futuro. Sta di fatto che Iran e Israele sono già in guerra, da tempo, per interposta persona.
Contro il paese ebraico, infatti, ci sono stati e ci sono attacchi da Gaza di Hamas e Jihad Islamico, dal Libano e Siria ad opera di Hezbollah, dall’Iraq di Kataib Hezbollah, dallo Yemen da parte di Houthi. Tutti proxy iraniani, che da questi prendono finanziamenti, armi e addestramento.
Restano ancora dubbi sull’atto che ha portato all’attacco iraniano. Il primo aprile, un raid ha colpito un appartamento di Damasco nel quale erano riunite guardie rivoluzionarie iraniane. Tra queste, graduati importanti, come il comandante delle forze Quds di Libano e Siria, Mohammad Reza Zahedi. L’uomo era considerato una delle menti che ha aiutato Hamas a realizzare il massacro del sette ottobre.
Il primo dubbio è relativo a chi abbia portato l’attacco. Israele, anche in tempi recenti (vedi a gennaio il raid a Beirut contro il numero due di Hamas Saleh al-Arouri o quelli recenti ad Aleppo), ha sempre rivendicato gli attacchi. Cosa che non ha fatto con quello di Damasco. Il secondo dubbio, è relativo al luogo. La palazzina oggetto del raid era di fianco all’ambasciata iraniana a Damasco. Ospitava diversi appartamenti per civili abitazioni, infatti nel raid sono morti due membri di una famiglia che vi risiedeva. Un appartamento era stato affittato dalle Guardie rivoluzionarie. L’Iran ha dichiarato che si trattasse di una sede diplomatica, infatti ha invocato l’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, riguardo alla legittima difesa del suolo, dal momento che , se sede diplomatica, è anche territorio iraniano.
Fino ad oggi il Consiglio di sicurezza dell’Onu, che pure ha condannato l’atto, non ha agito contro Israele e non lo ha neanche citato. Non solo perché non è ancora chiaro chi sia stato, ma anche perché c’è il problema della riconoscibilità della sede diplomatica. La convenzione di Vienna che regola i rapporti consolari, all’articolo 55 specifica infatti, al comma 2, che “Le stanze consolari non saranno adoperate in maniera incompatibile con l’esercizio delle funzioni consolari”. Il successivo comma, spiega che gli uffici di strutture esterne ai consolati, pur ospitati all’interno di strutture consolari, non sono ad esse riconducibili.
Bisogna quindi considerare che le attività delle Guardie rivoluzionarie non sono certamente il rilascio dei visti o la gestione dei residenti all’estero. Inoltre le stesse sono considerate gruppo terrorista dagli Stati Uniti e l’implicazione di Zahedi nei fatti preparatori al sette ottobre è stata acclarata.
L’unica strada, pertanto, oltre a quella diplomatica per invitare le parti a ridurre la tensione, resta quella delle sanzioni, che l’Unione europea ha già applicato e che il G7 si appresta a fare. Con la speranza che la risposta israeliana all’attacco di sabato non scateni un conflitto ancora più ampio di quello attuale.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
I rapporti tra i due amici di sempre, Stati Uniti e Israele, sono forse, in questi giorni, arrivati ai minimi storici. L’ultima goccia verso l’ulteriore deterioramento della situazione, solo in ordine di tempo, è stata la decisione di Washington di non porre il veto, limitandosi ad astenersi, alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che chiedeva un cessate il fuoco immediato a Gaza. Risoluzione che è riuscita ad essere approvata grazie all’astensione americana.
La posizione americana ha tuttavia destato le ire di Israele e in particolare del suo primo ministro, Benjamin Netanyahu, che probabilmente per dare ai suoi alleati e amici storici americani un segnale inequivocabile ha subito deciso di annullare un viaggio negli Usa che avrebbe dovuto essere compiuto da alcuni alti funzionari israeliani per discutere del piano israeliano di attaccare Rafah. Secondo Israele, la decisione americana costituisce un preciso e drastico cambio di rotta e soprattutto danneggia il tentativo di liberare gli ostaggi perché potrebbe dare ad Hamas la speranza che alla fine ci potrà essere un cessate il fuoco anche senza la liberazione degli ostaggi.
In realtà gli Stati Uniti hanno cercato, se non di difendersi, almeno di giustificarsi. Il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale americano, John Kirby, ha fatto sapere che gli Stati Uniti non hanno votato a favore della risoluzione perché il testo della Risoluzione non conteneva alcuna precisa condanna nei confronti di Hamas. Cosa che in passato aveva spinto Washington a porre per ben tre volte il veto, a differenza dell’ultima volta.
Vero è che, come detto, questo ultimo atto è stata solo la ciliegina sulla torta di una situazione già in parte compromessa. Biden, forse anche spinto da una campagna elettorale in corso dagli esiti ancora molto incerti e dalla necessità di non irritare l’opinione pubblica internazionale, ormai da settimane si oppone, più o meno fermamente, a Netanyahu.
Tante, troppe almeno per Israele, le divergenze. Sugli aiuti da fornire alla popolazione di Gaza, specie nella zona nord, ormai prossima ad una vera e propria carestia, sul piano per attaccare Rafah, a cui gli Usa si oppongono ritenendo che porterebbe a un massacro. Come pure sul futuro, estremamente incerto, di Gaza.
Eppure, nonostante gli strappi e nonostante alcuni analisti ritengano che le relazioni tra i due paesi non saranno più le stesse d’ora in avanti, sembra che l’intenzione sia sempre quella di ricucire, nei limiti del possibile, gli strappi. Il destino americano è ancora troppo incerto.
Biden spera, ma non ha la certezza, di essere riconfermato per un nuovo mandato. Nell’attesa di quello che sarà il suo destino politico, il presidente americano cerca di accontentare un po’ tutti, o almeno di non scontentare apertamente troppe persone. Ecco perché il suo sostegno a Israele si è affievolito, senza azzerarsi però.
Dopotutto, i segnali di allarme li ha ricevuti, soprattutto da uno stato come il Michigan. Qui è forte la presenza degli arabi, ed è stato fondamentale per gli equilibri politici americani, dove nel 2020 Biden vinse non di molto. Secondo gli exit poll dell’Associated Press, Biden ha vinto il 64% dei voti musulmani nel 2020 e Trump il 35%. Ma il sostegno a Biden tra gli elettori arabo-americani è crollato ad appena il 17% in ottobre, subito dopo l’inizio della guerra, con il 25% che, secondo un sondaggio condotto dall’Arab American Institute, afferma di non essere sicuro per chi avrebbe votato se le elezioni si fossero svolte in quel momento.
Una politica non troppo filo israeliana, ad oggi, potrebbe forse avvantaggiarlo almeno con certa parte dell’opinione pubblica di sinistra. D’altro canto opporsi drasticamente ad Israele (come ad esempio avrebbe potuto fare votando a favore della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza) lo metterebbe in cattiva luce con i moderati che sperano nella sconfitta di Hamas e “parteggiano” di più per Israele. E dunque prevale la politica della “via di mezzo”.
Non a caso, se da un lato Biden critica, dall’altro la sua amministrazione non fa mancare appoggio economico e militare. L’appoggio americano serve poi a Tel Aviv. Non si dimentichi che gli Stati Uniti forniscono ad Israele aiuti militari per quasi tre miliardi di euro all’anno. E così ora, nonostante le tensioni, sembra che il dialogo possa ripartire, sia pure lentamente e con cautela.
Si è appreso che Netanyahu ha accettato di riprogrammare il viaggio degli alti funzionari israeliani in America per parlare della operazione a Rafah, magari delle sue alternative, ma anche del rilascio degli ostaggi. Per Washington nulla è ancora perduto e un dialogo tra Israele ed Hamas sugli ostaggi “è ancora possibile anche se restano ancora questioni difficili da risolvere”.
Segnali di apertura e di amicizia anche da parte del presidente israeliano, Isaac Herzog, che ha detto a un gruppo di deputati democratici in visita che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è “un grande amico di Israele”. “Quando lo abbiamo ospitato qui meno di due anni fa, ho potuto vedere il suo amore, affetto ed emozione verso il popolo di Israele e lo Stato di Israele – ha detto il presidente Herzog – lui è un vero amico e lo rispetto molto per questo”.
Herzog ha anche aggiunto che il legame tra i due paesi è “essenziale per il benessere delle nostre nazioni, e dovremmo semplicemente concentrarci sul miglioramento e rafforzamento di questo legame”.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
E’ sempre più alta la tensione nel Mar Rosso, dove le milizie yemenite degli Houthi stanno dando non poco filo da torcere. Da novembre, poco dopo l’inizio della guerra tra Israele ed Hamas, i miliziani Houthi, gruppo di ribelli che hanno il controllo di gran parte dello Yemen e che sono spalleggiati dall’Iran, hanno cominciato a minacciare tutta la zona del Mar Rosso attaccando con missili navi cargo e altri mercantili che percorrevano quel tratto di mare.
Gli attacchi sono andati sempre a peggiorare: nelle ultime settimane si sono registrate le prime vittime tra i marinai e una nave è stata affondata. Ne hanno risentito i traffici commerciali, che per motivi di sicurezza hanno dovuto modificare le rotte, con un aumento notevole dei tempi e dei costi. A causa degli attacchi Houthi, la rotta utilizzata non è più quella tramite il canale di Suez.
Anche l’Italia ne ha fortemente risentito. Basti pensare che dal canale di Suez transitava il 40% del Made in Italy. Con il blocco di Suez, oltre ad un crollo dell’economia egiziana, si ipotizza un aumento dell’inflazione italiana dell’1,8% per la crisi di Bab el-Mandeb, lo stretto dinanzi allo Yemen che è l’accesso al Mar Rosso.
Qualche settimana fa, Banca d’Italia stimava che è a rischio, direttamente o indirettamente, il 16% del nostro export. Con l’aumento di 20 giorni di navigazione, dal momento che ora le navi devono circumnavigare l’Africa, si registra un incremento del costo del trasporto dall’Asia all’Europa del 360%. Impatto negativo non solo legato al trasporto di beni, anche a quello informatico.
Dinanzi alle coste dello Yemen, infatti, passano importanti cavi sottomarini di comunicazione, che collegano l’Asia con l’Europa. Poche settimane fa sono stati tagliati quattro cavi di comunicazione sottomarini nel Mar Rosso, colpendo il 25% del traffico dati che scorre tra l’Asia e l’Europa. In un comunicato, la società che li gestisce ha spiegato che l’80% del traffico diretto a ovest dall’Asia passava attraverso i quattro cavi (Seacom, TGN-Gulf, Asia-Africa-Europa 1 e Europe India Gateway). Gli Houthi, che più volte hanno minacciato azioni del genere, non hanno rivendicato questo atto, incolpando invece le operazioni belliche congiunte anglo-americane.
A muovere le azioni degli Houthi è l’appoggio a Gaza e la volontà di combattere Israele. Non a caso gli Houthi hanno chiaramente parlato di una guerra intesa anche come campagna di solidarietà con i 2,2 milioni di palestinesi di Gaza.
La reazione dell’Occidente non si è fatta attendere e una coalizione formata dagli USA e dal Regno Unito, insieme ad altri 8 Paesi ovvero Australia, Bahrein, Canada, Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Nuova Zelanda e Corea del Sud ha iniziato attacchi sistematici nell’area contro obiettivi Houthi in Yemen.
A febbraio anche altri paesi europei sono scesi in campo con la missione Aspides (ne fanno parte Grecia, Belgio, Germania e appunto Italia). L’idea alla base della missione non è quella di colpire (come invece fanno gli americani) obiettivi Houthi in Yemen ma svolgere per lo più una funzione difensiva, inviando appunto navi che possano scortare le navi mercantili che passano nell’area, abbattendo ovviamente eventuali droni o minacce degli Houthi.
Che è appunto quello che ha fatto nei giorni scorsi il cacciatorpediniere italiano Caio Duilio quando ha abbattuto tre droni (uno a inizio marzo e due qualche giorno fa). Non è chiaro se i droni si stessero dirigendo proprio contro la nave italiana, comunque sono stati intercettati in quanto ritenuti pericolosi e quindi da abbattere.
Fatto sta che da quel momento l’attenzione del gruppo yemenita si è spostata un po’ anche verso l’Italia. Il portavoce degli Houthi, Nasr al-Din Amer, ha detto che l’operazione italiana era “inaccettabile” ma che il gruppo sciita almeno per ora non intende prendere di mira l’Italia, avendo come obiettivo principale le navi americane, britanniche e israeliane. Gli Houthi hanno anche di recente annunciato che intensificheranno le operazioni militari durante il mese sacro islamico del Ramadan.
Continuano intanto gli attacchi mirati dell’aviazione anglo-americana che nei giorni scorsi ha effettuato sei attacchi di autodifesa contro obiettivi Houthi solo poche ore dopo l’ultimo attacco ad una nave mercantile della zona.
Secondo fonti yemenite, gli attacchi aerei Usa avrebbero ucciso almeno 11 persone e ferite 14. L’agenzia Novosti, citando una fonte militare, ha scritto che i ribelli Houthi avrebbero testato con successo un razzo ipersonico nello Yemen. Gli Houthi starebbero pianificando di iniziare a produrre missili da utilizzare contro obiettivi nel Mar Rosso, nel Mar Arabico e nel Golfo di Aden, nonché contro Israele.
Gli Stati Uniti avrebbero usato canali diplomatici per fare indirettamente pressioni sull’Iran affinché spinga gli Houthi a fermare le loro azioni. Da novembre, da quando hanno cominciato a prendere di mira le navi di passaggio, il gruppo sciita filo iraniano ha lanciato più missili di quanti lanciati negli otto anni di guerra con i sauditi.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
La politica palestinese cerca la propria unità a Mosca. Il governo russo, che da sempre tiene sotto la sua ala protettiva Ramallah e le varie fazioni in diaspora, ha convocato tutti per una tre giorni all’ombra del Cremlino per tentare una riconciliazione. Soprattutto tra Fatah e Hamas, un obiettivo che già in molti in passato, soprattutto paesi arabi, hanno fallito, dal 2007, da quando il gruppo che controlla Gaza ha preso possesso della Striscia e ha cacciato Fatah.
Ma il momento è di quelli che possono favorire una riconciliazione, perché c’è un comune nemico: Israele. Hamas e Fatah, infatti, si erano divisi proprio perché la seconda aveva sottoscritto gli accordi di Oslo che spingevano, tra l’altro, al riconoscimento di Israele e in qualche modo alla nascita di uno stato palestinese.
Hamas, che nel suo statuto fondativo, sia originario del 1998 che rifatto nel 2017, ha la cancellazione dello stato israeliano e il non riconoscimento di ogni accordo con gli ebrei, si è tenuta a distanza, coltivando il suo orticello nella Striscia, non accettando neanche di entrare in quella Organizzazione per la Liberazione della Palestina che è l’unica rappresentante dei palestinesi a livello internazionale. Lo era anche al Palazzo di Vetro prima che l’Onu poi riconoscesse alla Palestina lo status di Osservatore.
Fatah fino ad ora ha fatto volentieri a meno di Hamas, delegando a questi il gioco sporco, visto che, almeno formalmente, aveva rinunciato alla lotta armata. Ma ha commesso errori politici, soprattutto piazzando troppa distanza tra l’establishment e i cittadini, lasciando troppo spazio ad Hamas e sodali e, soprattutto, non rinnovandosi.
L’ottuagenario presidente Mahmoud Abbas (Abu Mazen) non ha intenzione di lasciare il trono. Non convoca elezioni da quelle vinte proprio da Hamas 2006, per paura che si ripeta lo stesso risultato. Da più parti, gli è stato chiesto di cambiare quel carrozzone elefantiaco che è l’Autorità Nazionale Palestinese per essere pronta a governare anche Gaza nel dopo guerra. Il messaggio era chiaro a tutti: era indirizzato anche a lui.
Ma il presidente palestinese ha fatto finta di non sentire e, in cambio, ha concesso le dimissioni del governo alla vigilia della tre giorni moscovita.
Rassegnando le dimissioni, il premier Shtayyeh ha detto che lo faceva per spingere all’unità i palestinesi. Alla vigilia di Mosca, il ministro degli Esteri dimissionario, al-Maliki, ha detto che auspica per la Palestina un governo tecnocratico, con la più ampia partecipazione di esponenti, che possa portare il paese alle elezioni e poi alla creazione dello stato. “Ma – ha detto – senza Hamas”.
La preoccupazione è che, come successo nel 2007, soprattutto i paesi occidentali che hanno iscritto il gruppo che controlla Gaza nell’elenco dei movimenti terroristi, possano non accettare il nuovo esecutivo e bloccare il sostegno politico ed economico.
Quindi riforma dell’Autorità Nazionale Palestinese e riforma di Hamas, che dovrebbe distanziarsi dalla parte militare e avvicinarsi alle fazioni palestinesi che già fanno parte dell’Olp. Oggi, il gruppo che controlla Gaza, insieme al Jihad Islamico, è fuori dall’ombrello rappresentativo palestinese. E questo, in un certo senso, gli ha dato ancora più potere, riducendo di fatto anche l’influenza della stessa Fatah.
Non solo: ma ha dato la possibilità al gruppo di Gaza di aumentare il consenso nei Territori palestinesi oltre che, ovviamente, a Gaza, soprattutto tra le nuove generazioni che, come dicevamo, vedono l’Anp e Fatah molto distanti dai loro bisogni, mentre Hamas come l’unico partito e gruppo che si batte per loro. La propaganda, qui, è fondamentale.
A Mosca i lavori sono stati aperti dal ministro degli Esteri russo Lavrov, che ha sottolineato l’importanza dell’unità dei gruppi. Tutti si sono impegnati a cercarla, ma da qui a realizzarla, dovrà passare tempo e, soprattutto, si dovranno limare tante posizioni. Certo, la guerra a Gaza aiuta in questo, perché la lotta sul campo e politica contro il comune nemico israeliano cementa l’appartenenza.
Si pone quindi il problema politico di quale governo per la Palestina. Seppure Hamas dovesse entrare nell’Olp, come la prenderebbero i paesi come Usa, Francia, Regno Unito e altri se dovesse sedere anche nel governo? Ci vorrebbero prese di posizione molto estreme da parte di Hamas, fino ad ora impensabili.
Ma è necessario tendere l’attenzione e pensare anche al dopo Abu Mazen. Diversi i nomi che circolano. In questo momento però due in particolare hanno le caratteristiche di riunire i consensi: Marwan Barghouti, incarcerato in Israele con cinque ergastoli, chiamato il Mandela palestinese e Mohammed Dahlan. Quest’ultimo è di Fatah, è originario di Gaza dove guidava il partito che controlla i Territori, prima di essere cacciato come traditore da Abu Mazen e riparare negli Emirati, dove ha lavorato agli accordi di Abramo con Israele.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
L’ENI e altre società del settore energetico, hanno ricevuto una diffida da uno studio legale che difende alcune Ngo palestinesi, d’intraprendere attività di esplorazione nelle zone marittime dinanzi alla striscia di Gaza.
I giacimenti sono stati scoperti per la prima volta nel 1999 nelle acque territoriali palestinesi e sono stati a lungo visti come un importante trampolino di lancio verso l’indipendenza energetica palestinese, ma sono rimasti inutilizzati principalmente a causa delle obiezioni e degli ostacoli posti da Israele.
Nel novembre 1999 era stato firmato un contratto di 25 anni per l’esplorazione di gas e lo sviluppo di giacimenti di gas tra il British Gas Group (Bg) e il Pif palestinese, il fondo di investimento di Ramallah. Bg Group si ritirò poi dal progetto nel 2016 cedendolo a Shell, che a sua volta si è ritirata dall’accordo nel 2018. Nel 2021, l’Autorità Palestinese ha firmato un memorandum d’intesa con l’Egitto per sviluppare il giacimento di gas di Gaza e le infrastrutture necessarie.
L’azienda petrolifera italiana, insieme alla inglese Dana Petroleum (controllata dalla South Korea National Petroleum Company) e Ratio Petroleum (una società israeliana) hanno ottenuto lo scorso 29 ottobre dal Ministero dell’Energia israeliano una licenza per esplorare la ricerca di gas naturale nello spazio di mare antistante la Striscia di Gaza. Il progetto rientra nel quarto round di offerte offshore, denominato Obr4, lanciato dal ministero israeliano nel 2022 e riguarda l’esplorazione della zona G.
Questa è un’area il cui 62% rientra nei confini marittimi dichiarati dallo Stato di Palestina nel 2019, “in conformità con le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) del 1982, di cui la Palestina è firmataria”, come si legge nel comunicato delle Ngo che si sono rivolte allo studio legale americano Foley Hoag LLP. Israele non fa parte dell’Unclos ma ha risposto alle obiezioni sostenendo che, poiché non riconosce la Palestina come stato sovrano, la stessa non può dichiarare i propri confini marittimi.
La questione era già stata avanzata dalle organizzazioni nel settembre del 2019, ma il governo israeliano ha ribadito la sua posizione, secondo la quale, per principio consolidato, solo gli Stati sovrani hanno il diritto alle zone marittime, compresi i mari territoriali e le zone economiche esclusive, nonché di dichiarare i confini marittimi. La cosa, secondo i legali, è in contrasto con il diritto internazionale.
In un comunicato del giugno scorso dell’ufficio del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, si legge che il progetto, che si localizzerebbe a 36 chilometri dalla costa di Gaza, rientra nel quadro dei negoziati in corso all’epoca tra Israele, Egitto e Autorità nazionale palestinese. Nel comunicato però veniva precisato che i progressi sarebbero dipesi dalle azioni necessarie per “preservare la sicurezza dello Stato di Israele e le esigenze diplomatiche”.
A maggio la tv israeliana Channel 13 aveva riferito che il governo era in trattative segrete con l’Autorità palestinese per estrarre gas dal giacimento al largo della costa della Striscia di Gaza, con l’approvazione di Netanyahu e del ministro della Difesa Yoav Gallant, aggiungendo che i colloqui erano ripresi come parte del processo politico e di sicurezza iniziato di recente tra Israele e l’Autorità palestinese sotto la mediazione degli Stati Uniti.
L’Autorità nazionale palestinese, attraverso il suo Fondo di Investimento (Pif) avrebbe guadagnato il 27,5% dei profitti dal giacimento, mentre la palestinese Consolidated Contractors Company, partner del Pif, avrebbe ottenuto un altro 27,5%. Il restante 45% sarebbe andato alla Egyptian Natural Gas Holding Company, che dovrebbe gestire il progetto. Secondo alcuni analisti il progetto potrebbe dare respiro all’economica palestinese, allentando nel tempo le tensioni tra Israele e Palestina. Ma con la guerra a Gaza, tutto è in stand by.
Le Ngo battono sulla questione della proprietà dell’area, visto che per il diritto internazionale, Israele è potenza occupante della Palestina, e controlla le sue aree marittime. La striscia di Gaza rientra in questa occupazione. Per i legali, l’emissione della gara (Israele ha pubblicato anche bandi per zone H ed E che pure inglobano aree marittime palestinesi) e la concessione delle licenze, violano anche il diritto internazionale umanitario, perché realizzate secondo la legge interna israeliana, annettendo così “de facto e de jure” delle aree marittime palestinesi.
Le Ngo Adalah, Al Haq, Al Mezan e Pchr, hanno scritto pochi giorni fa al Ministro dell’Energia israeliano, chiedendo di revocare gare e licenze e di bloccare lo sfruttamento delle aree palestinesi, ricordando che “l’esplorazione e lo sfruttamento del gas nelle aree marittime della Palestina violano palesemente il diritto fondamentale del popolo palestinese all’autodeterminazione, che comprende la gestione delle sue risorse naturali”. Hanno anche notificato alle compagnie petrolifere, tra le quali l’ENI, che il procedere nell’esplorazione li rende complici di saccheggio e quindi di crimini di guerra che, considerando la causa in corso dinanzi alla Corte internazionale di Giustizia dell’Aja, potrebbe tirarli dentro.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
I media hanno riportato con enfasi e quasi con sorpresa, la notizia che il segretario di Stato americano, Antony Blinken, si sia fatto preparare un dossier dai suoi collaboratori con tutte le opzioni possibili per la risoluzione del conflitto a Gaza e per prepararsi al dopo, comprese quelle del riconoscimento dello Stato di Palestina, non usare il veto per impedire al Consiglio di Sicurezza di ammettere la Palestina come stato membro dell’Onu e incoraggiare altri paesi a riconoscerla.
Alla notizia americana, anche l’omologo inglese di Blinken, David Cameron, ha annunciato la stessa possibilità per il regno dei Windsor. Dopotutto sia gli americani che gli inglesi sono tra quei popoli che formalmente non riconoscono ancora lo stato di Ramallah e gli americani in particolare hanno usato spesso il loro diritto di veto al Consiglio di Sicurezza dell’Onu per bloccare molte risoluzioni che riguardano l’unica e ibrida figura palestinese all’interno del consesso internazionale.
La questione dello status palestinese è uno di quegli ostacoli fondamentali al processo di pace. Nel 1974 la risoluzione 3236 dell’assemblea generale delle Nazioni Unite riconosce ai palestinesi il diritto all’autodeterminazione e all’indipendenza e sovranità attraverso uno Stato proprio. Nell’occasione si riconosce nell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (Olp) l’interlocutore privilegiato tra Nazioni Unite e gli altri paesi, con i palestinesi.
Quattordici anni dopo, nel novembre 1988, la stessa Olp proclamò la nascita dello stato palestinese, che fu riconosciuto da una settantina di stati. Con gli accordi di Oslo di trent’anni fa nacque l’Autorità nazionale Palestinese, l’ente che amministra il territorio palestinese che fu diviso in tre aree: l’area A sotto il totale controllo dell’Anp, la B sotto controllo militare israeliano e la C sotto controllo civile e militare israeliano.
Nel 2012, con la risoluzione 67/19, l’Assemblea generale dell’Onu (che nel 1988 con altra risoluzione aveva accettato la dichiarazione di indipendenza palestinese, utilizzando così il nome “Palestina” invece di quello dell’Olp) ha riconosciuto alla Palestina lo status di osservatore all’interno delle Nazioni Unite. Ad oggi sono 139 su 193 gli stati membri dell’Onu che riconoscono la Palestina come stato. L’Italia, come Stati Uniti, Spagna, Inghilterra e altri, non ancora. Però in Italia c’è una ambasciata palestinese al cui capo viene riconosciuto il rango di ambasciatore. Di contro, l’Italia non ha una sua ambasciata nei territori palestinesi, ma il Console generale italiano a Gerusalemme funge come una sorta di ambasciatore presso Ramallah.
Il presidente Trump oltre a decidere di spostare l’ambasciata americana da Tel Aviv a Gerusalemme, riconoscendo la città santa capitale d’Israele come previsto nelle leggi fondamentali del paese ebraico e di fatto chiudendo il consolato a Gerusalemme che serviva i palestinesi, oltre a bloccare i finanziamenti alle organizzazioni internazionali che aiutavano la Palestina, decise anche di chiudere l’ambasciata palestinese a Washington. Una volta eletto, Biden, promise di ripristinare tutte queste cose, ma ad oggi non è stato fatto.
La guerra a Gaza, con il continuo aiuto americano e anche appoggio politico a Israele, ha fatto il resto, allontanando sempre più palestinesi e arabi dagli Stati Uniti. Se n’è accorto lo staff che a Biden sta curando la campagna elettorale presidenziale, notando che il consenso ricevuto nella passata consultazione da parte della comunità araba americana, è sceso vertiginosamente.
I dati sono stati resi noti in occasione della visita di Biden in Michigan, dove è forte la presenza degli arabi, stato fondamentale dove nel 2020 Biden vinse non di molto. Secondo gli exit poll dell’Associated Press, Biden ha ottenuto il 64% dei voti musulmani nel 2020 e Trump il 35%. Ma il sostegno a Biden tra gli elettori arabo-americani è crollato ad appena il 17% in ottobre, subito dopo l’inizio della guerra, con il 25% che secondo un sondaggio condotto dall’Arab American Institute afferma di non essere sicuro per chi avrebbe votato se le elezioni si fossero svolte in quel momento. E’ chiaro che quindi il presidente americano voglia spingere su questo punto del riconoscimento palestinese per recuperare terreno.
Ma Biden ha anche necessità che finisca la guerra, non solo per ragioni umanitarie, ma anche economiche e politiche, vista la frattura all’interno del suo partito sul conflitto. La mossa di annunciare il possibile riconoscimento dello stato palestinese è una chiara pressione su Netanyahu affinché cambi strategia nella guerra.
I palestinesi sanno bene che è solo politica, anche perché conoscono i limiti internazionali di questa faccenda. Ramallah ha infatti problemi ad adempiere appieno ai dettami della convenzione internazionale di Montevideo del 1933, che stabilisce i criteri di riconoscibilità di uno stato. Convenzione che è importante ma che non dirime e detta le uniche regole al riconoscimento di una nazione come Stato.
Per la Convenzione di Montevideo gli attributi classici che uno Stato deve possedere per essere considerato tale sono: deve avere una sovranità effettiva su un territorio delimitato, una popolazione stabile, un insieme di istituzioni in grado di rispondere ai bisogni dei suoi cittadini, e essere riconosciuto come suo pari dagli altri Stati.
La Palestina è inclusa in quelli con sovranità limitata, dal momento che l’Anp è un ente amministrativo che governa su un arcipelago, visto che il territorio palestinese è occupato da un lato dalle colonie israeliane, dall’altro da una entità che amministra e governa autonomamente una porzione di territorio palestinese, cioè Hamas a Gaza. Per assurdo, secondo la stessa convenzione, se si trovasse un accordo garantendo una sorta di extraterritorialità alle colonie israeliane (come le proprietà vaticane in Italia), rimarrebbe il problema, per i palestinesi, di Hamas che governa e amministra in autonomia una loro porzione di territorio.
Ma il riconoscimento dello stato palestinese, prima di essere formale e portare alla creazione dello Stato vero e proprio, è sicuramente politico. E in questo conflitto è necessario che la politica faccia appieno la sua parte per far finire la guerra e il conteggio delle vittime civili.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
“Questa sicuramente è una fase nuova della guerra. La prima è stata la risposta immediata, quella dopo il 7 ottobre quando è stato necessario riorganizzarsi dopo l’attacco. La seconda è stata la guerra intensiva su larga scala con i bombardamenti, le operazioni di terra. E ora penso che stiamo iniziando la terza fase, che vedrà un livello inferiore di ostilità ma più mirate e le vedremo per un lungo periodo. Non tanto per conquistare più territorio, perché la maggior parte dell’area che Israele potrebbe voler conquistare a Gaza è stata occupata. Si tratterà di trovare i leader, eliminarli, distruggere i tunnel e questo sarà comunque significativo”. Questo il pensiero del professor Chuck Freilich, ricercatore senior presso l’Institute for National Security Studies di Tel Aviv.
Ieri un drone ha ucciso il numero due di Hamas. Israele continua a non rivendicare la responsabilità dell’omicidio. In Iran c’è stato un altro grave episodio, nel giorno della data di morte del generale iraniano Suleimani. Una coincidenza?
“Israele ha annunciato subito dopo lo scoppio della guerra che cercherà di eliminare i massimi dirigenti di Hamas e che cercherà di farlo ovunque si trovino. Questa è la politica ma comunque non penso che Israele abbia nulla a che fare con quello che è successo in Iran. Non è questo il modo in cui Israele ha mai operato, causando attacchi di massa nel corso degli anni. Sono sempre stati diretti contro gli individui direttamente coinvolti in atti terroristici”.
Israele o no, come la morte di al-Arouri potrà cambiare le strategie, visto il fronte nord e le minacce di ritorsioni dal leader di Hezbollah?
“Vedremo – dice Freilich – come risponderà. Ma tendo a pensare che sia suo interesse non volere una grande escalation nel momento in cui sa che Israele è in piena allerta ed è pienamente preparato. Fino ad ora, durante tutta la guerra, hanno mantenuto le ostilità. Ultimamente il confine è diventato più caldo, ma l’hanno mantenuto a un livello che non ha costretto Israele a un’escalation sul fronte libanese, anche se ci sono persone in Israele, anche massimi leader, che credono che queste siano effettivamente le circostanze appropriate per cercare finalmente di porre fine alla minaccia di Hezbollah, che è molto, molto più grande della minaccia di Hamas”.
L’uccisione del numero due di Hamas, Saleh al-Arouri, potrebbe creare problemi alle trattative per la liberazione degli ostaggi?
“Beh, ovviamente potrebbe farlo a breve termine. Hanno rifiutato le proposte avanzate finora. Penso che vogliano tenere almeno una parte degli ostaggi fino alla fine, perché questa è, per così dire, una polizza assicurativa per Hamas”.
In questo momento Netanyahu sembra isolato: dagli alleati americani che vorrebbero chiudere presto il capitolo bellico, dall’opinione pubblica per la breccia nella sicurezza che ha portato alla strage del 7 ottobre, dalle famiglie degli ostaggi, dalla magistratura che ha ribaltato il nucleo fondante della riforma della giustizia. Eppure continua a guidare il Paese e questa guerra. Non dà l’impressione di farlo più per fini personali, per raggiungere un risultato tale da poter essere ricordato per questo, che per il resto?
“Netanyahu – continua Freilich – penso, abbia sue ragioni personali per voler prolungare la guerra. Ma ricordate, in Israele esiste un consenso virtuale sulla necessità di distruggere Hamas militarmente e di rovesciarla politicamente. Questo consenso non è stato minato. Se ci fosse una guerra con Hezbollah nel nord sarebbe lo stesso, penso che Netanyahu godrebbe di un ampio sostegno pubblico in Israele per questo, a meno che la gente non pensi davvero che lo stia facendo per ragioni politiche. In termini di rapporto con gli Stati Uniti? Decisamente sì. C’è stata molta opposizione negli Stati Uniti, ma il fatto è che, dopo tre mesi, stanno ancora dando a Israele un sostegno sostanzialmente completo. Va bene. Continuano le spedizioni di armi. Ai voti alle Nazioni Unite è stato posto il veto. L’opposizione è molto esplicita, ma il quadro generale è un sostegno americano che resta molto, molto forte. In futuro si vedrà se questa opposizione avrà conseguenze per Israele ma per ora il supporto è molto, molto forte. E sì, certo che il presidente americano fa considerazioni che hanno a che fare le future elezioni”.
Israele è circondato da molti lati. Non si teme l’escalation di un conflitto globale nell’area e quali sono le mosse per fermarlo?
“C’è sicuramente il rischio – conclude il professor Frielich – di un’escalation. Quindi potrebbe esserci un conflitto più ampio tra Israele e l’Iran. Esiste anche la possibilità che ciò possa coinvolgere altri, che si tratti di alcuni stati arabi o degli Stati Uniti. La domanda è se l’Iran vuole che ciò accada in una situazione in cui Israele è completamente in allerta e totalmente schierato e mentre gli Stati Uniti hanno ancora due portaerei nella regione”.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Gli Houthi dello Yemen e la strategia del loro ingresso nella guerra tra Israele e Hamas. Il blocco del Mar Rosso e del Canale di Suez, causato dagli attacchi alle navi mercantili, ha provocato un aumento dei prezzi delle materie prime, di gas e carburante, e rischia di allargare sempre più i confini del conflitto.
La guerra a Gaza non è rimasta limitata solo alla Striscia. Grazie agli appoggi di Hamas con altri gruppi legati all’Iran, i cosiddetti ”proxy” degli Ayatollah, Israele si è trovato a fronteggiare minacce da più parti.
Fino ad adesso la più importante era rappresentata da Hezbollah, il partito di Dio, che dal Libano è sempre stata una spina nel fianco di Israele. Lanci di razzi dal sud del paese dei cedri, ma anche dalla Siria, hanno spinto l’esercito del paese ebraico a rispondere pesantemente.
L’Israeli Defence Force già prima effettuava raid contro basi di Hezbollah o comunque di gruppi legati a Teheran, in Siria. Come erano e sono continui i raid in Cisgiordania contro i due altri proxy di Teheran nell’area, Hamas e il Jihad Islamico Palestinese (Pij). Contro questi, l’esercito israeliano continua a combattere soprattutto a Jenin e Nablus, ma anche contro i loro gruppi associati, tutti legati al regime degli ayatollah: dal Saraya al Quds e al Battaglione Jenin; dalle Brigate Balata alla Brigata Nablus, dalla Brigata Yabad all’ultima temuta, la Fossa dei Leoni.
Un panorama del terrore che il governo israeliano è deciso ad annientare a tutti costi. Importa poco se anche minorenni sono ad imbracciare i fucili per difendere le loro case, se i proiettili e colpi sparati durante le battaglie uccidono civili di ogni età e sesso. Le operazioni che l’esercito porta avanti quasi quotidianamente e gli scontri anche cruenti e feroci con i locali, mostrano l’interesse israeliano a chiudere il capitolo, ma anche l’accresciuta potenza militare dei gruppi palestinesi che, non solo Hamas, secondo gli analisti, sono foraggiati e istruiti dall’Iran.
Non a caso, spesso i vertici di Hamas e Pij sono a Teheran o esponenti iraniani ne incontrano i capi in Siria o Libano. Alle armi “Carlo”, le pistole mitragliatrici artigianali autocostruite in molti luoghi della Cisgiordania, ampiamente diffuse, si sono aggiunti i fucili d’assalto M-4, M-16, CAR-15. Non sono pochi quelli che possiedono pistole, come M18 e P-320. Armi che arrivano dall’Iran attraverso Siria, Libano e, soprattutto Giordania, portate smontate per poi essere assemblate nei piccoli negozi delle cittadine palestinesi e stipate soprattutto nei sottoscala e depositi sotterranei del centro delle città di Nablus e Jenin.
L’ultima minaccia è rappresentata dall’altro gruppo legato all’Iran, gli Houthi dello Yemen. Da quando è scoppiata la guerra a Gaza, questi dapprima hanno lanciato colpi contro Eilat (la città costiera israeliana sul Mar Rosso), intercettati sia da Israele che dalle navi da guerra americane, poi si sono lanciati verso attacchi contro le navi mercantili che attraversano la zona.
Avevano minacciato di colpire tutte le imbarcazioni di proprietà israeliane, o legate al paese ebraico o dirette verso esso. Una decina quelle colpite. Quattro delle cinque principali compagnie di navigazione del mondo – Maersk, Hapag-Lloyd, CMA CGM Group ed Evergreen – hanno annunciato che sospenderanno la navigazione attraverso il Mar Rosso nel timore di attacchi Houthi. Il colosso petrolifero BP ha dichiarato che avrebbe fatto lo stesso, una mossa che ha causato un’impennata dei prezzi del petrolio e del gas.
Il gruppo prende di mira soprattutto quelle imbarcazioni che, dirette verso il canale di Suez, passano dinanzi alle coste yemenite, passando per lo stretto di Bab-el-Mandeb. Una situazione che ha spinto diversi paesi a formare una coalizione marittima contro il gruppo yemenita, il cui intervento, rischia di allargare sempre più i confini del conflitto.
Il gruppo Ansarallah, i sostenitori di dio, sono nati negli anni ‘90 da Huseein al-Houthi, che diede vita ad un movimento religioso sciita contro il governo sunnita yemenita. Dopo che per un decennio almeno erano stati tollerati dal neonato governo dell’unificato Yemen, le due fazioni si spaccarono dopo l’appoggio governativo all’invasione americana dell’Iraq.
Nel 2004 al Houthi venne ucciso dalle forze governative, ma non finì il suo movimento che crebbe lentamente, aiutato dall’Iran anche in chiave anti-saudita. Con la primavera araba, il presidente Yemenita Saleh fu deposto anche perché gli Houthi avevano preso il controllo del nord e, dopo qualche anno, di zone della capitale Sanaa.
A difesa del governo è intervenuta nel 2015 l’Arabia Saudita in quella che doveva essere una guerra lampo e che si è protratta per sette anni, in quella che l’Onu ha definito la peggiore crisi umanitaria al mondo, con oltre 250 mila vittime. Da allora, gli Houthi controllano la capitale yemenita, oltre a tutto il nord, continuando ad essere foraggiati dall’Iran che ne ha accresciuto anche le capacità belliche.
La loro discesa in campo contro Israele sta creando non pochi problemi, perché la preoccupazione è che si tirino dietro anche Teheran, che per ora gioca con i propri proxy da lontano. Ma l’impatto del gruppo yemenita nel conflitto è notevole, sia per le capacità belliche, sia perché ha provocato un aumento dei prezzi del trasporto delle materie prime, soprattutto gas e carburanti, che passano per la zona, aumentando quindi i prezzi al consumatore. Le navi, infatti, per evitare di passare per le coste yemenite, devono circumnavigare il continente africano, spendendo di più. Anche il porto israeliano di Ashdod ha visto una notevole riduzione del suo volume di traffico.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Un sondaggio condotto sia in Cisgiordania che a Gaza, tra il 22 novembre e il 2 dicembre, dal Palestinian Center for Policy and Survey Research (PSR), il Centro palestinese per la politica e le ricerche di mercato, ha evidenziato che l’anziano presidente palestinese non ha più neanche il minimo consenso.
Per garantire la sicurezza dei ricercatori e degli intervistatori, i sondaggi con i residenti di Gaza sono stati condotti durante i sette giorni di cessate il fuoco. Sono state ascoltati 1231 adulti, di cui 750 sono stati intervistati faccia a faccia in Cisgiordania e 481 nella Striscia di Gaza.
Mentre cala clamorosamente il sostegno ad Abbas, di contro aumenta quello ad Hamas che, per il 57% degli intervistati a Gaza e l’82% in Cisgiordania, ha fatto bene ad attaccare Israele lo scorso 7 ottobre. Solo il 10% degli intervistati ha affermato che Hamas ha compiuto crimini di guerra. Per un’ampia maggioranza, Hamas ha agito per difendere la moschea di Al Aqsa a Gerusalemme e ottenere il rilascio dei prigionieri palestinesi.
Dunque questi risultati evidenziano una ulteriore delegittimazione della Autorità Nazionale palestinese, accusata di non prendere una posizione decisa contro Israele da un lato e di non essere capace di gestire negoziati credibili per una soluzione del conflitto israelo-palestinese, dall’altro.
Sempre stando al sondaggio, nel complesso, l’88% vuole che Abbas si dimetta, in aumento di 10 punti percentuali rispetto a soli tre mesi fa, prima della guerra. L’autorità nazionale palestinese viene definita incapace e corrotta. Allo stesso tempo, il 44% in Cisgiordania dichiara di sostenere Hamas, rispetto al 12% di settembre. All’interno della Striscia di Gaza, il gruppo terroristico gode del 42% di sostegno, rispetto al 38% di tre mesi fa.
Per la maggior parte di coloro che sono stati sentiti, inoltre, Israele non riuscirà a sradicare Hamas, né a provocare una seconda Nakba palestinese, né ad espellere i residenti della Striscia di Gaza. Un’ampia maggioranza ritiene addirittura che Hamas uscirà vittorioso da questa guerra e che riprenderà il controllo della Striscia di Gaza dopo la guerra.
I risultati indicano anche una significativa opposizione allo spiegamento di una forza di sicurezza araba nella Striscia di Gaza, anche se il suo scopo fosse quello di fornire sostegno all’Autorità Palestinese.
E si è parlato anche di rapporti con gli Stati Uniti e con gli altri paesi occidentali, accusati di non impegnarsi seriamente per una soluzione a due stati e di ignorare la necessità del sostegno umanitario alla gente di Gaza. La maggior parte dei palestinesi intervistati affermano di essere insoddisfatti della posizione di Stati Uniti, Germania, Gran Bretagna, Francia, Nazioni Unite e persino della Russia in questa guerra.
Inoltre, la stragrande maggioranza è insoddisfatta anche dei comportamenti di alcuni paesi arabi come Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Egitto e Giordania, mentre la percentuale di soddisfazione verso la Turchia e l’Iran è piuttosto alta.
La maggioranza afferma infine di essere soddisfatta del comportamento di Yemen, Qatar e Hezbollah. E tutto questo, crea ulteriori preoccupazioni a Netanyahu, oltre a legittimare, in un certo senso, la sua ostinazione verso la guerra.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
I rapporti tra Nazioni Unite e Israele non sono mai stati idilliaci. Le guerre che hanno visto impegnato il paese ebraico, la questione dei Territori, i confini. In questi luoghi tutti imparano ad avere a che fare con le Risoluzioni, a riconoscerne i numeri, a sapere compiti e poteri dei vari organismi. Ma in questo periodo, dall’aggressione di Hamas a Israele del 7 ottobre con conseguente attacco a Gaza, sembrano ormai irrimediabilmente compromessi i rapporti tra Israele e le Nazioni Unite.
La decisione da parte di Gerusalemme, formalizzata mercoledì, di revocare il visto a Lynn Hastings, coordinatore umanitario per le Nazioni Unite nella città santa, è stata solo l’ultima delle schermaglie tra le due parti. Il ministro degli esteri israeliano, Eli Cohen, ha infatti affermato senza mezzi termini che “chi non ha condannato Hamas per il brutale massacro di 1.200 israeliani ma condanna invece Israele, un paese democratico che protegge i suoi cittadini, non può prestare servizio nelle Nazioni Unite e non può entrare in Israele!”.
Per Israele, l’Onu è sempre stata troppo politicamente schierata verso la causa palestinese, ma ora, con la guerra a Gaza, le differenze e i contrasti si sono ulteriormente acuiti. Già pochi giorni fa la Hastings aveva sottolineato come i continui bombardamenti di Israele rendono difficili le operazioni umanitarie, senza mai però fare cenno alla condizione e alla sorte degli ostaggi israeliani a Gaza.
Oltre alla Hastings, Israele non vede di buon occhio nemmeno le continue esternazioni del Segretario Generale dell’ONU, Antonio Guterres. Il 18 ottobre Guterres aveva chiesto un cessate il fuoco immediato, condannando la punizione collettiva dei palestinesi.
Pochi giorni dopo, il 25 ottobre, aveva poi suscitato grande scalpore una sua frase, in cui aveva affermato che l’attacco di Hamas contro Israele il 7 ottobre non è avvenuto “nel vuoto poiché i palestinesi sono stati sottoposti a 56 anni di soffocante occupazione”. “I palestinesi – aveva aggiunto il segretario dell’Onu – hanno visto la loro terra costantemente divorata dagli insediamenti e piagata dalla violenza; la loro economia soffocata; la loro gente sfollata e le loro case demolite. Le loro speranze per una soluzione politica sono svanite”.
“Scioccanti, orribili e totalmente distaccate dalla realtà”, così furono immediatamente definite queste dichiarazioni dal rappresentante israeliano all’Onu, Gilad Erdan. Rincarò la dose il ministro Eli Cohen, che chiese a Guterres “dove vive, sicuramente questo non è il nostro mondo”.
A causa di queste frizioni, Cohen poi cancellò un incontro programmato con il segretario generale dell’Onu. “Dopo il 7 ottobre – ha detto varie volte Cohen – non c’è spazio per un approccio equilibrato”.
Guterres, forse per tentare di aggiustare il tiro in uno sforzo diplomatico, aveva alla fine detto che “le lamentele del popolo palestinese non possono giustificare gli spaventosi attacchi di Hamas. E questi terribili attacchi non possono giustificare la punizione collettiva del popolo palestinese”. Ma servì a poco.
In risposta a quella frase l’ambasciatore israeliano presso le Nazioni Unite, Gilad Erdan, aveva detto che sarebbero stati negati i visti ai funzionari delle Nazioni Unite. Cohen, nei giorni scorsi ha anche detto senza mezzi termini che Guterres non è idoneo a guidare l’Onu, accusandolo di sostenere Hamas e chiedendo le sue dimissioni. Il suo mandato a capo dell’agenzia è stato definito da Cohen come “un pericolo per la pace nel mondo”.
Da qui in poi è tutto stato un’accusa reciproca. Pochi giorni fa sui principali giornali israeliani è apparsa, con grande risalto, la notizia che uno dei prigionieri israeliani rilasciati durante la tregua di sette giorni era stato tenuto segregato da un’insegnante di una scuola gestita dall’Unrwa (l’organizzazione delle Nazioni Unite che si occupa dei rifugiati palestinesi). Accuse subito respinte dall’organizzazione, che le ha definite infondate e che ha controbattuto accusando Israele di bombardare le loro scuole e i loro edifici e che 130 persone del loro staff sono rimaste uccise nei raid israeliani.
Le scuole Unrwa attualmente ospitano circa 1,2 milioni di civili – due terzi di tutti gli sfollati a Gaza – sia nel nord che nel sud della Striscia. Ma in queste scuole sono state anche trovate armi dall’esercito.
Nel mirino delle polemiche, è finita anche l’Unicef la cui direttrice generale ha infatti rilasciato una dichiarazione in cui condanna genericamente le violenze sessuali perpetrate in Israele il 7 ottobre, senza però mai né menzionare né condannare apertamente Hamas.
Cosa che Israele ha ritenuto inaccettabile. Come pure il fatto che l’agenzia Onu per le donne ci ha messo 57 giorni per aprire un dibattito sugli stupri e le violenze contro le donne israeliane da parte di Hamas.
Il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, ha deciso intanto di tentare la sua ultima carta, invocando, per la prima volta dal suo insediamento, l’art. 99 della Carta delle Nazioni Unite. In una lettera inviata al Consiglio di Sicurezza, il capo delle Nazioni Unite ha utilizzato quello che è considerato lo strumento diplomatico più potente che ha a disposizione per portare all’attenzione qualsiasi questione che, a suo avviso, possa minacciare il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. “Ho appena invocato l’articolo 99 della Carta delle Nazioni Unite, per la prima volta nel mio mandato di segretario generale – afferma Guterres in un post su ‘X’ – di fronte al grave rischio di collasso del sistema umanitario a Gaza, esorto il Consiglio a contribuire a evitare una catastrofe umanitaria e faccio appello affinché venga dichiarato un cessate il fuoco umanitario”.
Cohen ha subito detto che è una mossa che vuole aiutare Hamas, perché un cessate il fuoco permette al gruppo che controlla Gaza di riorganizzarsi. La risoluzione per il cessate il fuoco è già pronta, ma, come sempre successo nella storia dei rapporti tra Israele e Onu, il primo può contare sul suo alleato americano, che ha il diritto di veto in Consiglio, per bloccare queste risoluzioni. Cosa che succederà ancora, aprendo di nuovo il dibattito sui veri poteri e ruolo del palazzo di vetro.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
“Stavolta l’ha combinata grossa, non sopravviverà politicamente. Mi ha deluso”.
Ronen è il mio padrone di casa. Ebreo i cui antenati sono arrivati dall’Iraq, moglie americana, guida una macchina totalmente elettrica, ha fatto fortuna nelle costruzioni. Possiede appartamenti a Gerusalemme, Tel Aviv e altre città. Come molti, gira con una pistola.
E’ sempre stato un sostenitore di Netanyahu. Nella chat del palazzo e in quella allargata alla strada di Gerusalemme dove vivo ha sempre strenuamente difeso Bibi, e quando non era in carica, criticava i governi del momento facendo campagna per lui all’approssimarsi delle elezioni.
“Stavolta è diverso – dice – non credo che lo sosterrò ancora. Per anni è stato l’unico che ci ha difeso, l’uomo del muro, del sistema anti razzo, quello che ha portato stabilità economica e sicurezza. L’unico che ci sembrava potesse rispondere alle nostre preoccupazioni per la sicurezza interna. Ed invece, quello che è successo il 7 ottobre mi ha fatto crollare tutto. Non me ne vado perché abbiamo lottato per riavere questo paese, questa terra è nostra, da sempre. E’ la nostra casa. Ma vederla violata in questo modo è davvero troppo. E’ triste doverlo ammettere, Netanyahu è il colpevole”.
L’idillio tra il più longevo primo ministro nella storia di Israele e il suo popolo, sembra oramai definitivamente finito. L’uomo che è stato capace dell’impensabile, di stringere patti con i paesi arabi, di arrivare addirittura a paventare un accordo con uno dei nemici storici, l’Arabia Saudita, oggi, politicamente parlando, è un morto che cammina. Lo sa bene, e le sue ultime uscite senza senso, come le accuse mosse ai servizi segreti per quanto successo il 7 ottobre, senza assumersi in prima persona alcuna responsabilità (accuse poi ritirate e per le quali si è scusato), rappresentano proprio questo momento di difficoltà.
Un sondaggio del Dialog Center, pubblicato dal Jerusalem Post, ha mostrato che il 94% degli intervistati ritiene che il governo di Netanyahu abbia almeno una parte di responsabilità per l’assenza di adeguate misure di sicurezza che hanno portato al massacro del 7 ottobre, mentre il 56% degli intervistati ha affermato che dovrebbe dimettersi dopo che la guerra è finita. Nel frattempo, il sostegno a Netanyahu è diminuito considerevolmente; un altro sondaggio condotto da istituti di ricerca israeliani, mostra che solo il 29% degli intervistati lo sceglierebbe come primo ministro preferito, secondo Bloomberg.
Gli israeliani sono pronti a perdonare tutto, ma non le falle sulla sicurezza. Era successo già a Golda Meir dopo l’attacco a sorpresa in occasione della festa dello Yom Kippur nel 1972. Guerra vinta ma che le costò il premierato. Dopotutto, Benjamin Netanyahu si è sempre presentato come Mister Sicurezza, ha fatto di questo argomento il cardine di tutte le sue campagne elettorali. Eppure, è proprio su questa che Netanyahu pagherà il prezzo più importante della sua carriera politica.
In un paese che fa della prevenzione il suo credo, con l’Iron Dome, il sistema missilistico e il muro che contiene gli ingressi dalla Cisgiordania, il fatto che oltre mille miliziani entrino indisturbati da Gaza e massacrino quasi 1500 israeliani di ogni sesso ed età e se ne portino nella Striscia oltre 230, è davvero inaccettabile per la popolazione.
Non è soltanto un fallimento dell’intelligence, una delle più quotate al mondo e che si è presa le proprie responsabilità, come pure il ministro della difesa. Ma è anche un problema strategico recente e più vecchio.
Il governo Netanyahu è appoggiato da alcuni partiti di estrema destra che hanno nei coloni la loro base elettorale. Uno di questi è stato anche l’unico a votare contro l’accordo con Hamas per la liberazione degli ostaggi. Partiti che non vorrebbero nessun arabo in questa terra martoriata e che promulgano la costruzione di nuove colonie illegali. Visto che quest’anno era già segnato come uno dei più tragici per il numero di vittime negli scontri con i palestinesi nei territori occupati, a difesa di queste colonie, il ministro della sicurezza interna, più che un alleato di Netanyahu (anche se spesso una presenza troppo ingombrante), aveva spostato qui diverse truppe. Che poi il 7 ottobre hanno fatto fatica a raggiungere i confini con Gaza, le città e i kibbutzim oggetti del massacro.
Per molti critici, però, il fallimento derivante dall’attacco del 7 ottobre, non è dovuto solo a scelte sbagliate recenti, ma anche a errori strategici del premier negli ultimi anni. Soprattutto quando, per delegittimare l’Autorità nazionale Palestinese (che, a dire il vero, già era in autonomia sulla buona strada per non essere più rappresentativa del proprio popolo), ha in qualche modo potenziato Hamas, cercando di contenere i militanti con un misto di deterrenza militare e incentivi economici.
Neanche la vittoria nella guerra potrà salvarlo. Per lui c’è una uscita onorevole, se dovesse ammettere di aver sbagliato e se dovesse vincere, annientando Hamas. Vittoria (come la sconfitta, nel caso) che condividerebbe con il suo ex premier a rotazione, ex capo di stato maggiore Benny Gantz che, dall’opposizione, ha accettato di entrare nel gabinetto di guerra.
E già si parla del futuro, di una sua vita lontano da Israele, con l’ascesa del figlio Yair, che già si è fatto conoscere per molti commenti sui social, come suo possibile successore.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Intervista a Nabil Abu Rudeineh, Vice Premier e Ministro dell’Informazione palestinese. La colpa, secondo il portavoce di Abu Mazen, non è solo di Israele, ma soprattutto americana, per il disinteresse di Biden a una soluzione del problema palestinese.
“Non c’è né Hamas né Fatah. L’unico rappresentante del popolo palestinese è l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Solo con noi e con il suo presidente, Mahmoud Abbas (Abu Mazen, ndr), bisogna parlare”.
E’ perentorio Nabil Abu Rudeineh, vice premier e ministro dell’informazione palestinese. Politico di lungo corso, è nel comitato centrale di Fatah ed è attualmente anche portavoce del presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese, posizione che ricopriva anche con Yasser Arafat.
Lo incontriamo nel palazzo presidenziale di Ramallah, il Muqata. Da un lato c’è il mausoleo e il museo di Arafat, quest’ultimo ospitato nei luoghi che lo videro confinato negli ultimi giorni della sua vita sotto assedio dei carri israeliani. Dall’altro, gli uffici della presidenza dell’organo amministrativo palestinese, nato nel 1993 con gli accordi di Oslo e che avrebbe dovuto traghettare la Palestina alla creazione di un nuovo stato.
Il massacro del 7 ottobre e la guerra a Gaza hanno sicuramente messo in ombra l’Anp e il suo presidente Abu Mazen. I palestinesi da tempo hanno perso fiducia in lui e si spostano sempre più verso Hamas, considerando questi gli unici che si battono per la loro causa. Ma il governo di Ramallah, secondo il portavoce, è impegnato a tenere ferma la barra, continuando i negoziati.
“Non ci siamo mai tirati indietro, ci siamo sempre seduti a qualsiasi negoziato e sarà sempre così”, ci ha detto Nabil Abu Rudeineh, sottolineando che l’unico interlocutore per la soluzione del problema palestinese è l’Organizzazione per la liberazione della Palestina, l’organo che rappresenta tutti i palestinesi, anche quelli della diaspora.
A Ramallah sono certamente preoccupati per l’evolversi del conflitto, anche perché oltre a drenare consensi a Fatah, il partito reggente, e alla stessa Autorità nazionale Palestinese, la guerra ad Hamas sta minando parecchio il dialogo che, comunque, negli ultimi anni era fermo. La colpa, secondo il portavoce della presidenza palestinese, non è solo di Israele, ma soprattutto americana. L’arrivo dell’amministrazione Biden, infatti, era stato visto come un momento di rottura con Trump e le sue politiche anti palestinesi, come vengono considerate, dimostrate, secondo Ramallah, dallo spostamento dell’ambasciata americana da Tel Aviv a Gerusalemme, dalla chiusura della sede palestinese a Washington, dal taglio degli aiuti. Questioni a cui Biden aveva promesso di porre rimedio e che invece, ad oggi non sono cambiate.
“Ogni volta – dice Nabil Abu Rudeineh – quando incontra il nostro presidente, anche pochi giorni fa, Biden promette che cambia la situazione, ma non lo ha fatto mai e non credo lo farà”. Per il portavoce, alla fine anche Trump aveva un piano per la Palestina, non condiviso da questi, ma un piano lo aveva presentato. Come pure tutti i suoi predecessori. Biden invece ha mostrato totale disinteresse alla cosa.
Il pericolo, per il governo di Ramallah, non è solo la stasi nella pace dell’area, ma che la stessa possa tramutarsi in un intero campo di battaglia, con il conflitto attuale che potrebbe allargarsi.
“Questo – spiega il ministro dell’informazione – è deleterio e un problema serio non soltanto per noi qui, ma anche per voi in Europa”.
Secondo il politico palestinese di lungo corso, infatti, un conflitto ampio in tutto il Medio Oriente, da un lato significa problemi di sicurezza in tutta Europa, dall’altro un maggiore problema di emigrazione. La destabilizzazione dell’area avrebbe così, secondo Ramallah, riverberi in tutto l’Occidente, principalmente nel vecchio continente sia per la vicinanza, sia per la forte presenza di cittadini provenienti dai paesi di quest’area.
La soluzione è nelle mani degli Stati Uniti, più che di Israele.
“Washington – ha detto Rudeineh – deve fare pressione sugli israeliani. Sono gli unici che questi ultimi ascoltano. La prima cosa da fare è un cessate il fuoco. Dopo di questo, ci possiamo tornare a sedere. Noi siamo aperti a qualsiasi discorso, abbiamo dimostrato di essere aperti a concessioni. Dobbiamo tornare a parlare sulla base delle risoluzioni Onu, di Gerusalemme est e dei confini del 1967”.
In questa nuova fase negoziale, un importante ruolo lo giocano anche i paesi arabi che, secondo Ramallah, non hanno voltato le spalle al popolo palestinese e l’ultima volta che si sono riuniti pochi giorni fa hanno lanciato un chiaro messaggio di sostegno.
Ma la guerra, per l’autorità palestinese, non è solo quella che si combatte a Gaza. Il portavoce lamenta che si è di fronte ad una “guerra contro i palestinesi”, visto che continuano incessanti i raid dell’esercito israeliano in Cisgiordania, nel territorio controllato dall’Autorità Nazionale Palestinese, dove circa 200 morti sono stati registrati dall’inizio del conflitto. Raid che comunque vengono anche organizzati di concerto con la stessa Anp, in base al coordinamento di sicurezza voluto dagli accordi di Oslo.
Spesso sfuggono di mano, come anche fuori controllo sono gli attacchi dei coloni israeliani, contro i quali anche Netanyahu si è lamentato. La pacificazione, pertanto deve interessare l’intera area per essere credibile e per evitare l’allargamento di un conflitto a proporzioni non più contenibili.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Nelle discussioni sul futuro del Medio Oriente dopo la guerra di Gaza, più volte è stata tirata in ballo l’Autorità Nazionale Palestinese e da più parti. L’organo amministrativo dei territori cisgiordani, nato 30 anni fa con gli accordi di Oslo, che avrebbe dovuto traghettare i palestinesi verso la creazione del loro stato, di fatto è un ente senza rappresentatività. Questo perché il suo ottuagenario leader Mahmoud Abbas (Abu Mazen) da subito ha capito che la via del dialogo mal si combaciava con le velleità e le idee di Hamas che, alla prima occasione, hanno dimostrato tutta la loro forza.
Alle prime elezioni dopo Oslo, quelle del 1996, Hamas non volle partecipare, per non dare legittimità all’Autorità Nazionale Palestinese, nella quale non ha mai creduto, così come ha sempre avversato e non riconosciuto, come d’altronde è scritto nel suo statuto, qualsiasi accordo con Israele, visto tra l’altro che non riconosce lo stato ebraico e lotta per l’eliminazione di questo e degli ebrei.
Fatah, che già nell’ambito dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina era il gruppo più forte, ottenne una schiacciante vittoria che servì a Yasser Arafat, eletto primo presidente dell’Anp, anche a dimostrare al mondo intero la volontà democratica palestinese che avrebbe poi dovuto portare alla creazione dello Stato.
Yitzhak Rabin, l’altro artefice degli accordi di Oslo, era morto da poco quando si tennero le elezioni e il processo di pace sembrava già in salita, molto di più di prima. Fallirono tutti i negoziati, morì Arafat, e furono convocate altre elezioni nel 2005 (presidenziali, nelle quali Abu Mazen ebbe un plebiscito) e politiche nel 2006 (con la vittoria di Hamas).
La sconfitta, per pochi punti, di Fatah alle politiche, l’incarico a Ismail Haniyeh, capo di Hamas, come premier, la guerra civile con la presa di potere di Gaza da parte di Hamas, hanno creato una profonda frattura nella società palestinese.
In quest’ultima, Fatah e l’Autorità Nazionale Palestinese, sono visti come corrotti e asserviti a Israele. Complici anche le promesse non mantenute, la continua ed esponenziale espansione delle colonie in Cisgiordania, i quasi quotidiani raid dell’esercito israeliano nei territori palestinesi, soprattutto in città come Nablus e Jenin dove il dissenso e la radicalizzazione, a causa di questi raid, sono andati ad aumentare. E’ da qui che parte la rivolta contro il potere centrale a Ramallah. E’ da qui che si chiede un cambio di passo, con la restaurazione di Hamas al potere. Una mossa che significherebbe rottura totale con Israele, ma anche con altri paesi occidentali, che potrebbero così anche tagliare i cordoni della borsa. La stessa che in questi anni ha arricchito non poco l’Anp.
Hamas, con il controllo di Gaza, rappresenta uno stato nello stato palestinese. Ha un suo parlamento, un suo apparato amministrativo e politico. Due stati palestinesi non possono esistere e difficilmente si autorizzerà la nascita di uno stato sotto l’egida di chi vuole la distruzione totale del suo vicino (o di alcuno).
Hamas, con i suoi razzi, molto spesso azioni dimostrative con i cani sciolti in Cisgiordania che attaccano in particolare i militari ai check point e soprattutto con il massacro del 7 ottobre, ha dimostrato ai palestinesi di essere l’unico partito ad interessarsi delle loro sorti. In molti analisti parlano dell’esito insperato, in particolare nei numeri, per il massacro del 7 ottobre, e di una frizione tra l’ala militare delle Brigate al Qaasam, che combattono sotto le bombe e i colpi israeliani, e quella politica, i cui esponenti, a parte forse Yaya Sinwar, sono tutti all’estero al riparo.
Proprio per il crescente consenso di Hamas nei Territori, che si è tradotto nella conquista della maggior parte dei seggi alle elezioni studentesche in Cisgiordania da parte del gruppo che controlla Gaza e liste ad esso collegate, Abu Mazen non convoca elezioni, sicuro di perderle. L’80% dei palestinesi, secondo sondaggi, non lo vuole più. Eppure dalla Muqata, il palazzo presidenziale di Ramallah, e negli incontri che ha avuto con i leader di tutto il mondo nelle scorse settimane, Abu Mazen è sembrato possibilista sulla presa di controllo di Gaza se nell’ambito di un piano rivisto e migliorato, implementato, della soluzione a due Stati. Ribadendo che l’unico interlocutore dei palestinesi con il mondo è l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina, non Hamas, non Fatah, non l’Anp. In termini pratici cambia poco, visto che è lui il presidente dell’ombrello sotto il quale ci sono tutti i palestinesi, anche quelli della diaspora, anche Hamas. Ma in termini politici no, dal momento che l’Olp è, come dicevamo, il rappresentante di tutti i palestinesi. A dire: Hamas è parte, non il tutto, siamo noi a parlare per loro. E accettando di prendere il controllo di Gaza, di fatto Abu Mazen accetta l’estromissione del gruppo che controlla Gaza e, soprattutto, dei modi brutali che adopera. Resta da capire con quale consenso.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
La guerra ad Hamas sul suolo della Striscia di Gaza, che si sta combattendo da quando il gruppo e gli altri simili dell’enclave hanno perpetrato il massacro lo scorso 7 ottobre, si combatte nei cieli, nelle acque, sul terreno della lingua di terra tra Israele ed Egitto e nelle sedi diplomatiche internazionali.
Già perché il conflitto, complici vecchie alleanze e disaccordi, propaganda e atavici risentimenti, ha polarizzato due schieramenti nei quali non è difficile riconoscere diverse posizioni nell’ambito della stessa parte. Soprattutto, non tanto sulla discussione della gestione della guerra, ma riguardo al futuro assetto dell’area.
Da un lato, i paesi arabi. Al loro interno c’è chi è alleato di Israele, come Egitto e Giordania, che però non hanno alcune interesse a sobbarcarsi la gestione dei profughi palestinesi.
In particolare, Amman “ha già dato”, dal momento che ospita una delle maggiori diaspore palestinesi a seguito delle varie guerre e dello stesso controllo del regno Hashemita sulle aree al di là del fiume Giordano rispetto alla proprio territorio. Tra l’altro, la convivenza non è mai stata delle migliori: non dimentichiamoci che proprio in uno di questi campi profughi nacque il dissidio che portò allo scontro armato di Settembre Nero, con la volontà palestinese di sovvertire il potere in Giordania e creare un proprio Stato lì. Dalle sue ceneri nacque anche l’omonimo gruppo, protagonista indiscusso della fase terroristica della seconda metà del secolo scorso. E fu proprio un palestinese ad uccidere nella moschea di Al Aqsa Abdallah I, il fondatore del moderno stato giordano sorto sulle ceneri della Transgiordania.
L’Egitto non ha una storia di relazioni così turbolente con i palestinesi, ma non vuole che i campi profughi, come quelli in Cisgiordania, in Giordania, in Siria diventino veri e propri conglomerati urbani sul suo territorio. Un’area, tra l’altro, già difficile, quella del Sinai, per la presenza di bande di beduini che ne controllano gran parte. Da qui il rifiuto egiziano a prendersi i profughi gazawi nonostante anche Israele gli abbia promesso in cambio la cancellazione del debito. Il suo impegno è talmente forte, nel lasciare lo status quo, che al Sisi, strenue avversario dei Fratelli Musulmani, contro i quali ha fondato il suo potere, ha ospitato nei giorni scorsi al Cairo Ismail Haniyeh, capo politico di Hamas, organizzazione nata come filiazione proprio dei Fratelli Musulmani.
Oltre a loro, gli alleati sono i recenti sottoscrittori degli accordi di Oslo, Bahrein Emiratie Arabi in testa, che hanno ovviamente criticato i bombardamenti israeliani ma non sono andati oltre, auspicando il cessate il fuoco.
L’Arabia, che era data per prossima firmataria della pace con Israele, anch’essa si sta impegnando per pace e ostaggi, ma non ha usato, come avrebbe potuto, più di tanto parole contro lo stato ebraico.
Il Qatar, che pure non ha rapporti con Israele, è l’attore principale insieme all’Egitto per la liberazione degli ostaggi, forte dei suoi rapporti con Hamas, visto che ne ospita il lider maximo e altri e finanzia sia il partito che i cittadini gazawi. L’impegno qatarino, è chiaro, è favorito dalle pressioni americane.
Gli Usa hanno criticato l’alleato israeliano quando da Gerusalemme è stato detto che “Israele manterrà la responsabilità della sicurezza a Gaza per un tempo indefinito”. Che voleva dire Netanyahu? Che il suo paese occuperà Gaza? Che caccerà i locali e diventerà un luogo di insediamenti come prima del 2005? In una intervista giovedì sera (americana) a Fox News il premier israeliano ha detto chiaramente che Israele non cerca di spostare i palestinesi nella guerra contro Hamas, aggiungendo che “Ciò che dobbiamo vedere è Gaza smilitarizzata, deradicalizzata e ricostruita. Tutto ciò può essere raggiunto. Non cerchiamo di conquistare Gaza. Non cerchiamo di occupare Gaza. E non cerchiamo di governare Gaza”. Il giorno dopo, parlando ai sindaci della fascia intorno a Gaza, ha detto che “Le forze dell’Idf (l’esercito israeliano, ndr) manterranno il controllo della Striscia, non lo daremo alle forze internazionali”, secondo una lettura del suo portavoce.
Le dichiarazioni sono in contraddizione? Che abbia cambiato idea su pressione americana? Più probabile che Netanyahu non abbia mai avuto la voglia di accollarsi il problema anche solo della ricostruzione di Gaza, che in termini economici sarà onerosa, oltre che socialmente difficile. E non solo per i gazawi, ma soprattutto per gli israeliani, nei quali oramai sono insiti sentimenti di forte di condanna, risentimento e paura oltre che di orrore per quanto successo il 7 ottobre nelle città e kibbutzim a ridosso della striscia.
Netanyahu sicuramente pensa ad una zona cuscinetto ampia tra la Striscia e il suo territorio. Niente di contraddittorio nelle sue affermazioni. Una cosa è la sicurezza, una cosa la gestione della Striscia.
L’idea internazionale sarebbe quella di portare Gaza sotto l’ombrello dell’Autorità Nazionale palestinese. Abu Mazen, che ha perso il controllo della striscia dove di fatto c’è un altro “stato palestinese” oltre a quello cisgiordano, ha detto che non sarebbe mai entrato a Gaza su un carro armato israeliano. Ma comunque, ci sarebbe entrato. E dal momento che gli accordi di Oslo prevedono un coordinamento di sicurezza tra Israele e l’Anp, per il quale l’esercito, previa informativa, può entrare nei territori palestinesi in operazioni ritenute utili per la sua sicurezza, ecco che la stessa cosa potrebbe avvenire su Gaza.
Senza contare poi altre due questioni.
Uno dei criteri per il riconoscimento di uno stato, è il controllo territoriale, cosa che l’Anp non ha, sia per i coloni ma anche per Hamas, a Gaza. E Abu Mazen ha scaltramente detto di volersi interessare a Gaza in un discorso che porti alla creazione dello stato palestinese.
Il secondo punto è il successore dell’ottuagenario presidente palestinese, che potrebbe essere Mohammed Dahlan, l’uomo avversato da Abu Mazen con il quale condivide l’appartenenza al partito Fatah, che vive negli Emirati e che gode di molto credito dentro e fuori la Palestina. Ma che, soprattutto, è di Gaza.
—
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Lo scoppio della guerra a Gaza ha rimesso in discussione tutti gli accordi che Israele aveva sottoscritto da anni con i paesi islamici. Sia quelli più antichi, come con Egitto e Giordania, sia quelli più recenti, ricaduti nell’ambito degli Accordi di Abramo, con Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Marocco e Sudan.
Questo perché il massacro che ha compiuto Hamas, al quale è seguito il bombardamento indiscriminato della striscia di Gaza, non è stato condannato dai paesi arabi, puntando invece il dito sul secondo. Le posizioni occidentali, da quelle arabe, differiscono su questo. I primi, condannano il massacro e riconoscono il diritto a Israele di difendersi, ma allo stesso tempo ammettendo la strage di civili a Gaza, chiedono dalla tregua al cessate il fuoco per permettere l’arrivo di più aiuti. I secondi non tengono in considerazione quanto accaduto il 7 ottobre, accusando Israele del genocidio dei civili a Gaza attraverso i bombardamenti.
Due posizioni che riscrivono la mappa dell’area, fortificando antiche alleanze, rendendo più forti nuovi rapporti e facendo chiaramente emergere alcuni attori.
Gli ultimi due a negare la condanna al massacro del 7 ottobre sono stati Turchia e Giordania. Qualcuno, si è spinto anche oltre. Il presidente turco, Erdogan, che ospita spesso i vertici di Hamas, non vuole perdere, anzi vuole conquistare sempre più, la sua leadership nel mondo arabo. La dichiarazione secondo la quale Hamas opera solo per la liberazione della sua terra e i suoi miliziani sono dei mujaheddin che lottano per la libertà, va proprio in questo senso.
Che Erdogan abbia mire espansionistiche su Gerusalemme, è noto. Il sultano turco farebbe carte false pur di assicurarsi la gestione e la custodia della Spianata delle Moschee, diventando così il punto di riferimento del mondo islamico, facendo concorrenza all’Arabia Saudita che già lo è dal punto di vista religioso e al Qatar che lo è dal punto di vista economico.
In una intervista con la giornalista della Cnn Christiane Amanpour, la regina Rania di Giordania si è rifiutata, a specifica domanda, di condannare il massacro del sette ottobre, parlando di doppio standard occidentale, quando non si condannano le morti dei bombardamenti israeliani. E’ chiaro, pesano le sue origini palestinesi, ma è sintomatico di un sentimento unico nell’area.
Che poi è quanto ha espresso anche il segretario generale dell’Onu, criticato da Israele: quanto successo il 7 è conseguenza delle azioni israeliane, non tenendo però conto che giocando al gioco dell’uovo e della gallina, non si arriverà mai al termine o all’origine della questione. Qualcuno si spinge a dire che il massacro ad opera degli uomini di Gaza sia un atto di resistenza.
Se non li hanno definitivamente affossati, i bombardamenti a Gaza hanno certamente congelato e messo in discussione gli Accordi di Abramo. Ed è un peccato non solo per gli attori, ma per l’intero mondo mediorientale. Un Medioriente pacificato, che però non può prescindere da uno stato indipendente palestinese, è nell’interesse di tutti. Gli accordi non tendevano a pugnalare alle spalle Ramallah, ma semmai potevano servire anche ad ammorbidire le posizioni israeliane e, forse, con un cambio di leadership nei Territori, come auspicato dagli stessi palestinesi, si sarebbe potuto fare un passo avanti. Dopotutto Abu Mazen ha mostrato di camminare con due piedi in una scarpa: da un lato ha lodato gli atti di resistenza palestinesi, dall’altro ha detto, per poi ritrattarlo, che quanto fatto da Hamas non corrisponde al pensiero dei suoi.
In questa situazione i sottoscrittori degli accordi Abramo stanno alla finestra, a guardare. L’alleanza strategica ed economica con Israele è importante, ma certo non si possono giustificare i bombardamenti nei quali muoiono i civili, anche perché i vertici di Hamas vivono all’estero. Stesso discorso per i Sauditi, che sembravano avvicinarsi e che ora, pur consapevoli dell’importanza strategica di un accordo con Israele, devono giocoforza allontanarsi. Anche perché perdono di influenza rispetto al Qatar, che sta diventando il gestore del pallino per la questione degli ostaggi, nodo cruciale della questione; rispetto all’Iran, che aiuta, sostiene e finanzia la “resistenza” palestinese antiisraeliana attraverso Hamas, Hezbollah e Jihad Islamico Palestinese; rispetto alla Turchia che, oltre ad ospitare i vertici dei mujaheddin, è l’unico tra questi paesi che ha rapporti, seppur turbolenti, con Israele. Un panorama di relazioni intricate nelle quali la guerra sta anche spingendo ad una corsa alla leadership dell’area.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Israele è in guerra, e la guerra, stavolta, è in casa. Nell’ultimo giorno della festa ebraica di Sukkot, il Paese si è risvegliato più che con i razzi (ai quali tristemente sono tutti abituati, con la loro liturgia fatta di sirene e fughe nei rifugi) con la massiccia infiltrazione di terroristi di Hamas che da Gaza hanno letteralmente conquistato oltre 700 vittime, oltre 2000 feriti, oltre 100 ostaggi nelle mani dei terroristi.
Almeno un migliaio di miliziani, secondo fonti dell’esercito, avrebbero portato il terrore in città e insediamenti del sud di Israele, mentre sulle teste di tutti volavano oltre 4500 razzi.
Proprio lo spostamento dell’area di guerra, dal cielo alla terra, ha creato ancora più scompiglio, polemiche e non fa presagire nulla di buono. Israele ha messo per un attimo da parte le polemiche politiche e si è unito. Dalla maggioranza all’opposizione si chiede una risposta ferma, anche i partiti arabi si sono fatti sentire chiedendo alla popolazione non ebraica di non rispondere ai richiami di Hamas.
Una prima, forte risposta israeliana non si è fatta attendere. Dopo circa quattro ore di lanci di razzi, è partito il primo attacco a Gaza. Si contano circa 300 vittime palestinesi, secondo fonti locali. Ma sono i settecento israeliani che pesano su tutto il governo, dovuti in particolare all’operazione dei terroristi di Hamas e dei sodali del Jihad Islamico Palestinese che hanno portato casa per casa per prendere civili e militari. Facile, troppo facile, per i miliziani infiltrarsi con brecce nella recinzione e parapendii a motore, soprattutto in un’area che dovrebbe essere ipercontrollata. L’attacco di sorpresa lascia strascichi e polemiche nei confronti del governo ma, soprattutto dei servizi segreti. Un bilancio di vittime pesante, che ha fatto piombare Israele nella paura.
Strazianti le chiamate e i messaggi sui social dei cittadini israeliani sotto assedio dei terroristi che hanno chiesto aiuto all’esercito. Israele si sta muovendo per gli ostaggi. Tra loro anche cittadini stranieri, americani, ucraini, thailandesi e nepalesi. Orrende e terrificanti le immagini diffuse sui social, con i corpi dei soldati dileggiati dai miliziani e portati in trionfo per le strade della striscia. Tutto rientra nella politica di propaganda di Hamas.
Israele ha sempre operato sin dall’inizio della sua creazione per la salvezza dei suoi cittadini. Questo fa temere un attacco forte nei confronti di Gaza, forse anche di terra, cosa che non succede da tempo. Sono state già trasferite al sud diverse divisioni corazzate. Ma tutte le opzioni sono sul tavolo, il governo di Benjamin Netanyahu sta valutando il da farsi anche perché c’è il pericolo che il conflitto si espanda nei territori palestinesi.
Il Presidente Mahmoud Abbas (Abu Mazen) ha affermato che il suo popolo ha il diritto di difendersi dal “terrore dei coloni e delle truppe di occupazione”. Lo ha dovuto fare per non perdere terreno con Hamas che, con questa operazione, ha recuperato ancora di più posizioni. In diverse città palestinesi sono stati festeggiati gli attacchi da Gaza e l’infiltrazione, cosa che può far aizzare movimenti che, soprattutto nella fascia di Jenin e Nablus, negli ultimi mesi hanno rappresentato una vera e propria spina nel fianco di Israele. Anche Hezbollah a nord si è fatto sentire, sparando colpi di mortaio contro Israele. Il Presidente iraniano Raisi si è congratulato con Hamas e Jihad per il successo dell’operazione. Dopotutto Hamas ha molto seguito nei Territori: i suoi esponenti hanno vinto senza problemi le elezioni nelle università palestinesi, radicalizzando così i giovani. Incitazioni alla sommossa sono state udite in moschee anche a Gerusalemme est. La città vecchia di Gerusalemme è stata chiusa per diverso tempo, come lo è stato l’aeroporto di Tel Aviv per qualche ora dove molte compagnie ancora oggi non volano.
In un discorso alla nazione, ieri sera il Presidente Herzog ha richiamato all’unità nazionale, promettendo che Hamas, guidata dice dall’Iran, non vincerà. Unione che si manifesta anche con la possibilità di un governo di unità nazionale che abbracci tutto l’arco politico.
Ieri la città santa doveva riaprire dopo le feste, invece le sirene del giorno prima, i boati dei razzi intercettati, hanno obbligato alla chiusura di scuole e uffici almeno per un altro paio di giorni, mentre i negozi della parte est erano in sciopero così come tutta la Cisgiordania. La paura è tanta, così come la delusione. Non si sa che pesci prendere. La gente dorme nei rifugi. Le immagini delle famiglie uccise a sangue freddo, di bambini che hanno visto i loro genitori morire sotto i colpi dei terroristi infiltrati in casa, dei corpi dileggiati e portati come trofei, dei rapimenti, rappresentano un monito indelebile.
Mohammed Deif, il capo delle brigate Izz’al Dim Al Qassam, braccio armato di Hamas, che si è intestato l’operazione, che ha chiamato “Alluvione di al Aqsa”, ha spiegato in un messaggio che l’attacco è una rappresaglia per la “profanazione” israeliana della moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme e contro l’occupazione israeliana, chiamando a raccolta non solo i palestinesi dell’area, ma anche i combattenti di Siria e Libano e gli arabi israeliani a sollevarsi contro Israele.
L’attacco a sorpresa è arrivato l’ultimo giorno della festa ebraica di Sukkot, che chiude il ciclo dei festeggiamenti di inizio anno ebraico, cominciato con Rosh Hashanah e proseguito con Yom Kippur. Uno dei periodi più sacri dell’anno per gli israeliani, quando si riuniscono le famiglie e molti israeliani ed ebrei viaggiano nel Paese e all’estero per stare con i parenti o approfittare delle scuole chiuse per viaggiare. Hamas ha lanciato l’operazione il giorno dopo la data che ha segnato il cinquantesimo anniversario dell’attacco a sorpresa di Egitto e Siria, che diede inizio alla guerra dello Yom Kippur, il 6 ottobre 1973. Inoltre venerdì migliaia di manifestanti nella Striscia di Gaza hanno festeggiato l’anniversario della nascita del movimento di Hamas, che ha visto la luce nel 1987 come filiazione palestinese dei Fratelli Musulmani, dediti al Jihad.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Trenta anni fa, il 13 settembre 1993, nel giardino della Casa Bianca a Washington il Premier laburista israeliano Yitzhak Rabin e il leader dell’Olp Yasser Arafat si stringevano la mano dinanzi a Bill Clinton, Presidente americano, sugellando quelli che sono noti come gli Accordi di Oslo e che avrebbero dovuto portare ad una duratura pace in Medio oriente e alla creazione dello stato palestinese. Avrebbero, perché di tutto il carico di speranze che questa stretta di mano portava, dopo guerre, morti, attentati, intifada, soprusi, non è rimasto nulla. Anzi: la ferma convinzione che sono stati un fiasco, più legati alle personalità dei firmatari che alla reale volontà di cambiamento.
Quattro anni dopo lo scoppio della prima intifada, nel 1991 prende il via il primo tentativo di conciliazione vero tra israeliani e palestinesi, la conferenza di Madrid, che porterà, anni dopo, al solo trattato di pace tra Israele e Giordania. Solo, perché la questione palestinese fu messa da parte, anche perché l’Olp non era riconosciuto come un interlocutore attendibile vista la miriade di gruppi palestinesi presenti, alcuni dei quali avevano lanciato vere e proprie campagne di terrore in tutto il mondo. Non solo: Arafat era stato tra i pochissimi ad appoggiare, anche all’interno della Lega Araba, Saddam Hussein nella sua invasione del Kuwait e negli eventi successivi.
Mentre si discuteva a Madrid e in Terra Santa si sparava e si moriva, a Oslo, su iniziativa norvegese, funzionari israeliani e palestinesi dell’Olp in gran segreto si riunivano più volte per trovare una soluzione. Che sfociarono appunto nella stretta di mano del 13 settembre e negli accordi che presero il nome della città norvegese e che avrebbero dovuto ridisegnare il Medio Oriente. L’idea alla base delle intese, era quella di favorire la creazione di un’amministrazione civile per i palestinesi in Cisgiordania e Gaza e, dopo cinque anni, avviare trattative sullo status permanente dei Territori. Cosa sarebbe dovuta essere questa entità permanente, non si sapeva. I palestinesi volevano uno stato indipendente, gli israeliani quasi sicuramente no.
Di fatto Oslo ha aumentato l’occupazione e il problema dei palestinesi. Perché da un lato la separazione della Cisgiordania in tre aree (A, B o C a seconda di chi le controlla e in che modo) non ha fatto altro che aumentare la presenza israeliana nelle aree condivise, aumentare le colonie in quelle palestinesi e stringere ancora di più i palestinesi in un’area ristretta. Cosa che la nascita del muro di separazione da una parte e la presa di potere di Gaza da parte di Hamas dall’altra, hanno esacerbato, impedendo di fatto la circolazione libera dei palestinesi anche nella stessa loro terra riconosciuta tale. Dall’altro lato, la nascita dell’Autorità nazionale Palestinese, l’ente amministrativo che avrebbe dovuto gestire i palestinesi fino alla nascita dello Stato, ha creato una “apartheid nell’apartheid”. Già perché il governo attuale, nella persona del suo presidente, è in carica sin dalla sua prima elezione nel 2005. Da allora, nessuna elezione, nessun cambiamento, rendendo ancora più difficile la vita ai palestinesi. È per questo che, sono convinto, dalla situazione o problema palestinese, siamo ora passati alla situazione o problema dei palestinesi. Perché di questo parliamo, dei cittadini di uno stato che non ci sarà mai, oramai è chiaro.
Secondo alcuni, soprattutto analisti palestinesi, Oslo è fallito nel momento stesso che è stato concepito. Anche perché c’era e c’è un problema culturale nella comunità palestinese, dimostrata dal fatto che ad oggi nessuno (o pochi) ha mai manifestato per rimuovere il Presidente Mahmoud Abbas, nonostante la maggioranza dei palestinesi non lo voglia. La gestione di uno stato in questi termini sarebbe stata difficile. Ma poi, che stato? Uno i cui confini sono tutti (ad eccezione dell’area di Gaza) con Israele. Una sorta di San Marino o Vaticano per l’Italia, o Andorra per la Spagna. Uno stato che non ha risorse, non batte moneta, che anche a causa della propria classe dirigente si è isolato da molti paesi arabi che prima lo sostenevano. Non a caso, non sono in pochi nei Territori che sono convinti che l’unica soluzione sia la dissoluzione dell’Autorità Nazionale Palestinese, cosa che di fatto sancirebbe l’occupazione israeliana dei territori con tutto quello che comporta nel diritto internazionale. Dopotutto, Israele non ha fatto molto per far sì che nascesse lo stato palestinese, anche giustamente dal suo punto di vista.
Per analisti israeliani, invece, la morte di Rabin per mano dell’estremista di destra Yigal Amir, ha sancito la fine di Oslo. I governi di destra che si sono succeduti dopo Rabin, un Arafat non più leader così carismatico, la mancata attuazione di diversi punti di Olso 1993 ed altri ingredienti portarono nel 2000 al fallimento di Oslo 2, l’accordo che avrebbe dovuto definire tutto quello che non era stato definito sette anni prima, come lo status di Gerusalemme, i confini, i profughi, le risorse. Risultato? Il limbo nel quale si vive oggi.
Oramai non si sa più a cosa credere: l’ipotesi due stati pare definitivamente tramontata, nonostante Europa e Usa spingano sempre in questa direzione; qualcuno parla di federazione, altri di uno stato. Ma si rischierebbe una sorta di modello cinese, dove però quelle che dovrebbero essere provincie autonome come Xinjiang e Xizang (il Tibet) di fatto sono territori occupati dove non c’è alcun tipo di libertà, neanche per i musulmani farsi crescere la barba o farsi chiamare Mohammad.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Un asse diplomatico nuovo sta cambiando le regole di ingaggio in Medio Oriente. Un asse che parte da Pechino e, passando per Riad, attraversa e lega i paesi dell’area, finendo a Mosca. E riparte da qui, visto che la Russia ha sempre tenuto un piede nell’area. Un’asse reso possibile soprattutto da una assenza pesante: quella degli Stati Uniti che, in considerazione dell’impegno nel Pacifico per arginare la Cina, e distratta dal conflitto in Ucraina, si è disinteressata di un’area nella quale ha fatto, volente o nolente, il bello e cattivo tempo per anni. In maniera diretta o tramite delega a Israele.
In quest’asse, sia per questioni geografiche, che di interesse nell’area, che di autorevolezza pure legata alla religione, l’Arabia Saudita mantiene una sicura centralità. Sinistra per molti aspetti, legata soprattutto ai sotterranei e palesi rapporti che Riad intrattiene con molti degli “stati canaglia” dell’area e gruppi legati al terrorismo. Da un lato l’Arabia, per questioni storiche ma soprattutto economiche mantiene rapporti stretti con Washington dettati più alla necessità che altro, dall’altra non ha disdegnato ristringere relazioni, facendoli risiedere ai tavoli che contano, con Paesi come Iran e soprattutto Siria. Sinistra centralità che l’Arabia mantiene anche grazie alla longa manus di Pechino.
La politica estera cinese da anni è stata incentrata sull’occupazione di luoghi e posti lasciati liberi da altri. Con una visione strategica che, a differenza di quella delle altre superpotenze, americani in testa, guarda lontano nel tempo invece che vicino. Un investimento a lungo termine. Come ad esempio quello fatto in Africa, diventando il continente una vera e propria colonia cinese lì dove Francia, Inghilterra ed altri la facevano da padroni. E così è avvenuto in Medio Oriente. Un esempio su tutti: Israele e Palestina. Il paese ebraico, sicuramente anche su spinta americana, ha sempre tenuto chiuse le sue porte agli investimenti cinesi. Niente accordi sui porti israeliani, niente accordi sulle centrali energetiche, come avviene in altri paesi, Italia compresa. Per cui gli interessi cinesi sono ricaduti sui territori palestinesi. Non tanto per l’importanza locale, ma per quella strategica nell’area.
Il Presidente palestinese Mahmoud Abbas (Abu Mazen) a maggio è stato in visita a Pechino. Per le sue pessime condizioni di salute, l’ottuagenario Presidente è stato anche ricoverato nella capitale del celeste impero. Incontrando il Presidente cinese Xi Jinping, Abu Mazen ha anche detto che quanto la Cina fa nello Xinjiang, la regione autonoma a maggioranza musulmana dove Pechino tiene il pugno duro con una vera e propria repressione degli uiguri musulmani turcofoni, non rientra nella questione dei diritti ma in quella della sicurezza. Legittimando di fatto, mutatis mutandis, quello che il governo israeliano dice per giustificare le azioni contro i palestinesi.
L’interesse di Pechino per il Medio Oriente e il Golfo non è nuovo. Non dimentichiamoci che l’Arabia Saudita è ora il più grande fornitore di petrolio della Cina, e la Cina è il più grande cliente di petrolio dell’Arabia Saudita, per giunta. Pechino, su spinta del Presidente Xi, ha messo in atto un nuovo progetto diplomatico, la Global Security Initiative, con la creazione di connessioni che mettono insieme “comunità dal destino condiviso” per un ambiente economico e sociale migliore. L’accordo che Pechino ha favorito (anche se i colloqui tra le parti erano già in fase avanzata) e che nella città cinese è stato firmato a marzo tra Iran e Arabia Saudita per riprendere le relazioni, rientra proprio in questa filosofia. Pechino ha fatto anche sapere di essere pronta a mediare anche tra Israele e Palestina, ribadendo la cosa anche durante la visita di Abu Mazen nella Terra di Mezzo. Riad, poco dopo la riconciliazione con Teheran, ha riallacciato i rapporti anche con la Siria, facendola partecipare al vertice arabo che si è tenuto proprio nel Paese dei Saud. Accordi che non hanno lasciato indifferente Israele.
Il riavvicinamento tra Arabia Saudita e Iran e uno sforzo generale di Riad per ricucire i legami con i suoi rivali regionali, hanno aperto la porta a un nuovo capitolo anche con Hamas. La notizia della visita di Abu Mazen ma, soprattutto, l’eventuale incontro e ripresa dei rapporti con Hamas, gruppo foraggiato da Teheran, rappresentano certamente un duro colpo per il governo di Benjamin Netanyahu. Quest’ultimo, fautore degli accordi di Abramo del 2020, con i quali ha stretto rapporti con Emirati Arabi e Bahrein nell’area, ha sempre puntato sull’allargamento ad altri paesi arabi delle relazioni.
L’Arabia Saudita, convitato di pietra in questi consessi, è il vero oggetto del desiderio di Netanyahu e sembrava che le cose andassero verso questa strada, con una fitta rete di relazioni sottobanco, apertura di spazi aerei e paventato inizio di un collegamento aereo tra Israele e l’Arabia in occasione del pellegrinaggio rituale o del mese di Ramadan. Cosa che, invece, è stata messa in stand by. L’apertura di Riad nei confronti di Teheran prima e di Damasco poi, nemici giurati di Israele nell’area, ha raffreddato le cose. Un incontro con Hamas rende tutto ancora più difficile.
Dopotutto, Riad intende riprendere la centralità nell’area, che ha perso nei confronti sia di Emirati, dal punto di vista di sviluppo e da quello economico, sia del Qatar. Proprio contro Doha mise in atto un boicottaggio durato anni. Il Qatar, da sempre, ha rapporti con l’Iran, anche perché condividono il giacimento di gas più grande al mondo. E Doha è anche il maggior finanziatore di Gaza, dove sostiene settimanalmente le famiglie dell’enclave strette nella morsa di Israele, Egitto e della stessa Autorità Nazionale Palestinese. Nella capitale qatariota, inoltre, c’è una vera e propria ambasciata di Hamas e qui trovano rifugio i suoi leader.
Netanyahu, dal canto suo, continua ad ostentare sicurezza. Lo ha fatto in una intervista alla americana CNBC, nella quale ha affermato che le preoccupazioni saudite sul terrorismo avrebbero superato le remore per la linea dura del suo governo sui palestinesi, il ripristino dei legami dell’Arabia Saudita con l’Iran ha “molto poco” a che fare con Israele e riguarda principalmente l’allentamento delle tensioni nella regione, in particolare nello Yemen. Nell’intervista, il premier ribalta totalmente la questione, spiegando che quelle mosse di riavvicinamento di Riad con Teheran e Damasco hanno lo scopo di inviare loro un messaggio in vista di un possibile accordo di pace con Israele. “Forse per dire loro che dovranno prepararsi, forse per provare a dire loro di smettere di fare il tipo di terrore che fomentano”, ha detto. Netanyahu ha ribadito la sua convinzione che la pace con l’Arabia Saudita porrebbe fine al più ampio conflitto arabo-israeliano, anche se ha ammesso che non risolverebbe immediatamente il conflitto con i palestinesi. Netanyahu ha affermato che Riad era molto consapevole dei vantaggi della collaborazione con Israele. “Abbiamo fatto molto bene da soli, ma possiamo fare molto meglio insieme”, ha detto. E sulla mediazione cinese, il premier ha glissato, dicendo che non ha mai ricevuto alcuna proposta formale da Pechino, che il dialogo con la Cina è sempre aperto, ma che si aspetta una maggiore presenza e peso americani nell’area.
I partner di Israele negli Accordi di Abramo, come il Bahrain, potrebbero seguire l’esempio dell’Arabia Saudita e ripristinare la normalità con l’Iran. Il Bahrein potrebbe agire per convincere le forze segrete iraniane a smettere di incitare il suo 80% di cittadini sciiti.
Ma non solo arabi. Riad è stata al centro di importanti visite internazionali, a cominciare da quella del Segretario di Stato americano Blinken, corso dai Saud agli inizi di giugno, secondo alcuni proprio per mitigare l’influenza cinese che, giocoforza, è a scapito di quella americana nell’area.
Ma perché Riad? Perché da qui parte il petrolio, che ancora muove il mondo. I sauditi hanno più volte dichiarato di voler ridurre la produzione di petrolio, cosa che potrebbe aggiungere tensione al rapporto con Washington. Gli obiettivi del viaggio di Blinken sono stati anche di riconquistare influenza con Riad sui prezzi del greggio, respingere l’influenza cinese e russa nella regione e promuovere la normalizzazione dei legami sauditi-israeliani. Le tensioni tra i due Paesi si erano innalzate nel 2019 quando il Presidente Biden, durante la sua campagna elettorale per la presidenza, aveva definito Riyadh “pariah“ e li avrebbe trattati di conseguenza se fosse stato eletto. Subito dopo essere entrato in carica nel 2021, Biden aveva poi rilasciato una dichiarazione sostenendo che in base ad alcune rivelazioni dell’intelligence statunitense sarebbe stato il principe ereditario saudita ad approvare l’operazione per catturare e uccidere il giornalista e editorialista del Washington Post, Jamal Khashoggi, nel 2018. La situazione è leggermente migliorata nel luglio 2022 con la visita di Biden nel Regno Saudita. Un’ulteriore visita ad alto livello si è avuta lo scorso 7 maggio, quando il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, si è recato in Arabia Saudita. Ma a Riad ha fatto visita anche chi con gli Usa ha poco a vedere, come i cinesi. Il Presidente venezuelano, Nicolas Maduro, è stato pochi giorni prima di Blinken in Arabia Saudita per una visita ufficiale. Il Venezuela ha in precedenza cercato il sostegno dell’Arabia Saudita per le sanzioni statunitensi, imposte dall’ex presidente Donald Trump ma allentate dal suo successore, Joe Biden. Tuttavia, per revocare le sanzioni, Washington chiede al Venezuela di compiere passi concreti verso libere elezioni.
Venezuela e Arabia Saudita sono i Paesi con le maggiori riserve accertate di petrolio. Entrambi hanno un rapporto bilaterale di lunga data, rafforzato dalla loro partecipazione all’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEC), di cui entrambi sono membri fondatori. In termini di relazioni saudite-venezuelane, i due Paesi mantengono le rispettive ambasciate. Non hanno relazioni commerciali significative. Nel 2021, le esportazioni dell’Arabia Saudita in Venezuela ammontavano a soli 1,91 milioni di dollari, mentre il Venezuela ha esportato solo 508.000 dollari nel regno, secondo l’Osservatorio della complessità economica con sede negli Stati Uniti. Dopo la riunione OPEC+ di giugno, l’Arabia Saudita si è impegnata a tagliare 1 milione di barili al giorno di petrolio dalla sua produzione a partire da luglio.
La centralità di Riad nell’area ha spinto anche Emirati e Qatar a riallacciare i rapporti tra loro, dopo che lo hanno fatto i sauditi, che furono i fautori del boicottaggio qatariota. Una centralità che oramai è riconosciuta e verso la quale, giocoforza, guarda Israele, che sarebbe pronto a fare concessioni ai palestinesi pur di stringere rapporti con i sauditi. Ai quali gli armamenti israeliani fanno molta gola.
Il momento politico israeliano certo non aiuta. Le manifestazioni, che hanno superato le venti settimane, che ogni sabato vedono migliaia di israeliani scendere in piazza contro la riforma della giustizia voluta da Netanyahu; gli scontri nei territori dovuti ai continui raid dell’esercito nelle città palestinesi che stanno facendo diventare il 2023 uno degli anni con il peggior bilancio di vittime dall’inizio del conflitto tra i due, non favoriscono i riavvicinamenti. I nemici di Israele vicini ai suoi confini, che l’Iran sostiene – Hezbollah, Hamas e la Jihad islamica palestinese –, spinti anche da una continua propaganda in tal senso di Teheran, potrebbero credere che Israele sia ora più vulnerabile, specialmente con la discordia interna israeliana che raggiunge il culmine e sfida la sua coesione nazionale. Inoltre, sapere che l’alleato più importante di Israele, gli Stati Uniti, è sminuito agli occhi del Medio Oriente a causa dell’influenza della Cina, aumenta i rischi che correranno i gruppi filo Teheran, con possibilità di errori di calcolo e violenza. La percezione di Israele come indebolito non è mai positiva per l’America o per l’Occidente.
La Cina farebbe anche pressioni su Israele affinché non destabilizzi la regione con azioni preventive sul territorio iraniano, ora che le vendite di petrolio dall’Arabia Saudita e dall’Iran, la linfa vitale dell’economia cinese, sono più sicure. Per diversi analisti, questo sarebbe un eccellente colpo da parte di Cina e Iran per minare la normalizzazione saudita-americana e saudita-israeliana. Aiuta a salvare Teheran dal freddo e mina gli sforzi americani e israeliani per costruire una coalizione regionale per affrontare l’Iran mentre è sempre più avanzato il suo sviluppo di armi nucleari.
L’assenza di Washington si fa sentire, anche perché, come detto, l’interesse di Pechino è strategico e legato al petrolio, mentre i sauditi rivendicano un posto predominante. Ma in caso di scontro vero tra Israele e Iran, difficile che saltino gli accordi di Abramo o che si intromettano gli altri. Pechino e Riad potrebbero giocare da pacieri, ma significherebbe esporsi, riconoscere, in qualche modo Israele. Gli Stati Uniti devono riprendere il loro ruolo centrale nell’area, riprendendo un ruolo attivo sia con Israele che con l’Arabia Saudita. Anche perchè le relazioni con i sauditi, oltre che favori economici, portano a un importante soft power. Non dimentichiamoci che Riad gestisce i primi due luoghi islamici più importanti, Mecca e Medina. Ogni cambiamento che avviene qui (pensiamo ad esempio alle modernizzazioni che il principe saudita ha messo in campo) influenza il mondo islamico in generale. Il Medio Oriente ha bisogno dell’America tanto quanto dei Sauditi.
Questo articolo è pubblicato anche sul numero di Luglio/Settembre di eastwest
Puoi acquistare la rivista sul sito o abbonarti
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Si stringono sempre di più i rapporti tra Iran e Arabia Saudita, dopo anni di gelo. A seguito dell’accordo, siglato a marzo scorso, con cui i due paesi hanno deciso, dopo una rottura di sette anni, di riprendere le relazioni diplomatiche e di riaprire le rispettive ambasciate, ieri l’ambasciatore dell’Arabia Saudita è arrivato in Iran mentre il suo omologo iraniano è atterrato a Riyadh.
La notizia è stata riportata con enfasi sia dalla stampa locale che internazionale. Secondo quanto riportano diversi giornali, l’ambasciatore Abdullah Bin Saudi, al suo arrivo a Teheran, ha dichiarato che “la leadership dell’Arabia Saudita riconosce l’importanza di rafforzare i legami, aumentare l’impegno e portare la relazione verso orizzonti più ampi. Il Regno e l’Iran vantano un grande potenziale economico, risorse naturali e vantaggi che contribuiscono al consolidamento dello sviluppo, del benessere, della stabilità e della sicurezza nella regione, a vantaggio comune dei paesi e dei popoli fratelli”. Nello stesso giorno, l’ambasciatore iraniano designato in Arabia Saudita, Alireza Enayati, è arrivato nella capitale Riyadh.
L’Arabia Saudita aveva interrotto le relazioni diplomatiche con Teheran nel 2016 dopo gli attacchi alla sua sede diplomatica in Iran, in seguito all’esecuzione nel regno arabo del religioso sciita, Nimr Al Nimr. Con gli accordi di marzo scorso, l’asse politico internazionale ha subito numerosi cambiamenti.
L’Arabia Saudita ha infatti ristabilito anche i rapporti con la Siria, alleata dell’Iran, e sta spingendo per la pace nello Yemen, dove per anni invece aveva guidato una coalizione militare contro le forze appoggiate dall’Iran.
In attesa dell’insediamento ufficiale dei relativi ambasciatori, il mese scorso il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, si era recato in visita in Arabia Saudita e aveva anche incontrato il principe ereditario, Mohammad bin Salman, oltre che il ministro degli esteri saudita, Farhan bin Faisal, che a sua volta era stato a Teheran a giugno.
E, dal 1 gennaio 2024, Iran e Arabia Saudita entreranno anche a far parte del BRICS, insieme anche ad Argentina, Egitto, Etiopia ed Emirati Arabi. Lo ha annunciato di recente in una conferenza stampa il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa.
Il BRICS è un blocco che riunisce attualmente cinque paesi, Brasile, Russia, India e Cina, a cui nel 2010 si è aggiunto anche il Sudafrica (per cui l’acronimo da BRIC è divenuto BRICS). L’allargamento dei Brics ad altri sei Paesi “rappresenta un nuovo capitolo nella collaborazione dei Paesi emergenti e in via di sviluppo”, ha commentato il presidente cinese Xi Jinping, esprimendo soddisfazione per gli accordi raggiunti.
“I paesi BRICS – ha detto invece il presidente iraniano – rappresentano un nuovo potere emergente nel mondo che è riuscito a unire paesi indipendenti con l’obiettivo comune della cooperazione economica e della lotta contro l’unilateralismo”.
Ora con questi nuovi ingressi, si calcola che i membri del BRICS rappresenteranno il 36% del Pil globale e il 47% della popolazione mondiale.
La riapertura del dialogo e delle relazioni diplomatiche tra Arabia Saudita e Iran mostra un cambiamento di rotta nelle politiche mediorientali, dove la divisione “amici-nemici” degli Stati Uniti fino ad oggi aveva guidato le relazioni.
Con il disinteresse americano per l’area, interesse spostato verso il Pacifico e la Cina, l’Arabia si è sempre di più accreditata come decision maker, non disdegnando proprio una stretta di relazioni con Pechino. Contro questo nuovo asse, gli Usa sono corsi ai ripari e funzionari americani di ogni grado hanno e stanno effettuando numerose visite in Arabia.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Non si placano, per la seconda settimana di seguito, le proteste in Siria. Sono migliaia i siriani che quotidianamente scendono in strada a Sweida, nel sud-ovest del Paese, per manifestare contro il governo.
La folla sventola la bandiera drusa (Sweida è infatti una area popolata in gran parte dalla minoranza drusa) mentre vengono incendiate foto del presidente Bashar al-Assad. Ad un certo punto, i manifestanti hanno poi anche fatto irruzione negli uffici appartenenti al partito Baath (il partito di Assad), cacciando via i membri del partito che erano dentro. Hanno poi sigillato le porte e scritto slogan antigovernativi sui muri.
Le proteste sono cominciate circa due settimane fa più che altro come segnale di protesta per l’aumento dell’inflazione e per la difficile situazione economica della Siria, devastata dalla guerra, ma in seguito si sono estese e concentrate contro il governo. I manifestanti chiedono la caduta dell’attuale governo, accusato di essere il principale artefice della situazione attuale del paese, complessivamente insostenibile.
Le proteste si sono ulteriormente inasprite alla notizia della riduzione, da parte del governo, dei sussidi per il carburante. La sterlina siriana intanto si è ancora di più indebolita e il tasso di povertà fra la popolazione è altissimo. Le proteste, oltre che a Sweida, hanno investito anche la vicina provincia di Deera.
Sembra quasi di essere ritornati al 2011, quando le proteste che scossero il paese vennero poi represse con il sangue da Assad. “Siamo qui – ha raccontato un manifestante di Deera – perché il governo detiene ancora più di mezzo milione di persone, e poi anche per gli omicidi, per i prezzi troppo elevati e per i posti di blocco, dove le milizie del regime chiedono soldi ogni volta che passiamo. Non si può andare avanti così. Le proteste continueranno finché il regime non sarà rovesciato. È inevitabile. A Deraa abbiamo paura di essere arrestati ai posti di blocco, ma per tutto il resto non abbiamo paura.”
Centinaia di manifestanti si sono radunati anche ad Aleppo e Idlib, nel nord-ovest, e a Deir Az Zor, Raqqa e Hassakeh, nel nord-est. A Damasco, Latakia, Tartous e altre roccaforti del governo, le proteste ci sono, ma sono più pacate.
La vita della popolazione siriana è difficilissima. Nel conflitto hanno perso la vita sinora 300.000 persone, intere famiglie sono state decimate, altre sfollate. Si calcola che il 90% dei Siriani viva sotto la soglia di povertà. Fenomeni come la corruzione sono all’ordine del giorno. L’inflazione rende complicato per le famiglie anche riuscire a comprare i beni di prima necessità.
Intanto il governo non sembra preoccuparsi eccessivamente di quanto sta accadendo. Le forze governative hanno persino consolidato il loro potere in gran parte del paese ed è iniziata la repressione. A Deraa, sono state arrestate una sessantina di persone, mentre a Sweida, la reazione contro i manifestanti è stata più contenuta, forse perché al-Assad vuole evitare di usare la forza contro i Drusi anche per difendere la sua immagine di governo che difende le minoranze religiose.
Secondo Minority Rights Group International, un’associazione che opera per la tutela delle minoranze, i Drusi sono la terza minoranza religiosa più grande della Siria e rappresentano dal 3% al 4% della popolazione del paese.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
La normalizzazione dei rapporti israelo-sauditi, dovrebbe arrivare nel giro di dodici mesi. E’ quanto afferma un rapporto del Wall Street Journal, secondo il quale l’attivismo nelle ultime settimane di Washington nei confronti di Riad, con le numerose visite di funzionari statunitensi ad alto livello governativo in territorio saudita, dimostra che si stanno stringendo i tempi. Indiscrezioni e piano sconfessati, però, sia da esponenti governativi di Washington che di Riad, secondo i quali non ci sono ancora i presupposti e le basi per un accordo che allarghi gli Accordi di Abramo anche all’Arabia Saudita.
Nella questione si è inserito, dalle colonne dello stesso giornale, anche il Ministro degli Esteri israeliano, Eli Cohen, che ha espresso le perplessità del suo esecutivo verso uno dei punti in discussione più controverso e avversato da Gerusalemme: un programma nucleare civile saudita.
Certo, in Arabia il petrolio è sufficiente a garantire le necessità energetiche del paese, ma Riad guarda ad un accordo come quello che ha permesso a Teheran, altra fonte e produttore di idrocarburi, di ottenere un programma nucleare civile. Una circostanza, quella del nucleare saudita, che Israele non vede di buon occhio, preoccupato com’è di una proliferazione nucleare nell’area tra paesi non certo amici, sentendosi già minacciato dal programma iraniano.
Per questo Cohen appoggia un’altra richiesta saudita: quella di cooperazione difensiva con Washington. L’Arabia Saudita sta cercando un trattato di sicurezza reciproca simile alla NATO che obblighi gli Stati Uniti a venire in sua difesa se viene attaccata. Questo, insieme a un programma nucleare civile monitorato e sostenuto dagli Stati Uniti, e la capacità di acquistare armi più avanzate da Washington, come il sistema di difesa missilistica antibalistica Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), da utilizzare per combattere il crescente arsenale missilistico dell’Iran. In cambio, gli Stati Uniti chiedono a Riad di offrire un pacchetto di aiuti senza precedenti alle istituzioni palestinesi in Cisgiordania, ridurre gli accordi con aziende tecnologiche cinesi come Huawei, utilizzare dollari USA invece della moneta cinese per valutare le vendite di petrolio, respingere il piano di Pechino per stabilire una base militare sul suolo saudita e rafforzare la tregua che ha posto fine alla guerra civile nello Yemen. Per quanto riguarda i passi specifici che Israele dovrà intraprendere nei confronti dei Palestinesi, quelli non sono ancora stati chiariti.
Per il Ministro degli Esteri israeliano, gli Stati Uniti dovrebbero dare all’Arabia Saudita una garanzia per difenderla dall’aggressione nucleare iraniana come parte di un accordo di pace con Israele. Cohen, sulle pagine del giornale americano, ha paragonato la minaccia nucleare che l’Iran pone ad altri paesi della regione con la minaccia nucleare della Corea del Nord alla Corea del Sud e oltre. “La Corea del Sud, nonostante viva all’ombra di un vicino dotato di armi nucleari e abbia i mezzi per sviluppare le proprie armi nucleari, si è astenuta dallo sviluppo di armi nucleari”, ha scritto Cohen. “L’impegno di difesa degli Stati Uniti funge da deterrente della Corea del Sud contro l’aggressione del Nord. Un analogo impegno di difesa americano potrebbe rassicurare le nazioni mediorientali, in primo luogo l’Arabia Saudita e gli stati del Golfo”. Se l’Iran costruisse un’arma nucleare, “quasi certamente scatenerebbe una corsa agli armamenti nucleari regionale”, con l’Arabia Saudita, gli stati del Golfo, l’Egitto e la Turchia che stanno considerando di fare lo stesso e “potenzialmente far precipitare l’intero Medio Oriente in un conflitto”, ha scritto il Ministro degli Esteri israeliano. “Israele non vorrebbe la proliferazione da nessuna parte, ma la cosa più importante è impedire all’Iran di ottenere un’arma nucleare”, ha detto. Tuttavia, “la normalizzazione è tutto, più e più, senza svantaggi”, ha detto. “È nel nostro interesse per la sicurezza nazionale intrattenere rapporti con l’Arabia Saudita”.
In tutta questa discussione, restano a margine i Palestinesi e le loro aspirazioni. Come guardiani dei siti sacri dell’Islam, i Sauditi hanno sempre messo l’affermazione di uno stato palestinese indipendente dinanzi a qualsiasi ipotesi di apertura con Israele. Ma se Mohammad Bin Salman, il vero artefice dell’apertura verso gli ebrei su spinta americana (impensabile con suo padre per i forti legami di questo con la Palestina), è ovviamente molto a disagio con un governo, quello attuale israeliano, spostato verso la destra estrema con esponenti che non riconoscono neanche il diritto all’esistenza dei Palestinesi, lo è anche nei confronti della leadership di Ramallah, in particolare con Mahmoud Abbas, Abu Mazen. Se infatti è improbabile e difficile che MBS possa stringere accordi con l’attuale governo di Smootrich e Ben Gvir, non ha mai negato che non condivide il modus operandi dell’ottuagenario presidente palestinese, pur continuando a sostenere la battaglia per l’indipendenza del popolo che questi guida.
Per molti analisti, la questione palestinese è solo una casella da smarcare su un’agenda, nel senso che un accordo, anche al ribasso, rispetto a sovranità territoriale, si può trovare facilmente. E favorirebbe gli accordi tra Arabia e Israele a ovvio scapito dei Palestinesi. Cosa che potrebbe non essere d’aiuto nel Senato americano che dovrebbe votare anche gli accordi di sicurezza e nucleare con i Sauditi di cui sopra, dove le preoccupazioni dei diritti civili e molte altre, rendono difficile, al momento, l’approvazione delle clausole che spianerebbero la strada all’accordo fra i due paesi mediorientali.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Sono undici le persone che hanno perso la vita, e centinaia sono i feriti, durante quattro giorni di combattimenti nel campo profughi di Ain al-Hilweh, nel sud del Libano. Secondo quanto fatto sapere da Unrwa, l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, gli scontri sono iniziati durante lo scorso fine settimana, tra i membri del movimento laico Fatah, del presidente palestinese Mahmoud Abbas, e i militanti islamisti rivali.
Testimoni oculari hanno riferito di razzi caduti sulle case e di autovetture date alle fiamme. Tantissima gente è stata costretta ad abbandonare le proprie abitazioni per mettersi in salvo.
Tutto è cominciato sabato scorso quando un militante islamico è stato ucciso nel campo, probabilmente nell’ambito di una faida tra gruppi rivali. Ciò ha innescato una cascata di attacchi come rappresaglia, inclusa l’uccisione del comandante di Fatah, Abu Ashraf al-Armoushi, che guidava le forze di sicurezza palestinesi nel campo. Lui e quattro dei suoi aiutanti sono caduti in un’imboscata in un parcheggio.
“Questo atroce crimine non avvantaggia nessuno tranne il nemico, e cioè i sionisti, perché sono i principali e unici beneficiari.” ha detto Jalal Abuchehab, un funzionario di Fatah. Secondo la gente del posto, l’esercito libanese dovrebbe intervenire e proteggere la popolazione del campo, aiutandola a risolvere questi conflitti.
In verità, un accordo del 1969 vieta ai militari libanesi l’ingresso nei campi palestinesi. Possono dispiegare le loro forze solo nei pressi del campo, senza entrarvi. All’interno, la sicurezza viene gestita da un comitato congiunto di tutte le fazioni palestinesi, rendendo il campo una scena di violenza regolare tra fazioni rivali che si contendono il potere. Solo pochi giorni prima che scoppiassero gli scontri, secondo quanto riferito dalla stampa locale, il capo dell’intelligence dell’Autorità nazionale palestinese, Majed Faraj, aveva visitato il Libano, invitando le autorità locali a disarmare il campo.
Secondo le stime sarebbero circa 200.000 i palestinesi, discendenti di coloro che fuggirono da Israele durante la guerra del 1948, che attualmente vivono in Libano e sono considerati rifugiati, numero ben sotto gli oltre 400mila profughi registrati dall’Unrwa. Questo perché molti sono scappati all’estero, soprattutto dopo le stragi di Sabra e Shatila di 41 anni fa. Qui praticamente non hanno diritti e sono relegati nei campi profughi, diventati vere e proprie città ghetto.
Non sono ben visti dalla popolazione libanese anche per aver appoggiato, durante la guerra civile, la componente drusa e musulmana, per cui restano relegati nei 12 campi che non possono neanche allargarsi. Sopravvivono incassando piccole rendite e gli vengono offerti parte dei servizi basilari dall’Unrwa, l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa dei profughi palestinesi in patria e fuori. Hanno un tasso altissimo di disoccupazione: ufficialmente nei campi è del 18% ma tra i giovani di età compresa tra 20 e 29 anni è del 28,5%. A loro non vengono concessi dalle autorità libanesi permessi di lavoro e in molti si arrangiano in nero.
Intanto resta complicata la situazione dei palestinesi anche all’interno della Striscia di Gaza dove domenica scorsa migliaia di persone sono scese in strada per manifestare contro Hamas, ritenuto responsabile delle condizioni di vita sempre più difficili per la popolazione del posto. Le marce si sono svolte a Gaza City, ma anche nella città meridionale di Khan Younis: il popolo ha issato cartelli con su scritto “vergogna”, in alcuni posti sono anche state bruciate le bandiere di Hamas.
I manifestanti hanno anche criticato, in rare manifestazioni, il gruppo che controlla la Striscia, per aver detratto una tassa di circa 15 dollari dai 100 mensili dati alle famiglie più povere di Gaza dal Qatar. La polizia è poi intervenuta per bloccare le proteste. In alcuni casi sono anche stati distrutti i cellulari di persone che avevano fatto dei video, per impedire di darne diffusione e ci sono stati diversi arresti.
Sostenitori e oppositori di Hamas si sono scontrati, lanciandosi pietre gli uni contro gli altri. Le manifestazioni sono state organizzate da un movimento online chiamato “il virus beffardo”. Non è però ancora stato chiarito chi vi sia dietro questo movimento.
Hamas ha preso il controllo di Gaza nel 2007, spingendo Israele ed Egitto a imporre un blocco totale su questo territorio. Israele afferma che la chiusura è necessaria per impedire ad Hamas, che non riconosce il diritto di Israele di esistere, di sviluppare proprie capacità militari. Tale chiusura ha devastato l’economia di Gaza, ha fatto salire alle stelle la disoccupazione e ha portato a molti problemi per la popolazione incluse frequenti interruzioni di corrente.
Le proteste dei giorni scorsi tuttavia si sono verificate proprio mentre Fatah e Hamas parlavano di una possibile riconciliazione. La scorsa settimana, il presidente Abbas e il leader di Hamas, Ismail Haniyeh, si sono incontrati in Turchia per discutere i modi per raggiungere l’“unità nazionale” e porre fine alla disputa scoppiata tra i due partiti dopo che Hamas ha vinto le elezioni parlamentari del 2006.
Domenica, Abbas e Haniyeh hanno poi partecipato a una conferenza dei leader di diverse fazioni palestinesi in Egitto, in un altro tentativo di porre fine alla rivalità Fatah-Hamas e raggiungere un accordo sulla formazione di un governo di unità palestinese. La conferenza, tuttavia, si è conclusa senza raggiungere alcun accordo, con Hamas che ha respinto l’appello di Abbas a sostenere una “resistenza popolare pacifica” contro Israele. Hamas ha anche chiarito alla conferenza che non aderirà a nessun programma politico che riconosca Israele o gli accordi firmati tra palestinesi e israeliani negli ultimi tre decenni.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
L’Arabia Saudita, come la Cina di dieci anni fa. La seconda, prima di tutti, cominciò un’azione di soft power sfruttando l’organizzazione di grandi eventi mondiali e puntando sul vero oppio dei popoli, il calcio. Nel giro di due anni, infatti, organizzò le Olimpiadi, 2008, e l’Expo di Shanghai, 2010. In barba a tutte le critiche sui diritti civili, in particolare per il trattamento riservato a Tibetani e Uiguri. Addirittura fece passare la fiaccola olimpica nelle due regioni “autonome”, non prima di averle per bene “bonificate” con l’esercito, reprimendo qualsiasi giusto e legittimo anelito di ribellione alla soppressione.
Per esercitare meglio il suo soft power, il paese del dragone investì moltissimo nel calcio, con l’intento non nascosto di portare nella terra di mezzo il campionato mondiale. Furono tanti i campioni che andarono ad ingolfare il miserrimo campionato cinese. In panchina anche i campioni italiani Lippi, Cannavaro e Ferrara.
Risultato? Il mondiale non è mai arrivato, il calcio locale non si è mai diffuso così come si sperava e le squadre dei grandi investimenti, come la Evergrande di Guangzhou, proprio quella allenata da Lippi, è fallita. Già gli Usa si erano imbarcati in una situazione simile, ma più per aprire il mercato dei diritti calcistici verso loro che altro: campioni come Pelè, Chinaglia e Beckham, hanno deciso di chiudere lì la loro carriera. Oggi lo ha fatto Messi e il campionato italiano è pieno di società americane che posseggono squadre.
Così come sono cresciuti molto i giocatori a stelle e strisce, oggi campioni in diversi paesi, Inghilterra e Italia comprese. Gli Emirati hanno chiamato il più grande di tutti i tempi, Maradona, come allenatore e uomo immagine per dare lustro al loro campionato, ma non si è risolto nulla. Lo hanno fatto anche gli indiani. Il Qatar si è inventato una cittadella sportiva e ha organizzato qualsiasi mondiale, da quello di pallamano con charter gratuiti per tifosi da tutto il mondo a quello di calcio con le vittime di cui sappiamo. Operazioni che sono valse solo per mostrarsi al mondo come potenze.
Come la Cina, anche l’Arabia Saudita, che punta sull’organizzazione dell’Expo e sul calcio, per il suo “sportwashing”. Come ha scritto anche il Guardian, in meno di due anni, dal 2021 ad oggi, il regno dei Saud ha speso circa 6,3 miliardi di dollari in affari e contratti attinenti allo sport, più del quadruplo dell’importo speso nei sei anni precedenti. Una cifra enorme, che corrisponde al PIL dell’intero Montenegro o dell’isola di Barbados e che, secondo alcuni, sarebbe persino sottostimata considerando che alcuni accordi e alcuni dettagli non vengono resi pubblici.
Tra l’altro la cifra di 6,3 miliardi di dollari non include i 40-45 milioni di dollari che il gigante petrolifero statale Aramco spende ogni anno per sponsorizzare la Formula 1, o altri contratti firmati poco prima del 2021, come 65 milioni di dollari per tenere un Gran Premio annuale nel regno. Il totale esclude anche l’ampia spesa del PIF (Public Investment Fund) nel mondo degli e-sport, incluso un recente investimento di 1 miliardo di dollari nella società di videogiochi Embracer Group, ed altri eventi sportivi di cui non si conosce l’importo della sponsorizzazione.
Tutto rientra nell’ambito di un programma governativo, il cosiddetto Vision 2030, lanciato dal Regno dell’Arabia Saudita nel 2016 per volere del principe ereditario Mohammed bin Salman, con lo scopo di lanciare il paese dal punto di vista economico, sociale e culturale. Operazioni importanti che però, secondo la maggior parte degli analisti internazionali e dei gruppi che operano per la tutela dei diritti umani (tra i quali Grant Liberty, Amnesty International e Human Rights Watch) non hanno solo a che fare con lo sport in sé ma rientrano in una ben più ampia strategia politica di “sportwashing”, ovvero di operazioni che servono a distrarre l’opinione pubblica internazionale dai record negativi sui diritti umani e a “ripulire” l’immagine del paese.
Il club saudita Al Hilal ha presentato un’offerta da record mondiale per il capitano francese, Kylian Mbappé, del valore di 300 milioni di euro. I sauditi si sono già assicurati Ronaldo, Koulibaly, Milinkovic Savic.
La morte del giornalista Jamal Khashoggi nel 2018, aveva in qualche modo isolato l’Arabia, per la mano saudita dietro l’uccisione del giornalista. Negli ultimi due anni la situazione è radicalmente cambiata ed è modificata la percezione del paese a livello internazionale, soprattutto. Persino il presidente americano, Joe Biden, che aveva dichiarato di voler fare dell’Arabia Saudita un “paria”, sembra aver ammorbidito le sue posizioni tanto da essersi recato personalmente in Arabia Saudita, incontrando e salutando il principe ereditario Mohammed bin Salman.
Se i Qatarini hanno fatto spese nel lifestyle (grattacieli a Milano, negozi e alberghi a Londra e Parigi, etc, ma anche il Paris Saint-Germain), i Sauditi non sono voluti essere da meno, e hanno acquistato il Newcastle United nell’ottobre 2021 per ben 391 milioni di dollari, con non pochi grattacapi per i sostenitori dei diritti civili, meno per i tifosi. Nell’ottobre 2021, il fondo ha investito circa 2 miliardi di dollari per un importante torneo, il LIV di golf. Altri investimenti del regno includono la boxe e gli sport motoristici. Quest’anno, lo YouTuber e pugile Jake Paul ha combattuto contro Tommy Fury a Riad per oltre 3 milioni di dollari.
Il regno ha anche speso circa 60 milioni di dollari per ospitare una partita dei pesi massimi tra Oleksandr Usyk e Anthony Joshua nel 2022. Nell’ambito dei motori, il PIF ha investito in una sponsorizzazione da 550 milioni di dollari per la McLaren Group Ltd. Intanto, nonostante le operazioni per ripulire la facciata, la situazione dei diritti umani e delle violazioni in Arabia Saudita resta preoccupante; secondo recenti dati forniti da Amnesty International, l’Arabia Saudita è il paese con il più altro numero di esecuzioni capitali nel 2022: sono state 196 nel 2022, in netto aumento (circa tre volte di più) che nel 2021 quando erano state 65. Secondo Amnesty questi dati dovrebbero essere sufficienti a bloccare l’eventuale assegnazione dei mondiali di calcio del 2030 all’Arabia in quanto tali eventi dovrebbero essere ospitati solo dai paesi che rispettano i diritti umani e quindi sicuramente non all’Arabia Saudita.
E questo sarebbe anche il volere della gente: secondo un sondaggio sempre condotto da Amnesty in 15 paesi, emerge che il 53% delle 17.500 persone intervistate ritiene che i diritti umani in generale e soprattutto il rispetto delle donne, debbano essere un elemento fondamentale nelle decisioni sull’organizzazione dei grandi eventi sportivi internazionali. Secondo Amnesty, tuttavia, vi è il timore che la Fifa possa ignorare tali aspetti, visto l’impegno e le possibilità dell’Arabia Saudita di spendere molto per organizzare una delle prossime edizioni della Coppa del Mondo, nel 2030 o nel 2034. Come la Cina.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Da secoli, l’abito degli abbati benedettini, i monaci che stanno al vertice di una o più abbazie che seguono la Regola di San Benedetto, è nero o bianco con una croce pettorale, unico segno del loro ruolo a capo del monastero. Abito che non deve essere piaciuto a una donna usciere posta a controllo del Muro Occidentale o, come tutti lo conoscono, Muro del Pianto a Gerusalemme, dove l’abbate di un monastero gerosolimitano è stato bloccato perché indossava la croce.
Dom Nikodemus Schnabel è l’abate del Monastero della Dormizione sul monte Sion nella città vecchia di Gerusalemme, abbazia di benedettini tedeschi. Stava accompagnando il Ministro tedesco della Cultura in visita nella Città Santa, quando un usciere all’ingresso del sito religioso ebraico lo ha fermato ritenendo non adeguato il suo abito. Dom Nikodemus è molto seguito sui social e l’azione di bloccaggio da parte della donna è stata ripresa dagli obiettivi di un giornalista di Der Spiegel.
È questo l’ultimo episodio di intolleranza da parte della comunità ebraica nei confronti di quella cristiana a Gerusalemme e in Terra Santa, con episodi anche ben più violenti.
In verità, nonostante il clamore della vicenda che ha visto protagonista l’abate benedettino, anche per la presenza dell’esponente del governo tedesco, i toni si sono abbassati, anche se le proteste di Dom Nikodemus sono continuate in rete.
“È stato molto duro – ha detto Schnabel all’usciere – non stai rispettando la mia religione. Mi stai ostacolando nel mio diritto umano. Questa non è una provocazione, sono un abate. Questo è il mio vestito. La croce fa parte del mio dress code. Sono un abate cattolico romano. Vuoi che non mi vesta come la mia fede, questa è la realtà”.
La Western Wall Heritage Foundation è l’organizzazione ebraica che gestisce il sito più sacro per gli ebrei, perché si considera che nel muro risieda lo Spirito divino, in quanto la struttura è l’unica rimasta dalla costruzione del primo e secondo Tempio più sacri per la religione ebraica, distrutti prima dagli Assiro babilonesi e poi dai Romani. In una dichiarazione la fondazione si è scusata “per il disagio causato”, ma ha difeso le azioni della donna usciere, osservando anche che il sito è aperto a tutti e che non ci sono regole “su questo tema”. “L’usciere si è avvicinato e, innocentemente e gentilmente, ha chiesto se la croce poteva essere coperta per evitare disagi come è successo di recente nella Città Vecchia, per rispetto dell’ospite e del luogo. Dopo che si è rifiutato, il suo ingresso ovviamente non è stato impedito e l’usciere ha rispettato [questo] e se n’è andato”, si legge nella dichiarazione.
Non era la prima volta che succedeva. Solo ai vari pontefici venuti a Gerusalemme, ultimo Francesco, è stato concesso avvicinarsi al Muro senza alcun problema; anche ad altri cardinali e vescovi era stato già chiesto di nascondere le croci troppo grandi per non urtare la suscettibilità degli ebrei.
Suscettibilità che spesso diventa violenza. Sono quasi quotidiani i casi di intolleranza e violenza nei confronti dei cristiani da parte degli ebrei. I pellegrini, i religiosi e i preti, sono spesso oggetto di sputi da parte degli ebrei, che sputano o urinano sulle soglie delle chiese e dei monasteri, contenti anche di essere immortalati dalle telecamere di sorveglianza. Una situazione per la quale circa un mese fa fu organizzato da diversi ebrei un convegno a Gerusalemme dal titolo “Perché (alcuni) ebrei sputano sui cristiani”.
Il sindaco di Gerusalemme, su pressione di un suo vice, esponente del partito di estrema destra, chiese e ottenne che il convegno non si tenesse nella sua sede prevista, il museo della Torre di Davide in città vecchia. Si tenne il giorno dopo in altro luogo e vi parteciparono anche consiglieri comunali che hanno criticato la scelta del primo cittadino, dettata anche dalle non lontane elezioni, desideroso di non inimicarsi gli ebrei. Questi accusano i cristiani, confondendo tempi e persone, di tutto: nel dibattito in consiglio comunale c’è stato anche chi ha evocato la Shoah, le leggi razziali, l’atteggiamento di Pio XII durante lo sterminio, ma anche l’inquisizione e le crociate. Tra l’altro, la comunità cristiana autoctona in Terra Santa, è costituita per la quasi totalità da arabi, con una minima percentuale di ebrei convertiti.
Nel mirino degli ebrei c’è l’evangelizzazione cristiana, portata avanti non dalla chiesa cattolica, ma da alcune minoritarie chiese evangelico-protestanti. Ma per molti ebrei, i cristiani sono tutti eguali: traditori ed eretici.
Per questo è stato assalito un monaco copto, scritte con minacce di morte e vendetta sono state lasciate sui muri del quartiere armeno, sono state rotte le vetrate del Cenacolo, si è cercato di dare fuoco alla chiesa cattolica del Getsemani incendiandone alcune panche, è stata distrutta una statua di Cristo nella chiesa della condanna al monastero cattolico della flagellazione, solo per citare qualche episodio.
Un giornalista della tv israeliana, con il permesso e accompagnato da un frate francescano della Custodia di Terra Santa, ha indossato il saio ed è andato per le strade della città vecchia. Qui è stato preso di mira da insulti e sputi da parte di alcuni ebrei. È riuscito ad intercettarne uno, un giovane soldato, si è tolto l’abito ed è andato a parlarci, condannando il suo gesto.
Per il soldato il suo gesto era normale, e la denuncia televisiva del caso, ha portato all’arresto del ragazzo per un mese. Anche il presidente israeliano Herzog, qualche settimana, fa ha condannato questo trend anticristiano. “Condanno fermamente la violenza, in tutte le sue forme, diretta da un piccolo ed estremo gruppo, contro i luoghi santi della fede cristiana e contro il clero cristiano in Israele”, ha detto Herzog durante una cerimonia commemorativa di stato del fondatore del sionismo Theodor Herzl. “Ciò include sputi e profanazioni di tombe e chiese”, ha aggiunto, osservando che il fenomeno è in aumento “soprattutto nelle ultime settimane e mesi”.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Continua senza impedimenti l’iter legislativo voluto fortemente dal governo di Benjamin Netanyahu per approvare la riforma della giustizia. Lunedì la Knesset, il parlamento israeliano, ha approvato a maggioranza, 64 a 56, la prima lettura su tre della prima delle novità della legge, quella che limita il “principio di ragionevolezza”.
Israele non ha una Costituzione ma 13 leggi fondamentali. Allo stato attuale la Corte Suprema Israeliana può annullare qualsiasi legge decisa dal governo con una maggioranza semplice, basandosi sulle leggi fondamentali e, in mancanza di appoggio su queste, su un principio di “ragionevolezza”.
Per il governo, questo è uno sbilanciamento di poteri verso la Corte, perché anche due giudici su tre riuniti, possono decidere di bloccare una legge o una nomina del governo, se per loro non rispetta il principio di ragionevolezza.
Un blocco avvenuto ad esempio a gennaio scorso, quando Benjamin Netanyahu decise di licenziare il ministro degli Interni e della Salute, nonché vice Primo Ministro, Aryeh Deri, dopo una sentenza della Corte. Questi, capo del partito Shash degli ultra ortodossi, era stato protagonista della sentenza dell’Alta Corte secondo cui la decisione di nominarlo ministro degli Interni e della Salute era “estremamente irragionevole” alla luce delle sue condanne penali, l’ultima nel gennaio 2022. Deri aveva stipulato un patteggiamento con una corte di Gerusalemme, atto che gli ha permesso di lasciare la Knesset prima della sua condanna e quindi evitare un’udienza per stabilire se la sua condanna per frode fiscale comportasse turpitudine morale, designazione che gli avrebbe impedito di ricoprire cariche pubbliche per sette anni.
La Corte all’epoca accettò il patteggiamento perché era convinta della volontà di Deri di ritirarsi dalla vita pubblica nel breve tempo. Il politico, però, non ha lasciato l’agone politico e ha continuato a guidare Shash, portandolo ad essere uno degli alleati importanti ed essenziali nella vittoria della destra e di Netanyahu alle consultazioni elettorali del primo novembre scorso.
Da qui la scelta del premier di portarlo al tavolo del gabinetto, nonostante quanto preveda la Legge fondamentale: il governo richiede al Comitato elettorale centrale di determinare se il suo crimine comporta turpitudine morale prima che possa essere nominato ministro.
All’approvazione di lunedì sono scaturite proteste in diverse città. Oramai sono 27 settimane che ogni sabato manifestanti scendono in piazza contro la riforma e martedì ci sono stati blocchi in ogni città e all’aeroporto Ben Gurion.
La riforma della giustizia che il governo di Benjamin Netanyahu intende portare avanti ,e che ha scatenato le feroci proteste della piazza, interessa principalmente l’istituto della Corte Suprema. Questa è l’unico contraltare rispetto al potere dell’esecutivo e del Parlamento, dal momento che anche il presidente israeliano non ha potere di bloccare o rimandare indietro le leggi. La Corte Suprema israeliana, che ha sede a Gerusalemme, è composta da 15 giudici nominati da una commissione di 9 membri: 3 dalla Corte stessa, 2 avvocati, 4 politici scelti dal governo (2 ministri, 2 parlamentari). Il secondo parlamentare è stato appena scelto tra le file della maggioranza, dopo che l’opposizione riuscì a bloccarne la nomina, favorendo solo quella del proprio esponente.
Per gli avvocati, c’è stata una serrata votazione al consiglio nazionale, che poi sceglie i due membri della commissione di nomina dei giudici. Poiché ha vinto la corrente che si oppone a Netanyahu, dal governo si è anche paventata una legge per limitare le decisioni del consiglio nazionale forense proprio per evitare che vengano nominati membri ostili nella commissione per i giudici.
Così come è formata la commissione di nomina dei giudici, secondo l’attuale governo, comporterebbe un eccessivo sbilanciamento a favore del potere giudiziario su quello politico. L’obiettivo di Netanyahu è di portare a 11 i membri del Comitato (invece dei 9 di oggi) assicurando la prevalenza dei componenti di nomina politica sui tecnici. Altra intenzione della riforma voluta dal premier sarebbe di eliminare il potere della Corte Suprema di abolire le leggi approvate dal Parlamento. O, meglio, la Corte potrebbe decidere di bloccarle, ma il Parlamento, con la maggioranza semplice di 61 membri su 120, potrebbe ribaltare la decisione della Corte.
Secondo gli oppositori, in tal modo si darebbe troppo potere al governo e ciò rappresenterebbe una minaccia per la democrazia in Israele.
Si chiede anche di eliminare la “clausola di ragionevolezza”, lasciando alla Corte Suprema il compito di esaminare esclusivamente se una legge è aderente o meno ai princìpi espressi dalle Leggi fondamentali. La riforma prevede inoltre che le decisioni della Corte in materia di invalidità di una legge, anche di una legge fondamentale, vengano prese con una maggioranza di almeno l’80% e non più semplice.
Altro punto di discordia riguarda gli incarichi dei consulenti legali dei ministeri, che non sarebbero più indipendenti sotto il controllo del ministero della giustizia, ma scelti con criteri politici e i cui pareri sono vincolanti.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
La Cisgiordania come Gaza. Se nella Striscia l’esercito israeliano, l’Israeli Defence Force (IDF), ha fino ad ora risposto alla mole di razzi lanciati verso il sud del paese, con l’aviazione e attacchi mirati a leader e infrastrutture dei gruppi che la controllano, in Cisgiordania, per la prima volta da vent’anni, nei giorni scorsi una operazione di terra per oltre 40 ore ha battagliato con i miliziani a Jenin.
Da diverso tempo, sono quasi quotidiani i raid dell’esercito israeliano nelle città cisgiordane, in particolare Jenin e Nablus, alla ricerca di terroristi e fiancheggiatori. Da qui partirebbero gli attentati contro Israele. In queste città, nei loro campi profughi, nei vicoli dei centri storici, si annidano quelli che Israele riconosce come propri nemici. Militanti di gruppi che abbiamo imparato conoscere da tempo: da Hamas, un po’ più defilata, al Jihad Islamico Palestinese (Pij) e al suo famigerato Saraya al Quds e al Battaglione Jenin; dalle Brigate Balata alla Brigata Nablus, dalla Brigata Yabad all’ultima temuta, la Fossa dei Leoni. Un panorama del terrore che il governo Netanyahu è deciso ad annientare a tutti costi. Importa poco se anche minorenni sono ad imbracciare i fucili per difendere le loro case, se i proiettili e colpi sparati durante le battaglie uccidono civili di ogni età e sesso. È guerra totale, ed è dimostrato sia dall’uso dell’aviazione, come nelle due ultime operazioni a Jenin, sia nei mille soldati che nell’ultima operazione hanno messo a ferro e fuoco il campo profughi di Jenin.
Operazioni che da un lato mostrano l’interesse israeliano a chiudere il capitolo, dall’altro però l’accresciuta potenza militare dei gruppi palestinesi che, secondo gli analisti, sono foraggiati e istruiti dall’Iran. I militari israeliani hanno ammesso di essersi trovati in difficoltà più volte in queste operazioni. La forte pioggia di fuoco che li ha interessati, li ha bloccati per lungo tempo. Non solo: sono stati esplosi ordigni al passaggio dei veicoli; uno di oltre 40 kg a giugno durante un raid dell’esercito, ha reso necessaria l’evacuazione dei militari con l’elicottero da guerra.
Alle armi “Carlo”, le pistole mitragliatrici artigianali autocostruite in molti luoghi della Cisgiordania, ampiamente diffuse, si sono aggiunti i fucili d’assalto M-4, M-16, CAR-15. Non sono pochi quelli che possiedono pistole, come M18 e P-320. Armi che arrivano dall’Iran attraverso Siria, Libano e, soprattutto Giordania, portate smontate per poi essere assemblate nei piccoli negozi delle cittadine palestinesi e stipate in particolare nei sottoscala e depositi sotterranei del centro delle città di Nablus e Jenin.
Non solo armi leggere. Il Pij, in particolare, ha un buon arsenale di armi pesanti, dispiegato principalmente a Gaza, ma con alcune basi in Cisgiordania. In alcune operazioni recenti seguite allo scontro armato su Gaza del mese scorso, militari israeliani hanno distrutto una base per la fabbricazione e il lancio di razzi non più da Gaza, ma dal cuore della Samaria verso le città israeliane. Due i razzi lanciati da queste zone contro Israele nelle scorse settimane sono caduti in territorio palestinese. Secondo un rapporto del 2022 della Foundation for Defense of Democracies, Il Pij nella Striscia possedeva fino a 8.000 razzi, con portate diverse fino a 120 km e sistemi di difesa aerea portatili oltre ad alcuni droni. Gli iraniani sono i loro maggiori fornitori e addestratori all’uso. Non a caso, durante gli scontri di lunedì, i vertici di Hamas e Pij erano a Teheran.
Ma l’arma più potente è sicuramente la propaganda. Foto dei “martiri” campeggiano nelle città e questi gruppi hanno oramai il controllo delle università palestinesi, usciti vincitori dalle elezioni studentesche. I giovani vedono in loro gli unici interessati alla loro causa, vista l’assenza del governo palestinese. Non a caso quando l’esercito ha lasciato Jenin dopo quasi due giorni di battaglia, i palestinesi hanno attaccato l’ufficio locale delle forze di sicurezza, considerate colluse con l’occupante, così come il governo di Ramallah, i cui rappresentanti locali sono stati cacciati in malo modo.
Mentre prima sui social si trovavano immagini degli attacchi in auto contro i check point o anche di ragazzini con in mano la Carlo, oggi i video mostrano militanti armati fino ai denti con frasi che incitano all’attacco sottolineando la fragilità israeliana che, secondo i media iraniani, dipende dal momento difficile politico israeliano. Dopo i fatti delle scorse settimane ci sono video e foto di miliziani con pezzi di veicoli militare distrutti come trofeo di guerra, gente che canta e danza sulle macerie del campo profughi in segno di vittoria, immagini dei “martiri” agli angoli delle strade e sui social. Dopotutto, dicono, se Israele ha usato elicotteri, droni e molte forze di terra, significa che ci teme. Ed è per questo che da più parti in Israele chiedono anche in Cisgiordania operazioni a larga scala sul modello Gaza.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Dall’inizio dell’anno, sono 111 gli arabi che sono stati uccisi in vere e proprie esecuzioni in Israele. Di questi, 98 sono stati uccisi da colpi di arma da fuoco e 51 avevano meno di 30 anni. Nello stesso periodo del 2022, erano state meno della metà, 46, le persone uccise nella comunità araba. La situazione è molto tesa, molti leader locali incolpano la polizia, ritenuta inadeguata a bloccare le potenti organizzazioni criminali operanti in zona. Alcuni sostengono che la polizia israeliana spesso ignora del tutto queste violenze, lasciando che la gente si faccia giustizia da sé, disinteressandosi dell’escalation di violenza soprattutto perché riguarda esclusivamente la comunità araba, seppur israeliana. Il fenomeno include faide familiari, guerre per il controllo del territorio e violenza contro le donne.
La popolazione araba di queste zone, a prevalenza musulmana, è infatti in buona parte organizzata in clan familiari che lottano tra di loro per il controllo delle attività illecite, soprattutto droga e prostituzione. Le autorità israeliane sono convinte che la maggior parte degli omicidi maturino in questo genere di contesti. Questa settimana, solo in 24 ore, sono state ben cinque le vittime, in diverse città dove vive la popolazione araba, in particolare nel nord del paese. Ahmed Tibi, un membro arabo della Knesset (il parlamento israeliano), aveva dichiarato solo qualche settimana fa che l’ondata di criminalità nella comunità araba israeliana “è esacerbata dalla complicità della polizia israeliana, poiché consente il contrabbando di armi”.
All’inizio di giugno il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu aveva manifestato l’intenzione di cercare l’aiuto del servizio di intelligence interno, lo Shin Bet, per combattere il crimine all’interno della comunità araba in Israele. Il premier aveva anche aggiunto che il suo governo ha stanziato un budget enorme per la polizia “per assumere migliaia di ufficiali e per istituire una Guardia Nazionale”. La popolazione che vive nelle città maggiormente colpite è stanca, non si sente sicura e teme per la propria sicurezza.
Secondo diversi analisti e anche alcuni istituti di ricerca che hanno analizzato il fenomeno, le principali cause della violenza nella società araba sono da imputare, in primo luogo, alla scarsa o spesso insufficiente presenza della polizia nelle comunità arabe. Incide molto anche la situazione socio-economica della popolazione araba: molte infatti sono le famiglie che vivono al di sotto della soglia di povertà, così come molto alto è il tasso di disoccupazione, specie tra i giovani, che diventano quindi facilmente preda della criminalità locale.
Gli arabi-israeliani poi sentono di essere quasi cittadini di serie B, meno tutelati rispetto agli ebrei e vittime di disuguaglianze varie. Tra l’altro la comunità arabo-israeliana è composta soprattutto da giovani, con il 30% della sua popolazione che ha una età compresa tra i 18 e i 23 anni. Giovani che, osservano molti, hanno molti meno benefici e possibilità rispetto ai cittadini ebrei della stessa età. Secondo gli ultimi dati ufficiali, la popolazione araba di Israele è stimata in 2.048 milioni, che costituiscono il 21% della popolazione del paese, che conta in totale 9,7 milioni di persone.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Potrebbe finalmente vedere la luce lo sfruttamento del giacimento di gas al largo della Striscia di Gaza. Israele ha dato semaforo verde e la notizia sta avendo ampio risalto sulla stampa sia locale che internazionale. E questo perché, se il progetto si dovesse concretizzare, darebbe una notevole spinta in avanti all’economia palestinese.
In un comunicato stampa redatto sia in ebraico che in arabo dall’ufficio del Primo Ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, si legge che il progetto, che si localizzerebbe a 36 chilometri dalla costa di Gaza, rientra nel quadro dei negoziati in corso tra Israele, Egitto e Autorità Nazionale Palestinese. Nel comunicato però viene precisato che i progressi dipenderanno dalle azioni necessarie per “preservare la sicurezza dello Stato di Israele e le esigenze diplomatiche”.
Poco più di un mese fa la tv israeliana Channel 13 aveva riferito che il governo era in trattative segrete con l’Autorità Nazionale Palestinese per estrarre gas dal giacimento al largo della costa della Striscia di Gaza, con l’approvazione di Netanyahu e del ministro della Difesa Yoav Gallant, aggiungendo che i colloqui erano ripresi come parte del processo politico e di sicurezza iniziato di recente tra Israele e l’Autorità Palestinese sotto la mediazione degli Stati Uniti. Il progetto è stato discusso anche durante i colloqui tenutisi recentemente ad Aqaba e a Sharm El Sheikh. Dovrebbe essere una società egiziana a facilitare la produzione di gas naturale nei giacimenti offshore. Si stima che potrebbero essere prodotti oltre 1 trilione di piedi cubi di gas naturale, molto più di quanto sia necessario per alimentare i territori palestinesi. L’Autorità Nazionale Palestinese, attraverso il suo Fondo di Investimento (Pif) guadagnerebbe il 27,5% dei profitti dal giacimento, mentre la palestinese Consolidated Contractors Company, partner del Pif, otterrà un altro 27,5%. Il restante 45% andrà alla Egyptian Natural Gas Holding Company, che gestirà il progetto.
Secondo alcuni analisti il progetto potrebbe dare respiro all’economica palestinese, allentando nel tempo le tensioni tra Israele e Palestina. Si spera dunque che finalmente il progetto possa concretamente partire. L’economista Hamed Jad ha evidenziato come l’accordo finale non possa prescindere da un accordo anche con Hamas per evitare ulteriori problemi sul campo. Il portavoce di Hamas, Hazem Qassem ha detto ad Arab News: “Stiamo seguendo tutti gli sviluppi relativi alla questione del gas e agli accordi, il diritto del nostro popolo di beneficiare delle sue risorse naturali e del gas è garantito in tutte le leggi e risoluzioni internazionali”.
I giacimenti di gas di Gaza sono stati scoperti per la prima volta nel 1999 nelle acque territoriali palestinesi. I giacimenti sono stati a lungo visti come un importante trampolino di lancio verso l’indipendenza energetica palestinese, ma sono rimasti inutilizzati principalmente a causa delle obiezioni e degli ostacoli posti da Israele. Nel novembre 1999 era stato firmato un contratto di 25 anni per l’esplorazione di gas e lo sviluppo di giacimenti di gas tra il British Gas Group (Bg) e il Pif palestinese. Bg Group si ritirò poi dal progetto nel 2016 cedendolo a Shell, che a sua volta si è ritirata dall’accordo nel 2018. Nel 2021, l’AP ha firmato un memorandum d’intesa con l’Egitto per sviluppare il giacimento di gas di Gaza e le infrastrutture necessarie.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Resta grande l’instabilità politica in Libano dove il Parlamento non è riuscito ancora ad eleggere il nuovo Presidente. Quello di stamattina è stato il dodicesimo tentativo, fallito ancora una volta. Il punto cruciale è che per l’elezione occorre un quorum di almeno due terzi dei membri del Parlamento. Quindi qualsiasi candidato ha bisogno di almeno 86 voti per essere eletto al primo turno. Voti che scenderebbero a 65 al secondo turno. Numeri questi a cui gli attuali candidati, anche quelli più quotati, non si sono avvicinati.
L’ex ministro delle finanze Jihad Azour – candidato sostenuto dai partiti cristiani e dai partiti contrari a Hezbollah – ha ottenuto 59 voti, mentre l’ex ministro della sanità Suleiman Frangieh, sostenuto da Hezbollah, ha ricevuto 51 voti. E così il Paese resta in balia delle crisi economica e politica e senza un timoniere (il paese è senza presidente da oltre sei mesi, quando l’ex presidente Michel Aoun ha lasciato l’incarico). Anche se nessuno dei due ha raggiunto il numero di voti necessari per essere eletto sembra comunque che i due candidati più probabili restino Azour e Frangieh. Il primo attualmente è il direttore del Fondo monetario internazionale per il Medio Oriente e l’Asia centrale mentre Frangieh è il capo del movimento Marada, alleato di Hezbollah, e in passato è stato deputato e Ministro della Sanità.
Non è la prima volta che in Libano l’elezione del Presidente è così difficile. Già nel 2014 ci vollero ben 46 turni di votazioni prima di arrivare a eleggere Michel Aoun. In base al complesso accordo di condivisione del potere del Libano, il presidente del paese deve essere un cristiano maronita, il presidente del parlamento un musulmano sciita e il primo ministro un sunnita. Il compito più urgente del nuovo presidente sarà quello di far uscire la nazione, che conta circa 6 milioni di persone, tra cui più di 1 milione di rifugiati siriani, da una crisi economica senza precedenti iniziata nell’ottobre 2019.
Il crollo è arrivato dopo decenni di corruzione e cattiva gestione da parte della classe politica che ha governato il Libano dalla fine della guerra civile del 1975-90. La conclusione di un accordo di salvataggio con il Fondo Monetario Internazionale, di cui Azour è direttore, è considerata dai più la chiave per la ripresa del Libano. Azour ha sospeso però il suo incarico di direttore regionale dell’organizzazione dopo aver annunciato la sua candidatura alla presidenza. I sostenitori di Azour hanno accusato Hezbollah e i suoi alleati di bloccare il processo democratico. Hezbollah dal canto suo ha spesso criticato i candidati opposti come divisivi e “conflittuali”, sebbene Azour abbia affermato che se eletto lavorerà per tutti e per porre fine alla crisi economica. Tuttavia non tutti quelli che sono contrari ad Hezbollah sostengono la candidatura di Azour; alcuni lo vedono come rappresentante di partiti settari. Al momento non è stata ancora stabilita alcuna data per un tredicesimo tentativo di elezione.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Sembrano sempre di più andare verso la normalizzazione i rapporti tra Stati Uniti e Arabia Saudita. Il Segretario di Stato americano, Antony Blinken, è arrivato in Arabia Saudita ieri per una visita di tre giorni. Già subito al suo arrivo Blinken ha incontrato il principe ereditario Mohammed bin Salman e, secondo quanto ha dichiarato il portavoce del Dipartimento di Stato americano, Matthew Miller, i due si sono impegnati a “promuovere la stabilità, la sicurezza e la prosperità in tutto il Medio Oriente e oltre”.
La missione del Segretario di Stato americano ha come scopo quello di cercare di rafforzare le relazioni tra i due paesi che hanno una storia di relazioni difficili e disaccordi specie nel campo dei diritti umani. Tra gli argomenti in discussione anche la collaborazione per raggiungere la pace in Yemen. Blinken ha anche sottolineato che le relazioni bilaterali tra Washington e Riyadh sono state “rafforzate dai progressi sui diritti umani”, e ha ringraziato l’Arabia Saudita per il suo sostegno durante la recente evacuazione di cittadini statunitensi dal Sudan dilaniato dalla guerra, nonché per gli sforzi diplomatici per fermare i combattimenti tra fazioni sudanesi rivali.
Durante la visita Blinken incontrerà anche diversi alti funzionari sauditi. Non sono però tutte rose e fiori. Solo pochi giorni fa infatti Riyadh aveva dichiarato di voler ridurre la produzione di petrolio, cosa che potrebbe aggiungere tensione al rapporto con Washington. Gli obiettivi del viaggio di Blinken sarebbero anche riconquistare influenza con Riyadh sui prezzi del petrolio, respingere l’influenza cinese e russa nella regione e promuovere la normalizzazione dei legami sauditi-israeliani.
Le tensioni tra i due Paesi si erano innalzate nel 2019 quando il presidente Biden, durante la sua campagna elettorale per la presidenza, aveva definito Riyadh “pariah” e li avrebbe trattati di conseguenza se fosse stato eletto. Subito dopo essere entrato in carica nel 2021, Biden aveva poi rilasciato una dichiarazione sostenendo che in base ad alcune rivelazioni dell’intelligence statunitense sarebbe stato il principe ereditario saudita ad approvare l’operazione per catturare e uccidere il giornalista e editorialista del Washington Post, Jamal Khashoggi, nel 2018. La situazione è leggermente migliorata nel luglio 2022 con la visita di Biden nel regno saudita. L’Arabia Saudita ospiterà in questi giorni anche una conferenza internazionale sulla lotta all’estremismo che sarà co-presieduta proprio da Blinken.
Una ulteriore visita ad alto livello si è avuta lo scorso 7 maggio, quando il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, si è recato in Arabia Saudita. E sono comunque giorni, in Arabia Sadita, di visite ad alto livello. Il presidente venezuelano, Nicolas Maduro, è arrivato domenica in Arabia Saudita per una visita ufficiale ed è stato accolto all’aeroporto di Gedda dal vice governatore della regione della Mecca, il principe Badr bin Sultan e da altri funzionari. Il Venezuela, ha in precedenza cercato il sostegno dell’Arabia Saudita per le sanzioni statunitensi, imposte dall’ex presidente Donald Trump ma allentate dal suo successore, Joe Biden. Tuttavia, per revocare le sanzioni, Washington chiede al Venezuela di compiere passi concreti verso libere elezioni. La visita di Maduro costituisce l’ultimo esempio dell’Arabia Saudita che persegue buoni rapporti con Stati che hanno rapporti difficili con gli Stati Uniti.
A marzo, l’Arabia Saudita ha accettato di riprendere le relazioni diplomatiche con l’Iran in un accordo mediato dalla Cina. Ad aprile, il regno ha ripreso le relazioni con la Siria. La prossima settimana, l’Arabia Saudita ospiterà una conferenza d’affari in Cina.
Venezuela e Arabia Saudita sono i paesi con le maggiori riserve accertate di petrolio. Entrambi hanno un rapporto bilaterale di lunga data, rafforzato dalla loro partecipazione all’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEC), di cui entrambi sono membri fondatori. In termini di relazioni saudite-venezuelane, i due paesi mantengono le rispettive ambasciate. Non hanno relazioni commerciali significative. Nel 2021, le esportazioni dell’Arabia Saudita in Venezuela ammontavano a soli 1,91 milioni di dollari, mentre il Venezuela ha esportato solo 508.000 dollari nel regno, secondo l’Osservatorio della complessità economica con sede negli Stati Uniti. Dopo la riunione OPEC+ di domenica, l’Arabia Saudita si è impegnata a tagliare 1 milione di barili al giorno di petrolio dalla sua produzione a partire da luglio.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Il terremoto che il 6 febbraio scorso ha colpito Turchia e Siria, ha lasciato morte e distruzione. Ma ha anche mostrato un volto diverso in Medio Oriente, con due paesi certamente non amici, Israele e Siria, che hanno in qualche modo messo da parte ostilità. Non senza il tornaconto di paesi terzi, Russia in particolare.
Subito dopo il sisma, Israele aveva fatto sapere di aver ricevuto una richiesta da Damasco, giunta tramite Mosca, per fornire assistenza e soccorsi alla popolazione. Il premier Benjamin Netanyahu, in un gesto che a molti era sembrato estremamente significativo visti i rapporti tra i due Paesi, aveva dichiarato di essere pronto a inviare aiuti. “Israele ha ricevuto una richiesta da una fonte diplomatica per aiuti umanitari alla Siria, e io l’ho approvata”, aveva detto Netanyahu ai membri del suo partito, il Likud, aggiungendo che gli aiuti sarebbero stati inviati presto. Si sarebbe trattato di coperte, medicine, cibo e altri generi di prima necessità per alleviare le sofferenze delle popolazioni colpite. Netanyahu inoltre si sarebbe dichiarato disponibile ad accogliere anche i feriti. Tuttavia il quotidiano filogovernativo siriano Al Watan ha citato una fonte ufficiale secondo cui Damasco non avrebbe mai richiesto l’aiuto di Israele dopo il terremoto. Secondo altre fonti, la richiesta di assistenza a cui Netanyahu avrebbe fatto riferimento, sarebbe giunta dall’opposizione al governo di Assad e dai gruppi jihadisti nel nord-ovest del Paese.
Dalla creazione dello stato di Israele nel 1948, il governo siriano non ha riconosciuto Israele e i due Paesi hanno combattuto diverse guerre. Ancora oggi sono numerosi i raid dell’aviazione israeliana in Siria, per colpire, secondo fonti militari israeliane, basi iraniane e di ribelli che minerebbero la sicurezza dello stato ebraico. Il confine sulle alture del Golan è uno dei più militarizzati dell’area e pochissime volte si è aperto per favorire cittadini di una parte e dall’altra, soprattutto drusi, permettendo così a famiglie divise di incontrarsi o a fedeli di partecipare a feste religiose.
Cosa sia veramente successo tra i due Paesi non è chiaro. Certo è che aiuti israeliani sono stati inviati in Siria, anche attraverso organizzazioni non governative che da anni lavorano sul territorio, e personale dell’esercito con la stella di Davide ha operato diverse operazioni di aiuto in Turchia.
Se i rapporti con la Siria sono estremamente complicati, quelli con la Turchia segnalano alti e bassi. Per Ankara, Israele si è mossa subito. D’altronde, specie di recente, i rapporti tra i due Paesi sono migliorati, anche grazie e visite reciproche di alto livello. Già all’indomani del terremoto il Ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant ha parlato con il suo omologo turco e la macchina degli aiuti è partita velocemente. Israele del resto, come ricorda un editoriale del Jerusalem Post, ha decenni di esperienza nel fornire aiuti a seguito di disastri naturali, inclusi molti terremoti, oltre a fornire squadre di ricerca e salvataggio e assistenza umanitaria, specialmente sotto la guida del Comando del Fronte Interno.
In questo momento, i due Paesi sono vicini, hanno stretto di nuovo relazioni, i leader a tutti i livelli si chiamano e si parlano, dopo un periodo di grosso gelo. Una pacificazione fra i due è nel mutuo interesse, dal momento che hanno nemici e interessi in comune. Entrambi puntano a un ruolo prominente nell’area. Ankara, come pure l’Arabia Saudita, è interessata al controllo del terzo sito più sacro per l’Islam, la Spianata delle moschee di Gerusalemme, che attualmente è sotto controllo del Waqf, un’organizzazione controllata dal regno hashemita di Giordania. Per il “sultano” Erdogan, la possibilità di mettere le mani sulla Spianata rappresenterebbe sicuramente una grande vittoria interna ed esterna e spezzerebbe, nell’area l’influenza dei Paesi del Golfo, sauditi in testa, riportando ai fasti l’impero ottomano, sogno mai sopito del Presidente turco.
Non va dimenticato che tra Turchia e Israele, oltre all’interesse politico ed economico (Ankara guarda con estremo interesse alle trivellazioni, estrazioni e trasporto di gas dai giacimenti israeliani posti dinanzi alle sue coste), c’è anche quello militare. Entrambi i Paesi hanno nella Siria un nemico comune. Erdogan, dallo scoppio della guerra civile siriana nel 2011, si è schierato contro il governo di Assad, sostenendo gli oppositori e ospitando sul proprio territorio anche il quartier generale di questi, partecipando pure ad azioni militari. L’esercito turco ha occupato militarmente il nord della Siria e ha approfittato per portare avanti, sul territorio del Paese in guerra, operazioni contro i curdi. Israele, invece, è rimasto alla finestra, disinteressato alle vicende interne siriane e interessato più ai rapporti della Siria con l’Iran.
Il terremoto di febbraio ha un po’ stravolto le cose, facendo sotterrare l’ascia di guerra a tutti. Un’operazione certamente di facciata e sicuramente mediata dalla Russia di Putin, grande tessitrice e game master della situazione siriana. Mosca, infatti, funge spesso da public relation manager per Damasco e gli aiuti giunti dopo il terremoto, soprattutto dai paesi nemici, ne sono la prova. Dopotutto la Russia ha sempre garantito a Israele la possibilità di attaccare postazioni ostili, principalmente iraniane, in ogni angolo della Siria, facendo morti e danni. Mosca, nell’area, ha fatto una precisa scelta di campo: si è schierata con i “cattivi” per avere voce in capitolo e mediare con tutti per loro, oltre ad ottenere basi e punti di ascolto verso gli altri paesi. Come per la Siria, così è stato anche per la Palestina, uno dei pochi governi che hanno apertamente appoggiato l’invasione russa in Ucraina. La Russia è amica della Siria e dell’Autorità Nazionale Palestinese, ma per Israele è un importante alleato, vista la presenza in Israele di una nutrita componente ebraica russofona, che ha anche un partito politico e guida diverse città. Più per rispondere a questa esigenza che per venire incontro a Damasco, cercando una distensione, Israele si è mossa in aiuto delle popolazioni siriane colpite dal sisma.
È difficile che Netanyahu avrebbe fatto una fuga in avanti verso Damasco se non ci fosse stata la richiesta russa, anche se un segno di distensione verso la Siria potrebbe certamente aiutare nel soft power verso i Paesi arabi che il premier ha messo in campo da anni, e che è stato minato dalle recenti operazioni dell’esercito in Cisgiordania con la morte di decine di palestinesi e da nuovi accordi che potrebbero cambiare gli scenari. D’altro canto, la situazione così tragica e drammatica che la Siria vive, prima per anni di guerra civile, poi per il terremoto, può aver spinto a chiedere aiuti alla Russia che li avrebbe poi girati a tutti, Israele compreso.
Scenari diversi, dicevamo. Benjamin Netanyahu ha sempre fatto degli accordi di Abramo, l’importante documento di cooperazione e di apertura di relazioni di Israele con Paesi arabi del Golfo e poi successivamente africani, una bandiera, intestandosi, congiuntamente all’ex Presidente americano Donald Trump, una incontestabile vittoria politica internazionale. Fino all’agosto 2020, infatti, Israele era isolatissimo nell’area, potendo contare solo sugli accordi post bellici sottoscritti con i vicini Giordania ed Egitto. Ma nessun altro paese islamico, soprattutto mediorientale o del Golfo, era propenso a stringere rapporti con lo Stato Ebraico, in particolare per l’annosa questione palestinese. Interessi economici, l’Expo di Dubai, necessità di scambi e armi, faccende legate anche ai sorvoli sia militari che civili, hanno però spinto prima Emirati Arabi e Bahrein, poi Marocco e Sudan, ad allacciare rapporti con Israele. Spingendosi anche oltre. Gli Emirati hanno sottoscritto una serie di accordi con Israele, soprattutto nel campo della sicurezza, dall’acquisto di armi e tecnologie alle esercitazioni congiunte; il Bahrein ha permesso la presenza israeliana nel proprio territorio a militari israeliani in servizio nella quinta flotta americana di stanza nel Golfo. Tra Gerusalemme e Abu Dhabi, inoltre, è in via di definizione un accordo di libero scambio che favorirà entrambe le economie.
Ma due cose hanno stravolto, nelle ultime settimane, i piani di Netanyahu. Gli Emirati hanno fatto sapere che non intendono procedere ad acquistare armi da Israele a causa della presenza dei due esponenti di destra nell’esecutivo. Presenza, che non permetterebbe a Netanyahu di avere il pieno controllo del gruppo di governo. Secondo rilevazioni della israeliana Channel 12, il Presidente degli Emirati, lo sceicco Mohamed bin Zayed, avrebbe detto a funzionari israeliani che “fino a quando non saremo sicuri che il primo Ministro Netanyahu abbia un governo che può controllare, non saremo in grado di operare congiuntamente”. La notizia è stata successivamente smentita dagli uffici del Premier israeliano, ma comunque ha fatto rumore nella politica interna ed esterna israeliana. Primo perché è arrivata pochi giorni dopo il pogrom che gruppi di coloni hanno organizzato ad Hawara, la cittadina palestinese nella quale due coloni sono stati uccisi da un membro di Hamas mentre erano in auto, il tutto inasprendo i rapporti già tesi. Situazione che ha reso vano il vertice di Aqaba nel quale, dopo anni, si sono incontrati servizi palestinesi e israeliani per discutere, arrivando a un accordo, un alleggerimento delle tensioni in vista delle feste religiose di Ramadan e della Pasqua ebraica. Ma soprattutto, a sparigliare la situazione, è stato l’incontro, mediato dalla Cina, tra Arabia Saudita e Iran che hanno ristabilito i loro rapporti diplomatici dopo sette anni, una mossa che rende più difficile per Netanyahu raggiungere il suo obiettivo di normalizzare i rapporti con l’Arabia Saudita. Netanyahu ha cercato di stringere quante più relazioni possibili con i Paesi islamici per ottenere internamente l’isolamento della Palestina, esternamente quello dell’Iran. Per questo si parlava da tempo di accordi e di uno stato avanzato di colloqui con l’Arabia Saudita. Il permesso, concesso solo poche settimane fa, ai voli israeliani di attraversare lo spazio aereo saudita, per accorciare le rotte verso l’Asia, India in particolare, aveva fatto ben sperare. Invece, l’accordo che Riad, mediato da Pechino, ha stretto con Teheran per la ripresa delle relazioni, ha gelato tutti. Al momento, nessun esponente del governo o della presidenza israeliana ha commentato l’accordo. Lo hanno solo fatto, condannandolo, i leader dell’opposizione, che hanno parlato di minaccia ad Israele. Una grana per Netanyahu, che deve affrontare problemi e contestazioni politiche interne, sia da parte dell’opposizione che di molti cittadini, ma anche di alcuni sodali; gelo sulle relazioni internazionali, una delle maggiori vittorie di Bibi degli ultimi anni.
Il premier israeliano, infatti, deve riscrivere la sua road map estera, alla luce dell’accordo saudita-iraniano. Sembrava avesse la strada spianata per aumentare la propria influenza nel Golfo, ed invece deve ricominciare da capo. E con la pesante situazione di contestazione interna a causa della riforma della giustizia, non è semplice.
La presenza nel suo esecutivo di estremisti antipalestinesi, che hanno incitato, più volte, la folla contro i residenti musulmani in Cisgiordania e inneggiato a uno stato esclusivamente di ebrei, certo non lo aiuta. La sponda ritrovata con Ankara può essere sicuramente un aiuto, ma non dimentichiamoci che Erdogan da sempre mira a un’influenza nell’area che cozza non solo con quella israeliana ma soprattutto con le potenze del Golfo. L’accordo tra Riad e Teheran è una coltellata alle spalle a Gerusalemme, la stessa che, come denunciò Mahmoud Abbas (Abu Mazen) fu inferta ai palestinesi dai Paesi del Golfo con la sottoscrizione degli Accordi di Abramo.
Se una cosa gli aiuti al terremoto hanno dimostrato è che nell’area non si muove foglia che la Russia non voglia. La sua influenza, nonostante la lunga e debilitante guerra in Ucraina, non è cambiata, avendo conquistato posizioni importanti. Dopotutto Mosca fa sentire forte il suo ascendente. Non solo continuando a permettere i raid israeliani in Siria, non solo convincendo Gerusalemme a mandare aiuti alla popolazione nemica, ma ha nell’area anche una fonte di reclutamento per il proprio esercito. Sono infatti numerosi i palestinesi residenti in Libano che hanno accettato di andare a combattere a favore della Russia, nel conflitto in corso con l’Ucraina, in cambio di circa 350 dollari al mese. Secondo fonti di stampa, si tratterebbe per lo più di palestinesi nati dopo il 1969, cioè coloro che nel paese dei cedri non hanno un’adeguata registrazione anagrafica presso le autorità libanesi, e quindi per loro è più facile viaggiare per andare a partecipare al conflitto come mercenari. La maggior parte dei palestinesi schierati in prima linea in Ucraina proverrebbe da Ein Al-Khalwa, il più grande campo profughi palestinese in Libano, situato a sud della città di Sidone, e sarebbero quasi tutti membri del movimento politico Fatah, guidato dal presidente dell’ANP Mahmoud Abbas.
Questo articolo è pubblicato anche sul numero di aprile/giugno di eastwest
Puoi acquistare la rivista sul sito o abbonarti
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Una disputa sull’acqua ha rischiato di portare un conflitto tra Afghanistan e Iran nei giorni scorsi. Disputa che, in alcuni scontri alla fine della settimana scorsa, ha portato all’uccisione di due guardie iraniane di confine e una afghana, dopo che da una parte e dall’altra ci sono stati colpi esplosi in direzione dell’altro.
Nel 1973 i due paesi hanno siglato un trattato sulla condivisione delle acque del fiume Helmand, che scorre dall’Afghanistan verso l’Iran orientale. Il fiume, che è lungo più di 1.000 km e attraversa il confine, è stato arginato sul lato afghano per generare elettricità e irrigare i terreni agricoli. Una diga afghana ha infatti favorito l’afflusso di acqua nella provincia di Nimroz, per aiutare nelle coltivazioni, rendendo invece la portata del fiume verso la provincia iraniana del Sistan-Baluchistan quasi nulla. La siccità è un problema in Iran da circa 30 anni, che è peggiorato negli ultimi dieci anni, secondo l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO). L’Organizzazione meteorologica iraniana afferma che circa il 97% del paese deve ora affrontare un serio livello di siccità.
Secondo il trattato sull’acqua di Helmand firmato dai due paesi cinquanta anni fa, l’Afghanistan dovrebbe condividere annualmente con l’Iran 850 milioni di metri cubi di acqua da dell’Helmand. Ma non è quello che è successo ultimamente. La disputa va avanti da anni, ma si è esacerbata a metà di maggio quando il presidente iraniano Raisi ha accusato i talebani al governo in Afghanistan di violare il trattato. Da Kabul hanno respinto le accuse, appellandosi ad una risoluzione pacifica come prevede lo stesso trattato, che si spinge fino a nominare un mediatore terzo. Ma qualcosa deve essere andato storto e alla fine della scorsa settimana ci sono stati gli scontri e le vittime, che hanno poi spinto Teheran a chiudere fino a nuovo avviso il posto di frontiera di Milak-Zaranj, che non si trova nei pressi del luogo dello scontro, ma che è una importantissima arteria commerciale tra i due paesi. I quali non hanno mai nascosto le loro antipatie, dovute soprattutto a differenze di carattere religioso: tra i sunniti afghani e gli sciiti iraniani certamente non corre buon sangue. Teheran intrattiene rapporti con i talebani ma non li ha mai riconosciuti come i legittimi governanti del paese asiatico, anche perché li accusa di discriminare la minoranza sciita, rappresentata dagli Hazara, che hanno subito massacri e abusi dai sunniti afghani.
Entrambi i paesi stanno ora cercando di ridurre la tensione, appellandosi alla calma. Ma è chiaro che c’è fuoco che cova sotto la cenere. Sia i talebani che gli iraniani hanno chiesto di risolvere le questioni per via diplomatica. E’ però difficile che Kabul rinunci alla diga sul fiume Helmand in un momento nel quale l’acqua vale più del petrolio in zone dove la siccità la fa da padrona. Teheran continua ad accusare Kabul di non rispettare i trattati di confine, da quando nel 2021 hanno ripreso il potere. Cosa che ha portato a scontri spesso, derubricati in “incomprensioni”. Dopotutto il confine tra i due è conteso, il tracciato non condiviso. Teheran ha spesso accusato Kabul di usare il confine anche per il traffico di droga, scusa usata in un primo momento anche per giustificare gli scontri della settimana scorsa.
“L’Emirato islamico dell’Afghanistan considera il dialogo e il negoziato una via ragionevole per qualsiasi problema. Trovare scuse per la guerra e azioni negative non è nell’interesse di nessuna delle parti”, ha detto Enayatullah Khowarazmi, portavoce del ministero della Difesa talebano, allo scoppio dell’ultimo conflitto che ha portato alla morte delle tre guardie di frontiera.
Sabato scorso, il ministro degli Esteri ad interim dei talebani, Amir Khan Muttaqi ha incontrato un inviato iraniano in Afghanistan per discutere dei diritti sull’acqua del fiume Helmand, secondo i tweet del funzionario del ministero degli Affari esteri afghano Zia Ahmad. Ma per il resto le tensioni sono aumentate. Un altro video pubblicato online nei giorni scorsi mostrava presumibilmente una situazione di stallo con le forze iraniane e i talebani mentre i lavoratori edili iraniani cercavano di rafforzare il confine tra i due paesi.
Nei giorni scorsi, anche account filo-talebani online hanno condiviso un video con una canzone che invitava il Ministro della Difesa ad interim, il mullah Mohammad Yaqoob, a opporsi all’Iran. Il mullah Yaqoob è il figlio del mullah Mohammad Omar, defunto fondatore dei talebani e primo capo supremo.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Con un paese uscito dalle urne presidenziali diviso a metà, Recep Tayyip Erdogan rinnova per altri cinque anni il suo mandato presidenziale e inaugura il “secolo turco”, come lo ha definito lui stesso. Quello che al termine del suo mandato sarà il più longevo leader turco, più del fondatore della Patria Mustafa Kemal Ataturk, che ha già superato, ha vinto le presidenziali puntando soprattutto sull’identità turca, divisa tra laicismo e secolarismo. Ed è puntando sul secondo che ha sbaragliato un contendente che, comunque, non sembrava avere tutte le carte in regola, almeno non il carisma del “sultano di Istanbul”, per sbaragliare la partita. Così alla fine Erdogan ha chiuso al 52,14% la contesa, relegando Kemal Kilicdaroglu al 47,86%.
Sintomatica la divisione del paese: il sultano ha vinto nelle aree rurali del paese, il “Gandhi turco” (così definito più per una pseudo somiglianza fisica che per le idee politiche) vince nelle città e sulla costa mediterranea ed egea e nella parte orientale. Dopotutto, il laicismo della coalizione a sei partiti di Kilicdaroglu non poteva non fare breccia anche a Istanbul, dove comunque Erdogan ha cominciato la sua carriera politica essendone stato il sindaco per cinque anni, durante i quali ha gettato le basi per lo sviluppo internazionale della metropoli sul Bosforo, e nelle altre città e luoghi più fedeli alla svolta non religiosa voluta da Ataturk e maggiormente sviluppate dal punto di vista infrastrutturale ed economico; oppure alle zone orientali dove la presenza curda è da sempre una spina nel fianco per il sultano.
Proprio le metropoli turche, dove la pesante crisi economica si è fatta sentire di più, hanno sperato in un cambiamento. Anni di politiche economiche che hanno svuotato le casse dello stato a favore di prebende e investimenti faraonici, hanno portato l’inflazione al picco dell’83% ad ottobre, poi sceso ultimamente al 50%, con svalutazione totale della lira turca, che negli ultimi cinque anni ha perso il 77% del suo valore sul dollaro, quando invece veniva quotata uno a uno con il biglietto verde. Il raddoppio degli stipendi agli statali, visto come mancia elettorale da parte di Erdogan poco prima delle elezioni decisive, e lo scellerato sviluppo che ha portato alle costruzioni selvagge sbriciolatesi come crackers durante il devastante terremoto del 6 febbraio scorso facendo oltre 46mila vittime, sono solo alcuni ingredienti della profonda crisi economica che il sultano dovrà affrontare, crisi che comunque deriva dalle sue scelte.
La Turchia che aveva contribuito a creare agli inizi degli anni 2000 e che una decina di anni fa viaggiava a ritmi del 6% di crescita, è un mero ricordo. Ma la frustrazione per la questione economica che, non dimentichiamocelo, obbliga anche Erdogan ad essere sempre più dipendente dall’abbraccio mortale russo visto che Putin gli ha abbonato una corposa bolletta energetica, non ha impedito al sultano di vincere.
A pesare di più, il sentimento secolare. Dopotutto era una strada segnata da quando, finito il suo premierato al governo e cominciato il suo mandato presidenziale, cambiò la costituzione per far diventare la Turchia, di fatto, una democrazia guidata da un uomo forte. Puntando soprattutto sull’identità islamica, contro le “derive delle comunità LGTBQ+” ed altre simili provenienti dall’Occidente, festeggiando la vittoria elettorale nello stesso giorno, 570 anni dopo la vittoria di Maometto II che valse la conquista di Costantinopoli da parte degli ottomani, Erdogan è di nuovo in sella.
Lui dice per l’ultima volta: dopotutto la sua costituzione così dice, ma nulla è certo da parte di chi è accusato anche di aver orchestrato un finto (probabilmente non così farlocco) colpo di stato, nel 2016, per stringere di più ancora i cordoni contro gli oppositori e rimuoverne tra arresti e allontanamenti circa 5000.
Anche il suo oppositore aveva smesso i panni del padre indiano della non violenza e fatto dichiarazioni a favore del rimpatrio delle migliaia di profughi siriani presenti sul territorio, un cavallo di battaglia del sultano, cercando di combatterlo e superarlo sul suo stesso terreno.
Di certo è che la politica internazionale, soprattutto Europa e Nato, dovranno fare i conti con un Erdogan che esce ancora più rafforzato anche nella sua ambivalenza: quella che lo vede alleato di Putin, tanto da non accettare l’applicazione delle sanzioni, ma buon mediatore nel conflitto soprattutto per quanto attiene l’esportazione di grano ucraino; quella che lo vede a capo del paese con il secondo maggior esercito della Nato ma che blocca l’espansione dell’Alleanza difensiva, prima rendendo estremamente difficile l’ingresso della Finlandia e ora non accettando quello della Svezia; quello che ospita 50 testate nucleari americane; che ospita 4 milioni di rifugiati; che ha anche ampliato la portata dell’esercito turco nel nord della Siria; che mantiene stretti legami con diversi gruppi islamisti, alcuni ritenuti terroristi come Hamas che, infatti, è stato tra i primi a congratularsi per la vittoria. Una sfida, quella del secolo turco, non solo per i turchi ma per il mondo intero, Europa in testa.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Prove tecniche di normalizzazione tra Israele e Arabia Saudita? Nonostante da diverse settimane sembrava che i sauditi avessero virato verso altre sponde, normalizzando i rapporti con Iran prima e Siria poi, nemici storici di Israele, la stampa israeliana rilancia una indiscrezione che potrebbe cambiare di nuovo le carte in tavola, e ridare slancio agli accordi di Abramo, il programma di normalizzazione israeliano con i paesi arabi, che ha proprio nei sauditi l’obiettivo principale.
Secondo la stampa israeliana, infatti, il primo ministro Benjamin Netanyahu, e il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, avrebbero avuto almeno due colloqui telefonici nelle scorse settimane. Le telefonate si sarebbero svolte prima e dopo l’incontro della Lega Araba della settimana scorsa e si sarebbero incentrate sulla possibilità di normalizzazione dei rapporti tra i due paesi.
Sembrerebbe però che, almeno al momento, non sarebbero ancora stati fatti significativi passi in avanti tanto più che secondo alcune fonti il principe saudita avrebbe rifiutato una richiesta di incontro avanzata da Netanyahu, come pure ancora non si sarebbe raggiunto alcun accordo circa la possibilità di voli diretti da Israele all’Arabia Saudita per il pellegrinaggio alla Mecca.
I sauditi avrebbero fatto una serie di richieste, per lo più concessioni nei confronti dei palestinesi, tra cui il controllo di sicurezza palestinese sulla Moschea di al-Aqsa e sulla Chiesa del Santo Sepolcro, mentre il Muro occidentale resterebbe sotto il controllo israeliano.
Da parte israeliana pare ci sia molto ottimismo. La scorsa settimana, il ministro degli esteri Cohen aveva dichiarato al Jerusalem Post che la normalizzazione con l’Arabia Saudita “non è una questione di se, ma solo di quando. Noi e l’Arabia Saudita abbiamo gli stessi interessi”. Cohen ha aggiunto che la normalizzazione con l’Arabia Saudita potrebbe arrivare entro i prossimi sei mesi o al massimo entro un anno.
Funzionari sauditi invece avrebbero frenato tale ottimismo dicendo che affinché Riyadh faccia passi avanti occorre che ci siano progressi tra Israele e palestinesi. “La questione palestinese era e rimane la questione centrale per i paesi arabi – ha detto Mohammed bin Salman al vertice della Lega Araba tenutosi a Gedda la scorsa settimana – ed è in cima alle priorità del regno. Non tarderemo a fornire assistenza al popolo palestinese per recuperare le sue terre, ripristinare i suoi legittimi diritti e stabilire uno stato indipendente con Gerusalemme est come capitale”.
L’anno scorso circa 2.700 israeliani musulmani si sono recati alla Mecca e quest’anno dovrebbero farlo circa 4.500. Finora la maggior parte viaggiava attraverso la Giordania. Nel 2022 il Qatar ha consentito voli diretti da Israele verso Doha per la Coppa del Mondo, affermando pubblicamente che erano anche per i palestinesi, ma nessun palestinese è poi riuscito a partire per assistere ai mondiali partendo da Tel Aviv.
Israele in verità sta cercando di far decollare voli diretti per Jeddah per il pellegrinaggio alla Mecca già dal 2018 e ha compiuto uno sforzo diplomatico concertato quando il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha visitato l’Arabia Saudita lo scorso luglio. Biden ha detto di aver accolto con favore “le misure in discussione per includere voli diretti da Israele a Gedda per la Mecca per il prossimo anno”.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Per la prima volta nella sua storia, lunedì l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha commemorato la Nakba palestinese. Con la giornata della Nakba ogni 15 maggio, i palestinesi ricordano quello che chiamano “il giorno della catastrofe”, per piangere la creazione dello Stato di Israele nel 1948 e la conseguente distruzione dei villaggi palestinesi e lo sfollamento di 700.000 palestinesi che da allora sono diventati rifugiati. In occasione infatti della creazione dello stato ebraico, i nuovi cittadini israeliani sono rientrati nelle città che dichiaravano abitate dai loro avi e hanno preso le case che abitavano i palestinesi. Alcune, dicevano, erano quelle di famiglia, abbandonate secoli prima, altre invece senza alcun legame se non ideale. E così i palestinesi sono stati letteralmente cacciati dalle case, dai villaggi, diventando profughi sia nella terra che abitavano, sia nei paesi arabi vicini.
La storiografia contemporanea, dopo una prima negazione della Nakba, sembra accettare l’idea della cacciata dei palestinesi. In una dichiarazione pubblicata sul suo sito, l’ONU ha affermato che “Quest’anno ricorre il 75° anniversario dello sfollamento di massa dei palestinesi noto come la Nakba o la catastrofe. Il Comitato delle Nazioni Unite per l’esercizio dei diritti inalienabili del popolo palestinese (CEIRPP) commemorerà il 75° anniversario della Nakba presso la sede delle Nazioni Unite a New York”. Una decisione che non ha mancato di innescare polemiche e prese di posizione contrarie. L’amministrazione americana di Biden ha subito preso le distanze dall’evento, non partecipandovi, pur non rinnegando la sua assistenza finanziaria ai rifugiati palestinesi. Gli Stati Uniti “non hanno partecipato a questo evento organizzato dal Comitato sui diritti inalienabili del popolo palestinese, e non abbiamo mai programmato di partecipare a questo evento”, ha detto il portavoce della Missione statunitense all’ONU Nathan Evans.
Oltre agli Stati Uniti sono stati 45 i paesi che hanno deciso di non aderire all’evento organizzato dall’ONU. Tra questi il Regno Unito, il Canada, l’Australia, l’Albania, l’Ucraina l’India e 11 dei 27 Stati membri dell’Unione Europea, ovvero: Austria, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Portogallo, Romania e Slovacchia.
Israele, da qualche anno, ha varato una legge che vieta qualsiasi ricorrenza nel proprio territorio della Nakba palestinese. Uno dei momenti centrali dell’evento di New York è stato un discorso del presidente dell’Autorità palestinese Mahmoud Abbas (Abu Mazen) che ha chiesto la cacciata di Israele dalle Nazioni Unite. Abbas ha anche accusato gli Stati Uniti e il Regno Unito di essere responsabili della Nakba, di sostenere Israele e le sue politiche. Abbas ha poi chiesto alle Nazioni Unite di tenere annualmente tali eventi legati alla Nakba.
Il discorso del presidente palestinese ha suscitato molte critiche specie dal lato israeliano. L’ambasciatore di Israele alle Nazioni Unite, Gilad Erdan, ha detto che “Abu Mazen è delirante. Allo spregevole evento della Nakba, Abbas ha osato paragonare il governo israeliano al malvagio regime nazista, tra le altre menzogne antisemite assolutamente ripugnanti. I Paesi che hanno boicottato l’evento, oltre a Israele, hanno scelto di non cedere all’odio e alla menzogna. Meritano di essere elogiati per essersi schierati dalla parte giusta della storia”. Durante l’evento, sono stati proiettati numerosi video che hanno evidenziato la sofferenza dei rifugiati palestinesi mentre i sopravvissuti descrivevano come i residenti dei loro villaggi furono massacrati dall’esercito israeliano.
Il ministro degli Esteri Eli Cohen, tuttavia, non è riuscito a convincere la Svezia, paese che ha visitato quello stesso lunedì, a boicottare l’evento. Anche Cohen ha elogiato quei paesi che “hanno difeso la verità” e non hanno partecipato all’evento “vergognoso”. “Combatteremo la menzogna della ‘Nakba’ con tutte le nostre forze e non permetteremo ai palestinesi di continuare a diffondere bugie e distorcere la storia”, ha detto Cohen.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
All’alba di martedì 9 maggio, Israele ha intrapreso l’operazione militare “Scudo e Freccia” verso la striscia di Gaza. Obiettivo dei raid dell’esercito della stella di Davide, postazioni della Jihad Islamica Palestinese e del suo braccio armato le Brigate al Quds. A differenza di quanto successo in passato, stavolta Israele ha sferrato un poderoso attacco, fatto di oltre 133 obiettivi colpiti, 4 leader del movimento uccisi e altre 20 vittime (tra le quali diversi feriti, 5 donne e 5 bambini), non immediatamente dopo uno simile da Gaza. Anzi, a quello aveva già risposto. E la tempistica, unita a difficoltà interne, fa pensare a più di un analista che la risposta israeliana sia più per sistemare questioni interne che esterne.
Andiamo con ordine. Lo scorso 2 maggio, muore in un carcere israeliano, Khader Adnan, considerato uno dei leader della Jihad Islamica Palestinese. La morte di Adnan, dopo 86 giorni di sciopero della fame, ha provocato la ferma reazione sia in Cisgiordania sia dei gruppi terroristici di Gaza, in testa la Jihad Islamica Palestinese che, in una nota, ha avvertito Israele che il paese “pagherà il prezzo di questo crimine”.
Adnan, 44 anni, padre di 9 figli, era uno dei più noti prigionieri politici palestinesi nelle carceri israeliane e un leader carismatico riconosciuto in Cisgiordania. Originario di una cittadina vicino Jenin, si era avvicinato nella metà degli anni ‘90 alla Jihad Islamica Palestinese mentre studiava matematica alla Birzeit University di Ramallah. In quella occasione, era diventato portavoce del gruppo terroristico. L’uomo era stato arrestato 12 volte, 2 anche dall’Autorità Nazionale Palestinese, per lo più in detenzione amministrativa, l’istituto giuridico israeliano che permette l’arresto di persone su sospetto di pericolosità per la sicurezza nazionale. Attraverso questa detenzione, non ci sono udienze probatorie in tribunale e il detenuto può essere trattenuto in carcere senza formali accuse per un massimo di 6 mesi rinnovabili.
La Jihad aveva manifestato il suo dissenso lanciando razzi da Gaza verso il sud di Israele. Razzi che non hanno fatto danni, così come la risposta israeliana, attraverso aerei e carri armati, che hanno colpito obiettivi militari senza ferire alcuno. I falchi del governo Netanyahu, con in testa il leader di Potere Ebraico e ministro della sicurezza nazionale, Itmar Ben Gvir, si sono lamentati di quella che hanno definito una “risposta debole” all’attacco gazawi. A causa di questo, il partito di destra ha boicottato in segno di protesta i lavori parlamentari.
Ben Gvir è stato anche protagonista di una importante polemica con l’Unione europea. La delegazione israeliana dell’esecutivo di Bruxelles, lunedì 8, ha deciso di cancellare il ricevimento previsto per la sera dopo, in occasione della giornata dell’Unione europea, a causa della presenza di Ben Gvir. Questi era stato delegato dal governo a intervenire, e quindi anche a parlare, in assenza del ministro degli esteri in visita in India.
Polemiche tra Ue e governo israeliano c’erano già state domenica per la decisione del secondo di abbattere, nei pressi di Betlemme in Cisgiordania, una scuola creata con fondi europei, perché ritenuta illegale. L’Ue ha motivato la cancellazione del ricevimento con la volontà di non offrire il podio a “chi non condivide i valori che l’Europa promulga”. Ovviamente Ben Gvir ha protestato, soprattutto per l’ingerenza europea negli affari interni israeliani, considerando che Bruxelles da sempre tiene rapporti con dittatori di ogni dove.
Silenzio da Netanyahu sulla vicenda, che pure era stato stimolato a chiedere un passo indietro di Ben Gvir al ricevimento, una uscita dignitosa dal cul-de-sac. Che Ben Gvir sia una spina nel fianco del premier, è ormai noto. Come è nota anche la indispensabilità dei numeri suoi e dell’alleato Smotrich per la tenuta del governo. Da un po’ si parla di una sostituzione di questi con Gantz, ma sono più sogni, visti i rapporti tra l’ex ministro della difesa e Netanyahu, che solide realtà.
Martedì mattina, Netanyahu dà il via a una operazione su Gaza in risposta ai lanci della settimana prima. Una risposta poderosa, oltre 40 aerei e diversi altri velivoli impiegati. Operazione tutta contro postazioni e uomini del Jihad Islami, senza risparmiarsi neanche quando gli obiettivi sono in presenza della famiglia. E alle prime voci di una tregua, dopo che oltre 370 razzi sono stati lanciati in risposta da Gaza, diversi intercettati dal sistema antimissile israeliano, Netanyahu ha detto che l’operazione non è finita. La mediazione egiziana è stata, così, congelata.
All’annuncio dell’operazione Scudo e Freccia, il primo a congratularsi è stato proprio Ben Gvir che, contestualmente, ha annunciato di riprendere a partecipare ai lavori parlamentari. Netanyahu aveva tenuta segreta l’operazione finanche ai suoi ministri, Ben Gvir compreso, ovviamente era nota a quello della difesa.
Ora, dopo aver ucciso 4 tra i più importanti leader della Jihad Islamica, non è chiaro quali siano i nuovi obiettivi. Sul fronte interno, lo strappo è rientrato. Lo Shin Bet e l’esercito continuano anche le operazioni in Cisgiordania contro i fiancheggiatori della stessa organizzazione terroristica. Non è ancora chiaro che farà Hamas, che fino ad oggi non ha preso parte ai combattimenti, pur minacciando ritorsioni dopo la morte di Adnan.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
La morte di Khader Adnan, considerato uno dei leader della Jihad Islamica Palestinese, avvenuta dopo 86 giorni di sciopero della fame in un carcere israeliano, ha acceso ancor di più le luci sull’istituto della detenzione amministrativa. Adnan, 44 anni, padre di nove figli, era uno dei più noti prigionieri politici palestinesi nelle carceri israeliane e un leader carismatico riconosciuto in Cisgiordania. Originario di una cittadina vicino Jenin, si era avvicinato nella metà degli anni ‘90 alla Jihad Islamica Palestinese mentre studiava matematica alla Birzeit University di Ramallah. In quella occasione era diventato portavoce del gruppo terroristico.
L’uomo è stato arrestato dodici volte, due anche dall’Autorità Nazionale Palestinese, per lo più in detenzione amministrativa, l’istituto giuridico israeliano che permette l’arresto di persone se sono ritenute sospette di pericolosità per la sicurezza nazionale. Durante questa detenzione, non ci sono udienze probatorie in tribunale e il detenuto può essere trattenuto in carcere senza formali accuse per un massimo di sei mesi, rinnovabili. L’ultimo arresto, da parte di Israele, risale allo scorso 5 febbraio, quando fu prelevato dallo Shin Bet e dall’esercito israeliano, nella sua casa di Arrabeh, vicino Jenin, dove l’uomo gestiva un forno e un negozio di generi alimentari. Subito dopo l’arresto, Adnan ha cominciato lo sciopero della fame, per protestare contro la detenzione amministrativa. Pochi giorni fa era stato visitato dai medici della Ong Physicians for Human Rights Israel, che ne avevano chiesto il rilascio per le sue pessime condizioni di salute. L’Israeli Prison Service, che sovrintende alle carceri israeliane, ha riferito che Adnan è infatti stato trovato senza conoscenza nella sua cella, dopo aver rifiutato non solo il cibo, ma anche il ricovero in ospedale nei giorni scorsi. Per la sua liberazione o per le sue cure si era mossa anche la Croce rossa Internazionale, che ora chiede alle autorità israeliane di restituire alla famiglia il suo cadavere. Non era la prima volta che Khader Adnan sceglieva lo sciopero della fame per protestare contro la detenzione amministrativa, ispirando altri prigionieri nella sua condizione. La prima volta risale ai primi del 2000; nel febbraio del 2012 terminò uno sciopero durato 66 giorni.
Secondo gli ultimi dati disponibili, nelle carceri israeliane ci sono 4900 prigionieri politici palestinesi. HaMoked, un gruppo israeliano per i diritti che raccoglie regolarmente dati dalle autorità carcerarie, ha affermato che ad aprile c’erano 1.016 persone in detenzione amministrativa. Quasi tutti sono palestinesi arrestati in base alla legge militare, poiché la detenzione amministrativa è usata molto raramente contro gli ebrei. Quattro ebrei israeliani sono attualmente detenuti senza accusa.
Nella detenzione amministrativa, una persona è trattenuta senza processo senza aver commesso un reato, ma solo sulla base del fatto che probabilmente intende violare la legge in futuro. Poiché questa misura dovrebbe essere preventiva, non ha limiti di tempo. La persona è detenuta senza procedimento giudiziario, per ordine del comandante militare regionale, sulla base di prove classificate che non gli vengono rivelate. Ciò lascia i detenuti impotenti di fronte ad accuse sconosciute senza alcun modo per confutarle, senza sapere quando saranno rilasciati e senza essere accusati, processati o condannati.
In Cisgiordania (esclusa Gerusalemme Est), la detenzione amministrativa è effettuata ai sensi dell’Ordine riguardante le disposizioni di sicurezza. L’ordinanza autorizza il comandante militare della Cisgiordania, o un altro comandante a cui è stato delegato il potere, a porre persone in detenzione amministrativa per un massimo di sei mesi alla volta, se il comandante ha “ragionevoli motivi per ritenere che ragioni di carattere regionale, sicurezza o pubblica sicurezza esigano che una determinata persona sia trattenuta in stato di detenzione”. Se, prima della scadenza dell’ordinanza, il comandante militare ha “ragionevole motivo di ritenere che le medesime ragioni richiedano ancora il trattenimento del detenuto in stato di detenzione”, può prorogare l’originaria ordinanza per un ulteriore periodo di sei mesi di volta in volta.
L’Ordinanza sulle disposizioni di sicurezza non pone quindi limiti al tempo complessivo in cui una persona può essere trattenuta in detenzione amministrativa. In pratica, ciò consente a Israele di incarcerare palestinesi che non sono stati condannati per nulla anche per anni e anni. Le persone detenute in detenzione amministrativa devono essere portate davanti a un giudice militare entro otto giorni dall’ordine di detenzione originale o dalla sua proroga. Il giudice può confermare l’ordine, respingerlo o abbreviare il periodo di detenzione in esso previsto. Qualunque decisione prenda il giudice militare, sia il detenuto che il comandante militare possono appellarsi alla Corte d’appello militare e, successivamente, all’Alta Corte di giustizia.
Le udienze sui provvedimenti di custodia cautelare si svolgono a porte chiuse e ai giudici è consentito disapplicare il diritto ordinario della prova. In particolare, i giudici possono “accettare le prove in assenza del detenuto o del suo avvocato e senza rivelarle loro”, se sono convinti che la divulgazione delle prove possa “nuocere alla sicurezza regionale o pubblica”.
In sostanza quindi, l’accusato e i suoi difensori, non sanno neanche contro quali prove o indizi devono difendersi. Diverse le Ngo israeliane, palestinesi e straniere, che hanno denunciato più volte il ricorso e l’abuso a questo tipo di detenzione da parte di Israele, soprattutto nei confronti dei palestinesi. Basta che i servizi interni, lo Shin Bet, o organi di sicurezza simili suggeriscano l’arresto di un potenziale terrorista o fiancheggiatore, che può scattare la detenzione senza accuse. Una violazione, secondo molti. Del diritto di difesa oltre che di quelli civili, dal momento che Israele continua a fare largo uso dell’istituto.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Riprenderanno oggi, nella residenza del presidente Isaac Herzog, i colloqui tra maggioranza e opposizione sulla riforma della giustizia, fortemente voluta ma messa in pausa dal governo Netanyahu, che ha diviso l’opinione pubblica. Nonostante lo stop dato al processo di approvazione da parte dell’esecutivo, le manifestazioni contro la riforma sono continuate e, da sedici settimane, migliaia di israeliani scendono in piazza per esprimere la loro opposizione alla riforma ma, soprattutto, la loro preoccupazione che il cambiamento delle regole del gioco dei rapporti tra governo e suprema corte, possa portare ad un serio problema democratico. La riforma della giustizia che il governo di Benjamin Netanyahu intende portare avanti, interessa principalmente l’istituto della Corte Suprema. Questa è l’unico contraltare rispetto al potere dell’esecutivo e del parlamento, dal momento che anche il presidente israeliano non ha potere di bloccare o rimandare indietro le leggi.
Israele non ha una Costituzione ma 13 leggi fondamentali. Allo stato attuale, la Corte Suprema israeliana può annullare qualsiasi legge decisa dal governo con una maggioranza semplice, basandosi sia sulle leggi fondamentali sia, in mancanza di appoggio su queste, su un principio di “ragionevolezza”. La Corte, che ha sede a Gerusalemme, è composta da 15 giudici nominati da una commissione di 9 membri: 3 dalla Corte stessa, 2 avvocati, 4 politici scelti dal governo (2 ministri, 2 parlamentari). Questo, secondo l’attuale governo, comporterebbe un eccessivo sbilanciamento a favore del potere giudiziario su quello politico. L’obiettivo di Netanyahu è di portare a 11 i membri del Comitato (invece dei 9 di oggi) assicurando la prevalenza dei componenti di nomina politica sui tecnici. Altra intenzione della riforma voluta dal premier sarebbe di eliminare il potere della Corte Suprema di abolire le leggi approvate dal parlamento. O, meglio, la Corte potrebbe decidere di bloccarle, ma il parlamento, con la maggioranza semplice di 61 membri su 120, potrebbe ribaltare la decisione della Corte. Secondo gli oppositori, in tal modo si darebbe troppo potere al governo e ciò rappresenterebbe una minaccia per la democrazia in Israele. Si chiede anche di eliminare la “clausola di ragionevolezza”, lasciando alla Corte suprema il compito di esaminare esclusivamente se una legge è aderente o meno ai princìpi espressi dalle Leggi fondamentali. La riforma prevede inoltre che le decisioni della Corte in materia di invalidità di una legge, anche di una legge fondamentale, vengano prese con una maggioranza di almeno l’80% e non più semplice.
Se è vero che la riforma è avversata da migliaia di persone, è altrettanto vero che i suoi sostenitori sono comunque una parte molto consistente della società israeliana. Dopotutto, che la Suprema corte abbia poteri infiniti, che i suoi membri vengano scelti da un minuscolo cerchio ristretto di persone, che non voti a maggioranza qualificata, che decida anche solo per “ragionevolezza”, è vero. Come è successo nei giorni scorsi.
In occasione dei due giorni di festa nazionale nei quali si sono prima ricordati i caduti delle guerre e del terrorismo e poi l’indipendenza israeliana, il ministro della difesa Galant aveva deciso (non è una cosa senza precedenti, anzi) che per tre giorni restassero chiusi i checkpoint con la Cisgiordania, per evitare che infiltrati palestinesi potessero rovinare le feste. Dopotutto, le manifestazioni delle ultime sedici settimane hanno mostrato (a torto, perché parliamo comunque di un esercizio democratico) un paese diviso e questo ha spinto molti nemici di Israele a portare attacchi verso il paese della stella di Davide dall’estero e dall’interno.
Contro la decisione di Galant è intervenuta la Suprema Corte, ribaltandola. Poche ore dopo, un attentato a Gerusalemme, nel quale un arabo israeliano (quindi residente in Israele non in Cisgiordania) si è lanciato con l’auto contro una folla nel centro di Gerusalemme, facendo sette feriti e venendo ucciso da un civile. Simile a quanto è accaduto sul lungomare di Tel Aviv quando è stato ucciso l’avvocato italiano Alessandro Parini.
E’ chiaro che la decisione della Suprema Corte di riaprire i checkpoint non ha favorito l’attentato. Ma come le manifestazioni sono oramai diventate un vero e proprio referendum popolare contro Netanyahu, quello che viene definito lo strapotere della Suprema Corte sta spingendo in piazza i sostenitori della riforma e l’episodio di Gerusalemme aumenta le polemiche sulle decisioni della Corte.
Ieri, quelli che cercano una mediazione, che sono convinti che una riforma sia necessaria, erano a manifestare davanti alla casa del presidente Herzog, che ospitava inviati stranieri in occasione della festa dell’indipendenza. Oggi, migliaia di sostenitori della riforma saranno in piazza e sabato, quelli contrari. Anche perché, come detto, stasera riprenderanno i colloqui e la riforma tornerà comunque in parlamento domenica, dopo la “tregua” offerta dall’esecutivo in occasione prima della Pasqua ebraica e poi delle festività nazionali. Con timori che il paese possa di nuovo dare la sensazione di essere vulnerabile (nella prima ondata di manifestazioni Netanyahu licenziò il ministro della difesa e anche i riservisti rifiutarono le chiamate alle armi) ed essere oggetto di nuovi attacchi.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Sta diventando sempre più Riad il centro nevralgico e diplomatico della stabilizzazione in Medioriente. Dopo le aperture saudite a Iran e Siria, nei giorni scorsi Mohammed Bin Salman (MBS), il principe ereditario saudita ma di fatto il reggente dello stato arabo, ha incontrato il Presidente dell’autorità nazionale palestinese Mahmoud Abbas (Abu Mazen) a Riad. Ma nello stato arabo, sono presenti anche i vertici di Hamas, il gruppo ritenuto terroristico da diversi governi al mondo e che governa Gaza, il quale da anni non ha rapporti sia con i sauditi che con Ramallah.
Mahmoud Abbas e il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, hanno discusso, si legge in note diplomatiche, degli ultimi sviluppi nei Territori palestinesi, delle relazioni bilaterali, dei piani di diversificazione economica dell’Arabia Saudita e del conflitto con Israele. Mentre i due erano all’incontro, sia sui media che sui social media arabi sono stati pubblicati video che mostrano la leadership di Hamas mentre compie un pellegrinaggio alla Mecca. Non è chiaro se, come successo per Abu Mazen, MBS incontrerà anche i vertici di Hamas, con cui i rapporti da anni non sono idilliaci.
L’ultima visita in Arabia Saudita di un leader di Hamas è stata nel 2015. Nell’agosto 2021, un tribunale saudita ha condannato 69 cittadini palestinesi e giordani al carcere per accuse di legami con il gruppo che governa Gaza. Questi poi sono stati liberati negli ultimi mesi, a cominciare dal leader di Hamas nel regno saudita Mohammad al-Khudary. Lo scorso settembre, il leader di Hamas, Ismail Haniyeh ha affermato che il suo movimento stava cercando di ricucire le relazioni con l’Arabia Saudita, ma che terze parti indefinite stavano cercando di impedire che ciò accadesse. Haniyeh ha aggiunto che Hamas ha lavorato per ripristinare i legami con l’Arabia Saudita e la Giordania dopo che il gruppo ha ristabilito i rapporti diplomatici con il governo siriano.
Hamas, con i suoi stretti rapporti con l’Iran e i suoi legami con la Fratellanza Musulmana, ha avuto scarsi rapporti con l’Arabia Saudita negli ultimi dieci anni. Tuttavia, un recente riavvicinamento tra Arabia Saudita e Iran, e uno sforzo generale di Riad per ricucire i legami con i suoi rivali regionali, ha aperto la porta a un nuovo capitolo con Hamas.
La notizia della visita di Abu Mazen ma, soprattutto, l’eventuale incontro e ripresa dei rapporti con Hamas, gruppo foraggiato da Teheran, rappresentano certamente un duro colpo per il governo di Benjamin Netanyahu. Quest’ultimo, fautore degli accordi di Abramo del 2020, con i quali ha stretto rapporti con Emirati Arabi e Bahrein nell’area, ha sempre puntato sull’allargamento delle relazioni ad altri paesi arabi. L’Arabia Saudita, convitato di pietra in questi consessi, è il vero oggetto del desiderio di Netanyahu e sembrava che le cose andassero verso questa strada, con una fitta rete di relazioni sottobanco, apertura di spazi aerei e paventato inizio di un collegamento areo tra Israele e l’Arabia in occasione del pellegrinaggio rituale o del mese di Ramadan. Cosa che, invece, è stata messa in stand by.
L’apertura di Riad nei confronti di Teheran prima e di Damasco poi, nemici giurati di Israele, ha raffreddato le cose. Un incontro con Hamas renderebbe tutto ancora più difficile. Dopotutto Riad intende riprendere la centralità nell’area, che ha perso nei confronti sia di Emirati, dal punto di vista dello sviluppo e dell’economia, sia dal Qatar. Proprio contro questi mise in atto un boicottaggio durato anni. Doha da sempre ha rapporti con Teheran, anche perché condividono il giacimento di gas più grande al mondo. E Doha è anche il maggior finanziatore di Gaza, dove sostiene settimanalmente le famiglie dell’enclave strette nella morsa di Israele, Egitto e della stessa Autorità nazionale Palestinese. Nella capitale qatariota, inoltre, c’è una vera e propria ambasciata di Hamas dove trovano rifugio i suoi leader.
Netanyahu, dal canto suo, continua ad ostentare sicurezza. Lo ha fatto poche ore fa in una intervista alla americana CNBC, nella quale ha affermato che le preoccupazioni saudite sul terrorismo avrebbero superato le remore per la linea dura del suo governo sui palestinesi, il ripristino dei legami dell’Arabia Saudita con l’Iran ha “molto poco” a che fare con Israele e riguarda principalmente l’allentamento delle tensioni nelle regioni, in particolare nello Yemen.
Nell’intervista il premier ribalta totalmente la questione, spiegando che quelle mosse di riavvicinamento di Riad con Teheran e Damasco, hanno lo scopo di inviare loro un messaggio in vista di un possibile accordo di pace con Israele. “Forse per dire loro che dovranno prepararsi, forse per provare a dire loro di smettere di fare il tipo di terrore che fomentano”, ha detto. Netanyahu ha ribadito la sua convinzione che la pace con l’Arabia Saudita porrebbe fine al più ampio conflitto arabo-israeliano, anche se ha ammesso che non risolverebbe immediatamente il conflitto con i palestinesi. Il Premier israeliano ha affermato inoltre che Riyadh fosse ben consapevole dei vantaggi della collaborazione con Israele. “Abbiamo fatto molto bene da soli, ma possiamo fare molto meglio insieme”, ha dichiarato. E sulla mediazione cinese, il premier ha glissato, dicendo che non ha mai ricevuto alcuna proposta formale da Pechino, che il dialogo con la Cina è sempre aperto, ma che si aspetta una maggiore presenza e peso americani nell’area.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
La tensione che nei giorni scorsi ha scosso Israele, si è riverberata anche sul governo di Benjamin Netanyahu che sta vivendo un periodo di prime crisi e fratture al suo interno. Da un lato, infatti, il premier, dall’altro i due leader della destra estrema, Itmar Ben Gvir e Bezalel Smotrich, i quali hanno più volte manifestato in pubblico la loro insoddisfazione per decisioni dell’esecutivo. L’ultima, in ordine di tempo, quella presa da Netanyahu di impedire, fino alla fine del Ramadan prevista per il 23 di aprile, la salita per gli ebrei alla Spianata delle Moschee (per i musulmani) o Monte del Tempio. La decisione non è nuova, ripetendosi ogni anno.
Per non urtare la suscettibilità dei fedeli del Profeta negli ultimi giorni del mese sacro, è una consuetudine che la spianata venga chiusa a tutti coloro che musulmani non sono. Dopotutto, nei giorni precedenti alla chiusura che, tra l’altro hanno coinciso con la settimana di Pesach, la Pasqua ebraica, migliaia di ebrei sono saliti sulla Spianata. Lo status quo che regola gli accessi al sito, vieta ai non musulmani di andarvi a pregare. È per questo motivo che all’ingresso, vengono controllate le borse e gli zaini, per impedire che si portino oggetti religiosi non islamici. Per questo motivo, le visite ai non musulmani durante l’anno sono vietate il venerdì e il sabato. Diversi rabbini ortodossi, inoltre, da sempre vietano ai fedeli ebrei di salire sul luogo dove erano costruiti il primo tempio, distrutto dai babilonesi nel 586 avanti Cristo e il secondo, distrutto dai romani nel 70 dopo Cristo. Questo perché non essendo sicuri di dove si trovasse il Sancta Sanctorum, vogliono impedire che si calpesti il luogo sacerrimo. Ma durante i primi e gli ultimi giorni di Pasqua, oltre 3000 ebrei, in aumento del 32% rispetto all’anno scorso, sono saliti sulla Spianata accompagnati, come di consueto, dalla polizia per evitare che infrangessero lo status quo. Proprio il timore che andassero a pregare, aveva spinto frange estremiste di fedeli musulmani ad asserragliarsi di notte con bastoni e fuochi d’artificio all’interno della moschea di Al Aqsa alla vigilia della Pasqua ebraica, cosa che spinse la polizia a fare irruzione nel luogo sacro, aprendo la strada alla risposta dei gruppi terroristici che lanciarono razzi da nord e da sud del paese.
La scelta di Netanyahu è stata condannata da Ben Gvir, secondo il quale il premier è capitolato rispetto ai palestinesi. La decisione di chiudere il Monte del Tempio per i visitatori ebrei è un “grave errore che non porterà tranquillità” nella regione, ha detto Ben-Gvir in un attacco diretto a Netanyahu. “Può solo aggravare la situazione. La mancanza di presenza ebraica sul Monte del Tempio causerà automaticamente una diminuzione della presenza della polizia sul Monte, che creerà un terreno fertile per appelli all’incitamento all’omicidio di ebrei”, ha accusato il ministro della sicurezza nazionale. “Quando il terrore colpisce, bisogna rispondere con forza piuttosto che soccombere ai suoi capricci”.
Ben Gvir e Smotrich da qualche tempo stanno facendo sentire la loro insoddisfazione. Hanno già minacciato il governo quando, quasi un mese fa, Netanyahu, spinto da oltre dieci settimane di continue manifestazioni di piazza, ha deciso di congelare la contestata riforma della giustizia. Allora, parlando di capitolazione agli anarchici, minacciarono di uscire e in cambio Ben Gvir ottenne l’approvazione di un nuovo corpo di sicurezza. Lui che è dichiaratamente antipalestinese e pro coloni, controlla ora 2000 persone della neonata guardia nazionale, per gestire la quale ogni ministero si è dovuto tagliare il budget dell’1,25%. Questi avranno potere di intervento soprattutto nelle città arabe.
Poco prima della decisione di Netanyahu di impedire agli ebrei di salire sulla spianata negli ultimi dieci giorni di Ramadan, Ben Gvir, Smotrich and company hanno messo in scena un nuovo atto di forza. Erano loro il 9 aprile, insieme ad altri ministri e parlamentari, in testa al corteo di migliaia di coloni, ortodossi religiosi e simpatizzanti della destra estrema che ha sfilato verso l’avamposto di Evyatar, in Samaria, non lontano da Nablus. L’avamposto è nato nel 2013 ed è stato distrutto diverse volte, l’ultima nel 2021, dalle autorità israeliane perché illegale, costruito sul territorio della cittadina palestinese di Beita. Dopo l’attentato del 26 febbraio scorso nel quale due giovani coloni in auto nei pressi del villaggio palestinese di Hawara furono uccisi da un terrorista legato a Hamas, che provocò poi una sorta di pogrom da parte dei coloni nei confronti dei palestinesi, Ben Gvir annunciò che si sarebbe battuto per la riapertura di Evyatar, che si trova non lontano dal luogo dell’attentato.
La marcia, tra le proteste dell’opinione pubblica, è stata accompagnata e scortata da militari israeliani, che, oltre a bloccare diverse strade e tagliare di fatto i collegamenti con Nablus, hanno anche usato gas lacrimogeni e proiettili con la punta di gomma contro i palestinesi che hanno manifestato contro il furto di terra, con alcuni di loro che hanno lanciato pietre contro le forze di sicurezza. Almeno 120 i feriti, tra i quali alcuni giornalisti.
Una manifestazione che allontana ancora di più le posizioni in un governo lacerato e che sta perdendo consensi. Dopotutto, un sondaggio pubblicato domenica da Channel 13 ha evidenziato che il Likud del premier, se si tenessero ora le elezioni, perderebbe 12 seggi, un risultato che non si vedeva dal 2006. La sua coalizione di governo arriverebbe a 46 seggi, contro i 61 necessari per formare il governo, visto che anche i suoi alleati, Itmar Ben Gvir e Bezalel Smotrich, perderebbero seggi. In ascesa invece Benny Gantz, l’ex capo di stato maggiore e ministro della difesa di Netanyahu, quello che sarebbe dovuto essere il suo premier in alternanza. E si comincia a vociferare di una sostituzione nel governo, con Ben Gviur e Smotrich fuori e dentro Gantz, per evitare nuove elezioni.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
È una crisi economica molto grave quella che sta affrontando l’Egitto. In un Paese che fa del turismo una delle sue principali fonti di reddito e che tuttavia ancora non si è ripreso del tutto dalle perdite dovute agli anni di chiusura totale a causa della pandemia e che quindi deve per forza fare ricorso al debito estero, la sterlina egiziana è stata svalutata tre volte solo nell’ultimo anno, perdendo metà del suo valore a gennaio, quando l’inflazione ha raggiunto un livello record, superiore al 40%.
Ad aggravare la situazione anche la carenza di dollari americani e un arretramento nelle importazioni che ha determinato carenze di approvvigionamento sul mercato. Secondo molti analisti tutti i segnali indicano che si tratta di una crisi profonda e destinata a durare a lungo, forse anche anni, tanto più che i paesi del Golfo, pur amici dell’Egitto, non sembrano più disposti a fornire aiuti senza la garanzia di riforme sostanziali. La conseguenza più immediata e scontata della crisi, sarà il rapido aumento della povertà, con milioni di persone in più che dovrebbero scendere al di sotto della soglia di povertà.
Una situazione simile si era già verificata qualche anno fa. Tra il 2015 e il 2018, dopo la svalutazione del 2016, i tassi di povertà erano aumentati dal 27,8% al 32,5%, ovvero circa cinque milioni in più di persone scesero al di sotto della soglia di povertà.
Lo stesso presidente Al Sisi sembra aver preso coscienza della gravità della situazione tanto che in un discorso dello scorso 23 gennaio ha ammesso pubblicamente che trenta milioni di egiziani vivono attualmente sotto la soglia di povertà e stanno affrontando una “tremenda lotta quotidiana”. Secondo quanto ha dichiarato Rabah Arezki, ex capo della Banca Mondiale per il Medio Oriente “ il paese è “sull’orlo di un baratro finanziario ed economico”. Nelle scorse settimane, un reportage della BBC Arabic, ha messo in risalto come nel Paese ormai non esista più la classe media, e come solo i ricchi riescano a vivere bene. Molti cittadini, intervistati, hanno raccontato di aver dovuto rinunciare alla carne e al pollo, divenuti troppo cari. Il governo ha replicato di ovviare al problema mangiando le zampe di gallina, considerate molto proteiche, scatenando le ire del popolo sui social network.
La situazione sembra persino destinata a peggiorare; in primo luogo perché non ci sono afflussi di capitali in progetti di mega-infrastrutture, che potrebbero agire per mitigare parzialmente l’effetto della svalutazione monetaria, in secondo luogo perché secondo gli indicatori, la sterlina egiziana continuerà a svalutarsi, con conseguenze sempre peggiori sul costo della vita.
Le riserve di valuta estera sono scese a 34,352 miliardi di dollari alla fine di febbraio, la maggior parte costituite da depositi del Golfo per un valore di circa 28 miliardi di dollari, pari a circa l’82% delle riserve totali della Banca centrale d’Egitto. Il paese sta registrando una rapida crescita del debito estero a causa del numero dei prestiti accesi durante il governo del presidente Abdel Fattah Al-Sisi. L’importo dovuto era di 162,9 miliardi di dollari entro la fine del 2022, rispetto ai 145,529 miliardi alla fine del 2021, registrando una crescita del 12% secondo i dati del governo. Dati i prestiti che il governo egiziano ha contratto durante il primo trimestre di quest’anno, il debito estero dell’Egitto potrebbe raggiungere presto la soglia dei 180 miliardi di dollari.
Secondo un rapporto della banca HSBC, il programma di rimborso dell’Egitto è “difficile” da rispettare, con miliardi dovuti a diverse istituzioni finanziarie internazionali, tra cui il Fondo monetario internazionale, la Banca mondiale e i paesi del Golfo. L’Egitto dovrebbe rimborsare 9,33 miliardi di dollari nella prima metà di quest’anno e 8,32 miliardi di dollari nella seconda metà: un totale di 17,65 miliardi di dollari nel 2023. Nel 2025, l’Egitto dovrebbe rimborsare 9,3 miliardi di dollari nella prima metà dell’anno e 5,8 miliardi di dollari nella seconda, rispetto ai 6,6 miliardi di dollari della prima metà del 2026 e ai 10,2 miliardi di dollari della seconda metà dello stesso anno. Il governo egiziano afferma di aver rimborsato capitale e interessi per un valore di 25,2 miliardi di dollari nel periodo da luglio 2020 a settembre 2021. Secondo i dati della Banca Centrale d’Egitto, pubblicati dall’agenzia di stampa ufficiale egiziana, MENA, nel 2022 ha rimborsato circa 24 miliardi di dollari.
I paesi del Golfo sono i principali creditori dell’Egitto, detenendo il 25,1% del debito estero del paese. I dati della Banca Centrale Egiziana evidenziano che il Fondo Monetario Internazionale (FMI) possiede circa il 15%. I depositi del Golfo provenienti da Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Kuwait e Qatar dominano le riserve valutarie totali dell’Egitto, pari a 27,961 miliardi di dollari, ovvero circa l’81,4% delle riserve di cassa totali del paese. Quello degli Emirati Arabi Uniti è il più grande dei depositi del Golfo, valutato in circa 10,661 miliardi di dollari, seguito dal deposito saudita (10,3 miliardi di dollari). Secondo i dati ufficiali del governo, il deposito kuwaitiano ammonta invece a 4 miliardi di dollari e quello del Qatar 3 miliardi di dollari.
L’Egitto, tra l’altro, è considerato tra i paesi più deboli in grado di ripagare i propri debiti. Secondo Moody’s, il rischio di non riuscire a far fronte ai propri impegni per l’Egitto è di circa il 43%. Per gli analisti ed esperti, l’unica via per uscire, gradatamente, dalla crisi, potrebbe essere quella di interrompere o ridurre i prestiti esteri e di utilizzare invece i prestiti ottenuti per finanziare progetti che generano valuta estera e progetti che soddisfano le esigenze del mercato interno, riducendo così i costi di importazione. Inoltre, potrebbero essere avviate trattative con i paesi del Golfo per iniettare liquidità in nuovi progetti e attività in alternativa all’indebitamento estero.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Continua a cambiare l’assetto politico in Medio Oriente. La Siria e l’Arabia Saudita hanno annunciato, nei giorni scorsi, di voler riprendere le loro relazioni diplomatiche e riaprire le loro rispettive ambasciate verso la fine di aprile, alla fine del mese del Ramadan. I due Paesi avevano interrotto i loro rapporti diplomatici oltre dieci anni fa, nel 2011, quando, all’inizio della guerra siriana, Damasco aveva accusato Riad di finanziare per conto dell’Occidente i miliziani sul proprio suolo e perché, a sua volta, Riad aveva aderito alla campagna per isolare Assad, voluta da Washington.
La decisione della ritrovata “amicizia” tra la monarchia degli Al Saud con la Siria di Bashar Al Assad, secondo alcune fonti diplomatiche, (che vista la delicatezza della questione hanno chiesto di rimanere anonime), riprese dalla stampa, sarebbe il risultato di colloqui in Arabia Saudita con un alto funzionario dell’intelligence siriana e segue di poco il riavvicinamento dell’Arabia Saudita all’Iran, avvenuta grazie all’intermediazione della Cina. A negoziare per il riavvicinamento tra Riad e Damasco invece sarebbe stata la Russia. L’agenzia di stampa russa Sputnik ha fatto sapere che la riapertura dell’ambasciata saudita a Damasco sarà preceduta dalla visita in Siria del ministro degli esteri saudita, il principe Faisal bin Farhan Al Saud, durante la quale incontrerà il Presidente siriano Bashar al-Asad. Il passo successivo, secondo quanto si legge, potrebbe essere poi la riammissione di Damasco alla Lega araba, il cui prossimo meeting dovrebbe svolgersi a maggio nel Regno Unito.
Diversi analisti intanto, all’indomani della notizia della riapertura delle rispettive ambasciate, parlano di una generale normalizzazione delle relazioni con Damasco da parte dei paesi arabi. Non a caso solo pochi giorni fa Bashar al-Assad e sua moglie Asma erano stati ricevuti ad Abu Dhabi, con cui le relazioni diplomatiche sono state riaperte solo nel 2018 dopo sei anni di stop. I rapporti tra la Siria e i Paesi del Golfo, raffreddatisi con l’inizio della guerra nel Paese, hanno cominciato a migliorare proprio con l’annuncio da parte degli Emirati Arabi Uniti della riapertura della loro ambasciata a Damasco. Gli Emirati sono stati infatti il primo Paese a riaprire la propria sede diplomatica nella capitale siriana, seguiti dal Bahrein.
È molto diffusa l’opinione secondo cui i paesi arabi alla fine tendono a fare blocco comune perché, come ha dichiarato al Wall Street Journal Karen Young, del Center on Global Energy Policy della Columbia University “Gli Stati autoritari e quelli che esportano petrolio hanno più cose in comune rispetto alle democrazie occidentali, percepite come ipocrite per quel che riguarda il rispetto della sovranità e l’utilizzo delle sanzioni, per cui il trend generale in Medio Oriente è quello di un diffuso consenso sul principio della non interferenza negli affari domestici altrui”. Mentre in molti parlano di questo riavvicinamento come di un ulteriore duro colpo per l’asse Stati Uniti–Israele, dopo quello derivante dal riavvicinamento tra Riad e Teheran, ci si interroga anche sulla reale possibilità di tenuta di tali accordi.
Israele infatti, puntava ad un riavvicinamento con Riad dopo le relazioni con Bahrein, Emirati, Marocco e Sudan grazie agli accordi di Abramo. Invece, l’accordo saudita prima con l’Iran e ora con la Siria, isola ancor di più Israele che si sente quanto mai accerchiato, e inibisce l’allacciamento dei rapporti con i sauditi che sembravano essere all’orizzonte. I due governi, infatti, si erano fatti concessioni, come il sorvolo dello spazio aereo, e c’erano stati colloqui tra gli apparati di sicurezza. Con i due accordi, non solo l’Arabia torna centrale nello scacchiere mediorientale, ma emergono anche Russia e Cina, che si oppongono proprio al gruppo filo americano capeggiato da Israele. Non a caso, i cinesi hanno più volte provato ad entrare nel paese ebraico senza riuscirci e la Russia appoggia, ricambiata, la Palestina.
Sicuramente qualche grattacapo in più per Netanyahu e il suo governo, soprattutto perché il premier più longevo di Israele aveva fatto degli Accordi di Abramo, una bandiera e vanto politico interno e internazionale.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
La presenza nel governo israeliano degli estremisti di destra guidati da Itamar Ben Gvir e Bezalel Smotrich, potrebbe costare all’esecutivo di Netanyahu, e alla sua credibilità politica internazionale, parecchio. Questo perché gli Emirati Arabi Uniti, uno dei primi due paesi a firmare ad agosto 2020 gli Accordi di Abramo, l’importante documento di cooperazione e di apertura di relazioni di Israele con paesi arabi del Golfo e poi successivamente africani, hanno fatto sapere che non intendono procedere ad acquistare armi da Israele a causa della presenza dei due esponenti di destra nell’esecutivo. Presenza, che non permetterebbe a Netanyahu di avere il pieno controllo del gruppo di governo.
Secondo rilevazioni della israeliana Channel 12, il presidente degli Emirati, lo sceicco Mohamed bin Zayed, avrebbe detto a funzionari israeliani che “fino a quando non saremo sicuri che il primo ministro Netanyahu abbia un governo che può controllare, non saremo in grado di operare congiuntamente”. La notizia è stata successivamente smentita dagli uffici del premier israeliano, ma comunque ha fatto rumore nella politica interna ed esterna israeliana. Soprattutto perché è arrivata pochi giorni dopo che Arabia Saudita e Iran hanno ristabilito i rapporti diplomatici dopo sette anni, una mossa che sembrava rendere più difficile per Netanyahu raggiungere il suo obiettivo di normalizzare i rapporti con l’Arabia Saudita.
Benjamin Netanyahu ha sempre fatto degli accordi di Abramo una bandiera, intentandosi, congiuntamente all’ex presidente americano Donald Trump, una incontestabile vittoria politica internazionale. Fino all’agosto 2020, infatti, Israele era isolatissimo nell’area, potendo contare solo sugli accordi post bellici sottoscritti con i vicini Giordania ed Egitto. Ma nessun altro paese islamico, soprattutto mediorientale o del Golfo, era propenso a stringere rapporti con lo Stato Ebraico, in particolare per l’annosa questione palestinese. Questioni economiche, l’expo di Dubai, necessità di scambi e armi, faccende legate anche ai sorvoli sia militari che civili, hanno però spinto prima Emirati Arabi e Bahrein, poi Marocco e Sudan, ad allacciare rapporti con Israele. Spingendosi anche oltre. Gli Emirati hanno sottoscritto una serie di accordi con Israele, soprattutto nel campo della sicurezza, dall’acquisto di armi e tecnologie alle esercitazioni congiunte; il Bahrein ha permesso la presenza israeliana nel proprio territorio a militari israeliani in servizio nella quinta flotta americana di stanza nel Golfo. Tra Gerusalemme e Abu Dhabi, inoltre, è in via di definizione un accordi di libero scambio che favorirà entrambe le economie. Questo, stando sempre al canale televisivo israeliano, comunque non dovrebbe essere interrotto come pure il coordinamento di sicurezza.
La decisione emiratina, che il governo israeliano nega sia vera, sarebbe nata soprattutto dopo i fatti di Huwara, il pogrom dei coloni al villaggio cisgiordano dopo che un palestinese aveva ucciso due coloni che percorrevano in macchina la zona. Ben Gvir, ministro della sicurezza, è stato riconosciuto dai paesi arabi anche responsabile di provocazione avendo deciso di effettuare una visita alla spianata delle moschee, come quella che il 28 settembre 2000 l’allora capo del Likud, Ariel Sharon, fece sullo stesso luogo dando il via alla seconda intifada. Dopo i fatti di Hawara, è stato il ministro delle finanze, Smotrich, a salire alla ribalta anti-araba, chiedendo di cancellare il villaggio di Hawara. I due leader destrorsi, il cui appoggio e voti sono necessari alla stabilità dell’esecutivo a guida Netanyahu, si sono sempre opposti a qualsiasi avvicinamento con arabi, sia interni che esterni, considerandoli una minaccia. Netanyahu, dal canto suo, ha invece cercato di stringere quante più relazioni possibili per ottenere internamente l’isolamento della Palestina, esternamente quello dell’Iran. Per questo si parlava da tempo di accordi e di uno stato avanzato di colloqui con l’Arabia Saudita.
Il permesso, concesso solo poche settimane fa, ai voli israeliani di attraversare lo spazio aereo saudita, per tagliare le rotte verso l’Asia, India in particolare, aveva fatto ben sperare. Invece, l’accordo che Riad, mediato da Pechino, ha stretto con Teheran, ha gelato tutti. Al momento, nessun esponente del governo o della presidenza israeliana ha commentato l’accordo. Lo hanno solo fatto, condannandolo, i leader dell’opposizione, che hanno parlato di minaccia ad Israele. Una grana per Netanyahu, che deve affrontare problemi e contestazioni politiche interne, sia da parte dell’opposizione che di molti cittadini, ma anche di alcuni sodali; gelo sulle relazioni internazionali, una delle maggiori vittorie di Bibi degli ultimi anni.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
A Doha probabilmente non hanno mai letto le satire di Giovenale. Non hanno, ritengo, pertanto adottato il panem et circenses con questa consapevolezza. Neanche, credo, conoscessero la storia del Regno Borbonico, quando Ferdinando, governava con le tre “f”: feste, farina e forca. Ma la politica interna ed estera del Qatar negli ultimi anni, pare essere molto vicina a quella del re nasone. Già perché da qualche anno, Doha ha sfruttato la sua enorme ricchezza per diffondere il suo soft power in giro per il pianeta. Ricchezza derivata dai più grandi giacimenti di gas al mondo: il South Pars, gestito insieme all’Iran, ha 51 trilioni di metri cubi di gas naturale in situ e circa 50 miliardi di barili (7,9 miliardi di metri cubi) di condensati di gas naturale. Solo pochi anni fa poche persone avrebbero saputo indicare su una mappa il Qatar, o dire quale fosse la sua capitale. Oggi del Qatar si parla di continuo, sui giornali e in tv, certamente per il mondiale di calcio, i primi in uno stato del Golfo e i primi in inverno.
Doha esercita sia “hard power” che “soft power”. Il primo è basato sul potere politico, economico e militare di una nazione, il secondo è caratterizzato dal potere di attrazione su di sé di interessi diversi, per i motivi più disparati. Ecco, il Qatar, oggi più che mai, ancora più di altri, è considerato un esempio di soft power.
Un piccolo stato con appena 2,6 milioni di abitanti, dei quali i locali rappresentano poco più del 10% mentre il resto è costituito dagli immigrati soprattutto dal subcontinente. Piccolo ma dalle enormi ricchezze, che lo hanno reso inviso ai vicini, in particolare ai cugini dell’Arabia Saudita, con cui il Qatar ha un rapporto difficile soprattutto considerato che il regno dei Saud ha storicamente rivendicato il territorio dell’emirato qatarino, anche intervenendo ripetutamente nella politica interna del Qatar.
Le tensioni con i sauditi, ma anche con altri paesi vicini, sono culminate con l’interruzione delle relazioni diplomatiche con il Qatar da parte di Arabia Saudita, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Egitto e Maldive e l’istituzione di un blocco contro l’emirato degli al-Thani nel giugno 2017, finito nel 2021. Il Qatar quindi ha cominciato sempre di più a sentirsi isolato e ha avvertito il bisogno di accreditare la sua immagine, specie presso il mondo occidentale. Una immagine che però ha avuto seri contraccolpi, specie negli ultimi anni, con le notizie legate allo sfruttamento degli operai, degli immigrati, costretti a turni massacranti, a salari inesistenti e a condizioni di vita infime. La stessa scelta del Qatar come nazione ospitante dei mondiali di calcio nel 2022 era stata largamente criticata. Scelto nel 2010 per ospitare il campionato mondiale di calcio, battendo paesi come Stati Uniti, Corea del Sud, Giappone e Australia, il Qatar, sin dalla sua selezione, era stato inondato da polemiche. Le accuse di corruzione e concussione avevano colpito anche la FIFA, Joseph Blatter − allora presidente dell’organizzazione − e Michel Platini, presidente della UEFA. Eppure, nonostante l’elevato numero di lavoratori morti durante la costruzione degli stadi e la situazione precaria dei diritti umani nel Paese, il Qatar sta consolidando la sua posizione di potenza regionale grazie proprio in primo luogo al suo impegno nello sport. Le feste e la forca di borboniana memoria: tra il 2016 e il 2021 almeno 21 persone sono state condannate a morte in Qatar. Dei 21, solo tre casi hanno coinvolto cittadini del Qatar e solo uno ha coinvolto una donna (accusata di omicidio). I restanti 18 erano di nazionalità straniera: sette indiani, due nepalesi, cinque bengalesi, un tunisino e tre asiatici di nazionalità sconosciuta. Di questi casi, 17 riguardano omicidio e uno una condanna per traffico di droga. La maggior parte dei casi di omicidio ha riguardato lavoratori migranti di sesso maschile provenienti dall’Asia meridionale, condannati per reati legati al loro precario status di lavoratore migrante. I rimanenti casi di omicidio riguardavano un uomo tunisino e due imputati di nazionalità sconosciuta. Le autorità governative di Doha, pur avendo sottoscritto la convenzione di Vienna del 1963 sui rapporti consolari, ignorano il diritto internazionale non informando le ambasciate quando i loro cittadini vengono arrestati, detenuti o sono in attesa di processo per una condanna a morte. Oggi sono undici, secondo le organizzazioni non governative, gli occupanti del braccio della morte in Qatar e l’ultima esecuzione, che qui avviene per impiccagione o fucilazione, è stata eseguita nel 2020.
Lo scandalo Qatargate che ha scosso i palazzi di Bruxelles, è solo l’ultimo esempio del traffico di influenze che Doha mette in campo. Lo fa con i soldi, con gli investimenti, con il gas (ha subito minacciato l’Ue di chiudere i rubinetti), lo fa con lo sport. E quest’ultimo è stato scelto come “festa” o “circenses” preferita. I mondiali di calcio ne sono l’esempio più recente e più lampante, per i quali si stima che il Qatar abbia speso ben 220 miliardi di dollari nei dodici anni trascorsi dall’assegnazione del torneo, più di 15 volte la cifra spesa dalla Russia per i mondiali precedenti, nel 2018. Ma non sono solo i mondiali. Nei primi anni 2000, gli al-Thani investirono in un centro, l’Aspire, che sarebbe dovuto diventare un punto di riferimento per lo sport mondiale. E così è stato. È nato nel 2003 e prima ha organizzato fiere del settore, poi ha aperto una Academy per vari sport, poi ha chiamato manager ed esperti da tutto il mondo pagandoli a peso d’oro, non badando a spese, per acquisire competenze e capacità nel settore. Infine, ha cominciato a organizzare eventi sportivi continentali prima e mondiali poi. Tra questi, la prima vetrina è stata con gli Asian Games nel 2006, per poi vedere i primi mondiali, quelli di pallavolo per club, nel 2009 e le Ginnasiadi nello stesso anno. A seguire, mondiali indoor di atletica, mondiali di pallamano (che videro un sorprendente secondo posto del Qatar infarcito di campioni provenienti da tutto il mondo, pagati quanto un calciatore di serie A italiana), di box, di ciclismo, ginnastica artistica e perfino di robot. Per chiudere, prima dei mondiali di calcio di quest’anno, con quelli di atletica leggera nel 2019.
In questo campionato, nonostante le difficoltà economiche dovute all’embargo dei paesi vicini, lo sfarzo è stato enorme, un po’ meno gli stipendi. Nel novembre 2021, il Qatar ha ospitato il suo primo Gran Premio di F1 e il paese ha ora un contratto di 10 anni per ospitare gare di F1. Inoltre, nel 2011 il Qatar Sports Investment ha acquistato una delle principali squadre di calcio francesi, il Paris Saint-Germain. Secondo Daniel Patiño Portillo, un analista politico, per il Qatar lo sport, e in particolare il calcio, è così importante perché “smuove le masse, alimenta le passioni e mobilita sentimenti come l’identità o l’accettazione”. Un metodo, questo, che spiega invece Juan Corellano, regista di un documentario dal titolo Qatar: i Mondiali ai tuoi piedi, non è nuovo e ha citato come esempi i Giochi Olimpici nella Germania nazista negli anni ‘30 e la Coppa del mondo del 1978 durante la dittatura argentina. Un esempio che il Qatar ha preso dalla più importante economia del mondo, altro paese non certo campione di democrazia (probabilmente il rispetto per i diritti civili e la crescita economica nel mondo non seguono le stesse parabole): la Cina.
L’Impero di Mezzo, alla fine degli anni Settanta del secolo scorso si aprì al mondo e nel 2008 si aggiudicò le olimpiadi. Tutto come oggi: nei mondiali di calcio la finale è stata disputata nella ricorrenza della festa nazionale, quando si celebra la nascita del nuovo Qatar; in Cina si scelse l’otto di agosto 2008 in quanto l’otto è il numero più fortunato per i cinesi. Le polemiche che hanno giustamente accompagnato l’assegnazione dei mondiali di calcio in Qatar per la poca propensione dell’emirato a rispettare i diritti civili, accompagnarono anche la Cina che in quel periodo aveva messo in opera una violenta repressione in Tibet ed erano ancora vive e sanguinanti le ferite di Tien’anmen. Anche allora, come oggi, i vertici sportivi mondiali fecero spallucce dinanzi ai miliardi e alla potenza politica degli organizzatori.
Il Qatar dunque si sta accreditando con il mondo principalmente attraverso lo sport, ma non solo. Un’altra delle “vie” del soft power viene ritenuta anche quella che passa attraverso Al Jazeera, posseduta proprio dal governo del Qatar. Tramite la “Cnn araba”, il paese veicola le notizie, contenendo il criticismo contro l’emiro del Qatar e orientando l’informazione, anche sui rapporti con i paesi vicini, a suo favore. Non è poi neanche trascurabile il fatto che il Qatar si è spesso offerto di essere un mediatore in situazioni di conflitto, ad esempio nelle guerre in Libano, Sudan e Yemen. Anche recentemente, nella guerra in Ucraina, l’emiro del Qatar si è offerto di contribuire agli sforzi di mediazione. Il Qatar, che attraverso il suo fondo sovrano ha diverse proprietà in Italia e in Inghilterra, ha poi anche indirizzato i suoi investimenti verso la Francia, uno dei suoi principali alleati, paese dal grande peso geopolitico e militare. Ha acquistato aerei militari dopo che Sarkozy ha mediato il voto di Platini per i Mondiali. Sono tutti modi, per il Qatar, di migliorare la propria reputazione in ambito internazionale. E poi non dimentichiamo anche le ingenti donazioni alle università straniere (tra cui la Carnegie Mellon University, la Georgetown University e la HEC di Parigi), e la creazione di moschee in giro per il mondo a favore della comunità islamica internazionale. Tutte attività mirate a un unico scopo. Accrescere il proprio soft power.
Tutti gli sforzi però non riescono, almeno non del tutto, a far dimenticare i tristi record del paese. Doha viene spesso accusata di sostenere gruppi ritenuti terroristici, Hamas in testa, che nell’emirato ha una zona franca per i suoi leader. Il Qatar inoltre mensilmente rimpingua le casse di Gaza. Proprio recentemente, poche settimane prima dell’inizio dei mondiali di calcio, diverse Ong per i diritti umani e organizzazioni internazionali hanno nuovamente messo in guardia sulla situazione del Qatar, nonché sulle spaventose condizioni di lavoro dei lavoratori stranieri che hanno costruito gli stadi. Secondo un’inchiesta di The Guardian, tra il 2011 e il 2020 in Qatar sono morti almeno 6500 lavoratori migranti e cause dei decessi sono state indicate come il “lavoro forzato” o “forme di schiavitù moderna”. Molti di loro avrebbero perso la vita a causa delle alte temperature del Paese e delle difficili condizioni in cui erano costretti a lavorare. Turni massacranti, per dieci, dodici ore al giorno sotto il sole cocente, con stipendi da fame, costretti a vivere in case minuscole, umide e senza finestre. La maggior parte dei lavoratori migranti che lavora in Qatar proviene da paesi asiatici come India, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka e Nepal. Secondo i dati ufficiali raccolti dal New York Times, i decessi sono stati causati in prevalenza da malattie cardiovascolari, a seguire da incidenti stradali, mentre elevato è stato anche il numero di suicidi. Le numerose polemiche sorte in questi anni qualche piccolo risultato lo hanno avuto perché Doha ha iniziato ad adottare alcune misure, come ad esempio la creazione di una commissione per le dispute di lavoro. Ha abolito la kafala, la legge per la quale il dipendente è proprietà del datore di lavoro e ha ospitato una missione dell’International Labor Office, che però è stato accusato dalle Ong del campo, di essere accondiscendente con il governo di Doha in cambio di lauti finanziamenti. Una goccia nel mare, specie considerato che ci sono tantissimi casi che dovrebbero essere esaminati per pochi giudici istituiti allo scopo.
È evidente comunque che Doha sta cercando di prendere le distanze e dissociarsi dalle morti e dalle critiche, sostenendo che tutte le accuse fanno parte di “una campagna di propaganda senza precedenti”. In un’intervista alla AFP, il ministro del lavoro del Qatar, Ali bin Samikh Al Marri, ha affermato che tutte le critiche sono basate sul “razzismo”. Critiche verso gli stranieri, come quella di Giovenale nella terza satira.
Questo articolo è pubblicato anche sul numero di gennaio/marzo di eastwest
Puoi acquistare la rivista in edicola, sul sito o abbonarti
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Numerosi palestinesi residenti in Libano avrebbero accettato di andare a combattere a favore della Russia, nel conflitto in corso con l’Ucraina, in cambio di circa 350 dollari al mese. Lo hanno riferito fonti libanesi e la notizia sta ora avendo ampio risalto anche sui media palestinesi.
L’attività di reclutamento, secondo quanto si legge, sarebbe stata compiuta da attivisti affiliati all’ambasciata palestinese in Libano. Si tratterebbe per lo più di persone nate dopo il 1969, poiché i nati dopo da questo momento in poi non hanno un’adeguata registrazione anagrafica presso le autorità libanesi, e quindi per loro è più facile viaggiare per andare a partecipare al conflitto come mercenari. La maggior parte dei palestinesi schierati in prima linea in Ucraina proverrebbe da Ein Al-Khalwa, il più grande campo profughi palestinese in Libano, situato a sud della città di Sidone e sarebbero quasi tutti membri del movimento politico Fatah, guidato dal presidente dell’Autorità nazionale palestinese Mahmoud Abbas. In misura minore, ci sono anche appartenenti ad altre organizzazioni come il Fronte popolare per la liberazione della Palestina. In cambio della partecipazione alla guerra, riceverebbero dalla Russia uno stipendio mensile e un ulteriore compenso per le loro famiglie.
Il reclutamento verrebbe effettuato in coordinamento con l’organizzazione di Hezbollah con sede in Libano e sostenuta dall’Iran. Secondo le informazioni provenienti dal Libano, Hezbollah starebbe poi anche arruolando attivamente giovani sostenitori, compresi quelli esperti nell’utilizzo di droni e individui con esperienza nella guerriglia nelle aree urbane, sempre per assistere i russi nella guerra in Ucraina. “Non ho informazioni specifiche su questo argomento, ma non mi sorprende che sia successo questo – ha riferito alla stampa libanese Riad Kahwaji, ricercatore originario del paese dei cedri ed esperto in questioni di sicurezza e difesa, che risiede a Dubai – perché la situazione nei campi profughi è terribile, non ci sono posti di lavoro per i giovani, non sorprende dunque che siano stati reclutati per lavorare con i russi in cambio di soldi, perché l’ambiente del campo è terreno fertile per queste situazioni”.
Secondo le stime sarebbero circa 200.000 i palestinesi, discendenti di coloro che fuggirono da Israele durante la guerra del 1948, che attualmente vivono in Libano e sono considerati rifugiati, numero ben sotto gli oltre 400mila profughi registrati dall’Unrwa. Questo perché molti sono scappati all’estero, soprattutto dopo le stragi di Sabra e Shatila di quarantuno anni fa. Qui praticamente non hanno diritti e sono relegati nei campi profughi, diventati vere e proprie città ghetto. Non sono ben visti dalla popolazione anche per aver appoggiato, durante la guerra civile, la componente drusa e musulmana, per cui restano relegati nei 12 campi che non possono neanche allargarsi. Sopravvivono incassando piccole rendite e gli vengono offerti parte dei servizi basilari dall’Unrwa, l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa dei profughi palestinesi in patria e fuori. Hanno un tasso altissimo di disoccupazione: ufficialmente nei campi è del 18% ma tra i giovani di età compresa tra 20 e 29 anni è del 28,5%. A loro non vengono concessi dalle autorità libanesi permessi di lavoro e in molti si arrangiano in nero. Come loro, anche i profughi siriani, che però hanno una prospettiva diversa, dal momento che potrebbero rientrare in patria, una possibilità per ora negata a quelli che oramai rappresentano al quarta generazione di palestinesi.
La questione dei profughi palestinesi è sempre in campo ad ogni tornata elettorale in Libano, ma nulla si muove. Non è chiaro esattamente quanti palestinesi siano stati finora reclutati per combattere per la Russia, ma si parla di circa 300 persone a cui se ne potrebbero aggiungere altri. Sembra infatti che almeno altre 100 persone, provenienti dal campo profughi di Ein Al-Khalwa, potrebbero aggiungersi a breve. L’ambasciata palestinese in Libano ha rifiutato di commentare la questione, affermando di non avere alcun collegamento con il conflitto in Ucraina e di non incoraggiare i palestinesi a parteciparvi. Dopotutto nell’area la Russia ha un grosso ascendente. L’Autorità Nazionale Palestinese è uno dei pochi rappresentati istituzionali a non aver criticato anzi, apertamente appoggiato, l’invasione russa in Ucraina. Mosca inoltre ha forti legami sia in Siria che in Iran.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
È in fiamme, la Terra Santa, sia per le strade che nei palazzi. Di giorno in giorno, aumenta la tensione in ogni scampolo della società israeliana e in Cisgiordania, facendo registrare un periodo record di vittime e tensioni.
Ci si batte su più fronti. In Israele la piazza è sempre più calda mentre il Parlamento porta avanti l’iter della legge di modifica dei poteri dell’Alta Corte. Le manifestazioni di protesta, che hanno portato centinaia di migliaia di persone nelle piazze delle città israeliane, da settimanali sono diventate quasi giornaliere. E si è cominciato a passare alle vie di fatto. Se prima la polizia assisteva inerme, mercoledì ci sono stati scontri, lanci di granate, arresti. Il Ministro della sicurezza nazionale, Ben Gvir, ha annunciato il pugno duro contro i manifestanti. Il capo della polizia ha annunciato che sarà usata la forza dagli agenti se si dovessero sentire minacciati. Una quarantina di persone sono già state arrestate e oltre dieci sono dovute ricorrere alle cure dei sanitari.
Il governo è sotto attacco della piazza, dell’opposizione ovviamente, ma anche al suo interno la situazione non è rosea. Le diverse sensibilità rispetto alla gestione della sicurezza sia interna che nei confronti dei palestinesi, sta portando a fratture. Un sottosegretario del partito di Ben Gvir ha lasciato l’esecutivo senza far mancare il suo apporto alla coalizione di maggioranza. Lo stesso Ben Gvir e i suoi hanno disertato i lavori della Knesset un paio di giorni fa dimostrando il suo malcontento per come il premier Netanyahu stava gestendo la questione con i palestinesi.
Bibi, se da un lato ha dato il via libera ai desiderata di Ben Gvir di portare in Parlamento e far avanzare una proposta di legge per la pena di morte contro i terroristi palestinesi, dall’altro in segreto ha permesso che si tenesse un incontro a sorpresa ad Aqaba, in Giordania, tra i responsabili dell’intelligence di Israele e l’Autorità Palestinese. Tra i partecipanti, Majed Faraj, capo dell’intelligence palestinese e il capo dell’agenzia di sicurezza interna israeliana Shin Bet Ronen Bar che, in una dichiarazione congiunta al termine dell’incontro, hanno “ribadito la necessità di impegnarsi a ridurre l’escalation sul campo e a prevenire ulteriori violenze”. All’incontro, che è il primo da anni, erano presenti anche il coordinatore del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti per il Medio Oriente e il Nord Africa, Brett McGurk, insieme a funzionari della sicurezza giordani ed egiziani, ed è stato organizzato sotto l’egida del re giordano. Si è deciso di bloccare la nascita di insediamenti per sei mesi e riattivare il coordinamento di sicurezza, il tutto per garantire un clima di tranquillità durante il Ramadan e le festività pasquali ebraiche.
Mentre sulle rive del Mar Rosso si riunivano e riavvicinavano le distanze, a qualche centinaia di chilometri a nord ovest, a Huwara, una cittadina palestinese circondata da alcuni insediamenti di coloni israeliani, due ebrei venivano uccisi a colpi di arma da fuoco mentre si trovavano in auto. La cosa ha scatenato la furia di una folla inferocita di coloni che hanno letteralmente messo a ferro e fuoco la cittadina, dando alle fiamme almeno 35 case che sono risultate distrutte completamente, mentre altre 40 sono state danneggiate parzialmente. Oltre 100 le vetture distrutte dalle fiamme. Almeno 400 i feriti e una vittima, uccisa da colpi di arma da fuoco a Za’tara vicino Nablus. Almeno nove le famiglie che hanno rischiato di morire bruciate nelle loro case e sono state salvate. Ventiquattr’ore: ecco che un po’ più a sud, nei pressi di Gerico, un altro ebreo, di origini americane, veniva ucciso mentre transitava in auto, allo stesso modo dei due fratelli di Hawara. Per quest’ultimo attentato, tre palestinesi sono stati arrestati, come sei i coloni arrestati per l’assalto alla cittadina. Si cerca ancora il responsabile dell’attentato di Hawara.
E così si è ripiombati nel caos. Gli attentati e l’assalto alla cittadina hanno sbaragliato le carte e i buoni propositi di Aqaba sono rimasti lettera morta. Il Ministro delle finanze Bezalel Smotrich, che da pochi giorni ha ottenuto anche ampia autorità sulle questioni civili in Cisgiordania come la costruzione di insediamenti, ha immediatamente liquidato i risultati dell’incontro di Aqaba come privi di significato, annunciando che l’espansione delle colonie non si fermerà.
Gli inviti alla calma da tutte le parti, soprattutto da parte del presidente Herzog, non sono valsi a nulla. Il governo sta entrando, a pochi mesi dall’insediamento in una profonda crisi sia politica, soprattutto sociale, nei confronti degli israeliani. E dalla Cisgiordania è oramai chiaro che l’Autorità Nazionale Palestinese non rappresenta nessuno se non sé stessa e non riesce ad avere il controllo su nessuno.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Resta sempre molto difficile la situazione interna del Libano, sia sul fronte politico che su quello sociale ed economico. Analisti ed osservatori si dicono estremamente preoccupati per una situazione che sembra sempre più compromessa e difficile da gestire. “Il Libano potrebbe essere destinato all’oblio”, ha detto Charles Arbid, presidente del Consiglio economico e sociale. Lo ha dichiarato durante una riunione di emergenza presso la sede del Sindacato generale del lavoro, secondo quanto hanno riportato diversi media locali. Secondo Arbid, senza un salvatore all’orizzonte, il Paese rischia davvero di perdere il controllo. “Temiamo — ha aggiunto — che il Libano stia cambiando e che agli attuali leader non interessa il suo destino. Molti paesi sono stati dimenticati e abbandonati. La povertà e la violenza hanno prevalso dopo che il mondo ha perso interesse per loro”. Parole dure e precise, pronunciate proprio mentre la moneta libanese continua a crollare gettando il paese nello sconforto.
Il tasso di cambio per un dollaro è arrivato a circa 81.000 lire libanesi nel mercato parallelo. È stato calcolato che in tre anni la valuta libanese ha perso circa il 98% del proprio valore. Le banche continuano a scioperare, rifiutando peraltro di essere ritenute pienamente responsabili della crisi finanziaria del paese. Il governatore della banca centrale, Riad Salameh, ha dichiarato ad Al-Qahera News: “Il mercato nero in Libano è fuori dal controllo della banca centrale, che è diventata incapace di risolvere le crisi perché le soluzioni richiedono un progetto nazionale concreto”.
Da settimane ormai le proteste della popolazione, con sit-in di fronte alle banche, sono all’ordine del giorno. L’Associazione delle banche in Libano ha messo in guardia contro “un piano per distruggere sistematicamente il settore bancario, portato avanti da un gruppo di non più di 50 mercenari”. L’associazione si riferisce a un gruppo di manifestanti che giovedì scorso durante le proteste ha anche appiccato il fuoco dinanzi alle sedi di alcune banche. L’associazione ha aggiunto in un comunicato di essere sconcertata da tutte le accuse secondo cui il suo sciopero starebbe contribuendo al deprezzamento della valuta locale. “Se le banche chiudono, sono accusate di svalutare la moneta locale; se aprono, sono accusate di giocare con il mercato”. L’associazione ha poi accusato lo stato di aver speso più di 20 miliardi di dollari dal 2019 a sostegno del contrabbando — sovvenzionando materiali portati illegalmente in Siria.
A Beirut, la città che un tempo era definita la “Parigi dell’Est”, ora circa due terzi della popolazione patisce la povertà. La vita è diventata molto complicata, con blackout elettrici frequenti e carenza di beni di prima necessità (in primo luogo le medicine). Negli ultimi anni la Pandemia da COVID-19 ha persino aggravato la situazione, come pure l’esplosione avvenuta nel porto di Beirut nel 2020 che ha ucciso centinaia di persone, lasciato centinaia di migliaia di senzatetto e danneggiato oltre metà della città, infliggendo enormi perdite economiche. Human Rights Watch e Amnesty International, hanno definito le indagini sull’esplosione una “farsa”. Diversi analisti fanno risalire l’inizio della crisi a ben 18 anni fa quando fu ucciso Rafik Hariri, eminente politico ed ex primo ministro del Libano, che fu assassinato da un camion esplosivo suicida a Beirut. Hariri, che aveva fatto fortuna nell’edilizia, oltre che per il suo impegno in politica, viene anche ricordato come un benefattore del paese. Aveva donato milioni di dollari alle vittime della guerra e del conflitto in Libano, e in seguito aveva svolto un ruolo importante nel porre fine alla guerra civile e nella ricostruzione della capitale. Il suo assassinio, sostengono in molti, è stato lo spartiacque che ha segnato un drammatico cambiamento di rotta, in negativo, per il Paese.
“Hariri è stato ucciso 18 anni fa e ci sono voluti circa 15 anni per distruggere l’intero paese dopo tutto quello che lui ha cercato di costruire”, ha detto l’economista libanese Nadim Shehadi. Nonostante un tribunale internazionale abbia giudicato i membri di Hezbollah colpevoli dell’assassinio di Hariri, dopo varie richieste di un’indagine sulla sua morte, il gruppo di milizie sostenuto dall’Iran ha ugualmente rafforzato la presa sul Libano. Secondo l’economista, l’influenza di Hezbollah sul Libano significa che i veri autori dell’assassinio rimarranno impuniti e il gruppo continuerà a tenere il Paese in scacco. Shehadi ha infatti affermato che, nonostante una magistratura storicamente “molto sana e funzionante” nel Libano, Hezbollah ha interferito con le indagini. Troppe dunque le problematiche irrisolte.
Otto mesi dopo le elezioni generali del paese, il Libano non ha ancora raggiunto un consenso sul suo presidente o su un parlamento funzionante. Gli analisti evidenziano come sarebbero necessarie riforme politiche urgenti per sbloccare i 3 miliardi di dollari di fondi di emergenza del Fondo monetario internazionale, ma con il sistema politico del Libano a brandelli e i suoi parlamentari che organizzano regolarmente scioperi, l’accesso a questi fondi sembra al momento improbabile. “Il nostro — ha detto Shehadi — non è un parlamento con opinioni diverse o frammentato. Vi è la paralisi di tutte le istituzioni che si è accumulata da 15, anzi da quasi 17 anni”. Ha aggiunto poi che il Libano e le sue istituzioni sono “un ostaggio del potere di veto” di Hezbollah, che ha preso piede nel Paese attraverso omicidi e costruzione di alleanze politiche.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Non accennano a placarsi le manifestazioni di protesta in Israele contro il governo in carica guidato da Benjamin Netanyahu, che deve fronteggiare anche un malcontento e scontri all’interno della sua coalizione di governo. Lunedì circa 100.000 persone si sono radunate fuori al Parlamento a Gerusalemme per opporsi alla controversa riforma del sistema giudiziario che mira in primis a una riduzione del potere della Corte Suprema. I manifestanti sono arrivati da tutto il paese, da Haifa, da Tel Aviv e persino dalle alture del Golan. Hanno issato bandiere e cantato slogan contro il governo, invocando democrazia, libertà e l’indipendenza giudiziaria.
Il governo attualmente al potere è quello più a destra e religiosamente conservatore nella storia del paese. Il giorno prima della manifestazione, in un discorso televisivo, il presidente israeliano, Isaac Herzog, aveva invitato a trovare un compromesso per evitare che la crisi potesse lasciare il paese “sull’orlo del collasso costituzionale e sociale”. Effettivamente è palese che la portata delle proteste evidenzi il profondo disaccordo della società, o almeno di parte di essa, verso la linea adottata da Netanyahu e compagni. Il leader dell’opposizione, Yair Lapid, ha più volte parlato di crollo della democrazia israeliana; l’ex ministro della difesa, Benny Gantz, ha messo in guardia circa una possibile guerra civile. Il governo, dal canto suo, afferma che i cambiamenti rappresentano una riforma necessaria del sistema giudiziario che è diventato troppo potente. L’atmosfera è rovente.
Lunedì Netanyahu ha rimproverato i leader dell’opposizione, dicendo loro di “smettere di far deragliare intenzionalmente il paese nell’anarchia”, negando che la riforma sarebbe da lui voluta solo, come molti sostengono, per sfuggire alle condanne nel processo per corruzione a suo carico. I critici affermano che i cambiamenti al sistema giudiziario darebbero al primo ministro Benjamin Netanyahu di sfuggire più facilmente alla punizione nel suo processo per corruzione. Per il governo e i suoi sostenitori, anzi, la riforma rafforzerebbe la democrazia israeliana ripristinando la parità nel rapporto tra legislatori eletti e una magistratura non eletta e ritenuta troppo interventista, assicurando che le decisioni del governo riflettano meglio le scelte elettorali della maggioranza della popolazione.
Ma, proteste a parte, è un momento difficile anche all’interno dello stesso governo. I rapporti tra Netanyahu e il ministro per la sicurezza nazionale, Itamar Ben Gvir sono al momento tutt’altro che idilliaci. Ben Gvir si è scontrato nei giorni scorsi sia con il primo ministro che con il commissario della polizia israeliana Kobi Shabtai sulle sue richieste di procedere alla demolizione delle case palestinesi costruite illegalmente a Gerusalemme est. Diverse indiscrezioni hanno affermato che in entrambi i casi le conversazioni sono state accese e “le voci si sono alzate” e alla fine il Ministro della sicurezza interna ha promesso di portare avanti comunque le demolizioni. Ben Gvir, del partito di estrema destra Otzma Yehudit, vorrebbe avere una posizione più aggressiva contro le case palestinesi che sono state costruite senza i necessari permessi e ha definito la demolizione di tali strutture necessaria anche come parte degli sforzi di Israele per combattere il terrorismo palestinese.
Il primo scontro di Ben Gvir con Netanyahu si è verificato durante e dopo la riunione di gabinetto di domenica per decidere su ciò che Netanyahu ha definito “un’azione più ampia” dopo che tre israeliani, tra cui due fratelli di 6 e 8 anni, sono stati uccisi in un attacco a Gerusalemme venerdì scorso quando un arabo si è lanciato con la sua auto contro una fermata dell’autobus. Secondo il sito di notizie Ynet, gli animi si sono accesi durante l’incontro e in una successiva conversazione tra Ben Gvir e Netanyahu. Secondo quanto riferito, Ben Gvir avrebbe chiesto che gli fosse permesso di radere al suolo un edificio disabitato di 14 piani costruito senza permessi vicino alla barriera di sicurezza nel quartiere di Sawarha, a Gerusalemme est. Sembra però che Netanyahu lo abbia invitato ad una maggiore moderazione, osservando che la demolizione dell’edificio avrebbe probabilmente scatenato una reazione internazionale. Ben Gvir avrebbe allora gridato a Netanyahu: “Sono stanco di portare avanti una politica di pacificazione. I nostri bambini sono stati uccisi e tu sei preoccupato di infastidire gli arabi?”. Ben Gvir avrebbe poi litigato anche con il commissario della polizia israeliana che gli avrebbe fatto notare che le demolizioni devono seguire un programma prestabilito e non possono essere ordinate ed eseguite in questo modo. Ed è di poche ore fa, secondo quanto riporta la stampa locale, una dichiarazione di Ben Gvir secondo cui “non erano questi gli accordi, così non possiamo andare avanti”. Si annuvola l’orizzonte del governo israeliano, a poco più di tre mesi dalle ultime elezioni.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Sta diventando una vicenda politica e non solo umanitaria quella relativa agli aiuti per la popolazione siriana, colpita duramente da un devastante terremoto che ha colpito il paese, insieme alla Turchia, facendo finora, complessivamente, oltre 16.000 vittime, bilancio che pare destinato tristemente a salire di ora in ora.
Subito dopo il sisma, Israele aveva fatto sapere di aver ricevuto una richiesta da Damasco, giunta tramite la Russia, per fornire assistenza e soccorsi alla popolazione. Netanyahu, in un gesto che a molti era sembrato estremamente significativo visti i rapporti tra i due paesi, aveva dichiarato di essere pronto ad accettare ed inviare aiuti. “Israele ha ricevuto una richiesta da una fonte diplomatica per aiuti umanitari alla Siria, e io l’ho approvata”, aveva detto Netanyahu ai membri del suo partito, il Likud, aggiungendo che gli aiuti sarebbero stati inviati presto. Si tratterebbe di coperte, medicine, cibo e altri generi di prima necessità per alleviare le sofferenze delle popolazioni colpite. Netanyahu inoltre si sarebbe dichiarato disponibile ad accogliere anche i feriti.
Tuttavia il quotidiano filogovernativo siriano Al Watan ha citato una fonte ufficiale secondo cui Damasco non avrebbe mai richiesto l’aiuto di Israele dopo il terremoto. Secondo altre fonti, la richiesta di assistenza a cui Netanyahu avrebbe fatto riferimento, sarebbe giunta dall’opposizione al governo di Assad e dai gruppi jihadisti nel nord-ovest del paese.
Dalla creazione dello stato di Israele nel 1948, il governo siriano non ha riconosciuto Israele e i due paesi hanno combattuto diverse guerre. Ancora oggi sono numerosi i raid dell’aviazione israeliana in Siria, per colpire, secondo fonti militari israeliane, basi iraniane e di ribelli che minerebbero alla sicurezza dello stato ebraico. Il confine sulle alture del Golan è uno dei più militarizzati dell’area e pochissime volte si è aperto per favorire cittadini di una parte e dell’altra, soprattutto drusi, permettendo così a famiglie divise di incontrarsi o a fedeli di partecipare a feste religiose. “L’occupazione israeliana è la causa delle guerre e delle tensioni nella regione, e quindi Netanyahu dovrebbe essere l’ultima persona che ha il diritto di parlare di fornire aiuti e assistenza”, ha detto un funzionario siriano.
Il mistero dunque si infittisce. Da un lato, è difficile che Netanyahu abbia fatto una fuga in avanti, anche se un segno di distensione verso la Siria potrebbe certamente aiutare nel soft power verso i paesi arabi che il premier ha messo in campo da anni, e che è stato minato dalle recenti operazioni dell’esercito in Cisgiordania con la morte di decine di palestinesi. Dall’altro, la situazione così tragica e drammatica che la Siria vive prima per anni di guerra civile, poi per il terremoto, può aver spinto a chiedere aiuti alla Russia che li avrebbe poi girati a tutti, Israele compreso.
Aiuti sono invece stati inviati già, da Israele, anche verso l’altro paese dilaniato dal terremoto, la Turchia, e continueranno ad essere inviati anche nei prossimi giorni. Per Ankara, Israele si è mossa subito. D’altronde, specie di recente, i rapporti tra i due paesi sono migliorati, anche grazie e visite reciproche di alto livello. Già all’indomani del terremoto il ministro della difesa israeliano, Yoav Gallant ha parlato con il suo omologo turco e la macchina degli aiuti è partita velocemente. Israele del resto, come ricorda un editoriale del Jerusalem Post, ha decenni di esperienza nel fornire aiuti a seguito di disastri naturali, inclusi molti terremoti, oltre a fornire squadre di ricerca e salvataggio e assistenza umanitaria, specialmente sotto la guida del Comando del Fronte Interno.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Si è svolta in un momento estremamente difficile e delicato la visita in Israele del Segretario di Stato americano, Antony J. Blinken. La complicata situazione politica del paese da un lato e la recente, ennesima, escalation della violenza tra israeliani e palestinesi, hanno fatto da sfondo a questa visita.
Blinken e Netanyahu hanno ribadito e confermato il legame duraturo tra i loro paesi. Numerosi analisti, anche sulla stampa internazionale, non hanno tuttavia mancato di sottolineare alcune divergenze sempre più profonde su una serie di questioni fondamentali, che rischiano di minare tale unità. Per prima cosa Blinken ha voluto sottolineare la priorità da dare alla questione rapporti Israele e Palestina, chiedendo a entrambi di evitare ulteriori rappresaglie dopo i sanguinosi episodi degli ultimi giorni. Appena arrivato a Tel Aviv, il Segretario Blinken ha detto di essere “particolarmente scioccato” per l’attacco avvenuto venerdì fuori da una sinagoga in cui un uomo armato palestinese ha ucciso sette persone. L’episodio aveva fatto seguito a un raid israeliano, avvenuto giovedì, contro un campo profughi palestinese nella città di Jenin, in Cisgiordania, che aveva provocato la morte di 10 palestinesi, tra cui una donna di 61 anni. I funzionari palestinesi hanno definito gli omicidi un massacro e l’Autorità palestinese ha sospeso la sua cooperazione in materia di sicurezza con l’esercito israeliano. Israele ha però affermato che il raid era stato ordinato per arrestare alcuni militanti della Jihad islamica che stavano organizzando un attacco contro suoi cittadini.
Blinken ha fatto appello alla calma, specificando che “la vendetta contro vittime innocenti non è la risposta, gli atti di violenza contro i civili non sono mai giustificati”. Il segretario di stato americano ha poi anche ribadito il sostegno americano al “mantenimento dello status quo storico nei luoghi santi di Gerusalemme”, incluso il Monte del Tempio o Spianata delle Moschee, un luogo sacro per ebrei e musulmani. All’inizio di questo mese, il ministro israeliano della sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, aveva effettuato una visita provocatoria suscitando le ire della leadership palestinese, preoccupando anche i funzionari statunitensi. Blinken ha ricordato la grande amicizia che lega Israele agli Stati Uniti d’America ma ha riaffermato l’auspicio di una soluzione a due Stati con i palestinesi, obiettivo che, almeno al momento, con un governo in carica fortemente spostato a destra, che sopravvive soprattutto grazie alle forze nazionaliste che vanno contro qualsiasi istanza avanzata dai palestinesi, sembra quanto mai lontano.
In maniera abbastanza velata, ma in fondo neanche troppo, Blinken ha poi anche parlato dell’importanza della democrazia e del consenso popolare che appoggia le istanze del governo. Il suo è sembrato a molti un riferimento chiaro alla proposta di riforma giudiziaria (che se attuata concederebbe al governo molto più potere rispetto al potere giudiziario) che sta scatenando le proteste di massa. Nelle ultime settimane in tutto Israele si stanno registrando manifestazioni di protesta. Sabato scorso, secondo i dati resi noti, sarebbero state circa 100.000 le persone scese in strada per esprimere il proprio dissenso verso questo governo. Cosa che ha meravigliato non pochi, dal momento che gli israeliani sembrano essere più preoccupati per il problema politico-giudiziario legato alla paventata riforma giudiziaria più che al problema sicurezza.
Con i palestinesi, Blinken ha “scoperto l’acqua calda”, affermando, a Ramallah, dopo l’incontro con il presidente Abu Mazen (Mahmoud Abbas), che “l’orizzonte di speranza dei palestinesi si va restringendo”. Cosa che non è imputabile solo a Israele, alla sua occupazione, ma anche all’Autorità palestinese, che ha perso il controllo del suo territorio e non è più rappresentativa di alcuno. Ma è colpa anche degli stessi Usa che, se con Trump avevano una chiara politica anti palestinese (anche se il presidente presentò un piano di pace scritto da suo genero Jarod Kushner che prevedeva la creazione dello stato palestinese), con Biden avevano promesso mari e monti, senza invece spostarsi di una virgola da quanto ha fatto il predecessore alla casa Bianca. Blinken e Abbas hanno sottolineato dell’importanza di rafforzare le relazioni degli Stati Uniti con l’Autorità palestinese e il popolo palestinese, nonché della necessità di migliorare la qualità della vita dei palestinesi in modi tangibili. Hanno inoltre discusso delle sfide che l’Autorità palestinese deve affrontare e della necessità di una riforma. Il segretario Blinken ha ribadito che israeliani e palestinesi allo stesso modo meritano di vivere in modo sicuro e protetto e di godere di pari misure di sicurezza, libertà e prosperità e ha ribadito l’impegno dell’amministrazione statunitense per una soluzione a due stati.
Nella visita in Israele, non è mancato un accenno alla politica estera. Mentre Israele si muove in bilico per evitare di far arrabbiare Putin, Blinken ha evidenziato l’importanza di “fornire supporto alle esigenze dell’Ucraina”. Netanyahu infatti aveva confermato che continuerà la politica del suo predecessore, Yair Lapid, fornendo all’Ucraina solo aiuti non militari. In una intervista alla Cnn, Netanyahu si è anche proposto come moderatore fra i due paesi in guerra. Comunanza di vedute invece sulle relazioni di Israele con i vicini paesi arabi. Netanyahu vorrebbe normalizzare i rapporti con l’Arabia Saudita anche se sono in molti a ritenere che questo sarà ora più difficile, specie se Israele continua la sua politica di controllo ed espansione sulla Cisgiordania.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Non si appresta a placarsi in Israele lo scontro politico-istituzionale tra i poteri dello Stato ebraico, in particolare tra il governo e l’Alta Corte. Dopo le polemiche scaturite dalla proposta di legge del governo che limita i poteri della Corte, e la “squalifica” da ministro del responsabile del dicastero degli Interni poi licenziato da Netanyahu, è lo stesso primo ministro ad essere entrato nel mirino dell’agone, non solo per le decine di migliaia di manifestanti che ogni fine settimana scendono in piazza a protestare contro le decisioni del suo esecutivo.
La notizia secondo la quale il procuratore generale di Israele, Gali Baharav-Miara, prenderà in considerazione la possibilità di dichiarare il primo ministro Benjamin Netanyahu non idoneo alla sua carica, a causa del conflitto di interessi dovuto al processo penale in corso a suo carico, sta tenendo banco nella vita quotidiana civile e politica israeliana, riempiendo le pagine dei principali giornali locali. Il procuratore generale avrebbe intenzione di incontrare alti giuristi e funzionari del Ministero della Giustizia già questa settimana o la prossima per discutere e decidere circa l’eventuale conflitto di interessi dell’attuale premier. La mossa del procuratore generale arriva proprio quando, mentre è sotto processo per frode e corruzione presso il tribunale distrettuale di Gerusalemme, Netanyahu, appoggiato dal suo governo, sta spingendo proprio per una radicale riforma del sistema giudiziario, in una direzione che, secondo molti, servirebbe proprio a favorire la sua posizione attuale. Netanyahu ha infatti espresso il suo fermo sostegno al pacchetto di riforme proposte dal ministro della Giustizia, Yariv Levin, che prevedrebbe, tra le altre cose, la politicizzazione del processo di selezione dei giudici (che verrebbero scelti da una Commissione in cui il governo avrebbe la maggioranza) e in generale una diminuzione dell’autorità del procuratore generale.
L’ipotesi di squalificare il premier Netanyahu, da parte del procuratore generale Baharav Miara, sarebbe scaturita da una petizione presentata dall’organizzazione “Bastion of Democracy”, rappresentata dall’avvocato Dafna Holz-Lechner. I firmatari hanno chiesto a Netanyahu di rispettare le regole sul conflitto di interessi, redatte dall’ex procuratore generale Avichai Mandelblit, che gli impediscono di far parte delle forze dell’ordine e di ricoprire nomine giudiziarie o essere coinvolto in questioni legislative che potrebbero influire sul processo a suo carico, tuttora in corso.
Intanto, a seguito della diffusione della notizia secondo la quale il procuratore generale starebbe muovendosi in tale direzione, i capi della coalizione di governo hanno inviato una lettera allo stesso procuratore generale Baharav-Miara, avvertendola che una tale mossa equivale a un colpo di stato. “Recentemente, sui media sono apparse diverse notizie secondo le quali lei starebbe discutendo sulla possibilità di costringere il Primo Ministro di Israele a “prendere un congedo” congedo” – si legge nella lettera – con nostro stupore, fino ad ora lei non ha smentito queste notizie. Un tentativo di dichiarare o annunciare una tale mossa è un tentativo chiaramente illegale di deporre e rovesciare un governo eletto e legale, senza una briciola di giustificazione da parte della legge”. La lettera è stata firmata dai capi di tutti i gruppi della coalizione, ad eccezione del Likud di Netanyahu.
Secondo alcune fonti di stampa locale, il procuratore generale Baharav-Miara e i suoi collaboratori starebbero esaminando approfonditamente una decisione del 2021 del giudice della Corte Suprema Hanan Melcer, che aveva stabilito che solo il procuratore generale ha l’autorità per dare un ordine di sospensione di questo genere. Channel 12 ha riportato che Baharav-Miara sarebbe vicina a prendere una decisione senza precedenti. A seguito di tali notizie tuttavia il procuratore generale israeliano ha a sua volta scritto una lettera, indirizzata ai capi della coalizione, affermando che “contrariamente a quanto affermato dai media, non ho mai tenuto discussioni sull’incapacità del primo ministro e voglio anche chiarire che non ho tenuto discussioni su un eventuale congedo per il Presidente del Consiglio”. Nonostante ciò continuano le speculazioni secondo cui il procuratore generale potrebbe tenere nei prossimi giorni una serie di colloqui con alti funzionari del ministero della Giustizia per definire la vicenda. Solo qualche giorno fa il premier Netanyahu era stato costretto a cedere alla decisione della magistratura e aveva dovuto “licenziare” da ministro dell’Interno e della Salute, Aryeh Deri, a causa di sue precedenti condanne.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
È forte e acceso, in questi giorni, il confronto politico in Israele soprattutto a seguito dell’annunciato piano di riforma della giustizia da parte del primo Ministro Benjamin Netanyahu e del ministro della giustizia, Yariv Levin. Una proposta che sta già scatenando le ire di larga parte della popolazione che già parla di “fine della democrazia”.
Nei giorni scorsi in tre delle principali città del paese, Tel Aviv, Gerusalemme ed Haifa migliaia di persone sono scese in piazza in segno di protesta. Se approvata, la riforma della giustizia aumenterà i poteri per la Knesset (il Parlamento israeliano), permettendogli di annullare le sentenze della Corte Suprema con una maggioranza semplice. Il timore di molti è che il governo in tal caso potrebbe utilizzare tale strumento a suo favore: Netanyahu per bloccare eventuali ulteriori processi contro di lui, mentre il governo in generale, si dice, potrebbe avere molta maggiore facilità ad approvare leggi a favore ad esempio degli insediamenti, o per favorire ulteriormente le mire espansionistiche israeliane in Cisgiordania.
Con il sistema al momento vigente i giudici della Corte suprema possono bocciare le leggi approvate dal Parlamento, se contraddicono le 13 Basic Laws di Israele, la legge costituzionale dello Stato ebraico. Con la riforma verrebbe invece introdotta una “clausola di annullamento” che permetterebbe ai deputati di reintrodurre una norma bocciata dalla Corte suprema con una maggioranza semplice di 61 voti (su 120). Altro timore è che, con la riforma, potrebbe verificarsi un indebolimento della magistratura rispetto all’esecutivo. Al momento infatti in Israele, i giudici della Corte Suprema sono nominati e revocati da un comitato composto da professionisti, membri del governo e alcuni giudici. La riforma di Levin vorrebbe invece dare al governo la maggioranza nel comitato, con i numeri che propendono per il governo in carica. I giudici della Corte Suprema verrebbero dunque per lo più scelti dal governo. Il presidente della Corte suprema israeliana, Esther Hayut, ha affermato che il piano di riforma del governo Netanyahu schiaccerebbe il sistema giudiziario e minerebbe la democrazia del paese. Rispondendo a una intervista televisiva, la Hayut ha detto che “non è un piano per migliorare il sistema giudiziario, ma piuttosto un piano per schiacciarlo, che infliggerà un colpo fatale all’indipendenza dei giudici e alla loro capacità di servire il popolo”.
Di parere ovviamente opposto è il Ministro della giustizia, Levin, secondo il quale il nuovo piano servirà a bilanciare i poteri dello stato. “Andiamo alle urne, votiamo, scegliamo, ma di volta in volta poi persone che non abbiamo scelto decidono per noi – ha detto Levin – alludendo al potere dei giudici di ribaltare le leggi – è giunto il momento di agire”. “Sarà una democrazia vuota – ha detto Amir Fuchs, ricercatore senior presso il think tank Israel Democracy Institute di Gerusalemme – quando il governo avrà il potere supremo, utilizzerà questo potere non solo per le questioni relative ai diritti LGBTQ e ai richiedenti asilo, ma anche per le elezioni, la libertà di parola e tutto ciò che desidera”. Estremamente critico è stato anche il capo dell’opposizione, Yar Lapid che, anche attraverso alcuni tweet, ha dichiarato che “questa non è una riforma ma un cambio di regime, che taglia Israele fuori dalla cerchia degli Stati liberali”.
Contro la proposta, almeno 80mila persone son scese in piazza. Il Ministro della Sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, ha ordinato alla polizia di intervenire anche con durezza se i manifestanti dovessero bloccare strade o esporre bandiere palestinesi. A Tel Aviv i manifestanti hanno sventolato bandiere e hanno issato cartelli con scritto “governo criminale”, oppure “la fine della democrazia”. Sono state viste anche alcune bandiere palestinesi. Manifestazioni si sono svolte anche a Gerusalemme e ad Haifa. “Decine di migliaia di persone hanno partecipato alle manifestazioni ha twittato Miki Zohar, esponente del partito Likud di Netanyahu ma alle elezioni tenutesi due mesi e mezzo fa, si sono presentati in milioni”.
Netanyahu ha già condotto anche in passato campagne contro il sistema giudiziario. Ha sempre negato tutte le accuse a lui rivolte, affermando di essere vittima di una caccia alle streghe orchestrata dai media e da pubblici ministeri ostili. Il Ministro Levin ha tenuto ora però a specificare che il suo piano di riforma “non è collegato in alcun modo” alle vicende giudiziarie che riguardano il premier Netanyahu. Intanto i sondaggi per capire cosa realmente ne pensa la popolazione sono abbastanza discordanti. Mentre Channel 13 TV la scorsa settimana ha affermato che il 53% degli israeliani sarebbe contrario alla riforma giudiziaria, Channel 14 TV ha invece affermato che il 61% sarebbe a favore.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Il nuovo governo israeliano, nuovamente guidato da Benjamin, Bibi, Netanyahu, ha già messo in atto, in poco tempo, una serie di misure che rischiano di inasprire sempre di più i rapporti con la leadership palestinese, allontanando maggiormente le ipotesi, seppur remote, di pace. Dopotutto, nessuno si aspettava qualcosa di diverso da un governo, una coalizione e partiti che da sempre si dichiarano convintamente contrari ad uno stato palestinese.
Tanto per cominciare Israele non ha per nulla preso bene la mossa dell’Autorità nazionale palestinese che ha chiesto che la Corte internazionale di Giustizia delle Nazioni Unite si pronunci, definendola illegale, sull’occupazione israeliana in Cisgiordania e su Gerusalemme est. Il governo israeliano ha infatti descritto la richiesta dell’Autorità palestinese all’ONU come una decisione di intraprendere una guerra politica e legale contro lo Stato di Israele. “L’attuale governo non starà a guardare di fronte a questa guerra e risponderà se necessario”, ha affermato il Gabinetto in un comunicato. Come ulteriore segnale contro l’autorità nazionale palestinese, Netanyahu e i suoi alleati (un gruppo di religiosi e conservatori di estrema destra) ha fatto sapere che Israele tratterrà 39 milioni di dollari inizialmente destinati all’Autorità palestinese e trasferendo invece questi fondi a un programma di risarcimento per le famiglie delle vittime israeliane degli attacchi perpetrati dai militanti palestinesi. Ha poi anche affermato che Israele detrarrà ulteriormente all’autorità nazionale palestinese le somme corrispondenti che l’autorità ha pagato l’anno scorso alle famiglie dei prigionieri palestinesi e di coloro che sono stati uccisi nel conflitto, compresi i militanti implicati in attacchi contro israeliani. Tagli questi che, se attuati, contribuiranno ad aumentare i problemi economici nei Territori palestinesi, esacerbando gli animi. Verranno poi, fanno sapere dai vertici governativi israeliani, anche revocati una serie di benefici finora concessi ai funzionari palestinesi. In primo luogo verrebbero d’ora in avanti negati molti permessi che consentono loro di viaggiare facilmente dentro e fuori la Cisgiordania occupata, a differenza dei comuni palestinesi.
“Il ricatto israeliano − ha dichiarato il primo ministro palestinese Mohammad Shtayyeh − non ci impedirà di continuare la nostra lotta politica e diplomatica”, ammettendo però che le misure israeliane necessariamente aggraveranno la crisi finanziaria palestinese e il deficit di bilancio. Il nuovo governo di destra israeliano intende poi procedere e anzi dare priorità nella sua agenda all’espansione degli insediamenti in Cisgiordania. Attualmente Israele ha già dozzine di insediamenti ebraici che ospitano circa 500.000 israeliani che vivono insieme a circa 2,5 milioni di palestinesi. Il Gabinetto israeliano ha anche affermato che congelerà le costruzioni palestinesi nell’Area C, il 60% della Cisgiordania dove, in base agli accordi di pace provvisori, Israele esercita già un completo controllo.
Il governo inoltre prevede azioni ancora non specificate e chiarite contro le organizzazioni in Cisgiordania che promuovono attività terroristiche o qualsiasi attività ostile a Israele. Ciò includerebbe gruppi che svolgono azioni politiche e legali contro Israele con il pretesto di attività umanitarie. E le misure anti-palestinesi non riguardano comunque solo gli aspetti economici. Il ministro della sicurezza nazionale israeliano, Itamar Ben Gvir, ha ordinato alla polizia israeliana di bandire le bandiere palestinesi dai luoghi pubblici. “Ho ordinato alla polizia israeliana di far rispettare il divieto di sventolare qualsiasi bandiera palestinese o che mostri l’identificazione con un’organizzazione terroristica e di fermare qualsiasi istigazione contro lo Stato di Israele”, ha annunciato Ben-Gvir su Twitter.
Il Ministro Ben-Gvir, ha attirato l’attenzione di tutta la stampa non solo locale ma anche internazionale quando solo pochi giorni fa ha visitato il luogo sacro più delicato di Gerusalemme, la spianata delle Moschee (o Monte del Tempio). Molte sono state le condanne, anche da parte della comunità internazionale per questo gesto. E i timori sono che, come accadde con Sharon, queste continue provocazioni, possano far salire alle stelle le tensioni conducendo ad una terza intifada. Provocazioni che il governo israeliano continua anche a livello politico, con atti sempre più ostili nei confronti dei palestinesi, verso i quali anche gli Usa hanno inviato una timida protesta. Sarà la visita del Segretario di Stato Blinken entro la fine del mese a chiarire la posizione di tutti.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Un balzo indietro di oltre 20 anni. La visita di martedì 3 gennaio del Ministro per la Sicurezza nazionale israeliana, il discusso Itamar Ben-Gvir, a Gerusalemme sulla Spianata delle Moschee o Monte del Tempio per gli ebrei, poteva riportare il paese nel conflitto con i palestinesi come avvenuto a settembre del 2000. Allora, il 28 di quel mese, l’esponente del Likud, poi primo ministro, Ariel Sharon, compì lo stesso gesto, una passeggiata sul terzo sito più sacro per i musulmani, scatenando la reazione feroce di questi che si tradusse nella seconda, sanguinosa, Intifada.
La passeggiata provocatoria di Ben-Gvir ha, fortunatamente, scatenato solo reazioni, da entrambi i lati del conflitto e dall’estero, anche se Hamas non ha fatto venir meno la sua risposta armata. Un razzo, infatti, è stato lanciato da Gaza in direzione Israele ma è ricaduto nella stessa Striscia. Lo stesso gruppo islamico aveva già minacciato ritorsioni all’annunciata passeggiata del Ministro della Sicurezza nazionale israeliana, il quale non si è fatto intimorire e anzi, ha portato avanti il suo progetto provocatorio dicendo di non temere le minacce. Accompagnato da una decina di agenti e da un rabbino, per poco più di dieci minuti ha camminato sulla spianata, alle 7.30 del mattino. A quell’ora, il sito non è ancora pieno di turisti che in questi giorni, complici le festività natalizie, affollano in massa la Terra Santa. “Si è presentato come un ratto, si è fatto vedere e velocemente se ne è andato, il, codardo”, ci hanno detto i ragazzi che prestano servizio volontario sul sito per controllare che chi visita il luogo sacro per musulmani, ebrei e cristiani, sia vestito decentemente. Condanne dalla Palestina, ma anche da Israele, pure dagli ebrei ortodossi, per i quali non bisogna andare sulla Spianata perchè, non conoscendo esattamente l’ubicazione del Sancta Sanctorum del tempio ebraico distrutto due volte, si rischia di calpestare suolo sacro.
Itamar Ben-Gvir è una figura molto controversa nel panorama politico e sociale israeliano. Nato da una famiglia di origine ebraico-irachena, sin da da giovane ha abbracciato le idee del kahanismo, la corrente estremista di destra ritenuta poi terroristica e i cui partiti sono stati sciolti e dichiarati fuorilegge. Proprio per le sue idee di estrema destra, fu esentato dal servizio militare, in un paese nel quale non solo è obbligatorio, ma non farlo significa vedere la propria carriera spezzata. Il suo partito, Otzma Yehudit, il Potere ebraico, viene considerata una filiazione deli partiti kahanisti. Ben-Gvir, che vive con la sua famiglia nell’insediamento di Hebron, in una delle zone contese più calde del panorama israelo-palestinese, si vanta di essere stato sottoposto ad oltre 53 processi, sempre per gli stessi reati: incitamento all’odio, razzismo, disordini, terrorismo e simili. Otto volte è stato condannato. A casa accoglieva gli ospiti sotto il ritratto del terrorista israelo-americano Baruch Goldstein, che massacrò 29 fedeli musulmani e ne ferì altri 125 a Hebron, nella Grotta dei Patriarchi, nel 1994. Foto rimossa quando è entrato in politica. Da avvocato, ha difeso (non per soldi, dice lui) molti accusati di crimini contro gli arabi, come gli imputati nell’attacco al villaggio di Duma, nel quale morì bruciato, nel luglio del 2015, un bambino di 18 mesi e perirono anche i suoi genitori. Il suo credo lo porta a pensare a un Israele di soli ebrei, dal quale dovrebbero essere cacciati gli arabi israeliani e impediti matrimoni interreligiosi.
Entrato nei palazzi del potere come assistente parlamentare nel 2009, nel 2021 ottiene il suo primo seggio alla Knesset in coalizione con altri due partiti. E da parlamentare si fa notare per presentarsi armato a Sheikh Jarrah, sostenendo i coloni e urlando contro le famiglie arabe, in procinto di essere cacciate dalle loro case, “ricordatevi che sono il vostro proprietario, sono il proprietario di questo luogo”, incitando gli agenti a sparare contro gli arabi che lanciavano pietre per difendersi dagli attacchi dei coloni.
Il novello Sharon, anche più pericoloso di quest’ultimo, ha tessuto così bene le sue trame, pescando nel malcontento israeliano per il governo di larghissime intese di Bennet-Lapid, sotto il quale c’è stato il picco degli attentati in Israele e dei morti in Palestina da diversi anni, per accreditarsi come difensore della causa di sicurezza israeliana. Da un seggio, il suo Potere Ebraico ottiene sei seggi nell’ultima elezione del primo novembre scorso, diventando il terzo partito in coalizione con Noam. Benjamin Netanyahu, non ha potuto fare altro che allearsi con Ben-Gvir e accettarne le pretese: in particolare gli ha concesso la super posizione di ministro della sicurezza, creato apposta per lui, cambiando la posizione del ministero per la sicurezza interna. Nel suo incarico, Ben-Gvir controlla tutta la polizia israeliana, quella delle carceri e i vigili del fuoco ma, in particolare, la polizia di frontiera, quella cioè che sovrintende i checkpoint e gli aeroporti, ma che assiste anche l’esercito in operazioni antiterrorismo e di contrasto allo stesso in Cisgiordania, nonché a Gerusalemme. Le stesse operazioni che hanno portato, lo scorso anno, al record negativo di oltre 200 vittime civili nei Territori.
Se il buongiorno si vede dal mattino, per Netanyahu sarà difficile tenere a bada il suo ministro e questo potrà influire, tra le altre cose, nelle mire espansionistiche di normalizzazione con i paesi arabi, del premier più longevo nella storia di Israele.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Con una media di una elezione ogni otto mesi, il prossimo 1° novembre Israele tornerà alle urne per la quinta volta in tre anni. Sia gli attori che lo scenario saranno gli stessi. Da un lato la destra di Benjamin Netanyahu, dall’altro, tutto il mondo politico israeliano che, nell’ultimo anno, ha tentato di governare insieme proprio in chiave anti Bibi.
Si può dire con certezza che oramai Israele le ha provate tutte, ma non riesce ad avere un Governo stabile, a causa del sistema elettorale che vede una grossa frammentazione politica. Con un sistema proporzionale che deve assegnare 120 seggi, la soglia di sbarramento al 3,25% pare, stando alla storia recente israeliana, troppo bassa per consentire una vittoria sicura di un partito o di uno schieramento, tale da dargli almeno i 61 voti necessari per ottenere la maggioranza e governare il paese.
Le ultime legislature, l’ultima in particolare, uscita dalle elezioni e dai giochi politici del 23 marzo dell’anno scorso, hanno dimostrato come lo scarto o la decisione di un solo parlamentare possa portare alla dissoluzione del governo. L’ultimo esecutivo a guida Naftali Bennet, con Yair Lapid a fare da Primo Ministro a rotazione, è stato sconfitto dopo che un parlamentare prima e un altro dopo hanno abbandonato la maggioranza, non votando leggi. Una di queste riguardava la possibilità di portare il pane lievitato negli ospedali durante le festività ebraiche di Pasqua; l’altra era la necessità di estendere ai coloni la legge israeliana. I coloni in Cisgiordania hanno uno status legale parificato a quello israeliano, laddove vi è invece un trattamento diverso per i Palestinesi che vivono negli stessi luoghi. Questo avviene sulla base di regolamenti di emergenza che Israele ha messo in atto nel 1967 e che devono essere rinnovati periodicamente. L’attuale regolamento sarebbe scaduto il primo luglio: poiché il Governo non ha potuto raccogliere consensi per approvare il rinnovo, l’unica alternativa era appunto quella di sciogliere il Parlamento. In tal modo i regolamenti sono stati automaticamente prorogati per sei mesi, perché la Knesset si è sciolta prima del loro rinnovo.
Il Governo discioltosi incorporava partiti molto diversi tra loro, dalla sinistra estrema alla destra, passando per gli arabi. Questi si erano uniti con il solo ideale comune di impedire all’allora primo ministro Netanyahu di mantenere il potere dopo 12 anni consecutivi al timone di Israele. La coalizione ha cercato di mettere da parte l’ideologia e concentrarsi su questioni socioeconomiche e di governance, ma le differenze erano notevoli. E alla fine, proprio le questioni nazionaliste e ideologiche sono riemerse, spaccando la coalizione e rimandando Israele al voto.
Come per le elezioni dell’anno scorso, anche durante queste l’argomento principe è la sicurezza. Poco più di un mese dopo le elezioni dell’anno scorso, scoppiò il violento conflitto con Gaza, l’operazione “Guardian of the walls”, che vide l’esercito israeliano confrontarsi con Hamas. In quella occasione, la scintilla che fece esplodere il conflitto fu più politica, legata agli sgomberi forzati di palestinesi da Gerusalemme est, che portarono a scontri anche sulla Spianata delle Moschee.
Quest’anno, in piena campagna elettorale, una nuova operazione su Gaza, con altra origine e contro altri interlocutori. A “incrociare i razzi” con Israele, è stata la Jihad islamica palestinese. Un gruppo terrorista con base a Gaza e agganci in Libano con Hezbollah e in Iran, dai quali riceve aiuti militari. Non ha responsabilità di Governo come Hamas, a cui contende la palma di difensore degli interessi palestinesi. Lo scontro è nato dopo che l’esercito israeliano ha arrestato a Jenin, in Cisgiordania, Bassam al Saadi, comandante della Jihad Islamica in Palestina. Jenin è la città cisgiordana, da sempre una spina nel fianco per Israele. Da qui, infatti, provengono la maggior parte dei responsabili degli attentati che nei mesi scorsi in undici giorni hanno ucciso 14 persone in Israele. In risposta l’esercito ha organizzato numerose azioni in Cisgiordania contro terroristi, fiancheggiatori e presunti tali, che hanno fatto una trentina di vittime. A ordinare alcuni di questi attacchi contro le città israeliane, eclatante quello nel centro di Tel Aviv, proprio Bassam al Saadi. Durante uno di questi raid dell’esercito israeliano a Jenin, l’11 maggio scorso ha perso la vita la giornalista di Al Jazeera Shireen Abu Akleh, uccisa probabilmente da un militare dell’esercito israeliano che, con il suo reparto, era impegnato in uno scontro con dei militanti palestinesi. Subito dopo l’arresto di al Saadi, che comunque è una vecchia conoscenza delle carceri israeliane, la Jihad islamica aveva minacciato violente ripercussioni. Era cominciata una mediazione con l’Egitto e si attendeva una risposta israeliana, che però l’esecutivo ha pensato bene di anticipare con un attacco preventivo di precisione su Gaza, uccidendo, tra gli altri, Taysir al Jaabari, uno dei leader del movimento che, secondo informazioni di intelligence israeliane, stava pianificando attacchi nel paese, in risposta all’arresto di al Saadi.
Se l’anno scorso a guidare l’operazione su Gaza era stato Benjamin Netanyahu, quest’anno è stato il premier a rotazione Yair Lapid, centrista, a decidere di attaccare la Striscia. Una decisione non da poco, per una serie di ragioni. La prima: l’interventismo è sempre stato appannaggio della destra che ha fatto anche della sicurezza una delle bandiere elettorali. La seconda: Lapid e il suo co-premier Naftali Bennett guidavano una coalizione nella quale gli arabi avevano un notevole peso. La terza: il ministro della difesa Benny Gantz è l’uomo che nel giro di un anno ha incontrato diverse volte Abu Mazen sia in Israele che nei Territori. Ma la ferita lasciata aperta dai morti fatti nel cuore delle città israeliane ha spinto il Governo di Lapid ad agire. La sicurezza è da sempre uno degli argomenti verso il quale gli elettori israeliani sono più sensibili. Con gli ultimi sondaggi che danno in testa Benjamin Netanyahu, da sempre favorevole alla linea dura con i palestinesi, anche l’esecutivo di centro destra dell’attuale premier ha voluto, secondo alcuni, tenere dritta la barra sulla faccenda. Che la sicurezza sia argomento principe in Israele, anche elettorale, è fatto notorio. Dopotutto Gantz è un ex capo di stato maggiore dell’esercito israeliano. Dalla fondazione dello stato di Israele, su 21 capi di Stato maggiore (escludendo l’attuale in carica) ben 14, oltre i due terzi, sono scesi in politica; di questi, due (Yithak Rabin e Ehud Barak) sono anche stati Primo Ministro e sei invece Ministro della Difesa (Moshe Dayan, Yithak Rabin, Ehud Barak, Shaul Mofaz, Moshe Ya’alon and Benny Gantz). Dal 1997 ad oggi, in ogni legislatura, c’è stata la media di sei tra generali ed ex capi di Stato maggiore.
Tra la fine della legislatura e l’inizio dello scontro con la Jihad Islamica, c’è stato anche il tempo di ospitare, nella sua prima visita da quando vive nella Casa Bianca, Joe Biden. Visita che non ha smosso alcunché, non ha scalfito equilibri, non ha riavvicinato parti. Eppure l’amministrazione Biden aveva promesso sin dall’inizio un cambio di rotta nei confronti della Palestina rispetto all’amministrazione precedente. E invece nessuna delle promesse fatte è stata portata a termine: il consolato a Gerusalemme non è mai stato aperto, così come l’ambasciata a Washington chiusa da Trump. La cosa ha ovviamente aumentato il senso di frustrazione dei palestinesi, come la decisione dell’Arabia Saudita di riaprire cieli agli israeliani, scelta che qualcuno vede come il preludio al riconoscimento reciproco e possibile ingresso negli accordi di Abramo. Dopotutto anche la Turchia ha riallacciato i rapporti con Israele e sia Riad che Ankara mirano al controllo della Spianata delle Moschee, terzo luogo più sacro dell’Islam, ora gestito da una fondazione giordana. I palestinesi navigano a vista. Abbas, 87enne e malato, non lascia il potere. Tra i palestinesi, almeno stando ai sondaggi, l’80% non lo vuole, lo considera un agente degli israeliani. Ma nessuno si muove per sloggiarlo. Oramai governa dal 2006 senza opposizione, che lui annienta in ogni mezzo. Come, pare oramai annientato il sogno di uno stato per i palestinesi.
Questo articolo è pubblicato anche sul numero di settembre/ottobre di eastwest.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
La crisi ucraina derivata dall’invasione russa e dalla successiva guerra ha lasciato non pochi strascichi tra Israele e Territori Palestinesi. Gerusalemme da sempre è legata al mondo russofono: sia per l’alta presenza di ebrei in entrambi i Paesi in conflitto, sia per le implicazioni geopolitiche soprattutto mediorientali. Il Governo palestinese, dal canto suo, è strettamente dipendente da Mosca. Non a caso, l’Autorità nazionale palestinese è stata una delle poche realtà governative al mondo a non criticare la mossa di Putin. Neanche il premier israeliano Naftali Bennett ha criticato la decisione del presidente russo di invadere il Paese vicino, ci ha pensato invece il suo Ministro degli Esteri, Yair Lapid, e poi il Paese della stella di Davide ha preso seri provvedimenti internazionali.
Gerusalemme, dicevamo, è legata a doppio filo ai due Paesi. Sono moltissimi gli immigrati russi, in maggioranza, e ucraini in Israele. Ci sono città, come Rishon LeZion, quarta città per popolazione di Israele, non lontana da Tel Aviv, dove la presenza russa è maggioranza. La città stessa fu fondata dagli immigrati dell’ex impero alla fine del 19mo secolo. Qui ha la sua roccaforte elettorale Avigdor Lieberman, attuale ministro delle finanze, ex Ministro della Difesa, degli Esteri e vice Primo Ministro, leader del partito russofono Israel Beytenu.
Israele ha da sempre buoni rapporti con Mosca. È grazie all’appoggio russo che riesce a continuare i raid aerei contro le postazioni iraniane in Siria. Anche se guarda con circospezione lo stretto legame che Mosca ha con Ramallah, con la prima che fornirebbe aiuti militari non ufficiali alla seconda.
Allo scoppiare del conflitto, rispondendo pure agli appelli dell’ebreo Volodymyr Zelensky, Israele si è fatto subito mediatore con la Russia. Bennett è volato a Mosca e ha più volte parlato al telefono con Putin, cercando una soluzione negoziale al conflitto. Israele non ha fornito armi all’Ucraina, neanche il famoso scudo antimissile Iron Dome. Ma si è impegnata ad accogliere oltre 10mila profughi ai quali ha garantito la permanenza sul territorio israeliano per alcuni mesi. Le posizioni israeliane però più spostate oggi verso l’Ucraina, sfociate dalla iniziale equidistanza al voto israeliano favorevole in Consiglio di sicurezza Onu per la sospensione di Mosca, non hanno lasciato Putin indifferente. L’ambasciatore israeliano a Mosca è stato convocato da Lavrov e quello russo in Israele ha chiesto una posizione più equilibrata.
Nei giorni scorsi è esploso un contenzioso a seguito di una lettera inviata da Putin a Bennett con la quale chiede di autorizzare in tempi brevi il passaggio della chiesa di Alexander Nevsky, nella città vecchia di Gerusalemme, sotto il controllo di Mosca. I due paesi erano già d’accordo sulla cosa, che fu merce di scambio per la liberazione di una israeliana arrestata per droga in Russia, ma non è mai stata perfezionata. A complicare le cose, anche una telefonata di Putin ad Abu Mazen nella quale ha condannato le azioni israeliane sulla Spianata delle Moschee, ribadendo l’appoggio alla causa palestinese.
Sulla guerra in Ucraina, l’Autorità nazionale palestinese, è silente, non si espone. Per il Ministro degli Esteri palestinese, Riyad al-Maliki, i palestinesi si stanno allontanando dall’attuale conflitto in Ucraina, perché “siamo un paese sotto occupazione, non possiamo sopportare l’onere di prendere una posizione a favore di una parte a spese di un’altra e le ripercussioni di tale posizione su di noi”.
I palestinesi sono sì silenti sulla questione russa ma non mancano di rimarcare quello che ritengono un doppio modo di comportarsi dei media e dell’opinione pubblica internazionale tra l’occupazione russa dell’Ucraina e quella israeliana dei Territori Palestinesi. Lo stesso ministro al-Malik ha denunciato da giorni il fatto che il mondo simpatizza con l’Ucraina ma non fa lo stesso con la causa palestinese. Parlando a Ginevra alla 49ma sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, Al-Maliki ha affermato che alla potenza occupante, Israele, “viene concesso uno status indifendibile di trattamento eccezionale che le consente di continuare a commettere crimini con totale e abietta impunità”. Sui media palestinesi, ma soprattutto sui social, i richiami a questo doppio standard sono molti. Ad esempio con vignette, nelle quali si fa riferimento ai combattenti ucraini che fabbricano molotov come partigiani eroi mentre i palestinesi che fanno lo stesso vengono additati come terroristi. Ci sono molti post dove si denuncia questo doppio standard anche sui profughi, con quelli arabi respinti e quelli ucraini accolti, o altri, dove si denuncia il fatto che mentre da un lato si condanna la Russia per l’invasione dell’Ucraina, dall’altro non si fa altrettanto con l’occupazione israeliana.
Accuse negate dai media israeliani dove anzi si parla di propaganda palestinese, di “guerra sulle ideologie”, spiegando che la questione tra i due conflitti è totalmente diversa, non fosse altro perché la Russia ha invaso uno stato legittimo, cosa che la Palestina non è, non essendo mai esistita. Anzi, come scrive il Jerusalem Post, la Russia e Putin hanno molto più in comune con palestinesi e Hamas che con Israele, come ad esempio l’assenza di elezioni, di democrazia nei loro paesi, l’assenza di stampa libera, gli arresti ed esecuzioni degli oppositori e dei critici. E come i governanti palestinesi respingono l’idea dell’esistenza di uno stato ebraico, così la Russia nega la possibilità di esistere dell’Ucraina.
Putin, come visto, è entrato a gamba tesa, per dividere ancora di più le parti, sul rinnovato ciclo di scontri sia a Gerusalemme che con la striscia di Gaza, scoppiato in occasione delle festività ebraiche pasquali e del Ramadan. Come un copione che si ripete, infiltrati da una parte e dall’altra hanno dato il via a scontri che hanno portato a centinaia di arresti e feriti oltre che a lanci di razzi da Gaza con conseguente risposta israeliana. Una situazione ciclica, dettata da provocazioni di gruppi di coloni della destra ebraica che neanche riconoscono lo Stato di Israele e dall’altro quelle di infiltrati tra i fedeli musulmani, ai quali non interessa la preghiera, ma solo inneggiare con bandiere e striscioni ad Hamas, lanciare fuochi di artificio e pietre contro poliziotti e realizzare barricate sulla Spianata.
In mezzo, due Governi che oramai hanno perso gran parte del loro controllo. Quello israeliano è sull’orlo dell’ennesima crisi e quindi delle ennesime elezioni. Le defezioni sono arrivate proprio dal partito del premier Bennett e hanno portato la conta in parlamento a 60 pari. Con i fatti della spianata delle Moschee è stato annunciato il ritiro dalla coalizione Frankenstein di Governo, che va dalla destra estrema alla sinistra passando per gli arabi, proprio di questi ultimi, e questo agevolerebbe sicuramente Netanyahu. Anche perché gli ultimi sondaggi dicono che la maggioranza degli elettori lo ritiene il più adeguato a guidare il paese, in considerazione del periodo di stabilità sul fronte sicurezza interna vissuto sotto Bibi.
Ma se Atene piange, Sparta non ride. Alle scorse elezioni comunali, Fatah è riuscita ad aggiudicarsi di misura Ramallah, Nablus e Jenin, mentre le liste indipendenti islamiche, di fatto ispirate da Hamas, hanno raccolto consensi ovunque e preso alcune città, come Hebron, Tulkarem e Al Bireh. Hamas sta riuscendo a rosicchiare sempre più consensi, soprattutto tra i giovani, una generazione che non è mai riuscita a votare alle elezioni politiche e che è stanca delle promesse e della corruzione dell’Anp a guida Abu Mazen. Le università sono diventate territorio fertile per la propaganda di Hamas, che si sta accreditando come unico difensore dei palestinesi. E da più parti si chiede lo scioglimento dell’Anp.
Questo articolo è pubblicato anche sul numero di maggio/giugno di eastwest.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Ramallah sembra essere in un luogo diverso rispetto al resto della Cisgiordania. Mentre infatti nella città sede della presidenza, del Governo e degli uffici ministeriali dell’Autorità Palestinese si decide e si orienta il futuro dei Territori e dei palestinesi nel segno di una continuità incentrata sulla conservazione del potere, le altre città esplodono di rabbia contro i vertici amministrativi.
L’idillio tra i palestinesi e l’ANP è finito da tempo (se mai è esistito), complice l’autocrazia di Mahmoud Abbas (Abu Mazen), che regna indiscusso dal 2005, senza possibilità di contraddittorio, visto che ha cancellato anche le ultime elezioni politiche che dovevano tenersi la scorsa primavera dopo 15 anni.
Alla fine di dicembre, il Presidente palestinese ha incontrato il Ministro israeliano della Difesa Benny Gantz a casa di quest’ultimo in Israele, attirandosi le ire dei palestinesi che hanno parlato sudditanza da parte di Abu Mazen. Nei mesi successivi e precedenti, ci sono stati altri incontri sulla sicurezza tra vertici israeliani e palestinesi, in un rinnovato dialogo che era stato interrotto bruscamente durante la presidenza americana di Donald Trump e il premierato israeliano di Benjamin Netanyahu. Non che la cosa abbia sortito effetti, anzi: con i colloqui, Abu Mazen si è isolato sempre di più rispetto alla base palestinese, sempre più fomentata dai gruppi fondamentalisti, Hamas in testa.
A far esplodere la rabbia, che covava sotto la cenere, è stata l’uccisione l’otto di febbraio a Nablus da parte di Shin Bet ed esercito israeliano, di tre palestinesi ritenuti terroristi affiliati delle Brigate Martiri di Al-Aqsa, il braccio armato del partito di Abu Mazen, Fatah. Il raid che ha portato all’uccisione dei tre, è stato organizzato se non con la complicità o l’assenso delle forze di sicurezza palestinesi, almeno con il loro silenzio, girando la faccia dall’altra parte per non guardare. Cosa che ha scatenato non poche proteste contro il governo palestinese sia ai funerali dei tre, sia nelle altre città. L’occasione è stata ghiotta, soprattutto per i gruppi fondamentalisti che tentano invano di prendere il potere in Palestina e che chiedono una politica più incisiva contro Israele, per muovere critiche ad Abu Mazen e al suo entourage. Non che l’attuale Presidente abbia fatto qualcosa per evitare di esacerbare gli animi.
Nei giorni dell’uccisione di Nablus, si teneva a Ramallah la riunione, la prima in quattro anni, del Consiglio centrale dell’Olp che include le principali le organizzazioni palestinesi (ma non Hamas e Jihad Islamica Palestinese), che è assemblea ridotta del Consiglio nazionale dell’Olp, il “parlamento” di tutti i palestinesi nei Territori occupati, nei campi profughi e in esilio. Durante la riunione si dovevano prendere importanti decisioni e si è risolta nella cooptazione di fatto nel Comitato esecutivo dell’Olp, di un fedelissimo di Abu Mazen come segretario generale, cosa che proietta il nominato, Hussein Sheikh, considerato di posizioni molto moderate, Ministro, molto vicino ad Abu Mazen e responsabile per i rapporti con Israele, in rampa di lancio come successore dell’ottuagenario presidente. Durante gli incontri, il Presidente palestinese aveva anche annunciato l’interruzione del coordinamento di sicurezza con Israele e il riconoscimento dello stato ebraico come risposta alle proteste seguenti all’uccisione dei tre, ma oramai la frittata era fatta.
Sono sempre più i giovani, anche non musulmani, che stanno abbracciando le idee di Hamas e simili e pronti alla lotta armata, sono stanchi del doppiogiochismo e della immobilità di Fatah e dell’Olp come dell’Anp. Hamas prende sempre più piede soprattutto nelle università, riuscendo ad infiltrare e diffondere le proprie idee. Per ripicca, la sicurezza palestinese, che ha dimostrato in più occasioni di non riuscire a gestire il territorio nonostante oltre il 20% del budget dell’ANP venga destinata ad essa, ha sigillato alcuni atenei.
A soffiare sulla cenere, anche la non risolta questione degli sgomberi forzati di palestinesi da quartieri di Gerusalemme Est, come Sheikh Jarrah. Quella che l’anno scorso è stata la miccia che ha contribuito all’accensione dello scontro armato con Gaza, è ancora viva. Il Governo israeliano continua nell’opera di sgombero forzato dei palestinesi dalle loro case di Sheikh Jarrah per consegnarle ai coloni. In questi giorni la tensione è sempre molto alta e si teme per il peggio. Questo perché tra aprile e maggio c’è la concomitante ricorrenza non solo degli scontri dell’anno scorso, ma anche della pasqua ebraica, di quella cattolica e del ramadan.
Da più parti si è tentato di de-scalare le tensioni, esacerbate soprattutto dalla destra israeliana, un esponente della quale si è attrezzato un ufficio dinanzi alla casa di una delle famiglie che rischia lo sgombero. Ma l’intervento delle forze di sicurezza palestinesi nelle proteste nei Territori non è servito a ridurre le polemiche e le manifestazioni anti Abu Mazen e suoi sodali, così come la diffusione di Hamas nella popolazione palestinese al di fuori della striscia di Gaza.
Dopotutto, il gruppo che governa l’area costiera tra Israele ed Egitto conta su un apparato mediatico non indifferente. Non solo video sui principali social network, in particolare TikTok, meno sottoposto a controllo e censura, ma anche film e serie tv di propaganda. È questo il caso di Qabdat al-Ahrar (“Il pugno degli uomini liberi”), una serie che andrà in onda ad aprile in occasione del Ramadan e che è stata definita la risposta di Hamas a Fauda.
Nel 2015 la rete televisiva israeliana Yes ha mandato in onda la prima serie di Fauda (Caos, in arabo) che racconta la storia di un gruppo speciale dell’antiterrorismo israeliano, impegnato nella ricerca e uccisione di un terrorista palestinese. La serie è stata poi acquistata e trasmessa da Netflix, con la terza parte che ha raccontato una missione sotto copertura a Gaza per liberare due ostaggi israeliani. Tra aprile e maggio, dovrebbe andare in onda la quarta serie, della quale sono stati diffusi dei trailer. E, quando le televisioni del mondo arabo mandano tradizionalmente in onda le loro produzioni più importanti, Al-Aqsa, una tv satellitare di Hamas, trasmetterà la risposta gazawi a Fauda.
La storia raccontata nella serie ricalca una vera, ma è stata cambiata per esigenze di propaganda. Nella serie di 30 episodi i combattenti di Hamas vengono rappresentati come eroi che, nonostante non siano armati a dovere, superano in astuzia un esercito israeliano meglio armato. La trama è incentrata su un raid israeliano fallito, che nella realtà non fallì e accadde a Gaza nel 2018. La trama della serie vede una unità israeliana a Gaza sotto copertura travestita da operatori umanitari palestinesi, che suscita sospetti in una città vicino al confine. Quando la loro copertura salta, avviene un conflitto a fuoco in cui vengono uccisi sette combattenti di Hamas e un comandante israeliano. Nella vita reale, l’unità sotto copertura è stata scoperta dai residenti locali, il bilancio delle vittime è stato sbilenco e Israele ha evacuato con successo 16 agenti sotto copertura. Nella drammatizzazione, Hamas supera brillantemente gli israeliani e ottiene una grande vittoria, con l’uccisione di diversi soldati israeliani e del loro capo.
Hamas ha prodotto sette serie e diversi film incentrati sul conflitto, la maggior parte dei quali è andata in onda sulla sua rete televisiva satellitare Al-Aqsa durante il Ramadan. Nel 2017, ha costruito un intero set cinematografico basato sulla Città Vecchia di Gerusalemme, inclusa una replica della Cupola della Roccia, parte del sito del Monte del Tempio sacro a ebrei e musulmani e un punto centrale nel conflitto israelo-palestinese. Per le riprese, Hamas, che gestisce e controlla tutta la comunicazione a Gaza, ha utilizzato attori locali, anche presi dalla strada, ma non è chiaro quanti soldi siano stati investiti, anche se i responsabili della produzione assicurano che siano arrivati con donazioni. Hamas ha detto di voler distribuire gratuitamente la serie anche in Siria, Libano, Turchia e in altri paesi islamici, per contrastare la propaganda dell’occupazione israeliana. Occhio per occhio di celluloide.
Questo articolo è pubblicato anche sul numero di marzo/aprile di eastwest.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Un incontro durato circa due ore che però sta suscitando numerose polemiche quello tenutosi martedì sera tardi tra il Ministro della Difesa israeliano Benny Gantz e il Presidente dell’autorità nazionale palestinese Mahmoud Abbas (Abu Mazen), a casa del Ministro.
Praticamente unanime il dissenso da parte palestinese. Tutte le fazioni politiche hanno condannato questo vertice, definendolo un “vergognoso incontro”. Svoltosi a casa di Gantz a Rosh Ha’ayin, questo incontro ha sorpreso molti palestinesi, soprattutto perché è avvenuto in un periodo di crescenti tensioni e violenze in Cisgiordania, acuitosi soprattutto nelle ultime settimane. Erano oltre dieci anni che il Presidente palestinese non metteva piede in Israele. Anche numerosi attivisti palestinesi hanno espresso sui social media il loro rifiuto dell’incontro e hanno condannato Abbas come “traditore” e “collaboratore”.
Ussein al-Sheikh, capo dell’Autorità generale per gli affari civili dell’Autorità Palestinese e membro del Comitato centrale di Fatah che ha partecipato all’incontro insieme a Majed Faraj, capo dei servizi segreti generali palestinesi, ha però respinto le critiche. “L’incontro è una sfida ed è l’ultima possibilità prima di trovarci in un vicolo cieco”, ha scritto Sheikh su Twitter. “È un tentativo serio e audace per effettuare un percorso politico basato sulla legittimità internazionale e la fine dell’escalation contro i palestinesi”. Il Ministero degli Esteri dell’AP ha nel contempo però, forse anche nel tentativo di tenere a bada le critiche, fatto sapere in una nota che “condanna con la massima fermezza il rafforzamento degli insediamenti da parte dell’occupazione, il furto di terra palestinese e la continuazione del brutale e ingiusto assedio del nostro popolo nella Striscia di Gaza”.
L’autorità palestinese ha ribadito di ritenere il Governo israeliano “pienamente e direttamente responsabile delle violazioni, dei crimini e dell’ostruzione dell’orizzonte politico per raggiungere soluzioni politiche al conflitto attraverso negoziati diretti tra le parti palestinese e israeliana sotto gli auspici internazionali”. I leader e il portavoce di Hamas sono stati tra i primi ad attaccare Abbas per aver incontrato Gantz. Una vignetta pubblicata da siti web vicini ad Hamas poco dopo l’incontro mostra Abbas che lava i piedi a Gantz, che appare in uniforme militare, in riferimento al suo precedente lavoro come capo dell’esercito israeliano, proprio per sottolineare la ritenuta sudditanza di Abbas rispetto a Israele.
Totalmente di segno opposto le reazioni americane. Il portavoce del Dipartimento di Stato americano, Ned Price, ha twittato mercoledì che gli Stati Uniti sono “molto soddisfatti” dell’incontro. “Speriamo che le misure di rafforzamento della fiducia discusse accelereranno lo slancio per far avanzare ulteriormente la libertà, la sicurezza e la prosperità per palestinesi e israeliani nel 2022”, ha detto Price.
Gantz, nel corso dell’incontro, ha promesso un prestito di 100 milioni di shekel (28 milioni di euro) e uno status legale per 9.500 palestinesi. “Abbiamo discusso dell’attuazione di misure economiche e civili e abbiamo sottolineato l’importanza di approfondire il coordinamento della sicurezza e prevenire il terrore e la violenza per il benessere sia degli israeliani che dei palestinesi”, ha affermato Gantz, al termine del lungo colloquio.
È la seconda volta che Gantz incontra Abu Mazen. Per molti osservatori, l’attivismo del Ministro della Difesa va nella direzione di una candidatura al premierato in Israele, che Gantz ha perso quando ha accettato di condividerla con Netanyahu. L’incontro di Rosh Ha’ayin ha avuto luogo nel mezzo di un’escalation di violenza in Cisgiordania e la preoccupazione per la rinnovata violenza a Gaza.
Mercoledì i palestinesi a Gaza hanno sparato e ferito un israeliano di 33 anni che stava facendo lavori di manutenzione sulla barriera di sicurezza lungo il confine di Gaza. In risposta, l’esercito israeliano ha preso di mira una serie di postazioni di Hamas a Gaza.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
I capi delle chiese cristiane di Gerusalemme sono preoccupati per l’aumento degli episodi di discriminazione nei confronti delle diverse comunità cristiane, da parte di quella ebraica. È quanto hanno scritto, nero su bianco, in una denuncia pubblica, i patriarchi della chiesa latina, di quella ortodossa e armena in testa.
Dal 2012, lamentano i religiosi, ci sono stati innumerevoli episodi di aggressioni fisiche e verbali contro sacerdoti e altro clero, attacchi a chiese cristiane, con luoghi santi regolarmente vandalizzati e profanati e continue intimidazioni nei confronti dei cristiani locali che cercano semplicemente di adorare liberamente e di svolgere la loro vita quotidiana. “Queste tattiche – denunciano i leader religiosi – vengono utilizzate da tali gruppi radicali nel tentativo sistematico di cacciare la comunità cristiana da Gerusalemme e da altre parti della Terra Santa”.
Il Patriarca greco-ortodosso di Gerusalemme, Teofilo III, uno dei leader della campagna, ha affermato che “in nessun momento della storia umana il futuro delle nostre comunità cristiane è stato più traballante”, aggiungendo che “i gruppi radicali sono intenti a sradicarci dalle nostre case, commerci e luoghi rituali. Invece di essere divisi, dobbiamo unirci per una Terra Santa pacifica e tollerante per tutte le religioni”. È stato anche creato un sito internet, da parte delle chiese cristiane, dove raccogliere e denunciare questi episodi di discriminazione.
A far traboccare il vaso, diversi episodi di discriminazione negli ultimi tempi. In particolare, la decisione del Governo israeliano di impedire, per ragioni di contenimento della pandemia, l’ingresso nel Paese di pellegrini cristiani a differenza di quelli ebrei. Inoltre, la comunità armena, il cui quartiere nella città vecchia è quello più a ridosso del quartiere ebraico, ha denunciato diversi episodi di discriminazione da parte degli ebrei, come aggressioni a religiosi. Le telecamere della chiesa della comunità, hanno registrato anche un ebreo che, passando dinanzi al luogo religioso, ha sputato all’indirizzo della porta e mostrato il dito medio alla telecamera. Sputi e aggressioni verbali, lamentano gli armeni, sono costanti durante le processioni.
Il Governo israeliano però ha rispedito le accuse al mittente, con un comunicato diffuso dall’ambasciata presso la Santa Sede e l’ufficio stampa del Governo di Gerusalemme. “Queste accuse infondate di condotta discriminatoria – scrive il Governo israeliano – sono oltraggiose, false e pericolose. Ci aspettiamo che i leader religiosi non si impegnino e non promuovano discorsi infondati di odio e incitamento che servono solo ad aggiungere benzina sul fuoco dell’antisemitismo e possono portare alla violenza e causare danni a persone innocenti”.
Per dimostrare la giustezza della difesa, il Governo ha diffuso una serie di dati dai quali si evince che la presenza cristiana in Terra Santa è aumentata negli ultimi anni tra i locali. Al momento in Israele vivono circa 182.000 cristiani cittadini israeliani, che rappresentano circa l’1,9% della popolazione dello Stato di Israele. Dai dati diffusi, emerge che la popolazione cristiana è cresciuta dell’1,4% nel 2020. Il 76,7% dei cristiani in Israele sono cristiani arabi che costituiscono il 7,0% della popolazione araba totale di Israele. Il Governo israeliano, che si aspetta “che i leader religiosi rinuncino all’incitamento all’odio e li invitiamo a continuare il dialogo regolare e fruttuoso con il governo israeliano”, ha spiegato che in questo periodo nel quale il Paese si è chiuso, sono stati concessi permessi a molti fedeli e religiosi cristiani, come a quelli ebrei, anche se non è possibile permettere l’ingresso ai pellegrinaggi.
La presenza di questi ultimi, tra l’altro, come rilevano i leader cristiani, contribuisce con 3 miliardi di dollari all’economia israeliana. La mancanza dei pellegrini a Natale è un duro colpo per le istituzioni cristiane e per quelle turistiche, sia di Israele che in Cisgiordania. Qui città come Betlemme, che basano la loro economia sui pellegrini e il turismo, stanno attraversando una crisi senza precedenti. I leader religiosi lamentano anche una ebraizzazione forzata della città vecchia con conseguente cacciata dei cristiani e dei musulmani. Sono infatti molte le organizzazioni ebraiche che, anche con triangolazioni e falsi nomi, pure sfruttando prestanome spesso arabi, acquistano abitazioni di arabi nella città vecchia. Il caso più eclatante è stato quello degli alberghi Imperial e Petra, nel pieno quartiere cristiano e punti di riferimento di pellegrini, che sono stati acquistati da organizzazioni ebraiche e conquistati, condannano alcuni leader cristiani, con inganni e aiuti da parte delle autorità israeliane. I nuovi proprietari, stanno ora mandando via gli arabi che abitano la zona e dando ricovero a ortodossi ebrei.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Abdel-Fattah al-Sisi, Presidente egiziano in carica, è certamente una delle figure più discusse e controverse degli ultimi anni nel panorama internazionale. La sua ascesa al potere, voluta dal popolo in maniera quasi plebiscitaria per sfuggire a un Governo, quello di Morsi, durato peraltro solo un anno, che in quel momento non sembrava dare le necessarie garanzie per le riforme e la rinascita del Paese, si è invece trasformata in quella che per molti non è altro che una dittatura.
L’elezione del 2018, definita da alcuni analisti “al-Sisi contro al-Sisi” per la totale assenza di concorrenti (salvo l’unico candidato rivale, l’uomo d’affari Moussa Moustafa, definito all’epoca dai media “la comparsa”, messo in campo all’ultim’ora forse solo per dare una parvenza di democrazia all’elezione) rappresentò per al-Sisi una vittoria schiacciante (ebbe il 97,8% dei consensi). Una importante conferma di un percorso che era iniziato anni prima, con la prima elezione a Presidente avvenuta nel 2014 con il 96,91% dei voti favorevoli.
Al-Sisi arrivava dalle retrovie, anche se da retrovie importanti e di potere, quelle militari, quelle che di fatto, oggi, contano in Egitto. Del resto la sua è una formazione militare. Laureato nel 1977 all’Accademia Militare egiziana, dopo aver ricoperto numerose cariche, per lo più sempre in ambito militare, tra cui quella di capo delle informazioni e della sicurezza presso il segretariato generale del Ministero della Difesa, di Addetto militare in Arabia Saudita, Capo di stato maggiore, Comandante della zona militare settentrionale dell’Egitto nel 2008, nel 2011 diventa Capo dell’intelligence militare, e anche uno dei membri più giovani del Consiglio Supremo delle forze armate.
È il periodo delle cosiddette Primavere arabe. In Egitto c’è molto fermento e voglia di cambiamento. Storicamente è un momento decisivo, il Governo ormai trentennale del Presidente Hosni Mubarak è al suo epilogo. Nel Paese tira aria di cambiamento. L’esercito gestisce la transizione e nel 2012 si svolgono le elezioni. A vincere è il candidato dei Fratelli Musulmani, Mohamed Morsi. Al-Sisi è già però prepotentemente sulla scena e viene da lui nominato capo di Stato Maggiore delle Forze Armate. Ma il potere di Morsi dura poco. Complici alcune scelte impopolari, tra cui in particolare l’emanazione di alcuni decreti che gli avrebbero attribuito sempre più ampi poteri soprattutto in materia giudiziaria, addirittura per fare una nuova Costituzione, dopo solo un anno, il popolo si scaglia contro Morsi.
Al-Sisi coglie l’occasione e gli lancia un ultimatum di 48 ore al termine delle quali, non avendo ricevuto le risposte richieste, Morsi viene arrestato e così pure numerosi esponenti dei Fratelli Musulmani. Le accuse sono di incitamento alla violenza e disturbo della sicurezza e della pace del popolo. Per la Fratellanza Musulmana è la fine. Prendendo a pretesto alcuni attentati nel Sinai nel 2013 (in realtà poi rivendicati da Ansar Bayt al-Maqdis, una organizzazione jihadista) l’organizzazione venne dichiarata illegale, e nell’aprile del 2014 vengono condannati a morte circa 1200 membri di quel movimento. Al-Sisi li considera tuttora una minaccia all’integrità nazionale. I Fratelli Musulmani sono tuttavia ancora esistenti e seguiti nel Maghreb, in Tunisia e in alcune aree della Libia.
È comunque dal 2014, anno della sua prima elezione a Presidente, che comincia la prima vera era di al-Sisi. Per l’Egitto è un cambiamento radicale, di sistema. Il trentennale Governo di Mubarak era infatti basato sull’esistenza di un partito guidato per lo più dalla borghesia del paese che aveva relegato il potere militare a un ruolo secondario. A partire dal 2011 questi equilibri si rompono, il partito non esiste più e l’esercito assume il controllo, permeando da quel momento tutti gli aspetti della vita politica, economica e sociale del Paese. Non c’è più un partito che possa fungere da collegamento tra il potere e il popolo. Le sfide che il nuovo Presidente vuole affrontare sono tante: mettere in sicurezza l’area, attuare le riforme economiche promesse.
I primi anni sono quelli caratterizzati dai migliori auspici. Nel 2015 viene pubblicato un piano chiamato “Sustainable Strategy: Vision 2030”, un articolato programma di riforme economiche da realizzarsi per proiettare il Paese verso il mondo globale. Ma non tutto procede come sperato. Il Paese deve fare i conti con difficoltà economiche di non poco conto. Nel 2016 il Fondo monetario internazionale concede all’Egitto un prestito di 12 miliardi di dollari che dovranno a partire da quest’anno (2021) essere restituiti. E così è partito un rigoroso programma di riforma economica che includeva svalutazione della valuta, tagli alle sovvenzioni e aumenti delle tasse per ridurre il deficit di bilancio. Per al-Sisi, “le riforme economiche erano assolutamente necessarie anche se sono dure e hanno causato insoddisfazione tra gli egiziani”.
Secondo recenti stime della Banca mondiale, attualmente, a causa anche del forte rialzo dei prezzi delle materie prima e dell’effetto della svalutazione, il 35% della popolazione egiziana vive sotto la soglia di povertà. Sempre stando ai dati di Banca mondiale, inoltre, con al-Sisi la crescita economica tra il 2015 e il 2019 è stata inferiore alla media degli ultimi anni di presidenza Mubarak.
La crisi mondiale generata dalla pandemia da Covid-19 ha, se possibile, ulteriormente peggiorato la situazione economica e sociale. L’Egitto è un Paese che notoriamente conta moltissimo sul turismo, in pratica azzerato negli ultimi due anni, e questo ha anche innalzato molto il tasso di disoccupazione giovanile, arrivata al 29,6%. Inoltre la popolazione ha cominciato a fare i conti con un potere autoritario e quasi dittatoriale. Il presidente si avvale prevalentemente dell’esercito per imporre il suo volere. Le Forze Armate, su sua indicazione, attuano la repressione di chiunque si opponga al regime.
In questi anni e in numerose occasioni, organizzazioni quali Amnesty International hanno denunciato violazioni, maltrattamenti, torture, sparizioni forzate, detenzioni e uso della forza. Secondo le stime di Amnesty International nel solo 2020 sono state 710 le sparizioni forzate. Tanti i casi. Il 25 gennaio 2016 il ricercatore italiano Giulio Regeni scompare misteriosamente. Dieci giorni dopo viene trovato morto con evidenti segni di tortura. E poi c’è Patrick George Zaki, studente dell’Università di Bologna, in carcere da oltre un anno con l’accusa di propaganda sovversiva. Nel 2020, Freedom House ha classificato l’Egitto come Paese “non libero”; nel suo rapporto annuale “Freedom in the World”, in particolare per quanto riguarda i diritti politici l’Egitto ha avuto 7 punti su 40 e per quanto riguarda le libertà civili 14 punti su 60.
Per dare un crisma di legalità alle repressioni, fatte a suo dire in nome della sicurezza nazionale, il Presidente ha fatto approvare una legge nel 2018 che permette alle autorità di bloccare siti web in caso di pubblicazione di un qualsiasi contenuto che costituisca un crimine per la legge, che minacci la sicurezza nazionale o metta in pericolo la sicurezza del Paese o dell’economia nazionale, anche senza un ordine giudiziale. È stata poi anche modificata la legge sul terrorismo, in modo da poter accusare di terrorismo organizzazioni o individui anche solo sulla base di segnalazioni della polizia e anche nei confronti di chi non abbia alcun precedente di questo tipo.
E così, giornalisti, oppositori, persino membri di Ong, sono finiti nella lista dei terroristi. Sono stati ampliati i poteri in materia di censura, sequestro dei beni e sfratti. Una situazione pesante, più e più volte denunciata soprattutto dalle organizzazioni che operano per la tutela dei diritti umani, ma di cui al-Sisi non sembra curarsi più di tanto, affermando anzi in più occasioni di voler proseguire per la sua strada e di non voler accettare intromissioni, su questo come su altri temi.
La popolarità di al-Sisi dunque, nell’ultimo periodo sembra diminuita, non tanto e non solo a livello internazionale ma anche all’interno del Paese stesso. Nel settembre 2019, pochi mesi prima della crisi dovuta al Covid, centinaia di persone sono scese nelle piazze per chiederne le dimissioni. Gli oppositori, tra l’altro, gli contestano appropriazione dei fondi pubblici, corruzione, sprechi vari. Le proteste sono state duramente domate con arresti di giornalisti, attivisti e oppositori del regime. E nel frattempo il Presidente non ha perso tempo, facendo approvare degli emendamenti in base ai quali il mandato presidenziale è stato esteso da quattro a sei anni ed è stato tolto il limite dei due mandati. In tal modo al-Sisi resterà in carica per ora fino al 2024 (a meno di sorprese) anziché fino al 2022 e poi nel 2024 potrebbe essere rieletto per un terzo mandato di ulteriori sei anni rimanendo al potere almeno fino al 2030.
Cosa realmente accadrà negli anni a venire al momento è difficile a dirsi. Certo è che il Presidente sta facendo veramente di tutto per blindare la sua futura permanenza al potere, anche escludendo suoi potenziali concorrenti. Non a caso, tra le leggi da lui fortemente volute, quella approvata lo scorso anno, in piena pandemia, che obbliga i militari a chiedere l’autorizzazione del Consiglio delle Forze Armate, presieduto dallo stesso al-Sisi, per poter entrare in politica. In precedenza invece tale autorizzazione non era necessaria, bastava che il candidato abbandonasse la carriera militare. In tal mondo il Presidente si è anche assicurato il controllo sulle eventuali candidature per le prossime elezioni.
Non a caso nel 2018 uno dei suoi più temibili concorrenti, Sami Anan, era proprio un militare. Anche in quel caso al-Sisi riuscì a neutralizzarlo. Incarcerato subito dopo l’annuncio della sua candidatura per presunti brogli nella raccolta delle firme, Anan fu poi liberato successivamente, nel 2019, a elezioni terminate.
Sul fronte internazionale, nonostante tutto, al-Sisi conta ancora sull’appoggio, più o meno esplicito, della comunità internazionale. Persino Joe Biden, che pure alla vigilia della sua elezione aveva promesso che con lui sarebbero finiti i tempi della “carta bianca al dittatore preferito” di Donald Trump, alla fine ha ceduto e gli Usa hanno confermato le forniture militari all’Egitto per un valore di 197 miliardi di dollari. Si parla addirittura di un possibile riavvicinamento con la Turchia di Erdogan, nonostante questi si sia sempre rifiutato di riconoscere al-Sisi appoggiando invece i Fratelli Musulmani. Un loro riavvicinamento, dicono gli analisti, avrebbe significative ripercussioni sul mercato del gas e forse anche sul futuro del conflitto in Libia.
L’amministrazione di al-Sisi ha inoltre chiaramente estremo interesse a mantenere saldi i rapporti con altre due potenze, la Russia e la Cina. Con la Russia, al-Sisi mira a rafforzare le relazioni, principalmente nel settore militare, anche nell’ottica di ridurre la sua eccessiva dipendenza dagli Stati Uniti. Dal canto suo la Russia vede nell’amicizia con l’Egitto la possibilità di avere una apertura verso i mercati mediorientali e africani. Le relazioni con la Cina invece erano già importanti prima di al-Sisi. Anche il Presidente Morsi, in carica dal 2012 al 2013 con il sostegno dei Fratelli Musulmani, aveva espresso la sua stima per la Cina facendone il primo Paese che aveva visitato al di fuori del Medio Oriente.
Da quando poi la Cina ha concordato una partnership strategica globale con l’Egitto nel dicembre 2014, gli investimenti cinesi in Egitto hanno ripreso vigore, con un aumento degli investimenti diretti del 4,6% su base annua nella prima metà del 2019. Il commercio dell’Egitto con la Cina rappresenta il 2% delle esportazioni totali del Paese, ma il 15% delle sue importazioni totali, rendendo la Cina il suo maggiore importatore.
Il Presidente al-Sisi ha visitato la Cina sei volte in totale fino a giugno 2021.
Questo articolo è pubblicato anche sul numero di novembre/dicembre di eastwest.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Non accenna a placarsi l’ondata di violenze nelle città arabo-israeliane, che nelle ultime settimane mostra segni di aumento. Nel solo mese di settembre sono state 16 le persone uccise in episodi di violenza legate a faide e criminalità, 96 dall’inizio dell’anno. Decine di persone si sono radunate sabato sera davanti alla casa del Ministro della Pubblica Sicurezza, Omer Bar-Lev, per protestare contro l’aumento degli omicidi e le continue violenze nelle comunità arabe israeliane.
Tra gli episodi di violenza che si sono verificati negli ultimi mesi vi è stato anche l’omicidio di un consigliere anziano del Ministro della Giustizia Gideon Sa’ar e una sparatoria nella casa di un alto comandante della polizia araba. “Se si va avanti così si potrebbe arrivare a una guerra civile, è questo che vuole il Governo?”, ha dichiarato il dott. Thabet Abu Ras, co-direttore delle iniziative del Fondo Abraham, un’organizzazione che mira a creare un cambiamento sociale nel campo delle relazioni arabo-ebraiche. “La polizia – ha spiegato il dottore in una dichiarazione – è l’unico organismo che potrebbe combattere i crimini violenti nelle comunità arabe, a condizione che abbia il sostegno dell’establishment politico”.
Abu Ras ha poi aggiunto che è nell’interesse dello Stato combattere contro i criminali e i teppisti, perché siamo tutti colpiti. “Il problema principale sono le armi; – ha aggiunto – tutti stanno comprando armi in questi giorni. È diventato facile come acquistare un panino da McDonald’s”. Numerosi attivisti arabi hanno attribuito l’aumento degli omicidi al gran numero di armi illegali che sono arrivate nelle mani di individui e delle bande criminali. Secondo varie stime, ci sono decine di migliaia di fucili, pistole e bombe a mano nelle città, paesi e villaggi arabi in tutto il Paese. Sebbene la polizia ne abbia, nelle ultime settimane, sequestrato decine e arrestato diversi sospetti criminali, il numero degli omicidi risolti nel settore arabo rimane molto basso, principalmente a causa della mancanza di cooperazione verso gli agenti da parte dei componenti di quelle comunità.
Per molti arabi, come riportato ai giornali locali, nonostante la polizia dica di star facendo un grande sforzo per combattere i criminali, è evidente che non stiano facendo abbastanza, lamentando che gli agenti abbiano ammesso di aver perso il controllo della situazione. Effettivamente alti funzionari di polizia israeliana hanno ammesso che è diventato sempre più difficile farsi carico delle sparatorie e degli omicidi nella comunità araba, che sono aumentati nelle ultime settimane. “Abbiamo perso il controllo della strada nelle comunità arabe. Non esiste un piano ordinato per affrontare il crimine”, ha affermato un alto ufficiale di polizia, secondo quanto riportato da diversi giornali locali.
In risposta alle affermazioni secondo cui i cittadini arabi sarebbero riluttanti ad aiutare le autorità nella lotta ai crimini violenti, alcuni hanno affermato che questo dipende dalla paura di ritorsioni. “Diverse persone sono state accusate di aver aiutato la polizia – ha detto al Jerusalem Post Abdel Hakim Masarweh, residente a Kafr Kara – alcuni sono stati uccisi, altri sono stati costretti a nascondersi, insieme alle loro famiglie. La sensazione qui è che le autorità non ti proteggano abbastanza. “La gente ha perso fiducia nella polizia perché vede che non è seriamente intenzionata a combattere il crimine tra gli arabi – ha detto alla stampa Amal Mahajneh di Umm el-Fahm – molte persone hanno smesso di chiamare la polizia quando sentono degli spari vicino a casa loro. Viviamo in una giungla dove chiunque porti una pistola può fare quello che vuole. Dove sono i leader arabi alla Knesset? Cosa stanno facendo per aiutare la loro gente? Niente.”
Per molti arabi, la rapida cattura dei sei prigionieri palestinesi fuggiti dalla prigione di Gilboa all’inizio di questo mese ha dimostrato che le autorità, incluso lo Shin Bet, sono in grado di svolgere il proprio lavoro, a condizione che abbiano la volontà e le risorse per farlo.
“Le autorità hanno impiegato meno di due settimane per arrestare i sei prigionieri; – ha osservato Samir Ja’far di Haifa – se le autorità sono in grado di schierare migliaia di poliziotti e agenti di sicurezza e spendere milioni di shekel per catturare sei prigionieri, perché non possono fare lo stesso per fermare l’ondata di criminalità nel settore arabo? È forse perché alle autorità non interessa quando gli arabi uccidono gli arabi, ma sono pronte a fare uno sforzo enorme quando si tratta di questioni relative alla sicurezza?”. Mashhour Fawaz, importante esponente religioso islamico, ha affermato che la polizia ha mancato al proprio dovere di proteggere i cittadini arabi.
Molti dei recenti omicidi hanno coinvolto criminali noti alla polizia. Ma non solo. In un ospedale di Afula è ricoverato in gravi condizioni un bambino di 6 anni che è stato gravemente ferito pochi giorni fa mentre viaggiava in macchina a Umm al-Fahm. Anche gli altri occupanti dell’auto sono stati colpiti da colpi di arma da fuoco, ritenuti collegati a una lite tra due famiglie di quella città. La scorsa settimana un giovane è stato ucciso durante una festa di matrimonio a Taibeh. La sparatoria ha ferito altre cinque persone.
La polizia ha difficoltà a risolvere gli omicidi. Finora, solo il 21% di tutti gli omicidi avvenuti nelle comunità arabe quest’anno è stato risolto, rispetto a oltre il 50% di quelli avvenuti nelle comunità ebraiche. La maggior parte degli omicidi avviene nel distretto centrale, che comprende Taibeh, Tira, Kalansua, Lod e Ramle, nonché nel distretto costiero, che comprende l’area di Wadi Ara, Umm al-Fahm e Haifa.
La polizia ha recentemente cercato di agire contro le organizzazioni criminali arabe utilizzando metodi diversi, finora senza troppo successo. Pochi giorni fa, la polizia ha condotto un ampio raid a Deir al-Assad, Shfaram e Yirka, colpendo i residenti coinvolti in estorsioni e altri reati. Decine di migliaia di shekel sono stati confiscati, insieme alle armi, e sono stati arrestati 15 sospetti.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Un anno fa, il 15 settembre del 2020, nel giardino della Casa Bianca, dinanzi al Presidente americano Donald Trump, il Ministro degli Esteri del Bahrein Abdullatif Al Zayani e quello degli Emirati Arabi Uniti Abdullah bin Zayed, firmavano, con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, l’accordo di normalizzazione dei loro Paesi poi conosciuto come Accordi di Abramo, dal nome del patriarca di entrambe le religioni.
Un evento storico, che ha comunque cambiato la politica estera e gli equilibri del Medio Oriente. E che è stato seguito poi da accordi di normalizzazione che Israele ha firmato con il Marocco poi e con il Sudan prima, anche se con questo Paese l’accordo non è ancora definitivo. Un evento centrale nella vita dell’area, che ha spostato non poco gli interessi strategici, politici ed economici di una zona da sempre martoriata da conflitti. Israele, che nel mondo arabo prima aveva rapporti solo con i vicini Giordania ed Egitto – rapporti ancora non proprio idilliaci e comunque ottenuti a seguito di feroci conflitti – per la prima volta stringeva patti con Paesi arabi importanti, soprattutto dal punto di vista economico oltre che strategico, in un’area di notevole interesse.
Non foss’altro che il Golfo racchiude ricchi giacimenti di idrocarburi e le mire anche del nemico storico e giurato di Israele, quell’Iran verso cui, comunque oggi, grazie a una dichiarazione del Ministero della Difesa Benny Gantz, si potrebbe fare un passo con un nuovo accordo sul nucleare. Dichiarazioni di Gantz che però non trovano il sostegno del suo Governo, nel quale è considerato una colomba verso i conflitti di Israele (nonostante il suo cruento passato militare).
È stato lui a incontrare dopo anni il Presidente dell’Autorità palestinese, anche se il suo premier, Naftali Bennett, ancora qualche giorno fa assicurava che non ci sarà mai alcuno Stato palestinese. Proprio gli abitanti della Cisgiordania sono quelli posti ai margini degli Accordi di Abramo. Sia perché non interpellati, sia perché la loro stessa amministrazione li ha messi ai margini. Tanto che hanno definito gli accordi “una pugnalata nella schiena”, anche se ad oggi hanno portato solo benefici. Scontati quelli di natura strategica: Israele si avvicina anche geograficamente, sempre di più ad aree che gli erano interdette e viene riconosciuto come entità. Ma soprattutto le ricadute di carattere economico sono notevoli.
Secondo i dati pubblicati dal Central Bureau of Statistics israeliano, il commercio di merci tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti ha raggiunto circa 610 milioni di dollari da gennaio a luglio 2021. Israele ha esportato 210 milioni di dollari, e importato 400 milioni di dollari, con diamanti che rappresentano circa la metà di tutto il commercio. Questi numeri non includono le esportazioni di servizi hi-tech e militari, che costituiscono una quota significativa del commercio bilaterale. Secondo le proiezioni, quest’anno il commercio tra i due Paesi dovrebbe crescere a un miliardo di dollari e raggiungerne tre entro il prossimo triennio. Notevoli quindi le ricadute in tutti i settori, nonostante il periodo di pandemia e tutti i blocchi del caso.
Anche dal punto di vista militare, i due Paesi hanno stretto molti accordi, con gli Emirati che hanno acquistato diverse tecnologie israeliane. Con la perdita del premierato di Netanyahu e la caduta a Washington di Trump, il cui genero, Jarod Kushner, è stato tra i massimi fautori degli accordi, il progetto di espansione delle normalizzazioni è rallentato. L’amministrazione Biden pare non avere la stessa fretta di Trump e per ora non sta spingendo, cosa che avrebbe potuto portare a un accordo con il Sudan, ancora nella lista terroristica Usa. Ma è indubbio che Israele, come la regione tutta, abbia beneficiato della normalizzazione. Qualcuno, come il Marocco, anche per questi nuovi accordi, ha dovuto fare i conti con l’ostracismo di altri Paesi, come l’Algeria. Altri, come l’Arabia Saudita, sono alla finestra. Pare che il principe ereditario Mohammed bin Salman sia aperto a un accordo, cosa impensabile per suo padre che comunque è legato a una idea di panarabismo diversa, che ha sposato in toto la causa palestinese e l’anti-sionismo militante.
Dopotutto il regno dei Saud non vuole lasciare al Qatar posizioni di egemonia nel mondo arabo, anche se una normalizzazione con Israele potrebbe per loro significare mettere le mani, a spese della Giordania e degli interessi turchi, sul terzo luogo più sacro dell’Islam, la Spianata delle Moschee, dopo che controllano già i primi due. Per ora, politica e religione però sono in secondo piano e gli accordi che portano il nome dell’iracheno, partito da Ur Dei Caldei e stanziatosi nel regno di Cannaan e considerato il padre dei popoli ebraico e islamico, hanno rivelato per ora il loro carattere economico. Se anche questo può spingere a una pace duratura e a un benessere diffuso nell’area, allora anche il padre di Isacco e di Ismaele potrebbe essere contento che hanno dato il suo nome a questa nuova normalizzazione.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Dopo undici anni dall’ultimo incontro de visu di alti esponenti dei Governi israeliano e palestinese, alla fine del mese scorso il Ministro israeliano della Difesa, Benny Gantz, ha incontrato a Ramallah il Presidente dell’Autorità nazionale palestinese, Mahmoud Abbas (Abu Mazen).
I due hanno discusso di cooperazione economica e di sicurezza, ma da qui a dire che ci si è incamminati verso la soluzione del conflitto, ce ne vuole. L’ultimo incontro risaliva al 2010, sette anni dopo c’è stata l’ultima telefonata tra Netanyahu, allora premier, e Abbas. Gantz, invece, nei giorni scorsi, aveva telefonato al Presidente palestinese. Gli incontri di Ramallah, che hanno visto un colloquio privato tra Gantz e Abbas e uno insieme a funzionari governativi dei due Paesi, si sono svolti dopo il ritorno di Naftali Bennett, il Primo Ministro israeliano, da Washington, dove ha incontrato il Presidente Joe Biden e esponenti dell’amministrazione americana.
Al premier israeliano Biden ha ribadito l’interesse alla pacificazione nell’area, che significa anche aiuti e cooperazione economica con l’Autorità palestinese. Ma, dietro alle frasi di circostanza, Bennett ha le idee chiare sulla questione palestinese e non intende recedere. Non ci sarà alcuno Stato palestinese mentre governa Naftali Bennett. È quanto ha detto in una intervista televisiva il Ministro degli Esteri e premier a rotazione Yair Lapid. A Channel 11, il capo della diplomazia e futuro premier da agosto del 2023 ha detto che la formazione dello Stato palestinese, nell’ambito della soluzione del conflitto a due Stati, non è nell’agenda di questo Governo. Rintuzzato dal giornalista, alla domanda se questo potrebbe accadere sotto il suo premierato, Lapid ha detto “potrebbe”.
L’intervista è stata diffusa venerdì alla vigilia del 28mo anniversario della firma degli Accordo di Oslo che diedero il via al riconosciuto controllo territoriale dell’Autorità palestinese. Lapid ci ha tenuto a dire che la soluzione a due Stati, diversamente da quello che pensa il premier attuale, è per lui la soluzione migliore per la risoluzione del conflitto israelo-palestinese. L’intenzione del Ministro degli Esteri sarebbe quella di “dividermi dai palestinesi. Non ho alcun interesse a governare su più di 2 milioni di palestinesi a Gaza o 2,9 milioni in Giudea e Samaria”, le due regioni che compongono la Cisgiordania. Yair Lapid ha spiegato che questo Governo è nato soprattutto per risolvere questioni interne, senza alcun accordo sul fronte palestinese.
L’intervista è stata data in vista della visita che il premier Bennet terrà questa settimana a Washington, dove incontrerà il Presidente Biden e sul tavolo della quale ci sarà anche la questione palestinese. L’amministrazione americana non ha fatto azioni per il rinnovo dei colloqui fra le parti, che sono fermi al 2014, anche se ha chiesto a Israele di non fare passi che possano essere di ostacolo alla rinascita dei colloqui. Ma i contatti tra le parti non si sono fermati. Anche se Bennett non è a favore della nascita dello Stato palestinese, così come molti suoi alleati di Governo, nella stessa coalizione ci sono esponenti, come Lapid e Gantz, che invece sono favorevoli alla creazione dello Stato palestinese. Anche per questo Gantz ha parlato già al telefono con il Presidente dell’Autorità palestinese Abu Mazen, così come ha fatto il Presidente israeliano Isaac Herzog dopo essere stato eletto.
Nei giorni scorsi, sono riprese le manifestazioni di protesta contro Israele da parte dei palestinesi. Due le micce che hanno fatto esplodere i contrasti negli ultimi giorni. Da Gaza, nonostante Israele abbia allentato le sanzioni aumentando l’aerea di pesca e i permessi di lavoro, tra gli altri, hanno ripreso manifestazioni al confine, lanci di razzi e lanci di palloni incendiari. Forse anche come risposta agli incontri di Ramallah che, secondo alcuni osservatori locali tenderebbero a isolare ancora di più l’enclave. Dall’altra, le ritorsioni israeliane nei confronti dei prigionieri palestinese e di molte famiglie di carcerati, dopo l’evasione di sei di loro, cinque esponenti della jihad Islamica palestinese e di Zakaria ZUbeide, l’ex comandante delle Brigate dei Martiri di Al Aqsa da Jenin, hanno portato per strada molte persone in Cisgiordania.
Ma la Palestina ha necessità di pacificazione, anche perché la sua situazione economica è disastrosa. Il Covid ha solo peggiorato una situazione già pessima, dovuta da un lato alla riduzione delle contribuzioni dei Paesi stranieri, dall’altro al minore gettito di tasse che Israele versa a Ramallah, defalcato dei soldi che il Governo palestinese destina ai familiari dei carcerati. Il tutto, condito anche da una grande corruzione nell’establishment palestinese, che drena molte risorse. L’economia della Cisgiordania è stata colpita dal coronavirus, riducendosi dell’11,5% nel corso del 2020. Allo stesso tempo, Ramallah ha visto un forte calo degli aiuti arabi e internazionali, che in precedenza rappresentavano una fetta significativa del suo budget. Nel 2019, l’Autorità palestinese ha ricevuto circa 300 milioni di dollari di sostegno al bilancio entro la fine di giugno. Nel 2021 hanno ottenuto solo 30,2 milioni di dollari, poco più di un decimo dell’importo precedente.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Pensava di esserne uscito e invece anche Israele combatte ancora, in prima linea, con la pandemia da Covid-19. E questo nonostante larga parte della sua popolazione, più della metà, sia stata vaccinata con due dosi di vaccino Pfizer. E, in effetti, dopo una campagna vaccinale portata avanti a ritmo serrato, pareva che la vita nel Paese fosse tornata alla normalità. In tarda primavera i casi erano ridotti davvero all’osso, raggiungendo lo zero a maggio e l’obbligo di mascherine all’aperto era stato rimosso.
Ma invece il Covid è ritornato in una quarta e violenta ondata, scaturita dalla variante Delta. Tanto che Israele ora è addirittura considerato Paese a rischio. I numeri degli ultimi giorni sono effettivamente preoccupanti. Il Ministero della Salute israeliano ha fatto sapere che per ben quattro giorni consecutivi è stato superato il tetto dei 10.000 nuovi contagi al giorno. Mercoledì sono stati 11.246 su 145.000 test effettuati, il 7,9%.
La situazione è nuovamente peggiorata da metà luglio, e ci si chiede il perché. In effetti, un esame della situazione reale del Paese fornisce la spiegazione. Israele è un Paese che ha una grande fetta della popolazione di giovani e giovanissimi e, secondo i dati del Ministero, poco più della metà dei nuovi contagi appartengono, infatti, proprio a loro, persone sotto i 18 anni non vaccinate, aggredite soprattutto dalla variante Delta. Gli esperti rilevano inoltre come moltissime persone in Israele si siano vaccinate ormai oltre 6-8 mesi fa per cui il livello di protezione del vaccino comincia a diminuire.
Attualmente oltre il 70% dei maggiori di 12 anni è vaccinato con due dosi, ma poiché i minori di 12 anni rappresentano il 25% della popolazione, il totale dei vaccinati scende al 60%. E proprio i bambini sono gli untori del momento. Nessun vaccino è sicuro al 100% e per di più dopo alcuni mesi il livello di protezione chiaramente diminuisce. Ecco perché nel Paese, da circa un mese, è iniziata la campagna d’inoculazione della terza dose a tutti quelli che hanno avuto la somministrazione della seconda dose da più di cinque mesi. In circa un mese sono già quasi due milioni e mezzo le persone che hanno ricevuto la terza dose del vaccino e si spera che questo possa presto cominciare a dare i suoi frutti, innalzando nuovamente il livello di protezione della popolazione.
Resta il problema dei giovani non vaccinati. Mentre il Governo continua a invitare i giovani tra i 12 e i 18 che non lo avessero ancora fatto di vaccinarsi al più presto, il Primo Ministro Naftali Bennett ha dichiarato che i vaccini funzionano e che anzi, se tutto va bene, saranno approvati entro due mesi anche per i bambini tra i 6 e i 12 anni. Il contagio è esploso con la riapertura delle scuole, avvenuta ad agosto per le ortodosse e le internazionali e il primo settembre per le israeliane. Tra l’altro, le comunità più unite, ortodossa e araba, sono quelle che hanno minori percentuali di vaccinati. “Il vaccino non è velenoso – ha detto Bennett rivolgendosi ai ragazzi e alle famiglie – il veleno è il virus. Il vaccino rafforza solo il corpo e crea gli anticorpi per combattere il virus”.
Il Ministero della Salute ha inoltre sottolineato come la maggior parte dei casi gravi siano persone non vaccinate e quindi come il vaccino sia comunque efficace. Quelli che pur vaccinati hanno contratto il virus lo hanno fatto in forma meno grave. Le preoccupazioni ora sono però le imminenti feste ebraiche che inizieranno la settimana prossima con la celebrazione di Rosh Hashanah, il Capodanno ebraico, quando le persone si riuniscono nelle case con tutta la famiglia e vanno in sinagoga a pregare in massa. Le autorità stanno invitando la popolazione ad adottare comunque comportamenti prudenti, a pregare se possibile all’aperto e a monitorare soprattutto i bambini piccoli non vaccinati, eventualmente sottoponendoli a un test per il Covid prima di consentire loro di stare a contatto con le persone anziane della famiglia durante le feste.
Intanto ieri si è nuovamente riunito il comitato consultivo per i vaccini per discutere e decidere se vaccinare le persone che sono guarite dal virus con un’ulteriore dose di richiamo (finora chi è guarito dal Covid è stato poi vaccinato con una sola dose). Una decisione pare non sia ancora stata presa. Intanto un leggero ottimismo serpeggia. Anche se il numero dei nuovi casi rimane ancora alto e preoccupante, il numero dei casi gravi continua a diminuire. Mercoledì’ erano 675 contro i 710 di martedì, i 750 di lunedì e i 753 di domenica scorsa.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Dopo dodici anni ininterrotti di premierato, quindici in totale, Israele ha salutato Benjamin Netanyahu. Bibi, come è conosciuto nel Paese, ha perso il suo seggio più alto nel Governo, mettendo fine o, almeno, sospendendo, un’era. È dovuta scendere in campo “l’artiglieria pesante”, una coalizione che più ampia non poteva, che ha tenuto fuori solo i partiti religiosi ortodossi di destra ma che ha messo comunque al potere, per la prima volta in Israele, un religioso, sempre di destra. E con Bennett è un insieme di prime volte.
Per la prima volta nella storia di Israele c’è un Governo che è sostenuto apertamente da un partito arabo e da una coalizione di partiti arabi dall’esterno, considerando inoltre che senza l’accordo con questi, il Governo e la coalizione che lo regge non esisterebbero, non ci sarebbe stato alcun accordo per la sua creazione. Per la prima volta nella storia di Israele, c’è un premier che governa pur avendo in Parlamento pochissimi seggi, meno del 10% della coalizione che lo esprime.
Ma, al di là di queste novità ci sono due certezze: Netanyahu non sarà Primo Ministro e non ci saranno partiti ortodossi al potere, cosa che dura da 1997 con due piccole pause, e che li ha portati ad avere il monopolio degli affari religiosi. Sarà molto difficile governare con una maggioranza risicata in Parlamento.
Una formazione tenuta insieme dal sentimento avverso all’ex premier, e che va dai partiti di sinistra come Labor e Meretz e quelli di destra (alcuni più a destra del Likud di Netanyahu) Yamina, Yisrael Beitenu, New Hope, passando per i centristi spostati a destra Blu e Bianco e Yesh Atid, con la presenza dentro al Governo anche di Ra’am (Lista Araba Unita), il partito arabo derivazione del Movimento Islamico del sud che, nella sua parte settentrionale, aveva forti legami con i Fratelli Musulmani. A appoggiare esternamente il Governo, gli altri tre partiti arabi della Joint List che insieme a Ra’am nelle elezioni precedenti alle ultime si piazzarono terzi e che fu proprio Netanyahu, avvicinandosi a questa comunità, a contribuire a far scindere.
La coalizione l’hanno votata in 60 e tra questi non c’era uno dei 7 di Bennett, così che il nuovo premier guida il paese pur guidando uno dei partiti più piccoli, ma necessario ad ottenere il numero utile di voti. Ad agosto del 2023 Bennett lascerà lo scranno all’ex giornalista Yair Lapid, che fino ad allora sarà ministro degli Esteri, mentre Bennett prenderà poi gli Interni. Gantz resta alla Difesa, Sa’ar alla Giustizia, entrambi anche con il ruolo di vice Primo Ministro, mentre Avigdor Liberman, leader dei russofoni, è alle Finanze. Ai partiti di sinistra Trasporti, Salute e Ambiente, tra gli altri portafogli. Ra’am ha un sottosegretario alla presidenza del Consiglio, diventando così il primo partito della minoranza araba a entrare in un Governo.
Bisognerà ora vedere come reggerà la coalizione alle sfide che gli vengono poste. Innanzitutto si dovrà votare il budget, che manca da troppi giorni e che contiene tutte le promesse di investimenti fatte agli arabi per ottenere il sostegno al governo, investimenti localizzati soprattutto in Galilea e nel Neghev, che hanno creato non pochi mal di pancia in molti a destra. Bennett e Sa’ar (leader del partito di destra New Hope, fuoriuscito dal Likud e, come Bennett del quale è alleato, ex delfino di Netanyahu, ndr) hanno bisogno di tempo per costruire la loro leadership e prendere consensi e parlamentari a Likud.
Netanyahu sarà un’ombra, un fantasma contro la coesione di questo Governo, come è stato già visto in passato, e sarà leader dell’opposizione e capo del Likud esercitando questa funzione fino a quando il suo problema giudiziario non sarà risolto. Fino ad allora aspirerà sempre al premierato. Dopotutto ha molte carte per mettere in difficoltà il Governo. Da astuto politico qual è, caratteristica che manca a molti membri del governo attuale, presenterà progetti di legge che non potranno, per storia e ideali comuni, essere approvati dai partiti di destra presenti in coalizione, soprattutto quelli di Bennett e Sa’ar, con la prospettiva di creare non poche fratture ed eventualmente attirare a sé parlamentari scontenti di questa larga coalizione.
Dopotutto, e questo è indiscutibile, Netanyahu lascia una pesante eredità fatta di un periodo, se si escludono gli ultimi mesi, di pace e serenità, di sviluppo economico, del successo legato alla gestione della pandemia che ha fatto di Israele un modello nel mondo intero. Ma anche di accordi inimmaginabili a livello internazionale, come quelli con i Paesi arabi. Certo, si sono acuite delle distanze, soprattutto nella popolazione, tra arabi ed ebrei, favorendo il diffondersi di idee di gruppi fondamentalisti, in particolare nei giovani arabi esasperati per un paese che, anche a causa di leggi scellerate, è sempre più ebraicocentrico.
Resta appesa la questione dei palestinesi, ma anche (o forse soprattutto,) per le mosse o, meglio, per le non azioni del governo di Ramallah, che ha dato alibi a Gerusalemme e viceversa. Con Bennett da questo fronte, non dovrebbe cambiare nulla, visto che il religioso premier è sempre stato per l’annessione dei territori, per lui non esiste una questione palestinese. E ovviamente dovrà vedersela con quella parte del suo governo, la sinistra e gli arabi, che la pensa diversamente.
Le sfide per il Governo sono molte. Si è cominciato già in questi giorni, con una microcrisi di Governo dovuta a una visione diversa tra i partiti arabi e di sinistra rispetto a quelli di destra sulla questione dei matrimoni misti tra arabi israeliani e palestinesi. La coalizione deve normalizzare i rapporti che sono stati divisivi negli ultimi anni, anche con gli Usa dopo la elezione di Joe Biden alla Casa Bianca. Netanyahu aveva un legame speciale con Trump, ma Biden ci ha messo oltre un mese dalla sua elezione per telefonargli, invece dopo due ore dalla sua nomina a premier ha chiamato Bennett. Qualche frizione è avvenuta sull’Iran, con il quale l’amministrazione Biden vorrebbe normalizzare i rapporti e invece Israele non ne vuole sentire parlare. Bennett e Lapid sono determinati a stringere sempre i rapporti con gli Usa. Ma Washington vuole raggiungere un accordo con l’Iran e questo sarà un punto di frizione con Israele, e chiarirà la direzione. Al suo primo gabinetto, Bennett ha detto chiaramente che non considera l’opzione dialogo con l’Iran, lo ha definito “un regime di carnefici”.
L’Iran è un tabù per tutti in Israele, quello che è successo a maggio a Gaza è costato la vita a centinaia di persone e i successivi scontri, hanno sottolineato questa distanza. Gerusalemme non ha intenzione di ritornare al dialogo con il regime che lo vuole annientare, non vuole lasciare nessuna porta aperta, neanche uno spiraglio. E anche i continui raid in Siria lo dimostrano.
Jack Sullivan, consigliere americano per la sicurezza, commentando le parole di Bennett ha sottolineato che il suo Governo intende fare di tutto per raggiungere una soluzione diplomatica con l’Iran. Soluzione diplomatica sui negoziati che Gerusalemme non prende in considerazione, soprattutto ora che nel palazzo presidenziale iraniano siede quello che Bennett ha definito “il boia di Teheran, l’uomo famigerato tra gli iraniani e in tutto il mondo per aver guidato i comitati di morte che hanno condannato a morte migliaia di cittadini iraniani innocenti nel corso degli anni”.
Bennett ha così dettato la linea: il suo esecutivo non si discosterà di un millimetro dalla posizione di quello precedente di Netanyahu sull’Iran. La posta in gioco, per gli israeliani, è troppo grande, la loro stessa sopravvivenza, e non vedono margini di negoziato con Teheran. La cooperazione o, come qualcuno scrive, la subalternità di Gerusalemme a Washington, non è in discussione e a dimostrazione di questo, Israele ha votato contro la Cina una risoluzione americana per condannare il trattamento della minoranza islamica uigura nel Celeste Impero.
Questo articolo è pubblicato anche sul numero di luglio/agosto di eastwest.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
È la Cina uno dei nodi da sciogliere tra Stati Uniti e Israele. Oggi il premier israeliano, Naftali Bennett, è per la prima volta a Washington per una serie di colloqui che verteranno su vari temi, incontrando il vertice dell’amministrazione Biden, Presidente compreso. Tra questi sicuramente la preoccupazione americana per gli investimenti cinesi in Israele.
Secondo un articolo pubblicato dal media online americano Axios, durante la sua visita la scorsa settimana in Israele, il capo dell’intelligence statunitense, Bill Burns, avrebbe espresso le serie preoccupazioni dell’amministrazione di Washington per la presenza cinese nel Paese della stella di Davide. La presenza cinese appare infatti sempre maggiore e si basa su diversi progetti, tra i quali la costruzione della linea ferrata leggere di Tel Aviv. I cinesi inoltre hanno interessi nel porto di Haifa. A quanto sembra, Biden è allarmato dal fatto che gli investimenti della Cina in Israele abbiano superato i 19 miliardi di dollari negli ultimi 18 anni, inclusi 9 miliardi di dollari in tecnologia, mentre il commercio bilaterale ha raggiunto i 17,5 miliardi di dollari l’anno scorso.
È pertanto del tutto plausibile che Biden spingerà Bennett ad abbandonare la cooperazione di Israele con la Cina, in particolare nella sfera dell’hi-tech. Dal canto suo, Bennett farà pressione su Biden affinché abbandoni i negoziati sull’accordo nucleare iraniano. Anche se certo non mancheranno discussioni sul futuro dei Territori palestinesi e in generale sulla questione israelo-palestinese, su cui peraltro i due non saranno d’accordo, sono molti gli analisti che sottolineano come al momento l’amministrazione Biden sia concentrata in primis sulla sua più grande sfida strategica, la Cina, che ha sfruttato gli errori degli Stati Uniti come l’Afghanistan e l’Iraq e ha ampliato la sua influenza in Medio Oriente.
Biden dirà a Bennett che, in quanto principale beneficiario della ricerca e dello sviluppo avanzati degli Stati Uniti e della generosità degli aiuti esteri degli Stati Uniti, Israele è strettamente vincolato dai suoi accordi con gli States e deve quindi “cessare e desistere”, o affrontarne le conseguenze. Israele ha in gran parte ignorato tali avvertimenti delle precedenti amministrazioni statunitensi, ma Biden potrebbe decidere di non lasciar più correre. Bennett è partito, sembra, con le migliori intenzioni. “Joe Biden è un vero amico di Israele. C’è un nuovo Governo in Israele e una nuova amministrazione negli Stati Uniti, e sto portando con me un nuovo spirito di cooperazione”, ha detto il premier prima di partire da Tel Aviv.
Il tema dei rapporti Israele e Cina comunque non è nuovo. Preoccupazioni simili erano state già fonte di frizione tra il Governo di Benjamin Netanyahu e quello di Donald Trump, nonostante la forte vicinanza tra i due. Proprio per venire incontro alle preoccupazioni americane, l’amministrazione Netanyahu bloccò un investimento cinese in una centrale energetica Secondo una fonte anonima israeliana raccolta da Axios, gli israeliani avrebbero risposto alle preoccupazioni del capo della Cia che loro condividono parte di questi timori e che avrebbero voluto aziende americane interessate a questi progetti e investimenti, ma nessuno di questi si è presentato.
Le preoccupazioni israeliane risiedono soprattutto nel fatto che gli israeliani avrebbero scoperto che un attacco informatico portato avanti due anni fa contro proprie aziende sarebbe partito proprio dalla Cina. In una audizione al Senato americano la settimana scorsa, funzionari del dipartimento di Stato e del Pentagono hanno confermato che l’amministrazione Biden ha messo in guardia i partner mediorientali sulle intenzioni e gli interessi cinesi nell’area, cosa che può creare non solo problemi di sicurezza e di stabilità regionale, ma anche di sovranità e di relazioni di sicurezza con gli Usa.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
I fatti di Kabul, con i Talebani che sono ritornati al potere, non interessano solo Washington o i Paesi europei che temono nuove ondate migratorie, ma hanno un riverbero non indifferente anche nel Medio Oriente. Non solo perché molti Paesi mediorientali e del Golfo hanno interessi e rapporti con il Paese dei pashtun; ma soprattutto perché il ritiro americano dall’Afghanistan e la presa del potere da parte dei Talebani diminuiscono in Medio Oriente l’influenza di Washington, lasciando alcuni Paesi nel mezzo. Come l’Arabia Saudita.
l regno dei Saud non ha mai fatto mistero delle sue relazioni nel Paese, dal finanziamento dei combattenti mujaheddin all’organizzazione dei colloqui di pace del 2008 a Medina, solo per citare qualcosa. Dopo l’apertura nel 2013 di un’ambasciata talebana a Doha, l’Arabia Saudita ha affermato che il Qatar ha sostenuto il “terrorismo”. Ma secondo un ex combattente afgano, l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti hanno cercato di ospitare i Talebani prima che il gruppo aprisse una rappresentanza in Qatar. Quando il principe ereditario Mohammad bin Salman (MBS) visitò il Pakistan due anni fa, si disse che avrebbe potuto incontrare rappresentanti dei Talebani, incontro poi non confermato.
Con la partenza americana, il Regno ha mostrato un netto distacco nei confronti degli sviluppi in Afghanistan, anche perché la visione di un Islam moderato di MBS (almeno nelle intenzioni) cozza con quella talebana. Riad è ferma alleata di Washington e non ha interesse che l’autorità mediorientale di quest’ultima venga minata. Intanto, ha evacuato tutto il suo personale diplomatico da Kabul. Le preoccupazioni per la crescita di un Islam meno moderato nell’area, sono anche di Egitto e Giordania, che vivono, soprattutto il secondo, periodi di non eccessiva stabilità e che temono rigurgiti fondamentalisti che possano inficiare la loro credibilità e immagine internazionale.
Secondo gli analisti, il successo dei Talebani in Afghanistan avrà implicazioni anche per l’angolo più infiammabile del Medio Oriente. Sia in Iraq che in parti della Siria, dove gli Stati Uniti mantengono una presenza militare, l’uscita americana sarà inquietante, perché può creare un precedente. In Libano, che è diventato a tutti gli effetti uno Stato fallito, la débâcle in Afghanistan si aggiunge all’oscurità del momento e ringalluzzisce i movimenti fondamentalisti che non aspettato altro che prendere il potere nel Paese dei cedri. Spettatore inerme ma fortemente interessato è Israele, che deve fare i conti soprattutto con le implicazioni della battuta d’arresto subita dal suo principale alleato.
L’aumento dell’instabilità in Medio Oriente non è sicuramente a vantaggio di Israele. Tra Gerusalemme e Kabul non ci sono rapporti e l’Afghanistan ha più volte condannato la posizione israeliana contro i palestinesi. La presa dei Talebani preoccupa non poco Gerusalemme, così come la perdita di influenza americana nell’area. Hamas si è affrettata a salutare la vittoria talebana, parlando di incitamento a continuare a resistere alle occupazioni. A Gaza si è festeggiato e i leader palestinesi meno dialoganti si sono riuniti per definire le nuove azioni da intraprendere contro Israele. E, mentre discutevano, un razzo partito dalla striscia è stato intercettato dall’Iron Dome israeliano. Gerusalemme si sente ancora di più assediata e la situazione afghana fa temere per un isolamento maggiore, dovuto appunto alla perdita di influenza americana nell’area. Dall’altro lato, molti commentatori dello Stato ebraico leggono similitudini tra la questione afghana e quella palestinese, con il pericolo che, quindi, un ritiro o un allentamento del controllo israeliano sul territorio palestinese, possa portare alla crescita di uno Stato islamico fondamentalista. Ma, ovviamente, i due luoghi non sono paragonabili.
È vero però che il ritorno dei Talebani ha dato vigore e incitamento al fondamentalismo nell’area. L’Iran è ovviamente il Paese più interessato non solo perché ospita migliaia di afghani, non solo perché condivide con l’Afghanistan un lungo confine, ma anche perché il ritiro americano e la perdita di influenza aumenta di contro la propria nell’area. Con i Talebani, pur non condividendo le identiche idee religiose, l’Iran ha sempre mantenuto rapporti. Anche perché teme che una nuova guerra civile possa provocare una nuova ondata di profughi nel proprio Paese, già minato dalle sanzioni. Ecco perché Teheran si è adoperata più volte per portare avanti colloqui di pace tra le fazioni e riempire così gli spazi lasciati vuoti da Washington.
Spazi che fanno gola anche ad Ankara, che mira non solo al controllo dell’aeroporto, ma anche ad altri investimenti, per accreditarsi sempre più, in assenza americana, come il più importante playmaker mediorientale, capace di tenere rapporti con tutti i Paesi. Non a caso lo stesso Erdogan si è reso disponibile a trattare con i Talebani.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Il confine tra Israele e Libano è di nuovo teatro di scontri dopo il lancio, avvenuto ieri, di numerosi razzi contro il paese della stella di Davide che hanno poi causato il fuoco di rappresaglia contro il Libano. Gli attacchi sono stati rivendicati da Hezbollah, che ha nell’Iran in suo maggior finanziatore soprattutto nella sua battaglia contro Israele.
Gli episodi di ieri rappresentano il seguito di una serie di scaramucce verificatesi nelle scorse settimane tra i due paesi, perennemente in conflitto. Hezbollah ha dichiarato di aver lanciato dozzine di razzi venerdì in campo aperto vicino a posizioni israeliane nella contesa area di confine di Shebaa Farms proprio in risposta agli attacchi aerei israeliani di giovedì. Le fattorie di Shebaa, conosciute in Israele come Monte Dov, sono una striscia di terra rivendicata da Israele, Libano e talvolta dalla Siria e che si trova all’intersezione di tutte e tre le nazioni, adiacente alle alture del Golan.
Intanto Israele ha fatto sapere di non volere l’escalation di una guerra totale, ma di essere pronto a qualsiasi risposta. La Forza delle Nazioni Unite in Libano (UNIFIL) ha affermato che la situazione è molto grave e ha esortato tutte le parti a cessare il fuoco. L’esercito israeliano ha anche fatto poi sapere che il suo sistema Iron Dome ha intercettato 10 dei 19 razzi venerdì, con sei che sono caduti in aree aperte e tre atterrati all’interno del sud del Libano.
E’ stato un mese caldo dal punto di vista degli scontri, come non si verificava da lungo tempo e che ha riportato alla memoria le due guerre combattute tra i due paesi nel 1982 e nel 2006. Molti analisti politici stanno guardando con grande apprensione a questi accadimenti temendo un possibile coinvolgimento israeliano in una guerra su più fronti con l’Iran, che sostiene anche i militanti palestinesi nella Striscia di Gaza, con i quali Israele ha combattuto per 11 giorni a maggio.
Teheran è indicata come il responsabile di diversi attacchi, ultimo pochi giorni fa, a navi israeliane nel Golfo. Zvika Haimovich, un generale israeliano in pensione ed ex comandante delle forze di difesa aerea israeliane, ha affermato che sia Hezbollah che Israele stavano negli ultimi tempi cercando di agire secondo una formula adottata negli ultimi anni, ovvero cercare di mantenere il confine con il Libano tranquillo.
Tuttavia, Haimovich ha aggiunto: “Siamo vicini a un punto in cui Israele dovrà agire contro Hezbollah in Libano e gli eventi di gli ultimi giorni hanno portato quel momento ancora più vicino”.
Ma chi è questo leader di Hezbollah che minaccia Israele? Hassan Nasrallah, (Hassan Abdel Karim Nasrallah è il suo nome completo) guida Hezbollah (che vuol dire “partito di Dio”) ormai dal 1992. E’ nato nel 1960 a Beirut da una famiglia modesta. Suo padre gestiva un piccolo negozio di alimentari.
Studioso, sin da giovanissimo, dell’Islam, nel 1975 Nasrallah si è unito ad Amal, un gruppo paramilitare sciita libanese con legami con Iran e Siria. Poco dopo si è trasferito in Iraq, per studiare in un seminario sciita ma dopo l’espulsione di centinaia di studenti libanesi dall’Iraq nel 1978, tornò in Libano e sempre con Amal e diventò il comandante della valle di Al-Biqa. Dopo l’invasione israeliana del Libano nel 1982, Nasrallah lasciò Amal per unirsi al nascente movimento Hezbollah, una forza più radicale pesantemente influenzata dall’ayatollah Ruhollah Khomeini e dalla rivoluzione islamica del 1979 in Iran.
Con il passare del tempo il suo ruolo all’interno di Hezbollah si è rafforzato tanto che alla fine degli anni 80’ Nasrallah è diventata una figura di spicco negli scontri di Hezbollah.
Dopo un periodo in Libano per approfondire i suoi studi religiosi, nel 1989 è tornato a combattere. Ha preso la guida di Hezbollah nel 1992 dopo che il suo predecessore, lo sceicco Abbas al-Musawi, venne ucciso da un missile israeliano. Nel 1997 anche suo figlio di 18 anni, Hadi, venne ucciso mentre combatteva contro le forze israeliane.
Molto amato nell’ambiente arabo, Nasrallah nel 2004 organizzò uno scambio di prigionieri con Israele, cosa che fu considerata da molti arabi una grande vittoria. Ma nel tentativo di fare pressione su Israele affinché rilasciasse altri prigionieri, le forze paramilitari di Hezbollah lanciarono un’operazione militare nel 2006, uccidendo un certo numero di soldati israeliani e rapendone due.
Questo portò Israele a lanciare una grande offensiva militare contro Hezbollah. All’inizio della guerra, alcuni leader arabi criticarono Nasrallah e Hezbollah per aver incitato al conflitto. Ma alla fine della guerra durata 34 giorni, Nasrallah emerse ancora una volta come leader venerato in gran parte del mondo arabo per essere riuscito a tenere testa a Israele, portando il conflitto a un punto di stallo e a un conseguente cessate il fuoco che fu da parte libanese considerato una vittoria, quantomeno per aver fermato le velleità militari di Israele.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Non si placano le polemiche dopo che si è diffusa, qualche giorno fa, la notizia che un sofisticato software israeliano, Pegasus, creato dalla società israeliana NSO Group e destinato a rintracciare terroristi e criminali, è stato utilizzato per hackerare i cellulari di giornalisti e attivisti politici e 14 capi di Stato e di Governo e per ottenere indebitamente notizie riservate in molti Paesi del mondo.
Secondo quanto è emerso dall’inchiesta, scaturita dal lavoro di sedici media internazionali coordinati dall’organizzazione senza scopo di lucro Forbidden Stories, sarebbero almeno 50.000 i numeri di telefono colpiti e potenzialmente spiati. E 45 i Paesi coinvolti. Secondo fonti di stampa internazionale come il Guardian, ad essere stati intercettati ci sarebbero importanti giornalisti, uomini d’affari, autorità religiose, accademici, Ministri e funzionari governativi. Tra le curiosità emerge che Pegasus sarebbe stato persino usato dai servizi segreti degli Emirati Arabi Uniti per impedire la fuga della principessa Latifa Al Maktoum, una delle figlie dell’emiro di Dubai, Mohammed Al- Maktoum. La ragazza aveva già tentato la fuga quando aveva solo 16 anni, nel 2001. Nel 2018 la ragazza, dopo anni di prigionia in una cella del palazzo, aveva rimesso in piedi il suo piano di fuga, aiutata da un ex agente dei servizi francesi, Hervé Jaubert. Nascosta nel bagagliaio di un’auto attraversò la frontiera con l’Oman per poi imbarcarsi su un gommone che avrebbe dovuto portarla fuori dalle acque territoriali. Poco prima della “salvezza” però il gommone fu intercettato dalle forze speciali emiratine che la riportarono indietro.
Pare che a condurre gli uomini dell’emiro da lei fosse stato proprio il programma Pegasus che avrebbe consentito di tracciare ogni suo movimento e intenzione attraverso l’esame dei messaggi WhatsApp, sms, email, non solo della ragazza ma anche di chi stava provando ad aiutarla. Molte altre le vittime illustri, tra cui persino il Dalai Lama e il Presidente francese Emmanuel Macron. Tale utilizzo del software sarebbe in totale conflitto con lo scopo per cui il software è stato creato, ovvero essere venduto ai Governi esclusivamente per la sorveglianza di terroristi e criminali. Intanto Israele ha istituito una commissione parlamentare per esaminare la questione del controverso software di sorveglianza, soprattutto per capire se sia stato e chi ad utilizzarlo in modo improprio, per approfondire quanto accaduto e individuare le eventuali responsabilità.
La NSO Group ha negato qualunque accusa. Il suo amministratore delegato, Shalev Hulio, ha anzi fatto sapere che “sarebbe molto contento se ci fosse un’indagine, in modo da poter riabilitare il nostro nome”, aggiungendo che trattasi di tentativi “di diffamare tutta l’industria cibernetica israeliana”. Hulio ha affermato che anche se la società non può rivelare i dettagli dei suoi clienti a causa di “problemi di riservatezza”, offrirà piena trasparenza a qualsiasi Governo che voglia avere maggiori dettagli. Un paio di giorni fa in un discorso all’Università di Tel Aviv, il Primo Ministro israeliano, Naftali Bennett, ha esaltato le capacità dell’industria informatica israeliana, chiedendo però l’istituzione di un sistema di difesa informatica in rete, congiunto, da condividere con i Paesi che la pensano allo stesso modo. Il sistema Pegasus può hackerare i telefoni cellulari senza che un utente lo sappia, consentendo ai clienti di leggere ogni messaggio, tenere traccia della posizione di un utente e incidere anche sulla fotocamera e sul microfono del telefono.
Le notizie su Pegasus e su quanto accaduto hanno nuovamente acceso il dibattito sulla questione della potenza militare e cibernetica di Israele e sul commercio che ne deriva. Non è certamente un mistero che Israele è leader mondiale nella ricerca e nello sviluppo di strumenti informatici e di guerra. Come per le armi, anche l’industria hi-tech è al servizio dell’esercito e della sua rinomata capacità di intelligence. Il Paese ha istituito unità tecnologiche e di intelligence altamente sofisticate nel Mossad (l’intelligence israeliana) e nello Shin Bet (l’agenzia di controspionaggio e antiterrorismo del Paese). La più famosa tra queste è l’Unità 8200, che è il corpo più grande e importante dell’intelligence militare israeliana e che è responsabile della raccolta di dati e informazioni, della ricerca, dell’analisi, della decifrazione e dell’elaborazione, nonché del supporto di operazioni speciali.
Oltre a questo, negli ultimi due decenni l’Unità 8200 ha anche sviluppato misure cyber offensive, che sono state utilizzate anche durante operazioni congiunte con la intelligence statunitense per infiltrarsi – ad esempio – nei computer iraniani. Vi sono poi anche altre unità informatiche, tra le quali l’Unità 81 e i corpi cibernetici difensivi del Communication Corps, che hanno il compito di proteggere le reti militari dalla penetrazione di esterni. Il Ministero della Difesa israeliano promuove ed esporta i prodotti militari – missili, proiettili, aeroplani, artiglieria e carri armati, ma anche tecnologia e software – verso i mercati esteri. L’obiettivo non è solo quello di favorire l’economia israeliana; è anche uno strumento diplomatico.
Vendendo armi o strumenti informatici, Israele sta facendo breccia in territori finora inesplorati. In tal modo, Israele, principalmente attraverso il Mossad, ha aperto la strada alla creazione di legami prima clandestini e poi sempre più aperti con varie parti del mondo arabo, come gli Emirati Arabi Uniti, il Bahrain o l’Arabia Saudita. Ovviamente il Paese riserva sempre per se gli strumenti più avanzati in modo da essere sempre in una posizione di vantaggio rispetto agli altri. Da qui molti analisti sostengono che ad esempio proprio Pegasus, essendo ormai stato esportato, sia per Israele superato e che il Paese abbia già per se nuovi e più sofisticati software. Intanto, non mancano le polemiche e piovono le critiche. Israele è nell’occhio del ciclone e molti auspicano che il Paese cambi rotta, ideali e valori, e riconsideri in chiave etica e morale la sua politica sulla vendita di armi e software. Una delle ipotesi avanzate sarebbe che software come Pegasus andrebbero venduti ma in maniera molto più limitata e oculata e eventualmente non a Paesi con regimi dubbi.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Si è concluso con due condanne a 15 anni di carcere il processo contro un ex consigliere e un cugino del re di Giordania, accusati di stare preparando un complotto contro la monarchia. Secondo fonti di stampa sia locale che internazionale, Bassem Awadallah, ex capo della corte reale e consigliere del re, e il cugino del re, Sharif Hassan bin Zeid, sono stati condannati per sedizione.
I due erano stati arrestati ad aprile scorso nell’ambito di una inchiesta che riguardava anche il fratello più piccolo del re Abdullah, il principe Hamzah, il quale dopo aver giurato pubblicamente fedeltà al re non dovrà subire alcun processo. È stato però messo agli arresti domiciliari e le sue comunicazioni sono sotto controllo. Awadallah e Sharif Hassan sono stati accusati di aver aiutato a organizzare un complotto ordito dal principe Hamzah per alimentare il dissenso contro il regno di suo fratello.
Il processo si è tenuto a porte chiuse, scatenando non poche polemiche anche dalla stampa, esclusa dal poter seguire le udienze. La sentenza dovrà ora, entro 30 giorni, essere confermata o meno da un tribunale superiore. Tutto dunque è ancora aperto, soprattutto considerando che entrambi i condannati si sono sempre dichiarati non colpevoli. Gli avvocati giordani dei due hanno detto di non accettare tale sentenza e che presenteranno appello. Le accuse sono state formulate soprattutto a seguito di intercettazioni ambientali relative a messaggi tra il principe Hamzah, Awadallah e Hassan che parlavano di voler fomentare le proteste di alcuni leader tribali per la corruzione e le politiche del Governo che hanno tagliato i loro mezzi di sussistenza.
Del caso, che ha avuto ampio risalto mediatico, si è interessata anche l’Arabia Saudita. Awadallah infatti oltre che cittadino giordano e americano ha ottenuto anche la cittadinanza saudita. Dopo il suo arresto alti funzionari, incluso il capo dell’intelligence saudita, si sono precipitati in Giordania per agevolarne il rilascio. Inoltre la famiglia di Awadallah negli Stati Uniti ha rilasciato una dichiarazione affermando che è stato picchiato e torturato con cavi elettrici mentre era in detenzione in Giordania ed è stato costretto a dichiarare cose non vere. La famiglia ha invitato gli Stati Uniti a “proteggere i diritti e le libertà civili dei propri cittadini da trattamenti ingiusti e disumani da parte di altri Governi”.
La Giordania, tuttavia, nega qualsiasi accusa di tortura o maltrattamenti in carcere. L’avvocato giordano di Awadallah, Mohamed Afif, ha affermato di non essere in grado di commentare le accuse di tortura, mentre l’avvocato di Sharif Hassan, Ala Khasawneh, ha dichiarato che il suo cliente gode di buona salute e non ha avuto problemi in carcere. Fonti di stampa internazionale hanno però sottolineato come il rapporto sui diritti umani del 2020 del Dipartimento di Stato americano sulla Giordania abbia evidenziato che le organizzazioni internazionali e locali per i diritti umani hanno segnalato episodi di tortura nei centri di detenzione.
Il processo e, ancora prima, il tentativo di golpe dimostrano la fragilità della monarchia giordana, schiacciata dalla necessità di tenere rapporti con Israele, soprattutto per approvvigionarsi di acqua, e il sostegno ai palestinesi. Prima degli Accordi di Abramo, Amman era l’unico Paese arabo, insieme all’Egitto, a tenere rapporti con Israele, derivati soprattutto dalla guerra. Rapporti difficili, non sempre idilliaci, che continuano a portare a scontri diplomatici tra i due Paesi. Con gli Accordi di Abramo, il ruolo della Giordania nell’area è andato riducendosi, anche nei confronti dei palestinesi. Pure gli Stati Uniti stanno rivedendo le loro posizioni con Amman, anche se considerano la Giordania un importante alleato nell’area.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Cominciano a emergere le prime difficoltà per la coalizione di Governo che guida Israele, con la prima sconfitta in Parlamento per l’esecutivo. Il gruppo guidato dal Primo Ministro, Naftali Bennett, non è riuscito ad avere i voti necessari per consentire l’estensione della legge che nega ai palestinesi che sposano cittadini israeliani i diritti di residenza e cittadinanza.
La notizia ha avuto ampio risalto sulla stampa locale anche perché il voto è stato il primo importante test politico per il nuovo premier israeliano e l’ampia compagine governativa che va dalla sinistra dei labouristi e di Meterz alla destra di Benne, Sa’ar e Lieberman, passando per gli arabi di Ra’am. La legge oggetto della votazione impedisce ai palestinesi che vivono nella Cisgiordania occupata e nella Striscia di Gaza che sposano cittadini di Israele di ottenere loro stessi la cittadinanza e i diritti di residenza nello Stato ebraico. Ogni anno la legge viene rinnovata e all’ultimo appuntamento, qualche giorno fa, il Parlamento non è riuscito a confermare la scelta. La coalizione di otto partiti in Parlamento non è riuscita a raggiungere la maggioranza nelle prime ore di martedì dopo una maratona di sessioni notturne per estendere la cosiddetta legge sulla cittadinanza e l’ingresso in Israele, mostrando tutta la fragilità di questo Governo, dovuta principalmente alla sua eterogeneità. La votazione si è conclusa infatti con 59 voti a favore e 59 contro e due astenuti. Ha votato contro il Governo anche un membro del partito del premier Bennett.
Sami Abou Shahadeh, membro del partito Palestine Joint List alla Knesset (il Parlamento israeliano), ha affermato che il fallimento dell’estensione della legge è “una vittoria per migliaia di famiglie palestinesi”, molte delle quali stanno già chiedendo di veder riconosciuti i propri diritti anche se l’esecutivo sta pensando a una legge di emergenza per arginare il problema. La norma è stato emanata per la prima volta durante la seconda Intifada palestinese nel 2003 ed era stata giustificata dai suoi sostenitori da motivi di sicurezza. Per gli oppositori invece è una misura discriminatoria e prende di mira la minoranza palestinese di Israele.
Lunedì, il Ministro degli Esteri Yair Lapid aveva dichiarato che la legge “è importante per la sicurezza del Paese. È uno degli strumenti destinati a garantire una maggioranza ebraica in Israele – ha scritto su Twitter – Israele è lo Stato-nazione del popolo ebraico e il nostro obiettivo è che abbia una maggioranza ebraica”.
Lunedì, fuori dal Parlamento, diverse persone, arabi o sostenitori dei palestinesi o dei diritti civili, si sono riunite per manifestare contro la legge. Hanno sottolineato le difficoltà per ottenere i permessi per raggiungere i propri coniugi, o i rischi di entrare in territorio israeliano senza permesso. Jessica Montell, a capo di Hamoked, un gruppo israeliano per i diritti umani che fornisce anche servizi legali ai palestinesi, ha affermato che “decine di migliaia di famiglie sono danneggiate da questa legge”. Da quando è stata varata, la legge è stata sostenuta dai vari Governi di destra che si sono succeduti, soprattutto quelli guidati da Netanyahu. Il quale tuttavia in questa occasione ha votato contro solo per fare opposizione al Governo di Bennett, che dopo ben 12 anni lo ha spodestato. Non pochi lo hanno notato sin da quando il 13 giugno il nuovo esecutivo è entrato in carica. Si è fatto notare da più parti la estrema eterogeneità del gruppo, unito solo dalla volontà di sconfiggere Benjamin Netanyahu.
Il quale non perde occasione per dimostrare di essere ancora lui il decision maker di Israele, di avere ancora il pallino della politica israeliana. Lo ha dimostrato in questa occasione, continuerà a farlo, mettendo a rischio la stabilità del Governo, proponendo leggi che i suoi ex amici, soprattutto il premier e Sa’ar con i loro partiti, non possono non votare. E intanto continua a essere rinviato il processo contro di lui. Dopo il posticipo al 12 luglio giunge la notizia di un ulteriore rinvio, al 19 luglio. La nuova data cade però solo due giorni prima dell’inizio della pausa estiva del tribunale, che si protrarrà fino a settembre. Le festività ebraiche di settembre e ottobre aggiungeranno sicuramente ulteriori ritardi ai procedimenti per cui appare quasi certo che il processo non potrà fare passi avanti almeno sino a ottobre inoltrato.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Resta alta la tensione in tutta la Cisgiordania dopo la morte, avvenuta la settimana scorsa, dell’attivista politico Nizar Banat, per mano delle forze dell’ordine palestinesi durante un arresto a Hebron.
Da giorni ormai migliaia di persone stanno scendendo in piazza per manifestare contro l’Autorità nazionale palestinese, ritenuta responsabile della sua morte. In tantissimi hanno marciato nei giorni scorsi per le strade delle principali città della Cisgiordania, a Ramallah, Hebron, Betlemme, per protestare contro quanto accaduto. Tantissimi gli striscioni con la foto di Banat e tanti i cori per chiedere la fine del “regno” di Mahmoud Abbas (Abu Mazen), da 16 anni ininterrottamente al potere senza elezioni. Le forze dell’ordine palestinesi hanno però reagito duramente e in qualche caso, anche in maniera brutale.
Secondo il sindacato dei giornalisti palestinesi, bastoni, barre di metallo, gas lacrimogeni e violenze varie su manifestanti sono state usate per interrompere le manifestazioni e impedire ai giornalisti di documentare gli eventi. Intanto il Partito popolare palestinese di sinistra si è ritirato dall’Autorità palestinese guidata da Fatah a causa della “mancanza di rispetto per le leggi e le libertà pubbliche”, che poi ha comportato anche le dimissioni del Ministro del Lavoro, Nasri Abu Jaish. Banat, 43 anni, era da anni critico verso l’Autorità Palestinese. In particolare aveva accusato Abbas e la sua cerchia ristretta di corruzione e autoritarismo e aveva pianificato di presentarsi come candidato politico alle elezioni palestinesi che avrebbero dovuto tenersi a maggio e che poi invece sono state annullate.
Secondo la sua famiglia, l’attivista è stato duramente picchiato prima di essere trascinato via. Per fare luce sulla vicenda è stata creata una commissione d’inchiesta. Il Ministro della Giustizia dell’Autorità palestinese e capo della commissione d’inchiesta, Mohammed al-Shaalaldeh, ha fatto sapere che Banat è stato sottoposto a violenza fisica e che la sua morte è stata “innaturale”. In un’intervista con la TV ufficiale palestinese, il Ministro ha affermato che il primo rapporto medico sulla morte del 43enne Banat indica che è stato sottoposto a violenza fisica. L’attivista avrebbe perso conoscenza durante il suo trasferimento al centro di sicurezza preventiva dell’Autorità palestinese tanto che sarebbe stato dichiarato già morto all’arrivo in ospedale a Hebron. Secondo il rapporto medico la causa della morte sarebbe stato uno shock neurologico, che ha provocato una insufficienza cardiaca e polmonare. Secondo l’autopsia iniziale, Banat sarebbe stato picchiato alla testa, al petto, al collo, alle gambe e alle mani, e sarebbe passata meno di un’ora tra il suo arresto e la sua morte.
Al-Shalaldeh ha però aggiunto che l’incidente è da considerarsi un caso eccezionale e isolato e non riflette il modo di comportarsi dell’autorità palestinese nei confronti dei suoi critici e oppositori. La Commissione inoltre, secondo al-Shalaldeh, ha svolto il suo lavoro “in modo obiettivo, imparziale e confidenziale” e il suo rapporto è stato ora consegnato al Primo Ministro, Mohammed Shtayeh, che a sua volta lo passerà al capo della magistratura militare al fine di adottare le misure necessarie e indagare sui sospetti. Diversi gruppi che si battono per la tutela dei diritti umani, sia palestinesi che internazionali, hanno tuttavia chiesto che venga aperta anche un’inchiesta indipendente rispetto a quella dell’Autorità nazionale palestinese per fare luce sull’accaduto. “Il defunto Nizar Banat è stato minacciato dall’Autorità palestinese più di una volta e già sottoposto a un tentativo di omicidio a maggio. Era un’icona di libertà di parola, espressione di opinione e lotta alla corruzione. Dopo essere stato martirizzato, è diventato un simbolo per ogni palestinese”, ha detto Muhannad Karajah, l’avvocato della famiglia.
L’uccisione di Banat è diventata anche l’occasione per la popolazione palestinese per sollevare una ondata di proteste contro la classe politica locale, considerata da molti corrotta e incapace e che è ora più che mai invisa dopo la cancellazione delle elezioni che rappresentavano per molti uno spiraglio di luce nella via del cambiamento. Anche se nella società civile resta il problema della eventuale alternativa”. Se Abbas si dimette – fa notare Mariam Barghouti, scrittrice e commentatrice di Ramallah – i palestinesi potrebbero avere la possibilità di elezioni rappresentative. La domanda ora è: quali sono le alternative? Sono i capi delle forze di sicurezza che danno ordini per attaccare la società civile palestinese, o i leader che tentano di cooptare l’appello palestinese alla giustizia, alla libertà e al diritto all’autodeterminazione per le proprie agende politiche?”.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
È stata una discussione sulla questione iraniana ad aprire la prima riunione domenicale del nuovo esecutivo israeliano. Il Primo Ministro Naftali Bennett, aprendo l’incontro del suo Governo, ha sottolineato come le elezioni presidenziali iraniane “mostrano che il mondo deve agire affinché l’Iran venga fermato nel dotarsi di un’arma nucleare”. Mentre a Gerusalemme Bennett così si esprimeva con il suo esecutivo, a Vienna si teneva l’ultimo del sesto round di colloqui indiretti tra Washington e Teheran sulla possibilità di ritornare all’accordo sul nucleare del 2015. Le parole di Bennett sono arrivate anche mentre il capo di Stato maggiore delle Israel Defence Forces, l’esercito israeliano, Aviv Kohavi si dirigeva negli Stati Uniti con una delegazione di alti ufficiali militari israeliani per incontrare funzionari americani a Washington e discutere del programma nucleare iraniano e dei suoi sforzi espansionistici nella regione.
“L’elezione di Raisi a Presidente dell’Iran è un segnale per le potenze mondiali che devono svegliarsi”, ha detto Bennett. “Questo potrebbe essere l’ultimo segnale un momento prima di tornare all’accordo con l’Iran. Devono capire con chi stanno facendo affari e che tipo di regime stanno scegliendo di rafforzare. Un regime di carnefici non può avere armi di distruzione di massa”, ha detto il premier israeliano.
La posizione israeliana sull’Iran, con il passaggio dell’esecutivo da Benjamin Netanyahu a Naftali Bennett, non è cambiata: l’Iran è il nemico, il male assoluto e non si può scendere a patti con il regime degli Ayatollah. Eppure, il precedente cambio di vertice alla Casa Bianca ha variato la politica verso Teheran, in qualche modo costringendo Gerusalemme a rivedere le posizioni che però non si sono ammorbidite. Neanche il rapporto tra l’inquilino di Pennsylvania Avenue Joe Biden e quello di Balfour Street (dove però entrerà da luglio) Naftali Bennett, che pare essere molto stretto, ha cambiato per ora le cose. Sin dal suo insediamento alla Casa Bianca, Biden ha ribadito l’importanza di tornare a discutere con l’Iran di un nuovo accordo o, comunque, di rivedere le posizioni rispetto alla presidenza Trump tornando all’accordo del 2015. Cosa che invece Bennett e gli israeliani non vogliono ascoltare. Eppure, se Biden ci ha messo quasi un mese prima di chiamare Netanyahu dopo essere entrato in carica a Washington, gli sono bastate poche ore per telefonare a Bennett e complimentarsi con lui dell’incarico di guidare l’esecutivo dopo i dodici anni di Bibi.
Ma l’Iran è un tabù per tutti in Israele, i recenti scontri con Gaza, anche quelli degli ultimi giorni, hanno sottolineato questa distanza. Gerusalemme non ha intenzione di ritornare al dialogo con il regime che lo vuole annientare, non vuole lasciare nessuna porta aperta, neanche uno spiraglio. E anche i continui raid in Siria lo dimostrano. Jack Sullivan, consigliere americano per la sicurezza, commentando le parole di Bennett ha sottolineato che il suo Governo intende fare di tutto per raggiungere una soluzione diplomatica con l’Iran. Soluzione diplomatica sui negoziati che Gerusalemme non prende in considerazione, soprattutto ora che nel palazzo presidenziale iraniano siede quello che Bennett ha definito “il boia di Teheran, l’uomo famigerato tra gli iraniani e in tutto il mondo per aver guidato i comitati di morte che hanno eseguito migliaia di cittadini iraniani innocenti nel corso degli anni”.
Bennett ha così dettato la linea: il suo esecutivo non si discosterà di un millimetro dalla posizione di quello precedente di Netanyahu sull’Iran. La posta in gioco, per gli israeliani, è troppo grande, la loro stessa sopravvivenza, e non vedono margini di negoziato con Teheran. Margini che invece sia la parte americana che anche quella iraniana, dopo la chiusura dei colloqui informali domenica a Vienna con mediazione europea, sembrano essersi allargati, come hanno dichiarato gli stessi protagonisti dei negoziati. Ma sarà difficile che Gerusalemme faccia un passo indietro. È vero che quello di Bennett è un Governo del cambiamento, di radicale inversione di marcia rispetto a quello di Netanyahu, ma l’Iran è un dossier troppo scottante per fare in modo che venga totalmente stravolto.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Questo articolo è stato pubblicato sul numero di maggio/giugno di eastwest.
Puoi acquistare la rivista in edicola o abbonarti.
Sono trentasei i partiti che si sono registrati per le prossime elezioni palestinesi e il 93% degli aventi diritto si è registrato per votare. Dati che dimostrano quanto sia forte, nel popolo palestinese, la voglia di cambiamento, di rinascita, dopo uno stallo amministrativo e politico che dura fin dal 2007. È da allora, infatti, dopo che Hamas aveva vinto le elezioni l’anno prima, quando prese il potere a Gaza e ci furono scontri veri con Fatah, che il Presidente palestinese Mahmoud Abbas (Abu Mazen) di fatto non ha mai convocato elezioni. Dismettendo il Governo del gruppo di Gaza, ne formò uno di lealisti senza tener conto del risultato elettorale, evitando così che per quindici anni il Paese si potesse esprimere tramite le urne sulla composizione del Parlamento, del conseguente Governo e anche del Presidente.
Da quel 2007, anche se acqua sotto i ponti ne è passata parecchia, la situazione per i palestinesi è cambiata poco. I rapporti con Israele sono sempre tesissimi, anche se negli ultimi anni le violenze parevano cessate. Parevano, perché se è vero che i razzi lanciati da Gaza si sono limitati alle “ricorrenze”, come la festa dell’indipendenza israeliana, e non ci sono stati attentati seri, ci sono però stati attacchi di coloni e alcuni palestinesi sono stati uccisi con l’accusa di aver attentato alla vita di poliziotti a qualche check point. Una “anormale amministrazione” per una zona mai pacificata, nella quale gli estremismi di fatto sono cresciuti sotto traccia.
In Israele, infatti, la destra ebraica ha governato e ha acquistato sempre più potere, portando da un lato alla quasi scomparsa della sinistra e alla paradossale situazione nella quale anche alcuni partiti arabi sono disposti ad allearsi con quegli stessi partiti che vorrebbero un Israele composto da soli ebrei ortodossi. Dall’altro lato, la mancanza di democrazia, di partecipazione popolare in Palestina ha aumentato i sentimenti estremisti e gruppi anche sciolti si sono staccati dai partiti maggiori, sia Fatah che, soprattutto, Hamas a Gaza, ribadendo con la forza delle armi e delle proteste il loro fondamentalismo e l’avversione israeliana. Tutto questo accresciuto sentimento di odio, questa pentola che per diverso tempo ha sobbollito, è esplosa alla fine di aprile con da un lato, gli scontri a Gerusalemme tra gli arabi e la polizia e gli arabi e la comunità ortodossa soprattutto nella zona della porta di Damasco (una delle otto porte della città vecchia di Gerusalemme, quella che usano e attraversano musulmani ed ebrei per raggiungere i loro luoghi sacri); dall’altro lato, a Gaza con un lancio continuo di missili per diversi giorni che ha dimostrato sia forza ma soprattutto una precisione, mai vista prima, nell’arsenale di Hamas e dei suoi sodali. Per diversi osservatori, questi episodi di violenza sarebbero eterodiretti dai politici palestinesi che, volendo conservare lo status quo, fornirebbero al governo israeliano la scusa per impedire le elezioni, venendo a mancare il presupposto fondamentale del voto a Gerusalemme.
Facciamo un passo indietro. Tra i trentasei partiti che si sono registrati alle elezioni palestinesi, alcuni hanno serie carte per sfidare e vincere Fatah, impedendo di fatto a questo di tenere il potere. Secondo i sondaggi più accreditati, il sostegno a Fatah sarebbe del 43%, rispetto al 30% di Hamas. A seconda di chi altro corre, il supporto per Fatah potrebbe scendere fino al 32%. Sul fronte presidenziale, più dei due terzi dei palestinesi vorrebbero le dimissioni di Abbas. Contro di lui, che avrebbe il 29% dei consensi, i leader palestinesi più popolari sono risultati Marwan Barghouti, ex leader di Fatah in carcere in Israele da anni dove sta scontando diversi ergastoli, che sarebbe votato dal 48% degli elettori, mentre il leader di Hamas Ismail Haniyeh avrebbe il sostegno del 19% degli elettori. Sul fronte dei partiti, la situazione è altrettanto difficile per Fatah, che sconta anni di accuse di corruzione dei suoi vertici, con diverse defezioni eccellenti.
A cominciare da Nasser al-Qudwa, nipote del defunto Presidente palestinese Yasser Arafat ed ex ambasciatore, che è a capo del neonato Partito della Libertà. Abbas ha cacciato al-Qudwa, che è stato anche ministro degli esteri, da Fatah in seguito all’annuncio di questi che intendeva candidarsi in una lista separata alle elezioni palestinesi. Il colpo di teatro del nipote di Arafat, cacciato anche dalla fondazione intitolata allo zio e comunque molto popolare e rispettato nei Territori, è stato mettere in lista Fadwa Barghouti, la moglie del leader palestinese imprigionato Marwan. Barghouti non è stato ancora espulso da Fatah, come invece al-Qudwa, cosa che secondo molti avverrà tra poco, ma comunque la sua candidatura alla presidenza all’interno del partito è stata resa impossibile da una regola interna di Fatah, voluta da Mahmoud Abbas, in quanto nel 2009 è stato eletto a Betlemme a capo del comitato centrale del sodalizio.
Marwan Barghouti è un politico e leader molto noto e seguito, nonostante sia in carcere da tempo. Sta scontando, infatti, in Israele cinque ergastoli e altri quaranta anni di prigione, perché è stato ritenuto responsabile di una serie di attentati perpetrati dal gruppo militare che comandava, Tanzim, durante, soprattutto, la seconda Intifada. Marwan Barghouti si è sempre dichiarato innocente e ha sempre condannato gli episodi contro i civili sul suolo israeliano, ma è stato condannato da un tribunale israeliano nel 2004, accusato di essere stato anche a capo delle Brigate dei Martiri di Al-Aqsa.
Ogni volta che si parla di elezioni nei territori palestinesi si fa il nome di Marwan Barghouti come di candidato alla presidenza. La sua candidatura spesso viene annunciata soprattutto in chiave anti Mahmoud Abbas, che Barghouti ha sempre avversato. Il leader di Tanzim, che per molto tempo è stato anche un sostenitore degli accordi di Oslo, ha anche attaccato duramente Arafat e il suo circolo ristretto per corruzione. Non è chiaro cosa possa succedere in caso di vittoria di Marwan Barghouti, dal momento che è in carcere. Proprio per scongiurare la sua candidatura, lo scorso febbraio un importante emissario di Abu Mazen gli fece visita in carcere, una visita straordinaria, cercando ci assicurarsi la sua non partecipazione.
Oltre a questa lista, un’altra turba i sogni di Fatah e di Abu Mazen. Il partito Future di Mohammad Dahlan è guidato dall’ex leader di Gaza a Fatah e dal lealista di Dahlan Samir Masharawi, seguito dall’accademico di Gerusalemme ed ex capo dell’Università Al-Quds Sari Nusseibeh. Nusseibeh è stato coinvolto nei colloqui di Madrid del 1991 che hanno portato agli accordi di Oslo. Dahlan era il capo della sicurezza di Fatah a Gaza prima che Hamas sconfiggesse le sue forze nel 2007. Dahlan è stato condannato per accuse di corruzione, costruite forse ad arte da Mahmoud Abbas, un decennio fa. Da allora, Dahlan si è avvicinato alla leadership degli Emirati Arabi Uniti e ha influenzato la politica palestinese proprio attraverso la sua autorità nel Golfo.
È considerato l’uomo dietro gli Accordi di Abramo, la normalizzazione dei rapporti tra Israele e alcuni Paesi del Golfo. Ma poiché in Palestina coloro che sono condannati per crimini non possono servire nel Governo, al momento è impossibile per Dahlan essere candidato. La sua influenza è forte, è grazie a lui che Gaza ha ricevuto migliaia di dosi di vaccino nelle scorse settimane. Sia questi due, Barghouti e Dahlan, sia Hamas pongono una seria minaccia alla leadership di Fatah, sempre più in pericolo. Mahmoud Abbas, negli ultimi tempi, ha sempre dichiarato che senza la possibilità che i palestinesi di Gerusalemme votino, le elezioni sarebbero state cancellate. Hamas ha fatto sapere di ritenere Fatah responsabile di un eventuale fallimento o cancellazione della tornata elettorale, nonostante una sorta di riappacificazione nei mesi scorsi. Fatah ha anche accusato Israele di non permettere il voto a Gerusalemme est, ma il Governo israeliano, che nella tornata nel 2006 permise le elezioni, tramite alcune interviste sulla stampa ha fatto sapere che non ha deciso ancora se permetterle o negarle. Senza voler sprofondare nel complottismo, l’ondata di violenza su più fronti nei giorni scorsi fa pensare ad un tentativo di spingere Israele verso il divieto, così da non cambiare le cose per la Palestina.
Anche perché la tempistica è strana: le elezioni palestinesi, quelle parlamentari, dovrebbero tenersi il 22 maggio, a luglio quelle presidenziali, e un mese dopo quelle del comitato dell’Olp (Organizzazione per la Liberazione della Palestina). In Israele, da anni c’è lo stesso Primo ministro e lo stesso partito alla guida, con le stesse politiche nei confronti dei palestinesi. Che tutto scoppi ora, durante il Ramadan, qualche pensiero sul fatto che da Ramallah in verità le elezioni non vogliono tenerle (anche per le pressioni della comunità internazionale occidentale preoccupata di una eventuale ascesa al potere di Hamas, che molti considerano gruppo terrorista), si è fatto avanti. Non a caso, si è parlato pure della possibilità che si tengano solo elezioni politiche e non presidenziali, per permettere all’ottuagenario e malato Mahmoud Abbas di mantenere il potere, dal momento che da molti Paesi stranieri, ma non dai palestinesi, è considerato il minore dei mali possibili.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

È entrato in carica il 36mo Governo israeliano, il primo, dopo dodici anni ininterrotti, che non sarà guidato da Benjamin Netanyahu. In una votazione thrilling alla Knesset ieri sera dopo le 20, ha preso le redini del nuovo esecutivo Naftali Bennett, ex delfino dello stesso Netanyahu che, dopo non aver raggiunto un accordo con il premier più longevo di Israele quando Bibi ebbe il primo mandato a seguito delle elezioni di marzo, dopo essersi allontanato e cercato un accordo con il centrista Yair Lapid, sembrava a un certo punto avvicinarsi a Netanyahu durante i recenti scontri con Gaza.
Ma alla fine, l’accordo tra Lapid e Bennett è stato sottoscritto ed è entrato in carica un Governo che va dalla sinistra di Labor e Meretz alla destra appunto di Bennet, Sa’ar (altro ex delfino di Netanyahu, fuoriuscito dal Likud) e di Liberman, passando per i centristi Lapid e Gantz e il partito arabo Ra’am. Lo stesso partito che aveva flirtato con Netanyahu e che questi aveva contribuito a far uscire dall’alleanza dei partiti arabi, piazzatasi terza alle penultime elezioni. Una maggioranza di complicata tenuta, con un Governo di 28 membri alcuni davvero distanti tra loro. Difficoltà di rapporti e di tenuta dimostrata anche dai voti con i quali è stato approvato il Governo, 60 voti contro 59, con un astenuto, proprio nel partito arabo. In verità tre membri della lista unita di tre partiti arabi, dai quali si era staccata Ra’am, si erano piazzati fuori dall’aula per astenersi e abbassare il quorum e hanno votato contro solo quando era chiaro che il loro voto era ininfluente. Ma uno dei sette parlamentari di Yamina, il partito del neo premier, ha votato contro il Governo, rendendo Bennett il premier nella storia di Israele con alle spalle uno dei più piccoli partiti della coalizione.
Netanyahu, dopo che nel suo discorso in Parlamento aveva dichiarato Bennett non adeguato al ruolo, ha stretto la mano al suo successore annunciando una transizione pacifica. Bennett sarà Primo Ministro fino al 27 agosto 2023, poi cederà il premierato a Yair Lapid, che nel frattempo sarà Ministro degli Esteri e premier in alternanza, mentre Bennett dopo sarà Ministro degli Interni. Gantz resta alla difesa, Sa’ar alla giustizia, entrambi anche con il ruolo di vice Primo Ministro, mentre Avigdor Liberman, leader dei russofoni, va alle finanze.
Ai partiti di sinistra trasporti, salute e ambiente, tra gli altri portafogli. Ra’am avrà un sottosegretario alla presidenza del consiglio, diventando così il primo partito della minoranza araba a entrare in un Governo. E sarà anche per la prima volta che a guidare il Paese c’è un religioso, il quale dovrà fare i conti con il suo passato di oppositore alla autodeterminazione palestinese e fautore delle annessioni.
Certo, all’inizio il nuovo Governo, che per numero di partecipanti è il terzo nella storia di Israele, con un record di nove donne all’interno, avrà altre gatte da pelare. Il primo scoglio sarà l’approvazione del budget, che manca da oltre 140 giorni nel quale si dovranno concretizzare le promesse di investimenti fatte soprattutto agli arabi, in particolare nel Neghev e in Galilea, che hanno lasciato non poco amaro in bocca a diversi componenti della maggioranza. La quale, non dimentichiamolo, conta su di un grande appoggio della destra. Non quella ortodossa, però che è rimasta sodale con Netanyahu e non siederà al Governo, cosa che non accadeva da decenni. Il Governo dovrà anche normalizzare i rapporti con l’amministrazione americana, anche se non tutti ne condividono l’apertura verso l’Iran che è argomento sensibile nell’elettorato israeliano. Netanyahu non mollerà certo la presa e tenterà di tirare a sé gli scontenti della destra. La strada per il nuovo Governo, è tutta in salita.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

In qualsiasi altro momento storico e in qualsiasi altro Paese, una svolta come quella vista stanotte in Israele verrebbe salutata non solo come “storica”, ma anche con estrema speranza nella parte di popolazione che, da anni, non riesce ad avere gli stessi diritti di altri. E in quelli che questi diritti non li hanno mai avuti e non riescono neanche a essere popolazione.
Già, perché l’uscita di scena di Benjamin Netanyahu, sempre criticato per le sue scelte e le sue posizioni, pluri-indagato e sotto processo a Gerusalemme, ma soprattutto la formazione di una ampissima compagine di Governo in un momento delicato del Paese, con gli arabi per la prima volta in coalizione (se si escludono due parentesi relative a parti arabe di partiti ebraici), dovrebbe rallegrare tutti. In un Paese fondato idealmente sulle differenze, multiculturale e multietnico, dove tutti hanno avuto rappresentanza governativa ma solo se ebrei, indipendentemente dalla loro etnia, il fatto che un partito arabo entri al Governo è sicuramente una buona notizia. Perché parliamo di un Paese che nel 2018 ha approvato una legge totalmente discriminatoria nei confronti della parte araba della popolazione, dichiarando Israele la casa nazionale del popolo ebraico.
Sarebbe una buona notizia in questo momento, considerando quello che è successo il mese scorso, non tanto con lo scontro armato con Gaza, rituale nella sua drammaticità, ma per gli scontri nelle città a maggioranza araba, tra questa popolazione e gli ebrei. Un partito arabo al Governo potrebbe certamente garantire a questi qualcosa e rimetterebbe tutto in carreggiata. Potrebbe. Già, perché il pericolo è che così non sia. Per una serie di ragioni. La prima risiede nella stessa coalizione.
Unita dall’unico collante dell’”anti Netanyahuismo”, la coalizione che chiederà alla Knesset il mandato per governare nei prossimi anni va dalla sinistra estrema dei laburisti e di Meretz all’destra estrema del premier Bennet e dei suoi sodali Sa’ar e Liebermann (tutti ex amici di Bibi), passando per il “centro” di Lapid e di Benny Gantz. In mezzo, anche gli arabi, gli stessi che il premier incaricato Naftali Bennett, ex delfino di Netanyahu, ex Ministro della Difesa, in una dichiarazione disse di non aver avuto problemi a ucciderne molti nella sua vita. Un Paese che riesce a governare con una coalizione così ampia, che rispetta e ricalca gli interessi di tutta la sua popolazione, è un Paese che merita il rispetto di tutti. Ma gli esempi sono davvero pochissimi in passato e quelli che hanno avuto successo ancora meno.
Il secondo problema risiede nelle tempistiche. All’annuncio della scorsa notte non segue immediatamente la formazione del Governo. Ci vorranno almeno una decina di giorni per il voto in Parlamento. Giorni nei quali potrebbe ancora succedere di tutto. I malpancisti, infatti, sia da una parte che dall’altra sono tanti. Nello stesso partito del premier indicato, Yamina, almeno uno dei sette parlamentari ha annunciato che non voterà un Governo dove siedono gli arabi. Di contro, la Joint List araba, attualmente composta da tre partiti che nelle elezioni precedenti alle ultime comprendeva anche il partito Ra’am che oggi siede nel Governo e che diventò, la lista, il terzo partito, ha annunciato, nella sua quasi totalità (alcuni parlamentari non si sono espressi) l’opposizione in Parlamento.
In questi dieci giorni è possibile che ci siano altre defezioni e che i 61 voti attualmente sufficienti, e che la nuova coalizione ha sulla carta, possano scendere. Il terzo problema risiede nelle posizioni di alcuni partiti. Ra’am, il partito arabo di Masour Abbas, si sta attirando critiche da più parti del mondo politico arabo israeliano e, soprattutto, l’opposizione ferrea di quello palestinese, soprattutto da Gaza. Abbas viene criticato da molti come un opportunista, che ha scelto il Governo solo per interessi personali. Dopotutto, durante gli scontri tra arabi ed ebrei la sua voce non è che si sia sentita, e lui anche precedentemente era stato cacciato da manifestazione di arabi. Certo, se dovesse riuscire a portare tutti gli investimenti promessi nel contratto di Governo alle popolazioni e città arabe, sarebbe un successo enorme. Inoltre Abbas si era proposto subito anche a Netanyahu ed è stato proprio grazie a (o a colpa di) Bibi che si è rotta l’alleanza con gli altri partiti arabi.
Proposte che hanno fatto intendere all’elettorato una volontà di governare, indipendentemente dalla coalizione. Naftali Bennett, colui che dovrebbe guidare il Paese fino a settembre 2023 per poi essere sostituito da Yair Lapid fino al 2025, non ha fatto mai mistero della sua posizione antipalestinese. Per il premier indicato, non esiste l’occupazione israeliana dei territori e non c’è nessuno spazio per uno Stato palestinese. Come lui la pensano altri esponenti di Governo di destra, non quelli di sinistra che sono in minoranza anche nella coalizione. Le differenza sono tante, troppe e il timore è che si sia creata la coalizione solo per opporre fine al regno ininterrotto di 12 anni di Netanyahu. E che per farlo si sacrifichi qualcosa. Il timore è che, come successo già per la cancellazione delle elezioni a Ramallah, che si sacrifichi la questione dei palestinesi, cosa che darà sempre più campo libero agli estremisti e ai fondamentalisti. Se, invece, si dovesse riuscire senza sacrificare nulla, sarebbe il più grande successo politico della storia.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Cessati i lanci di razzi, fermati i raid israeliani, oltre a contare vittime e danni, nelle aree interessate dall’ultima serie di scontri tra Israele e i gruppi di Gaza, ma anche nei paesi vicini e lontani coinvolti nella questione, si comincia a ragionare su quanto successo. L’ultimo poderoso round di combattimenti che in undici giorni ha fatto oltre 250 vittime in entrambi gli schieramenti, ha lasciato più macerie di quanto non abbiano fatto razzi e bombardamenti.
Sia Israele che la Palestina devono ricostruire le macerie sociali e politiche, minate da una inconsistenza politica e da infiltrazioni fondamentaliste che ne scuotono le istituzioni dal profondo, così come la loro stabilità sociale. Se, come prevedibile, dal punto di vista bellico Israele ha inflitto una sconfitta fin troppo gravosa sia ad Hamas che alla Jihad Islamica Palestinese, distruggendo gran parte delle centinaia di chilometri di tunnel sotterranei usati come rifugio dai capi di Hamas e per trasferire armi e altro, uccidendo molti dei loro leader, lo Stato ebraico ha riscoperto di essere vulnerabile al fondamentalismo. La questione irrisolta della società israeliana nella quale, anche a causa di leggi varate non da molto, è molto ampia la frattura fra le comunità ebraica e araba, ha dimostrato nei giorni della guerra di Gaza tutta la fragilità del Paese.
Il fronte interno è sicuramente anche più preoccupante di quello esterno, in particolare quello di Gaza. Non a caso, anche quando sono cessate le armi e le sirene antirazzo, non sono finiti gli scontri tra gli arabi e la polizia israeliana nel luogo simbolo di tutto, quella spianata delle moschee che rappresenta le aspirazioni di Israele e della Palestina di controllare Gerusalemme. E gli scontri sarebbero anche “normali”, in un periodo certamente non facile anche dal punto di vista economico di una minoranza che già subisce una serie di torti, se non fossero fomentati dall’odio fondamentalista e dalla propaganda che Hamas è riuscita a insinuare nella società israeliana. Sin dal primo giorno delle rivolte e della guerra, oltre 11 giorni fa, sulla spianata e per le strade della città vecchia di Gerusalemme, così come per le strade delle città miste israeliane dove è scoppiata la rivolta tra arabi ed ebrei, le bandiere verdi di Hamas hanno accompagnato proteste, slogan e marce, scatenando la reazione veemente di polizia e civili ebrei.
Hamas, sin dall’inizio, si è accreditata come unica vincitrice della situazione, come unica forza a difesa dei palestinesi, come sola forma di resistenza all’occupazione. La sua mossa di accerchiamento di Israele che, partita da Gaza l’ha vista conquistare Ramallah e la Cisgiordania, l’ha portata ultimamente a manifestarsi fortemente anche all’interno del Paese della stella di Davide, in particolare a Gerusalemme. Un affronto per il Governo ebraico che ha opposto l’unica arma conosciuta, la forza, per reprimere il tutto.
Non importa se il teatro fossero le strade o la spianata: impensabile lasciare terreno alla propaganda di Hamas. Organizzazione questa che, non appena accettato il cessate-il-fuoco, ha moltiplicato per Israele la sua propaganda di vittoria. I leader internazionali che hanno espresso il loro plauso e soddisfazione per la fine delle ostilità, invocando ora una svolta politica, dovranno realizzare che bisogna fare i conti con una Hamas sempre più forte e rappresentativa. Se nel 2007 sono riusciti a contenerne il potere con la decisione di Abu Mazen, il grande assente di questo periodo, di estromettere l’organizzazione di Gaza dalla guida del Governo dopo le elezioni vinte l’anno prima, questa volta sarà ancora più difficile. E scendere a patti con Hamas significa legittimarne metodi, idee (come la distruzione dello Stato di Israele) e, soprattutto, protettori e padrini. A cominciare dall’Iran, convitato di pietra in tutta la questione.
È indubbio che Hamas abbia vinto la sua battaglia politica in questo round. L’avrebbe vinta anche si fossero tenute le elezioni palestinesi che, con la complicità di tutti, Abu Mazen ha cancellato (nessuno crede alla favola del rinvio). In questo ultimo caso, l’avrebbe vinta senza il troppo pesante bilancio di vittime. Anche Benjamin Netanyahu ha vinto la sua battaglia. Incapace di formare un Governo con i suoi ex delfini, ha assistito alla fine di fatto del tentativo del centrista Yair Lapid di formare una coalizione estremamente allargata che, dalla sinistra dei laburisti e di Meretz, arrivasse fino alla destra (con posizioni più radicali del Likud) di Yamina, New Hope e Israel Beitenu, passando anche per i partiti della Lista Unica dei partiti arabi. Con loro, anche il fuoriuscito Ra’am, che si era avvicinato pure a Netanyahu. Ma nessuno di questi partiti arabi sembra riuscire a intercettare il dissenso dei giovani della comunità arabo-israeliana, soprattutto gerosolimitana, nei quali si fanno sempre più largo sentimenti anti ebraici e anti israeliani. Il tutto, con buona pace di Bibi e del suo pugno duro. Non a caso gli ultimi scontri sono sì avvenuti durante il suo mandato governativo, ma mentre governava come Primo Ministro in carica in attesa che gli altri formassero una vera coalizione di Governo senza e contro di lui. Dopotutto, dal 2014, dall’ultima grande guerra con Gaza prima di questi giorni, Netanyahu ha governato ininterrottamente e Israele ha sperimentato un lungo periodo di stabilità e tranquillità, che si sono tradotte in significative affermazioni elettorali a ogni tornata.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Sono diversi i motivi che hanno portato all’escalation di violenza tra Israele e i palestinesi negli ultimi giorni.
Niente di nuovo: la pandemia ha solo congelato una situazione esplosiva che attendeva solo qualche scintilla per esplodere in tutta la sua devastazione. E di scintille, ce ne sono state diverse, a dimostrazione del fatto che la cenere aveva solo nascosto ma non spento i fuochi di rancori fra le parti. Non c’è stato un episodio scatenante, piuttosto una serie di concause hanno portato ai disastri di questi giorni. Se proprio dobbiamo individuare un punto di inizio, dobbiamo andare al 13 aprile, data di inizio del Ramadan.
Con l’enorme campagna vaccinale oramai alla fine, Israele quest’anno, agli inizi di aprile, ha permesso in presenza le cerimonie della pasqua ebraica e di quella cristiana, seppur con numeri ridotti. Partendo dalla considerazione che la comunità araba, insieme a quella ebraico-ortodossa, ha uno dei minori tassi di vaccinazione per propria scelta, le autorità hanno deciso di limitare la presenza dei fedeli musulmani sulla spianata delle moschee a 10.000. I controlli sono stati letti come impedimento a pregare liberamente e sono cominciate le proteste dei musulmani.
Le autorità israeliane hanno cominciato a controllare e bloccare gli accessi della comunità islamica sia attraverso la Porta dei Leoni che quella di Damasco. Dinanzi a questa, normalmente, i giovani arabi si riuniscono e da questa entrano anche gli ebrei ortodossi, visto che la porta si affaccia verso il quartiere di Mea Shearim. Questo ha scatenato proteste, per cui da una parte sono arrivati ebrei ortodossi al grido di “morte agli arabi”, dall’altro, al grido di “Allah Akhbar, questa terra ha bisogno del sangue” manifestanti arabi si sono scontrati con la polizia. In un gesto di distensione, la polizia dopo qualche giorno ha rimosso le barriere. Ma oramai, era troppo tardi. Anche perché nel frattempo due episodi avevano contribuito a esacerbare gli animi. Accusando Israele di non aver permesso il voto a Gerusalemme, il Presidente palestinese Mahmoud Abbas (Abu Mazen) ha bloccato (non si sa se cancellato o sospeso) le elezioni previste per fine maggio. All’annuncio di Abu Mazen, Hamas ha protestato, chiedendo di tenere comunque le elezioni. Le proteste si sono poi spostate al quartiere di Gerusalemme est di Sheikh Jarrah, che prende il nome dal medico del condottiero Saladino e ospita la tomba di un venerato rabbino del terzo secolo avanti Cristo.
Qui un ordine del tribunale chiede lo sfratto forzato di alcune famiglie palestinesi per dare la casa a quelle ebraiche. Dopo che nel 1948, alla creazione dello Stato di Israele, centinaia di migliaia di palestinesi persero la loro casa, nel 1956 ventotto famiglie palestinesi furono messe in questo quartiere dalla Giordania, che controllava Gerusalemme est, su autorizzazione dell’organizzazione Onu per i rifugiati. Ebbero la promessa di ottenere un certificato di possesso della terra in cambio della loro rinuncia allo status di rifugiato, ma la Giordania non lo fece mai. Nel 1967, con la Guerra dei Sei Giorni, Israele prende il controllo e la Giordania lo perde; le famiglie, che nel frattempo diventano 38, continuano a pagare un affitto simbolico. Comunità ebraico-ortodosse recuperano documenti che provano la loro proprietà sull’area dal 1885 e si appellano al tribunale israeliano che dà loro ragione. Già diverse famiglie sono state cacciate, quattro lo dovrebbero essere adesso e una ad agosto. Il punto è che la legge che permette loro di chiedere le case non si applica però alle migliaia di palestinesi che hanno abbandonato le loro case nel 1948, alla nascita di Israele.
Situazioni già viste in altre zone e nella città vecchia, dove si sta cercando di de-arabizzare la zona e aumentare la presenza ebraica, tant’è vero che gli arabi se costretti preferiscono cedere le case alle chiese. Per tentare di calmare la situazione, il premier del Governo israeliano ha chiesto al tribunale di rimandare la decisione prevista per questi giorni sugli sfratti forzati, ma si tratterà solo di rinviare una decisione di fatto già presa. Hamas, sfruttando il crollo di consensi di Fatah e del Presidente Abu Mazen e la vacuità della politica palestinese, ha infiammato gli animi dei giovani palestinesi esasperati. Bandiere di Hamas sono state issate sulla Spianata e quelle israeliane bruciate. La polizia è intervenuta, dopo che Hamas aveva minacciato attacchi a Israele, scatenando la rabbia per gli interventi nel luogo sacro. Per non esacerbare ancora, si è deciso di cancellare la marcia degli ebrei che ricordavano il giorno, del 1967, nel quale Israele conquistò Gerusalemme.
Ma la propaganda di Hamas oramai era partita, e dalla spianata delle moschee si è spostata a Gaza, da dove, da lunedì, sono stati lanciati oltre un migliaio di razzi. I primi sette in direzione di Gerusalemme, cosa che non accadeva da anni. Nelle ore e giorni successivi verso il sud del Paese, verso Tel Aviv, verso l’aeroporto. Scontata la risposta israeliana, con numerosi raid e diverse vittime. La protesta si è di nuovo spostata nelle città, dove Hamas, che nel frattempo ha proclamato la sua vittoria su Gerusalemme, ha spinto giovani arabi, stavolta con passaporto israeliano, ad attaccare case, negozi, auto e sinagoghe ebraiche. In uno scontro interno che preoccupa non poco, più dei razzi.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Benjamin Netanyahu non ce l’ha fatta e dopo 28 giorni ha dovuto rimettere al Presidente Rivlin il mandato di formare un nuovo Governo. Non è riuscito a mettere insieme i 61 parlamentari necessari che gli garantissero una maggioranza alla Knesset. E il Presidente Rivlin dopo consultazioni lampo, ha deciso di concedere lo stesso tempo per un nuovo tentativo a Yair Lapid, l’ex giornalista a capo di Yesh Atid, partito di centro che si era piazzato al secondo posto dietro il Likud di Netanyahu alle scorse elezioni di marzo.
Rivlin aveva tre possibilità: rinnovare per altre due settimane l’incarico a Netanyahu, dare l’incarico a un altro o mandare l’incarico al Parlamento, decisione con la quale l’assemblea avrebbe potuto nominare qualsiasi parlamentare a capo di un Governo anche senza la maggioranza. Scartata la terza ipotesi, da riservarsi come ultimo tentativo, scartata la prima dopo che aveva dimostrato, il Presidente, il suo “mal di pancia” nel dover dare in prima battuta il mandato a un premier incaricato sotto processo, Rivlin ha optato per la seconda e Lapid è risultato il più appoggiato dai partiti.
Diversamente da quanto accaduto un mese fa, questa volta verso Lapid si sono orientati anche i parlamentari di Gideon Sa’ar e del suo New Hope e la maggioranza della Lista Araba Unita, che in prima battuta non lo avevano sostenuto, facendo arrivare i consensi a 56 seggi, comunque sotto la maggioranza di 61. Lapid è al lavoro con Naftali Bennett, il capo del partito di destra Yamina, ex delfino di Netanyahu, per formare un Governo di coalizione che vada dalla sinistra dei Laburisti e di Meretz alla destra di Yamina, New Hope e Israel Beitenu, il partito russofono di Lieberman, passando per gli arabi. Proprio Bennett era stato tentato da Netanyahu di entrare in un suo Governo, magari con premierato a rotazione, ma non ci si è accordati. Stessa offerta da parte di Lapid, con Bennett che dovrebbe servire per primo.
Netanyahu e i suoi già parlano di Governo di centro-sinistra e accusano questi partiti, soprattutto Bennett di tradire le promesse elettorali, oltre a ritenerlo responsabile se si dovesse andare alle nuove elezioni. Dopotutto, un Governo che andasse dal Likud all’estrema destra, passando per Bennett, pareva la scelta più ovvia, ma le frizioni ataviche dei leader di Likud e Yamina non hanno aiutato e, soprattutto, le posizioni degli ortodossi ebrei, in particolare quelle dei kahanisti (movimento omofobo e ultra-ortodosso ebraico), che non considerano Bennett leader affidabile.
Se è possibile che entro il 2 giugno, quando scade il mandato esplorativo, si presentino a Rivlin con un Governo di minoranza (alcuni parlamentari di Yamina già stanno scalpitando per lasciare nel caso di un Governo con le sinistre) o che riescano a guadagnare qualche voto per arrivare ai 61 necessari ad assicurarsi la maggioranza della Knesset, è altrettanto probabile che non riescano nel loro intento. Questo perché anche in una fase di ricostruzione e di necessità di unità nazionale al termine di una pandemia come quella che Israele sta per superare, è altrettanto chiaro che le anime all’interno di questa formazione sono troppo diverse per riuscire a stare insieme senza scossoni. Rivlin lo sa bene e le sta tentando tutte per offrire stabilità al Paese.
Ma il suo mandato scadrà a luglio e l’attuale Knesset dovrà votare il successore. E se questo successore fosse Netanyahu? La cosa potrebbe certamente favorire la nascita di un Governo Lapid-Bennett e della sua durata per più tempo possibile, ma resterebbero tante le differenze. E in questo momento, il Paese ha bisogno solo di stabilità, non di nuove elezioni, che sarebbero le quinte in due anni e mezzo. Arrivati dove siamo, una delle priorità per il nuovo Parlamento sarebbe quella di rivedere la legge elettorale, che possa aumentare il premio di maggioranza e alzare il quorum di accesso, così da garantire migliore stabilità a chi vince le elezioni.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Entro la fine della settimana da Ramallah si dovrebbe svelare il segreto di Pulcinella: le elezioni nei Territori Palestinesi, previste in tre tornate a partire dal 22 maggio, non si terranno. Non si sa se cancellate o solo rimandate. In verità sono pochi coloro i quali hanno creduto che i palestinesi quest’anno, dopo 15 anni di attesa, sarebbero stati chiamati a maggio per eleggere il loro Parlamento, a luglio il loro Presidente e ad agosto il Parlamento dell’Olp.
Che Mahmoud Abbas (Abu Mazen) non avesse alcuna intenzione di cedere il potere era chiaro e i dati elettorali degli ultimi tempi, associati a una politica suicida di Fatah, ha messo il partito che fu di Yasser Arafat in una situazione di inferiorità rispetto a tutti. Per la stampa libanese e per alcuni funzionari egiziani, il Presidente dell’Autorità Palestinese avrebbe già deciso di rinviare o cancellare le elezioni previste per il prossimo 22 maggio. La motivazione risiederebbe nell’impossibilità di tenere le elezioni anche a Gerusalemme est per il rifiuto israeliano, rifiuto che in verità non c’è mai stato.
Fino a oggi, le autorità israeliane non hanno mai annunciato né smentito che permetteranno, come già successo nel 2006, le elezioni palestinesi anche a Gerusalemme est. In particolare un alto funzionario del Ministero degli Esteri israeliano ha ribadito che il suo Paese non intende bloccare o essere coinvolto nelle elezioni palestinesi. Lo ha detto il direttore politico del Ministero degli Esteri Alon Bar agli ambasciatori europei, dopo che questi si sono incontrati con Bar per sottolineare “l’importanza delle elezioni democratiche nei Territori Palestinesi per rafforzare la partecipazione e la responsabilità politica, nonché i controlli e gli equilibri democratici”, secondo alcuni tweet pubblicati da molte ambasciate.
L’Unione europea e i singoli Paesi del vecchio continente avevano più volte richiesto a Israele di non impedire le operazioni di voto palestinesi, arrivando anche a proporre un voto online che è stato però respinto come possibilità dal Governo di Ramallah. Dopotutto Israele avrebbe potuto addurre motivi di ordine pubblico, visto che da giorni si registrano scontri tra la comunità araba e quella ebraica prima e poi con la polizia, dinanzi alla porta di Damasco, una delle otto porte della città vecchia di Gerusalemme, attraverso la quale sia arabi che ebrei raggiungono i loro luoghi sacri.
Tutto è cominciato con le restrizioni del Ramadan, per il quale la polizia ha cercato di impedire ai non vaccinati di salire sulla spianata. Gruppi della destra ebraica hanno marciato contro gli arabi al grido di “morte agli arabi” mentre questi, al grido di “Allah Akbar” hanno attaccato ebrei e polizia. Scontri anche a Sheikh Jarrah, storico quartiere di Gerusalemme est, a causa di allontanamenti forzati di residenti arabi da case che rivendicano gli ebrei. Ma la polizia israeliana, dopo giorni di assedio, ha anche tolto le barriere dinanzi alla porta di Damasco, riducendo le tensioni. Neanche il dossier di 213 pagine di Human Right Watch che definisce Israele Stato apartheid ha sortito alcun effetto, se non la reazione di pragmatica di Israele e l’ovazione di Ramallah che, comunque, impedendo di fatto le elezioni da 15 anni e bloccando i contribuiti a Gaza, all’interno del suo territorio opera comunque una sorta di apartheid nei confronti dei palestinesi. Sia il giornale libanese Al-Akhbar che il network emiratino Al Arabiya riportano la notizia che Abu Mazen avrebbe già informato i Paesi europei, la Giordania e l’Egitto della decisione di non tenere le elezioni; non è chiaro se sospenderle per rinviarle a data certa o cancellarle per il momento. Il media di Dubai cita anche fonti dell’intelligence egiziana, che ha lavorato molto nei mesi scorsi per ricucire lo strappo tra Fatah e Hamas e portare il Paese alle prime elezioni dopo 15 anni, per ribadire che i vertici palestinesi avrebbero già deciso sul non tenere la tornata elettorale.
Da diversi giorni, sia il Presidente palestinese che il Primo Ministro Sthayyeh hanno ribadito che senza Gerusalemme est non si sarebbero tenute le elezioni, per una questione politica, perché avrebbe significato accettare il controllo israeliano sulla città che da Ramallah considerano la capitale. Hamas però si è dichiarata contraria alla scelta e spinge affinché si tengano lo stesso le consultazioni, forte del suo consenso elettorale che lo da in testa rispetto a Fatah. Secondo molti osservatori, quella di Gerusalemme est sarebbe solo una scusa per Abbas per non perdere il potere, dal momento che lui e Fatah sono dati dietro a molti altri. Decisione, quella del non tenere le elezioni, che se da un lato priva per l’ennesima volta il popolo palestinese di un legittimo esercizio democratico, riduce il rischio per Stati Uniti, Israele e molte potenze occidentali che considerano Hamas gruppo terrorista, di trovarsi questi come interlocutori, come accadde nel 2006.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

È forte la tensione tra Israele e Iran dopo l’esplosione avvenuta domenica nella centrale nucleare iraniana di Natanz. Dell’episodio, che ricalca uno simile nella stessa struttura avvenuto a luglio dell’anno scorso, Teheran accusa Gerusalemme e di risposta una nave israeliana è stata attaccata nel golfo persico. Secondo le informazioni di intelligence, un ordigno introdotto di nascosto ne complesso sarebbe stato fatto esplodere a distanza provocando non solo danni materiali e buche, ma anche la distruzione del sistema elettrico principale e di quello secondario, cosa che ha bloccato tutti i reattori. Ci vorranno mesi per ristabilire il tutto e Teheran ha annunciato vendetta.
L’Iran intanto annuncia che arricchirà uranio per il 60%, nonostante a Vienna si stia tentando di discutere per rimettere tutto sul giusto binario, dopo anche le aperture americane verso nuovi negoziati e una revisione delle sanzioni. Israele però contesta questa posizione e chiede più fermezza contro Teheran. Il Ministro degli Esteri iraniano, Javad Zarif, ha accusato Israele di essere responsabile dell’accaduto, unendo la sua voce a quella di numerosi funzionari iraniani che descrivono l’incidente come sabotaggio o “terrorismo”. “I sionisti vogliono vendicarsi a causa dei nostri progressi nel modo di revocare le sanzioni e hanno pubblicamente detto che non lo permetteranno. Ma ci vendicheremo dei sionisti”, ha detto Zarif. Domenica pomeriggio, il capo dell’organizzazione iraniana per l’energia atomica, Ali Akbar Salehi, aveva già parlato di un atto di “terrorismo nucleare”. Secondo lui l’attacco è stato compiuto da “oppositori del progresso industriale e politico del Paese, che mirano a prevenire lo sviluppo di una fiorente industria nucleare”.
I canali 11 e 13 della televisione israeliana hanno riferito che, secondo fonti dell’intelligence occidentale, si sarebbe trattato di un attacco informatico compiuto dal Mosad che avrebbe causato danni persino maggiori di quelli riferiti dalle autorità iraniane. Ipotesi però smentita dal New York Times, che sostiene che è stata una detonazione di esplosivi a causare i danni alla centrale di Natanz. L’attacco arriva quasi una settimana dopo che una nave iraniana sarebbe stata attaccata nel Mar Rosso, un attacco che il New York Times aveva attribuito a Israele. La nave mercantile, in realtà, sarebbe stata una base militare iraniana. Il giornale americano, citando fonti dell’intelligence americana e israeliana, afferma che l’esplosione avvenuta domenica nel sito nucleare iraniano di Natanz ha inferto un duro colpo alla capacità del Paese di arricchire l’uranio e potrebbe richiedere almeno nove mesi per essere ripristinata. Lunedì il portavoce del Ministro iraniano, Saeed Khatibzadeh, ha detto in conferenza stampa che l’incidente potrebbe essere considerato un “atto contro l’umanità”: “Non ci sono state contaminazioni o feriti, ma potrebbe comunque causare un disastro”. Israele non ha né confermato né smentito i rapporti, ma domenica il Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha detto che “la lotta contro l’Iran è un compito enorme”.
L’incidente al sito nucleare di Natanz si è verificato lo stesso giorno in cui il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin ha incontrato il Ministro della Difesa Benny Gantz in Israele, segnando la prima visita ufficiale di un funzionario statunitense da quando il Presidente Joe Biden si è insediato a gennaio.
Gantz si è impegnato a cooperare con gli Stati Uniti sull’Iran. “Lavoreremo a stretto contatto con i nostri alleati americani – ha detto Gantz – per garantire che qualsiasi nuovo accordo con l’Iran garantisca gli interessi vitali del mondo e degli Stati Uniti, impedisca una pericolosa corsa agli armamenti nella nostra regione e protegga lo Stato di Israele”. Nelle sue osservazioni pubbliche, Austin non ha parlato specificamente dell’Iran. “Le nostre relazioni bilaterali con Israele in particolare sono fondamentali per la stabilità e la sicurezza regionale in Medio Oriente; – ha dichiarato Austin – durante il nostro incontro ho ribadito al Ministro Gantz che il nostro impegno nei confronti di Israele è duraturo ed è solido”.
Sabato il Presidente iraniano, Hassan Rouhani, aveva ribadito l’impegno dell’Iran per la non proliferazione nucleare. Lo stabilimento di Natanz, che si trova nel deserto nella provincia centrale di Isfahan, è il fulcro del programma iraniano di arricchimento dell’uranio ed è monitorato dagli ispettori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica. Nel luglio dello scorso anno, nella stessa centrale di Natanz si era già verificato un incendio e secondo il Governo si era trattato un tentativo di sabotare il programma nucleare iraniano. Nel 2010, era stato individuato un virus informatico, lo Stuxnet, che si ritiene essere stato sviluppato dagli Stati Uniti e da Israele, per attaccare Natanz. L’Iran ha incolpato Israele anche per l’uccisione lo scorso anno di Mohsen Fakhrizadeh, considerato dai servizi segreti occidentali come la mente di un programma di armi nucleari iraniano sotto copertura.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Ancora una volta, il pallino della politica e del Governo israeliano è nelle mani di Benjamin Netanyahu, il più longevo Primo Ministro della storia di Israele. È a lui che martedì il Presidente Reuven Rivlin ha concesso 28 giorni per trovare la quadra e formare un Governo, dopo le elezioni dello scorso 23 marzo.
Un incarico dato non senza esitazioni. Rivlin non ha nascosto certo il suo “non entusiasmo” per la decisione che riflette solo il seguire la legge, considerando che Bibi è nel pieno del processo che lo vede imputato in tre casi penali. Il Presidente Rivlin ha detto che la sua decisione è stata presa tenendo in considerazione chi sia in grado di formare al meglio un Governo che possa ricevere la fiducia della Knesset (il Parlamento israeliano) e che nessun altro candidato può soddisfare al momento questa condizione. “Ho l’impressione che nessuno dei candidati abbia la possibilità di formare una coalizione”, ha detto Rivlin, non nascondendo che sia problematico nominare un candidato attualmente sotto processo, ma poiché la Corte Suprema lo ha dichiarato ammissibile, lui ha deciso di rimanere fuori da quel dibattito. “Il Presidente non può sostituire i legislatori”, ha detto Rivlin.
Durante le consultazioni con i 13 partiti eletti alla Knesset, Netanyahu ha ottenuto la maggior parte dei consensi (da parte di 53 membri appartenenti a 4 partiti); 45 membri hanno invece proposto la nomina di Yair Lapid, leader di Yesh Atid. Il partito di destra Yamina ha proposto l’incarico al proprio leader Naftali Bennet, mentre la lista araba Ra’am, quella Araba Unita e il partito di destra New Hope dell’ex delfino di Netanyahu, Gideon Sa’ar, non hanno proposto alcuno.
Secondo gli analisti, la decisione di Yamina risiede nel voler vedere cosa Netanyahu ha da offrire ed entrare eventualmente in un secondo tempo per ottenere l’incarico. Sia Netanyahu che Lapid hanno offerto a Yamina di entrare nel Governo, con il secondo che ha proposto una Governo di coalizione con la rotazione del premierato, prima a Bennet e poi a Lapid. “Il Presidente non aveva scelta”, ha dichiarato Lapid, “Ma dare il mandato a Netanyahu è vergognoso e macchia Israele”. E così Netanyahu ha di nuovo il pallino in mano e si aprono alcuni scenari. Il primo vede il capo del Likud riuscire a convincere Yamina e altri esuli della destra a entrare in una coalizione destrorsa e formare un Governo stabile. Il secondo vede un appoggio esterno degli arabi di Ra’am, contro i quali però hanno messo il veto gli alleati kahanisti e ultra destrorsi di Netanyahu, per un Governo di minoranza. Il terzo prevede la rinuncia all’incarico e la possibilità per il gruppo dei “contro” Netanyahu, uno schieramento che va dalla sinistra di Meretz e dei laburisti, passando per gli arabi della Lista Congiunta, al centro del Blu e Bianco e di Yesh Atid (questo è il secondo partito, il Likud, e il suo capo, Yair Lapid è l’antagonista di Netanyahu alla premiership), fino ai partiti di destra di New Hope e Yisrael Beiteinu, di tentare di formare un Governo.
Ma un esecutivo così ampio e diverso, con posizioni tra loro così distanti il cui unico collante è solo il sentimento anti Netanyahu, quanto può durare? L’esempio del precedente Governo con l’accordo Netanyahu/Gantz è lampante, anche se in questo caso il tranello tirato al leader del Blu e Bianco era chiaro, dal momento che Bibi aveva tutto l’interesse a non cedere la poltrona di premier per mantenere la sua immunità. Le elezioni, le quinte, potrebbero essere una ennesima possibilità, soprattutto in chiave processuale, perché darebbero la possibilità a Netanyahu di consolidare i numeri del Likud e aspirare a una maggioranza più decisa. Ma c’è un’altra incognita ed è rappresentata dalla scadenza a luglio del mandato presidenziale di Rivlin. La “pazza idea”, potrebbe essere quella di formare quindi adesso un Governo di destra non guidato da Netanyahu ma da Lapid o dagli altri partiti di destra, magari da Bennet, e Netanyahu eletto Presidente di Israele. Le elezioni dovrebbero avvenire tra aprile e giugno. Per la legge fondante di Israele, il Presidente dura in carica 7 anni e gode dell’immunità. Quanto pazza è questa idea?
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Non si diradano le nubi sul cielo di Israele che attende un Governo stabile dopo troppi anni. Quattro elezioni in due anni non sono state sufficienti per dare al Paese un esecutivo con l’avallo delle urne e lo spettro di altre elezioni è sempre più incombente.
Oggi il Presidente Reuven Rivlin, che finirà a luglio il suo mandato, ha ricevuto dal giudice della Corte Suprema e capo della commissione elettorale centrale, Uzi Vogleman, i risultati finali e ufficiali delle elezioni dello scorso 23 marzo. Nessuno scossone, nessuna novità, ma un quadro definito di instabilità, nella quale l’unica cosa che emerge forte, è una contrapposizione di due gruppi che girano intorno a una sola figura: Benjamin Netanyahu.
Come era emerso dagli exit poll, infatti, si sono definiti due gruppi distinti molto definiti, i “pro” e i “contro” il premier più longevo della storia di Israele. I “pro”, che oltre al Likud vedono i partiti di estrema destra ortodossi e tra loro anche i kahanisti, gli ebrei contrari a tutte le comunità non ebraiche o che non ne rispettano le leggi, come arabi, fedeli di altre religioni e alla comunità LGTB, hanno bisogno di nove seggi per raggiungere i sessantuno necessari per avere la maggioranza in Parlamento e presentare a Rivlin il nome di Netanyahu per il premierato.
Bibi e i suoi hanno cominciato le grandi manovre. Prima hanno cercato di convincere singoli parlamentari a entrare nel loro gruppo. Poi hanno flirtato con il partito arabo Ra’am, che il premier ha contribuito a far uscire dalla Lista Araba Unita e dal quale ha ottenuto la promessa di un appoggio esterno. Infine, si sta facendo sempre più forte il pressing su Naftali Bennet e il suo Yamina, un tempo alleati di Netanyahu (è stato, il leader del partito, anche Ministro della Difesa in uno dei Governi di Netanyahu e capo della sua segreteria), ora ago della bilancia. Netanyahu si è anche appellato a tutti i partiti di destra, anche quelli dei suoi ex amici e alleati, affinché costruiscano insieme il nuovo Governo. Anche con i soli voti di Yamina, il gruppo dei “pro” Netanyahu resta sotto la soglia dei 61, mancano ancora due voti all’appello. Per questo, il premier, che fino a ora non ha parlato, punterebbe a un Governo di minoranza, magari affidatogli in seconda battuta, con l’appoggio esterno degli arabi.
Dall’altro lato, alla coalizione “contro” Netanyahu che, dai partiti di sinistra Labor e Meretz, passando per gli arabi della lista unita, al centrista Yar Lapid (secondo nei voti dietro il Likud con il suo Yesh Atid), al Blu e Bianco di Benny Gantz, fino ai partiti di destra New Hope dell’ex Likud e delfino del premier Gideon Sa’ar e al partito dei russofoni di Avigdor Liberman, mancano 4 seggi. Per questo, il pressing non solo è su Yamina affinché passi da quest’altro lato della barricata, ma si sta anche cercando di convincere Ra’am. E, i partiti di destra della coalizione stanno facendo pressioni su Lapid affinché rinunci alle sue velleità del premierato, che gli competono visto che il suo è il primo partito della coalizione, per offrirlo a Bennet in cambio dell’adesione. L’idea sarebbe quella di andare verso un premierato a rotazione, con Bennet che comincia per primo e Lapid a seguire. Certo è che una coalizione così ampia, anche se unita dal sentimento anti Netanyahu, potrebbe avere vita difficile.
Come potranno convivere i labouristi e gli arabi con gli esponenti della destra che non vogliono sentire parlare di stato palestinese, è ancora da spiegare. Lo sa bene Rievlin che oggi, ricevendo i dati finali, ha auspicato che possano esserci, per formare la coalizione di Governo, anche “collaborazioni insolite” tra partiti per trovare a quadra e dare al Paese un Governo stabile, allontanando il pericolo di nuove elezioni. Il Likud, dopo che il Presidente Rivlin ha fatto appello all’unità anche attraverso le “collaborazioni insolite”, considerando questo come un sostegno alla coalizione anti Netanyahu, ha protestato in tutti i consessi, ricordando anche duramente al Presidente il suo ruolo super partes. Intanto, il 5 aprile sarà anche la data dell’inizio del processo che vede imputato, in tre casi, Benjamin Netanyahu. E due giorni dopo, Rivlin dovrebbe annunciare il nome della persona a cui affiderà l’incarico di formare il nuovo Governo.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Con la quasi totalità dei voti scrutinati nelle quarte elezioni in due anni per Israele, due sono le certezze: il Likud di Benjamin Netanyahu è il primo partito, non smuovendosi dal suo blocco di consensi e nessuna coalizione riesce ad avere la maggioranza per governare. Quello che praticamente è successo in ogni elezione da due anni a questa parte. Ora sarà solo un gioco di apparentamenti, alcuni dei quali paiono davvero azzardati.
Se infatti il Likud e gli alleati storici della destra ortodossa ebraica (Shas, United Torah in Judaism e Religious Zionism) pare abbia bisogno di almeno 9 seggi per raggiungere la maggioranza di 61 seggi necessari per governare, mettendo insieme tutto il fronte anti Netanyahu, che va dalla sinistra alla destra estrema passando per gli arabi, arriva a 56 seggi. Il fulcro di questa alleanza è Yar Lapid, l’ex giornalista a capo di Yesh Atid. Lui è quello che, insieme a Benny Gantz, formò l’alleanza Blu e Bianco per poi romperla quando l’ex capo di Stato maggiore si accordò con Netanyahu per un Governo di coalizione e premierato a rotazione.
Gli exit poll gli danno 17 seggi e potrebbe essere fatto il suo nome per la premiership. A sostenerlo, da un lato i partiti di sinistra, Labor e Meretz, che parevano scomparsi e che invece oltre a superare la soglia di sbarramento del 3,25% otterrebbero rispettivamente 7 e 5 seggi. Dall’altro, i partiti di destra di New Hope dell’ex delfino di Netanyahu Gideon Sa’ar e il partito russofono Yisrael Beiteinu. In mezzo anche il redivivo Benny Gantz. Tutti dovrebbero avere anche l’appoggio della Lista Araba Unita che, orfana del partito Ra’Am scenderebbe a 6 dei 15 seggi. L’unico collante di questa coalizione, sarebbe il sentimento anti Netanyahu. Se è vero che in politica nulla è definito e sicuro, come potrà però avere vita semplice una coalizione che mette insieme partiti arabi e anti, partiti di destra e di sinistra?
Certo, la volontà di far terminare il “regno” di Netanyahu è forte, ma il Presidente Reuven Rivlin, il cui mandato scadrà fra qualche mese, ci dovrà pensare molto prima di aprire a questo tipo di alleanza. L’alternativa sarebbe il voto. Il quinto. Troppo, per cui si potrebbe ingoiare il boccone amaro di un altro esecutivo a guida Netanyahu, con l’appoggio dell’ex suo sodale Naftali Bennet e del suo Yamina e, soprattutto dell’arabo Ra’am che, proprio per i contatti avuti in campagna elettorale con il premier più longevo della storia di Israele, ha rotto l’alleanza dei quattro partiti arabi.
Ra’am ha rosicchiato non pochi voti e i seggi non solo della lista araba unita, ma anche, a causa del sistema proporzionale, proprio del Likud e dei partiti di destra storici alleati di Netanyahu. Improbabile un suo ingresso nel Governo, ma non improbabile un sostegno esterno. Dopotutto, Netanyahu ha promesso loro che avrebbe realizzato un Ministero per i palestinesi con un palestinese, il primo, inserito in lista del Likud. Ma Ra’am ha aperto alla possibilità di sostenere anche lo schieramento anti Netanyahu, per cui i giochi non sono ancora fatti. Per ora vige il divieto di parlare per tutti, per non fare promesse o proclami che poi verrebbero sconfessate poco dopo o potrebbero inficiare le alleanze. Bisognerà attendere venerdì per i dati finali e le consultazioni che convocherà Rivlin per capire come evolverà. Mentre si attendono i risultati, tra quelli che sono alla finestra ad attendere, spiccano Ramallah e Washington.
Anche nei Territori Palestinesi è momento di apparentamenti per le elezioni, le prime in 15 anni, che si terranno a partire da maggio. Dopo che Hamas e Fatah nei giorni scorsi hanno annunciato che non correranno nella lista unita – decisione presa soprattutto per non urtare la suscettibilità di quei Governi che non vedono di buongrado un Governo del partito che controlla Gaza -, un sondaggio ha dimostrato che nessuno dei due potrà avere la maggioranza per governare, ma si dovrà apparentare con i partiti più piccoli o con l’altro contendente maggiore. Il sondaggio del Palestinian Center for Policy and Survey Research ha rilevato che se le elezioni si tenessero oggi Fatah avrebbe il 43% dei voti e Hamas il 30% e circa l’8% voterebbe per varie altre fazioni, con il 18% di elettori indecisi. Ma una potenziale lista di Mohammed Dahlan, l’ex leader di Fatah che vive negli Emirati, cacciato da Abbas e condannato in patria, guadagnerebbe il 10%. E Nasser al-Qidwa, che è stato espulso da Fatah, nipote di Arafat, potrebbe vincere il 7%. Preleverebbero principalmente voti da Fatah, facendo scendere la sua quota a circa il 30%.
Anche Washington guarda alle elezioni israeliane, per cominciare una nuova fase. Dopo la politica totalmente filo israeliana di Trump, l’amministrazione Biden si sta muovendo su terreni diversi. Ieri si è riunito per la prima volta in tre anni il quartetto di mediatori (Stati Uniti, Russia, Unione europea e Onu,) sulla crisi israelo-palestinese. Il quartetto ha chiesto ad entrambe le parti di evitare decisioni e mosse unilaterali per tornare a discutere. Qualche giorno fa da Washington è giunta la notizia che, diversamente dal piano di pace presentato da Trump, l’amministrazione Biden starebbe lavorando a una soluzione a due stati entro i confini del 1967. Soluzione anacronistica secondo i più.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

A una settimana dalle elezioni politiche in Israele, le quarte in due anni, ancora nessun partito o coalizione, secondo gli ultimi sondaggi diffusi nel Paese, ha la maggioranza per governare. Sondaggi che però riservano sorprese: se da un lato il Likud del premier Benjamin Netanyahu perde consensi rispetto al numero di seggi conquistati nell’ultima elezione di aprile, Netanyahu risulta vincente in tutti gli scontri diretti per il premierato. Ma, per arrivarci, dovrà realisticamente lavorare molto diplomaticamente per assicurarsi sostegni anche da suoi acerrimi nemici. Ma la politica, e la storia recente di Israele lo ha dimostrato, riserva sempre sorprese e nonostante il crollo di consensi al suo partito e i problemi non irrisori di politica internazionale, Netanyahu dovrebbe farcela.
Secondo gli ultimi sondaggi diffusi da Channel 12 e Channel 11, il partito di Netanyahu è salito a 30 seggi, dopo aver toccato 26 seggi, in discesa rispetto ai 36 ottenuti lo scorso marzo. A settembre del 2019, il Likud era arrivato a 32 seggi mentre nelle elezioni precedenti di aprile dello stesso anno, aveva ottenuto 35 seggi. Colpisce quindi il calo del partito, che paga la fuoriuscita di un pezzo grosso come Gideon Sa’ar, per molto tempo considerato il delfino di Netanyahu, e che con il suo neonato partito New Hope si attesta sui 10 seggi. Improbabile che questi possa sostenere il più longevo premier nella storia di Israele, per un altro mandato. L’unica possibilità per Netanyahu pare essere ottenere l’appoggio di Naftali Bennet, l’ex Ministro della Difesa che ha rotto in passato con Netanyahu e che è a capo della coalizione di destra Yamina. Channel 12 gli da 10 seggi, ma Channel 11 al partito di Bennet assegna due seggi in più che, uniti a quelli dei partiti religiosi Shah e United Torah in Judaism, farebbero arrivare questo gruppo a 62 seggi, uno in più della maggioranza dei 120 parlamentari della Knesset, necessari per ottenere l’incarico.
Ma è tutto molto precario e i numeri differiscono, seppur di poco, in maniera sostanziale, perché l’acquisto o la perdita di un seggio potrebbe determinare la maggioranza. Lo stesso problema ce l’hanno anche i partiti di destra che si oppongono a Netanyahu, da quello di Sa’ar a quello dei russofoni guidati da Avigdor Liberman. Anche qui, con l’appoggio di Bennet, non si riuscirebbe ad arrivare alla maggioranza.
Fuori dai giochi, almeno di improbabili accordi e sorprese, il gruppo di centrosinistra. Se infatti il partito Laburista, che però non è sicuro, come non lo è l’altro partito di sinistra, Meretz, di superare la soglia di sbarramento del 3,25%, ha annunciato che sosterrà il candidato centrista Yair Lapid e il suo Yesh Atid, questi, raggranellando tutto, arriverebbe a 58 seggi. Lapid, ex giornalista, è stato il fondatore, insieme a Benny Gantz, della coalizione Blu e Bianco ed è diventato il capo dell’opposizione quando l’ex generale ha accettato di entrare nel Governo con Netanyahu e di cadere nella trappola del premierato a turno. Allo stato attuale, Gantz è fuori da qualsiasi gioco e Lapid deve contare sul supporto di tutti, in chiave anti Netanyahu. Anche della lista araba, che lo stesso premier ha contribuito a scindere. Dai quattro partiti originari, tre sono rimasti compatti contro Netanyahu, mentre uno, Ra’am, si è detto disponibile a sostenerne un nuovo Governo del Likud se questi si impegna veramente nel migliorare le condizioni di vita degli arabi-israeliani. Proprio per questo, Netanyahu ha indirizzato più volte la sua campagna elettorale e le sue visite alle città a maggioranza araba. Ma Ra’am si è resa disponibile a sostenere anche Lapid, mentre gli altri partiti arabi non vogliono sentire assolutamente parlare di un altro Governo Netanyahu.
Intanto, alla domanda su chi fosse più adatto a essere il Primo Ministro, il 37% degli intervistati ha risposto Netanyahu, il 21% Lapid, il 10% il capo di Yamina Naftali Bennett e il 9% Gideon Sa’ar, il capo di New Hope. Il successo di Netanyahu deriva dal fatto che sono in molti quelli che considerano buona la sua gestione della pandemia.
Netanyahu sa che il successo passa attraverso gli arabi e così ha cercato di fare di tutto per accreditarsi verso i Paesi arabi. La settimana scorsa sarebbe dovuto volare negli Emirati Arabi Uniti, la prima visita dopo la firma l’anno scorso degli accordi di Abramo, ma ha dovuto rimandare la visita per un problema con la Giordania. Questa infatti, dopo che la delegazione del principe ereditario si era vista rifiutare l’ingresso da Israele al confine per la presenza di più agenti di scorta con conseguente ritorno indignato ad Amman, ha impedito il sorvolo dello spazio aereo agli aerei israeliani. Cosa che poi ha fatto anche Israele sul proprio spazio aereo per gli aerei giordani. Netanyahu ha quindi annunciato, dopo che la visita è stata cancellata quattro volte, che sarebbe andato giovedì negli Emirati, ma da Abu Dhabi hanno espresso tutta la loro irritazione perché considerano la visita uno spot elettorale di Netanyahu e non vogliono essere trascinati in questa contesa.
Venerdì saranno pubblicati gli ultimi sondaggi e martedì sarà l’Election Day, che non promette, ancora una volta, stabilità al Paese.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Sono finite con un risultato annunciato dal punto di vista dell’esito ma con molta fibrillazione e un chiaro messaggio politico, le elezioni interne di Hamas, il gruppo ritenuto terrorista da molti Paesi, che governa Gaza. Nel silenzio che contraddistingue tutte le operazioni del movimento, che nel 2006 vinse le elezioni palestinesi ma che non ha quasi mai governato, i membri del comitato politico hanno eletto di nuovo a capo del partito a Gaza, Yahya Sinwar, che era stato già eletto allo stesso ruolo nel 2017.
Non senza problemi, questa volta. Un paio di giorni fa, infatti, i giornali libanesi avevano parlato di una sconfitta di Sinwar alle elezioni a opera di Nizar Awadallah, uno dei leader storici del movimento. Ma poi mercoledì Hazim Qasim, portavoce di Hamas, in un comunicato ha annunciato la vittoria di Sinwar per un secondo mandato, fino al 2025. Su quanto sia successo, è ovviamente calato il silenzio e neanche i numeri ufficiali si conoscono, perché i risultati dovranno essere sottoposti per l’approvazione all’Hamas Shura Council, l’organismo semi-legislativo del movimento, e resi noti il mese prossimo. Ma questa comunque non schiacciante vittoria è certamente un segno di quanto sta accadendo nella Striscia.
Alcune versioni semiufficiali vogliono che alla fine di una prima tornata di voto nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza di 161 voti sui 320 disponibili, pertanto si è proceduto a una sorta di ballottaggio tra i due più votati per decretare il vincitore. E Sinwar avrebbe così conservato il posto che, nella gerarchia del movimento, è secondo solo a quello di Ismail Haniyeh, capo politico e volto esterno del movimento che vive tra Gaza e il Qatar. Proprio da quest’ultimo, Sinwar prese il posto nel 2017 e di quest’ultimo pare voglia prendere il ruolo. Dopotutto, ci dovranno anche essere le elezioni del capo politico e Haniyeh pare se la dovrà vedere con Khaled Meshal, a lungo capo del movimento che portò alla vittoria nel 2006.
Ma anche questa elezione dovrebbe essere scontata e Haniyeh, che è stato formalmente il Primo Ministro palestinese anche se dismesso da Mahmoud Abbas (Abu Mazen) dopo poco più di un anno dando il via al conflitto interno alla Palestina tra Fatah e Hamas, dovrebbe tenere l’incarico apicale. Il risultato di Sinwar ha però dato un segnale chiaro, perché il suo rivale, Awadallah, è considerato uno dei maggiori esponenti dell’ala più oltranzista. Fu lui, tra l’altro, nel 2011 a coordinare lo scambio di prigionieri con Israele che portò alla liberazione del soldato Gilad Shalit da una parte, e oltre 1000 palestinesi dall’altra, tra i quali lo stesso Sinwar. Quest’ultimo è stato l’ideatore delle proteste che fino al 2019 ogni venerdì hanno visto i gazawi far sentire la loro voce nei pressi delle barriere al confine con Israele. Ma la sua gestione della pandemia, il livello di povertà degli abitanti di Gaza sempre più basso mentre aumenta la corruzione, ne ha minato la leadership. Lui è anche visto come un punto di riferimento dall’Egitto nei negoziati con Israele e gli altri Paesi ed è anche al centro del tentativo di togliere il monopolio del Qatar sulla striscia, facendo entrare anche Emirati e Arabia Saudita, anche se Hamas ha un piano B, se i rapporti con l’Egitto dovessero deteriorarsi, fatto di contatti con Turchia e Iran.
Il leader Haniyeh ha salutato favorevolmente l’elezione e la conferma di Sinwar, inviando anche un messaggio, non tanto velato a Fatah e Mahmoud Abbas, facendo notare come almeno Hamas delle elezioni più o meno tali e più o meno democratiche interne le tiene, a differenze del partito dell’anziano leader. Che, anzi, è lacerato al suo interno non poco. Nonostante si avvicinino le tre tornate elettorali che da maggio ad agosto eleggeranno il Parlamento palestinese, il Presidente dello Stato e i membri del consiglio dell’Olp, Fatah sta sempre più perdendo di collante sia all’interno che all’esterno e Hamas è dato in testa. Non solo: giovedì Abbas ha cacciato dal partito Nsser al-Qudwa, esponente di spicco del partito, nipote di Yasser Arafat, ex Ministro degli Esteri e rappresentante palestinese all’Onu, a lungo considerato un possibile successore del Presidente.
La mossa, dopo una serie di contrasti tra i due sfociati nella decisione di al-Qudwa di presentarsi con una lista indipendente, tentando anche di appoggiare e farsi appoggiare da Marwan Barghouti, il leader incarcerato in Israele che tutti tirano per la giacchetta per farlo candidare alla presidenza contro Abbas, certamente porterà una fuoriuscita da Fatah che esacerberà le frizioni e le lacerazioni, aumentando le chance di Hamas di bissare il successo elettorale palestinese del 2006.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Israele passa da nazione delle startup a quella dei vaccini. È quanto ha detto ieri il premier Benjamin Netanyahu, che ha incontrato a Gerusalemme la Prima Ministra danese Mette Frederiksen e il Cancelliere austriaco Sebastian Kurz. I tre hanno definito piani di ricerca e sviluppo congiunti sui farmaci anti-pandemia, nonché deciso investimenti congiunti sulla produzione di vaccini.
Il Primo Ministro danese Mette Frederiksen ha detto che i tre Paesi “hanno lavorato a stretto contatto” dall’inizio della pandemia, condividendo una visione per il futuro secondo cui “l’accesso tempestivo ai vaccini sarà fondamentale per le nostre società negli anni a venire”. L’investimento congiunto in impianti di produzione di vaccini “riflette il rispetto che abbiamo gli uni per gli altri e la fiducia che abbiamo nel lavorare insieme per proteggere la salute della nostra gente”, si legge nel comunicato finale dell’incontro. I tre hanno dichiarato di avere una visione condivisa, basata sulla convinzione che non ci si può permettere “di essere colti di nuovo alla sprovvista. Abbiamo nuove mutazioni, forse nuove pandemie e forse nuove crisi sanitarie metteranno di nuovo in pericolo le nostre società”.
L’idea è quella di creare dei centri di ricerca e impianti congiunti in Israele, cosa che aveva spinto già il premier Netanyahu qualche giorno fa a uno scouting in questo senso. Il capo del Governo di Gerusalemme, infatti, ha proposto ai vertici delle più importanti aziende mondiali impegnate nella realizzazione dei vaccini anti Covid di aprire in Israele centri di ricerca e sviluppo, nonché impianti industriali, mettendo a disposizione non solo nuove strutture e luoghi, ma anche quelle già presenti.
Non dimentichiamoci, infatti, che il mercato farmaceutico israeliano è uno dei più importanti al mondo, con le esportazioni che sono salite da 208 milioni nel 1997 a 5,9 miliardi di dollari nel 2018 e oltre 1500 aziende che operano nel settore, con importanti brevetti medici e farmacologici acquisiti; basti pensare alla prima nano-medicina al mondo per il trattamento dei vari tipi di cancro e il farmaco per la sclerosi multipla. All’invito di Netanyahu, oltre ai colossi farmaceutici, hanno risposto alcuni Paesi. A parte Austria e Danimarca, il Bahrein, e altri sono alla finestra.
Dopotutto il Cancelliere Kurz, che sin dall’inizio del suo mandato ha stretto un forte rapporto con Netanyahu, ha istituito lo scorso anno un forum chiamato First Mover che include Netanyahu e Frederiksen, nonché i leader di Australia, Norvegia, Grecia, Repubblica Ceca, Singapore e Nuova Zelanda, per discutere le migliori pratiche nella lotta al Covid. “Questa pandemia può essere superata solo attraverso la cooperazione globale”, ha detto Kurz. “I vaccini ci consentiranno di tornare alla normalità in estate, ma dobbiamo prepararci già ora per le prossime fasi della pandemia dopo l’estate”. Netanyahu ha portato Kurz e Frederiksen in una palestra a Modi’in, non lontano da Gerusalemme, per mostrare loro come funziona il programma “passaporto verde“, che da domenica consente agli israeliani che sono stati vaccinati o sono guariti dal Covid di tornare a dedicarsi ad alcune attività al chiuso, come palestre, ristoranti, cinema.
La Prima Ministra danese Mette Frederiksen ha affermato che i tre Paesi coinvolti hanno un buon punto di partenza per il progetto, perché hanno industrie di scienze della vita altamente sviluppate. “Possiamo unire le nostre conoscenze in una sorta di sforzo collettivo per garantire un accesso migliore e più affidabile ai vaccini”, ha detto. “Vorremmo anche esplorare [insieme] la possibile cooperazione nelle sperimentazioni cliniche”. Frederiksen ha affermato che l’incontro “le ha fornito molta ispirazione su come possiamo lavorare più vicini quando si tratta di capacità di ricerca e produzione”.
La soddisfazione di Netanyahu è stata ovviamente tanta, anche perché confida che il modello vaccinale israeliano e l’approccio alla pandemia, nonostante le critiche interne, gli possano portare la rielezione il 23 marzo. Non a caso, parlando alla Fox, ha detto che ormai “il Covid è alle spalle”, avendo vaccinato l’87% della popolazione, almeno con la prima dose. Ma le polemiche lo accompagnano. Non a caso, è stata rinviata ufficialmente per la chiusura dell’aeroporto la visita in Israele di Albert Bourla, il Ceo di Pfizer, dopo che nel Paese molti hanno criticato la venuta, vista come spot elettorale e sostegno al suo amico Bibi.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Questo articolo è pubblicato anche sul numero di gennaio/febbraio di eastwest.
Il 23 marzo Israele tornerà alle urne, per la quarta volta in due anni. Uno stallo politico che non ha eguali nella storia del Paese e che ha in Benjamin Netanyahu il perno sul quale gira l’intera impasse. Il premier più longevo della storia di Israele negli ultimi due anni ha fatto il bello e il cattivo tempo nell’amministrazione e nel Governo israeliano, ma soprattutto nella politica. Restando non solo a galla ma addirittura in testa, nonostante scandali e inchieste giudiziarie, è anche riuscito a fare terra bruciata dei propri avversari politici.
L’ultimo è stato Benny Gantz. L’ex capo di Stato maggiore dell’esercito, arrivato sulla scena politica come il messia che avrebbe “de-netanianizzato” il Paese, rafforzando uno schieramento di centro sinistra, è stato fagocitato da Bibi e stritolato nel suo abbraccio mortale. A marzo dell’anno scorso, Gantz si era presentato di nuovo alla testa dell’alleanza Blu e Bianco contro Netanyahu. Dopo diverse esitazioni e rompendo l’alleanza che l’aveva fatto crescere, per evitare lo stallo elettorale, dopo una pessima esperienza nella tornata precedente nella quale non era riuscito a formare un Governo facendo ripiombare il Paese nelle elezioni, il generale aveva alfine accettato di sedere quasi otto mesi fa in un Governo con Netanyahu nel quale ha avuto il ruolo, creato apposta, di “Alternate Prime Minister”, premier in alternanza.
L’accordo era che Netanyahu sarebbe stato premier per i primi 18 mesi, e Gantz avrebbe guidato il Governo da novembre 2021. Gantz aveva giustificato la sua decisione e il voltafaccia a Yair Lapid, capo dello Yesh Atid, partito con il quale il suo Blu e Bianco aveva una alleanza anti Netanyahu, con la volontà di evitare al paese le quarte elezioni di fila soprattutto durante la pandemia. Circostanza che, invece, si è verificata alcuni mesi dopo.
La coalizione è scivolata, dopo dissidi sin dall’inizio, sul bilancio: il Likud di Netanyahu avrebbe voluto approvare solo quello dell’anno appena concluso e navigare a vista su quello del 2021; il Blu e Bianco invece approvare entrambi. Non solo: Netanyahu che aveva accettato di ruotare il premierato a novembre 2021, avrebbe fatto marcia indietro, chiedendo un rinvio a marzo/maggio 2022. Inaccettabile per Gantz e i suoi come pure le prese di posizione sulla riduzione dei poteri del Ministro della Giustizia nelle nomine dei giudici. Questo infatti è un tema molto caro a Netanyahu visto che con il nuovo anno è arrivato anche l’inizio del processo che lo vede imputato in tre casi per abuso di fiducia, corruzione e frode.
A marzo Gantz è destinato a scomparire, dicono i sondaggi. Così come la sinistra, quella che storicamente ha fondato il Paese. A marzo si presenteranno almeno tre nuove formazioni politiche. Innanzitutto la New Hope di Gideon Sa’ar, l’ex delfino di Netanyahu che ha anche “osato” sfidarlo nelle primarie e che è dato tra i vincenti. Unendosi agli ex alleati di Netanyahu, lo Yamina di Naftali Bennet e l’Yisrael Beiteinu di Avigdor Lieberman, potrebbe aspirare ad una maggioranza, stando ai sondaggi, con qualche aiuto esterno. Nuovo partito anche per il sindaco di Tel Aviv, Ron Huldai, che ha recuperato l’ex ministro della giustizia Avi Nissenkorn nella nuova formazione di sinistra The Israelis. E nuovo partito anche per l’economista Yalon Zelekha, che è stato ragioniere generale dello stato con Netanyahu Ministro delle Finanze dal 2003 al 2007 e che ha sempre criticato le scelte economiche di Netanyahu anche recentemente, dando voce alle manifestazioni di piazza che ogni sabato protestano contro Bibi dinanzi alla sua residenza di Gerusalemme. Zelekha aspira al Ministero delle Finanze, quindi potrebbe dare il suo appoggio a qualcuno, laddove servisse. Ma Netanyahu sarà sempre lì. Dalla sua due vittorie: gli accordi di Abramo con gli Emirati e il riconoscimento di altri Paesi arabi (Bahrein, Sudan e Marocco, con altri alla finestra, tra i quali l’Arabia Saudita) e il successo sul vaccino anti Covid.
Israele è stato tra i Paesi che hanno adottato misure più rigide nel contenimento della pandemia, pur continuando ad aiutare la popolazione, nonostante la crisi economica persistente. Con la possibilità del vaccino, se ne è accaparrate numerose dosi da diversi produttori: è il Paese al mondo che ha effettuato più vaccini, in rapporto alla popolazione, vaccinando oltre il 10% in poche settimane. Per le elezioni, Netanyahu punta ad aver completato le vaccinazioni.
I problemi per Bibi arrivano dall’area. Se infatti, molti Paesi arabi anche importanti hanno avviato relazioni con lo Stato ebraico, Israele deve fronteggiare due grandi minacce che si dipanano in altri Paesi e internamente: Iran e Turchia. Verso il Paese degli Ayatollah, Israele continua ad avere un atteggiamento molto ostile, ricambiato da Teheran. L’uccisione da parte degli Usa a gennaio dell’anno scorso di Qassem Soleimani, capo delle guardie rivoluzionarie, avvenuta in Iraq; quella di Mohsen Fakhrizadeh, a capo del programma nucleare iraniano, lo scorso novembre, per il quale sono accusati gli stessi israeliani; i continui raid dell’aviazione israeliana in Siria contro postazioni iraniane, non hanno giovato alla distensione dei rapporti.
Il cambio di leadership a Washington, se non dovesse cambiare la politica Usa in Medio Oriente, potrebbe cambiare i rapporti Usa con l’Iran, visto che Biden ha parlato di una ripresa dei colloqui sul nucleare. Bisognerà vedere. Intanto, un sottomarino nucleare israeliano è stato visto nelle acque del Golfo mentre Hezbollah, il movimento libanese foraggiato da Teheran, ha annunciato di aver raddoppiato il numero dei missili di precisione nel suo arsenale e di poter colpire qualsiasi obiettivo in Israele.
E nell’area vuole aumentare la sua influenza anche la Turchia. Ankara non fa mistero della volontà di controllare la Spianata delle moschee o Monte del tempio a Gerusalemme, terzo luogo santo per l’Islam. Attualmente è controllato dalla Giordania attraverso una fondazione, ma in caso di pace tra Israele e l’Arabia Saudita, è probabile che Riad, che già controlla gli altri due luoghi sacri, tenti la scalata alla spianata.
E la Palestina? Come sempre, resta ai margini. Oggi non si può più parlare di questione palestinese ma “questione dei palestinesi”, in quanto la loro stessa sopravvivenza, anche culturale, è in pericolo. Questo perché da un lato Ramallah, per molte colpe interne, è sempre più isolata dagli storici sostenitori Paesi arabi, con l’eccezione di Qatar (isolato tramite embargo da Arabia Saudita anche per i suoi legami economici sul gas con l’Iran) e Turchia, che sta aumentando la sua influenza. Dall’altro lato, i partiti di destra che sembrano andare verso la vittoria in Israele, hanno posizioni ancora più estreme di Netanyahu sulla questione palestinese. Non a caso, il voto che ha portato allo scioglimento della Knesset, è stato favorito anche dal voltafaccia di una parlamentare del Likud che, contestando la mancata annessione dei territori prevista dal piano Trump, ha votato per la dissoluzione e annunciato di aderire a New Hope.
Il piano di Trump presentato l’anno scorso e che a luglio avrebbe dovuto portare all’annessione israeliana di parte della Cisgiordania, è stato messo in pausa. Così come Netanyahu non ha sviluppato come promesso il piano di nuovi insediamenti. Difficile che Biden rimetta in gioco il piano di pace, ma è facile che, vincendo la destra, i palestinesi vedano rosicchiati altri pezzi del loro territorio. E questo rende l’Autorità Palestinese sempre più isolata. Mahmoud Abbas (Abu Mazen), promette da anni elezioni e i palestinesi si sono dichiarati stanchi di lui, anche se non c’è alternativa, per ora, se non quel Dahlan che vive a Dubai e che avrebbe favorito gli accordi di Abramo e quel Barghouti in carcere in Israele.
Il vaccino anti Covid dovrebbe portare a nuovi colloqui fra Israele e Autorità Palestinese, con il primo che si è dichiarato disposto a fornire i sieri necessari, mentre Ramallah li attende dal programma gratuito dell’Oms. Una mossa politica, da parte di Israele, ma anche legata a esigenze interne, per favorire l’eradicazione del virus in tutta l’area, viste le centinaia di migliaia di palestinesi che quotidianamente lavorano in Israele. Ma senza un cambio di leadership in entrambi i Paesi, difficilmente il processo potrà avanzare.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Il gas sta cementando i rapporti economici tra Israele ed Egitto. A far stringere le relazioni tra i due Paesi confinanti, i grandi giacimenti di gas dinanzi alle coste israeliane. Dopo la scoperta nei primi anni 2000 del bacino Tamar, entrato in funzione nel 2013, nel 2010 è stato scoperto, non lontano da questo, il bacino di gas naturale Leviathan, entrambi dinanzi ad Haifa. Giacimenti ricchi, tanto che grazie a questi, Israele potrà raggiungere l’autonomia energetica. E da questo, l’Egitto ha solo che da guadagnare; non a caso i due Paesi già da qualche anno hanno siglato accordi. L’ultimo, domenica scorsa.
Il Ministro israeliano per l’Energia, Yuval Steinitz, e il suo omologo egiziano Tarek el-Molla, in visita in Israele, hanno sottoscritto un accordo per costruire un gasdotto di collegamento tra il giacimento del Leviatano nel Mediterraneo orientale con gli impianti di liquefazione in Egitto, con l’obiettivo poi di aumentare le esportazioni verso l’Europa collegando anche l’Italia. Si stima che il giacimento Leviatano, scoperto 130 chilometri a ovest della città portuale di Haifa, contenga 535 miliardi di metri cubi di gas naturale insieme a 34,1 milioni di barili di condensa. Israele ha iniziato a pompare gas dal Leviatano nel dicembre 2019 e a esportarlo in Egitto già dal mese successivo.
L’importanza dell’accordo e della visita è dimostrato dal fatto che quella del Ministro egiziano è la prima visita di un Ministro egiziano in Israele dal 2016. L’americana Noble e l’israeliana Delek, che guidano il consorzio per lo sviluppo del bacino Leviathan e di quello più piccolo di Tamar, hanno siglato un accordo decennale da 15 miliardi di dollari nel 2018 con l’egiziana Dolphinus per fornire al Paese dei faraoni 64 miliardi di metri cubi. Il Cairo, infatti, si sta sempre più accreditando come hub regionale per il gas. Il Leviathan è il secondo più grande giacimento di gas nel Mar Mediterraneo, dopo la scoperta dell’agosto 2015 del giacimento di Zohr al largo delle coste dell’Egitto.
Ma al di là delle discussioni sulla cooperazione in materia energetica secondo gli analisti la visita del Ministro egiziano in Israele sarebbe servita anche a inviare un chiaro messaggio a Turchia e Stati Uniti. Tarek el-Molla è stato il primo Ministro egiziano a visitare Israele da quando il Ministro degli Esteri Sameh Shoukry ha incontrato Netanyahu nel 2016. E, viene sottolineato, El-Molla non è un attore minore, in quanto è molto vicino al Presidente egiziano Al-Sisi. Per molto tempo la Turchia è stata impegnata in un’aspra rivalità con l’Egitto. Il Paese dei faraoni si è allineato con Grecia e Cipro, che accusano la Turchia di perforare illegalmente il gas naturale nelle loro zone economiche esclusive. Insieme a Israele, i Paesi hanno formato l’EastMed Gas Forum, con sede a Il Cairo, e hanno condotto esercitazioni militari congiunte. Secondo alcuni osservatori, un incontro tra Israele ed Egitto, anche se non è lo scopo principale della visita, invia un chiaro messaggio alla Turchia.
La visita avrebbe anche avuto anche lo scopo di inviare un messaggio all’amministrazione Biden. L’Egitto infatti teme una maggiore pressione da parte del Governo degli Stati Uniti sulle faccende relative ai diritti umani. “Non tollereremo aggressioni o minacce da parte di Governi stranieri contro cittadini americani o loro familiari”, ha detto la scorsa settimana il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price dopo che il Governo di Al-Sisi ha arrestato la famiglia di un attivista politico che è anche cittadino statunitense. “Non ho dubbi che gli egiziani abbiano preoccupazioni per l’amministrazione Biden”, ha detto al Times of Israel Eran Lerman, vice Presidente del Jerusalem Institute for Strategy and Security ed ex vice direttore del Consiglio di sicurezza nazionale di Israele. “Tutto il Mediterraneo orientale si sta organizzando in modo che Biden veda in noi una posizione unificata”, ha affermato Lerman.
La visita, durante la quale el-Molla ha incontrato anche esponenti del Governo palestinese a Ramallah, ha permesso anche all’Egitto di ribadire la sua presenza come uno dei principali mediatori tra Israele e palestinesi. A dicembre, Al-Sisi ha detto che Il Cairo stava lavorando per portare avanti la soluzione dei due Stati. Una settimana prima dell’entrata in carica di Biden, l’Egitto ha ospitato i Ministri degli Esteri giordano, francese e tedesco per discutere del rilancio dei colloqui di pace israelo-palestinesi. L’idea è che più l’Egitto può presentarsi come una fonte di stabilità e cooperazione nella regione, minore sarà la pressione che dovrà affrontare dagli Stati Uniti per i diritti umani. Non solo: sia per il giacimento Leviathan che per quello Tamar, c’è una disputa internazionale tra Israele e Libano per i confini e la pertinenza dei siti. Il Libano in passato è ricorso anche alle Nazioni Unite sulla questione dei confini e gli americani, che hanno notevoli interessi attraverso società statunitensi, nell’esplorazione e gestione dei giacimenti, hanno sempre tenuto due piedi in una scarpa.
Ma il gasdotto serve a Israele anche per la pacificazione interna. Entro due anni, infatti, sarà completata la costruzione di un gasdotto destinato a portare il gas naturale da Israele a Gaza. Dopo estenuanti colloqui e trattative è stato raggiunto nei giorni scorsi l’accordo, che coinvolge anche il Qatar, le Nazioni Unite e l’Unione europea. Una volta terminata la fase infrastrutturale con la costruzione del gasdotto, la Chevron Delek, partnership tra l’americana Chevron e l’israeliana Delek, venderà il gas all’Autorità nazionale palestinese. Gas che arriverà dal bacino Leviathan. Nella striscia al momento c’è solo un impianto elettrico che si basa su carburante diesel importato via terra che non è sufficiente per il fabbisogno della popolazione della pur piccola zona, tanto che ogni giorno si verificano continui blackout che durano a volte anche per molte ore consecutive. L’Autorità Palestinese attualmente paga 11 milioni di dollari per l’elettricità da Israele, oltre ai 2,5 milioni di dollari stanziati per la centrale elettrica stessa. Il Qatar acquista 7 milioni di dollari di carburante ogni mese per questa centrale elettrica. Passare al gas naturale sarebbe quindi per Gaza molto importante non solo perché ridurrebbe il deficit energetico ma anche perché farebbe diminuire drasticamente il costo che l’autorità nazionale palestinese paga per l’elettricità. L’Unione europea ha destinato circa 5 milioni di dollari per contribuire al progetto mentre il Qatar dovrebbe occuparsi, anche se i dettagli non sono ancora chiarissimi e definiti, della costruzione del gasdotto sulla parte di suolo israeliano.
Intanto, mentre si discute di accordi e di nuovi gasdotti, gli ambientalisti sono sempre più preoccupati specie dopo la fuoriuscita di petrolio pare da una petroliera greca, che ha provocato lo sversamento di catrame da Haifa a sud fino ad Ashkelon inquinando 170 chilometri di spiaggia e scogliere. Tutte le spiagge israeliane affacciate sul Mediterraneo sono state chiuse e il Governo ha invitato la popolazione a evitare di bagnarsi, temendo rischi per la salute. È stata anche vietata la vendita del pescato del Mediteranno, dal momento che molta è la fauna rinvenuta morta e piena di catrame sulle spiagge israeliane, in quella che è stata annunciata come una delle peggiori catastrofi ambientali del Paese. La marea, si sta spostando anche sulle coste libanesi.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Oltre il 93% dei palestinesi si è registrato entro la scadenza di martedì per poter partecipare alla prossima triplice tornata elettorale dopo 15 anni di attesa. Un successo, considerando che 2.600.000 residenti nei Territori Palestinesi dei 2.800.000 eleggibili al voto, si sono registrati per decidere il 22 maggio i membri del Consiglio Legislativo Palestinese (il parlamento dell’Autorità Palestinese), il 31 luglio chi dovrà essere il presidente dell’Autorità Palestinese e, un mese dopo, i membri del Consiglio Nazionale palestinese, che è l’organo legislativo dell’Organizzazione di Liberazione della Palestina. Nelle precedenti elezioni, quelle del 2006, si registrò circa l’80% degli elettori, che erano 1.600.000, e andarono a votare poi circa un milione di palestinesi.
Le elezioni sono ormai sul binario e tornare indietro, secondo quanto dice il Primo Ministro Mohammad Shtayyeh, sarebbe un errore grave. Ma ci sono ancora molti dubbi sullo svolgimento delle elezioni. La scorsa settimana, i rappresentati di tutti i partiti in lizza, in particolare quelli di Fatah e Hamas, si sono riuniti a Il Cairo per trovare un accordo su alcune questioni procedurali. Qualche risultato è stato raggiunto. In Egitto le parti hanno deciso che sarà il tribunale di Ramallah a dirimere eventuali questioni, anche se i giudici li sceglierà il Presidente Mahmoud Abbas (Abu Mazen), che nelle scorse settimane è stato al centro di polemiche proprio per aver cambiato tutti i giudici dell’Alta Corte per poterli controllare meglio. Sarà inoltre la polizia di Ramallah a garantire la sicurezza. Al Il Cairo, inoltre, gruppi fondamentalisti come la Jihad Islamica Palestinese, hanno annunciato che non concorreranno alle elezioni, perché non accettano una riconciliazione con Israele. Problema, questo, che potrebbe verificarsi anche con Hamas.
La maggior parte dei partiti politici palestinesi, con Hamas in testa, è considerata terrorista da molti Paesi occidentali, Stati Uniti in primis. Una vittoria alle elezioni di Hamas, quindi, creerebbe non poco imbarazzo. Colloqui tra le parti si stanno tenendo anche per decidere una eventuale lista comune, anche se non sembra molto probabile. Nel 2006, alle ultime elezioni, Hamas vinse e, nonostante molti osservatori dichiararono che si erano svolte regolarmente, il risultato non fu preso in considerazione e complice il colpo di Stato a Gaza di Hamas mai omologato e il Parlamento mai convocato. Abu Mazen, poi, si è rinnovato sempre il suo mandato scaduto nel 2009.
La questione di Hamas non è secondaria e, ovviamente, preoccupa anche gli Stati Uniti oltre che Israele. Anche se la politica americana in Medio Oriente con il nuovo Presidente Joe Biden dovesse cambiare rispetto a quella del predecessore Donald Trump, è improbabile che si possa accettare l’esistenza e la vittoria di un gruppo che persegue la distruzione di Israele. Secondo alcune indiscrezioni di stampa, esponenti dell’amministrazione di Washington avrebbero già chiesto lumi a omologhi palestinesi circa l’accordo eventuale con Hamas.
Contemporaneamente, Fatah sta ragionando su una lista unica con le tante fazioni dei fuoriusciti, ma soprattutto per di evitare candidature alla presidenza scomode per Abbas. In primis, quella di Mohammad Dahlan, l’uomo che ha favorito la conciliazione tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti dove vive e i cui emissari, pochi giorni fa, sono ritornati a Gaza proprio in chiave elettorale. Ma si parla anche di Ismail Haniyeh, leader di Hamas, che i sondaggi danno per vincente sull’ottuagenario leader di Fatah (così come il suo partito contro quello di Ramallah), o di Jibril Rajoub, l’uomo dietro l’accordo tra Fatah e Hamas, segretario generale di Fatah, molto popolare per essere il Presidente del comitato olimpico palestinese ma, soprattutto, della Federazione gioco calcio della Palestina e di Saleh al-Arouri, vice capo di Hamas.
In questi giorni, però, esce forte la candidatura di Marwan Barghouti. L’uomo è in carcere in Israele e sta scontando 5 ergastoli e altri 40 anni di prigione, perché è stato ritenuto responsabile di una serie di attentati perpetrati dal gruppo militare che comandava, Tanzim, durante, soprattutto, la seconda Intifada. Barghouti, leader di Fatah, si è sempre dichiarato innocente e ha sempre condannato episodi contro civili sul suolo israeliano, ma è stato condannato da un tribunale israeliano nel 2004, accusato di essere stato anche a capo delle Brigate dei Martiri di Al-Aqsa. Ogni volta che si parla di elezioni nei territori palestinesi si fa il nome di Barghouti come di candidato alla presidenza. In molti credono che proprio la sua permanenza in carcere, oltre al suo carisma, siano la chiave per vincere le elezioni. Vittoria che obbligherebbe Israele a liberarlo, dopo che per molti anni voci anche all’interno dello Stato ebraico lo hanno chiesto. In questa situazione, non ci sarebbe imbarazzo per Gerusalemme.
La sua candidatura spesso viene annunciata soprattutto in chiave anti Mahmoud Abbas, che Barghouti ha sempre avversato. Il leader di Tanzim, che per molto tempo è stato anche un sostenitore degli accordi di Oslo, ha anche attaccato duramente Arafat e il suo circolo ristretto per corruzione. Anche Hamas ha più volte detto di appoggiare una eventuale candidatura di Barghouti alla presidenza. La settimana scorsa ha ricevuto in carcere la visita (evento straordinario soprattutto per la pandemia) di un Ministro palestinese molto vicino ad Abbas, proprio in chiave elettorale. Alcune fonti giornalistiche riferiscono che, in verità, l’intento della visita del Ministro al-Sheikh, sia stato quello di convincere Barghouti a non candidarsi alle elezioni. Tra l’altro, pare che lui non potrebbe neanche prendere parte alla contesa elettorale. Nel 2009, infatti, Barghouti è stato eletto a Betlemme a capo del comitato centrale di Fatah e per un regolamento elettorale voluto da Abbas, nessun membro del comitato può candidarsi. Barghouti era stato candidato alla presidenza dell’Autorità Palestinese anche nel 2005, dopo la morte di Arafat, ma ritirò la candidatura per favorire Abbas. In quella elezione, si candidò alla presidenza un suo lontano cugino, Mustafa, segretario generale della Palestinian National Initiative, arrivando al 20% dei consensi.
Resta poi irrisolto il nodo della possibilità di votare a Gerusalemme Est, senza la quale, i vertici palestinesi, dicono che non possono esserci elezioni. La preoccupazione palestinese è che Israele potesse negare le elezioni. In verità nel 2006 il Governo israeliano le permise, ma la preoccupazione odierna è più legata a una possibile scusa che i vertici palestinesi possano utilizzare per evitare che si vada alle contesa con i gruppi antagonisti troppo avanti nei sondaggi.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Ci sarebbero timidi segnali di riavvicinamento tra Israele e Turchia. Lo riferisce la stampa israeliana. E non è difficile credere che sia vero: i due Paesi, storicamente, hanno un legame lungo quanto burrascoso. Fu proprio la dissoluzione dell’Impero Ottomano che consegnò agli inglesi l’allora Palestina poi britannica e furono gli ottomani a controllare Gerusalemme dal 1516, anno in cui l’impero ottomano la prese dai mamelucchi, per quattro secoli fino al 1917, quando l’impero si dissolse.
Fu in quel periodo che vennero costruite le mura della città vecchia come le vediamo, in gran parte, oggi. Ma i rapporti burrascosi si sono acutizzati soprattutto negli ultimi anni, a causa della posizione israeliana nei confronti dei palestinesi. Ankara, infatti, è da sempre uno dei più strenui difensori della causa palestinese. Non senza un tornaconto: non è un mistero che dietro il soft power turco in Palestina, fatto di aiuti, strade, tutoraggio anche politico, ci sia la volontà di Erdogan di riprendere, come fu per Solimano il Magnifico, il controllo del terzo sito più importante per i musulmani, quella Spianata delle Moschee (o Monte del Tempio, come lo conoscono gli ebrei) che oggi è controllata da una fondazione giordana. I rapporti si sono fatti molto tesi undici anni fa.
Nel 2010, nove attivisti turchi furono uccisi dalla marina israeliana mentre quelli, a bordo di una flottiglia, rompevano il blocco navale per andare a portare aiuti a Gaza. Solo nel 2016 i due paesi ripresero a parlarsi. Per poi tornare a scontrarsi nel 2018, dopo l’uccisione da parte di Israele di 60 palestinesi a Gaza, che per il Paese della stella di Davide erano terroristi di Hamas e di altri gruppi, mentre Ankara parlava di genocidio. Da allora, Turchia e Israele hanno richiamato i rispettivi ambasciatori nell’altro Paese e, a oggi, non sono stati rimpiazzati, anche se a dicembre scorso il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan, annunciando la nomina del suo ambasciatore presso lo stato della stella di Davide, ha detto che la Turchia vorrebbe legami migliori con Israele, ma non accetta la politica di questi nei confronti della Palestina. In verità Ankara non sostiene solo il Governo di Ramallah, ma anche Hamas e altri gruppi di Gaza. E, questo, ovviamente non sta bene a Israele.
A Istanbul, Fatah e Hamas hanno siglato una riconciliazione e nella città turca hanno pure gettato le basi dell’accordo che ha portato a decidere di tenere le elezioni a partire da maggio, cosa che non accadeva da sedici anni. Una decina di giorni fa scorsa in Turchia è anche atterrato un aereo dell’El Al, cosa che non succedeva da tempo, anche se ci sono sempre stati quotidiani voli tra Istanbul e Tel Aviv con compagnie turche, sia di linea che low cost e gli israeliani apprezzano molto il mare e le strutture turistiche della Turchia. Qualche segno di avvicinamento tra i due si era registrato anche a settembre scorso, durante la crisi del Nagorno Karabakh, quando entrambi i Paesi hanno sostenuto l’Azerbaijan contro l’Armenia. E sia Turchia che Israele avevano anche in Donald Trump un amico comune. Ma quello che ha smosso il “sultano” Erdogan verso Israele, è sicuramente stata la firma degli Accordi di Abramo, con i quali Gerusalemme ha normalizzato i rapporti con quattro stati arabi, di fatto cambiando la geopolitica dell’area.
Quello che preoccupa la Turchia è di rimanere sempre più isolata, di perdere la sua sfera di influenza. Anche la recente fine dell’embargo contro il Qatar da parte di Arabia Saudita ed Emirati (i secondi già firmatari degli accordi di Israele e i primi che “ci stanno pensando” e che non nascondo di voler mettere le mani anche loro sulla Spianata delle Moschee), ha ridotto l’influenza nell’area di Ankara che si era erta a difensore di Doha. Negli ultimi anni la Turchia ha aumentato la sua presenza e le sue mire espansionistiche nel Mediterraneo, soprattutto alla ricerca di idrocarburi. Con Grecia e Cipro, da sempre due Paesi vicini politicamente a Israele, la Turchia da tempo non ha buoni rapporti e Ankara si è assicurata dalla Libia la possibilità di esplorazioni nel Mediterraneo per poi costruire oleodotti. In questo percorso, l’importanza della presenza di Israele è centrale. Dal canto suo, normalizzando con la Turchia, Israele potrebbe aprire un altro canale importante nel mondo islamico, soprattutto verso un Paese che ha una grande influenza su Hamas. Alcuni analisti, non credendo ancora maturi i tempi di una conciliazione totale tra i due paesi, immaginano un rapporto che ricalchi quello che Gerusalemme ha con Doha: Israele non ha formali relazioni diplomatiche con il Qatar, ma si “parlano” e cooperano soprattutto nel trasferimento dei milioni di dollari necessari alla loro sopravvivenza, da Doha a Gaza.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Ancora per qualche mese, almeno fino all’estate, gli haredim, gli ebrei ortodossi che orientano la loro vita allo studio e alla preghiera, non dovranno fare il militare.
Uno dei punti fermi della campagna elettorale dei partiti centristi, quello di obbligare anche gli haredim a svolgere il servizio militare obbligatorio come quasi tutti gli altri giovani israeliani, non è riuscito a diventare legge anche se al Ministero della Difesa c’è stato, e lo sarà fino alle elezioni del 23 marzo, il suo massimo esponente, quel Benny Gantz ex capo di stato maggiore dell’esercito della stella di Davide.
La questione dell’esenzione dal servizio militare di alcune comunità in Israele, è storia vecchia e ripiomba ogni volta nelle campagne elettorali. Per decenni, agli israeliani ultraortodossi è stata concessa un’esenzione quasi totale dal servizio nazionale a favore dello studio religioso (sebbene piccole percentuali si arruolino), ma nel 2012 l’Alta Corte di Giustizia ha abrogato la legge che consente questo accordo, ritenendolo discriminatorio nei confronti degli altri cittadini israeliani. Questi infatti sono obbligati al servizio civile dai 18 ai 24 anni: tre anni per gli uomini e due per le donne.
Una nuova legge è stata redatta per affrontare la questione nel 2014, sempre a favore dell’esenzione degli haredim, ma anche questa è stata ribaltata dal tribunale tre anni dopo, con la richiesta al governo di approvare una nuova legislazione in materia, altrimenti gli ultra ortodossi sarebbero stati costretti ad arruolarsi.
Da allora il governo, attraverso il Ministro della Difesa, ha richiesto e ricevuto proroghe a questa ordinanza del tribunale, poiché non è riuscito a redigere e approvare una legislazione che non fosse in contrasto con la legge sulla discriminazione.
A novembre scorso l’Alta Corte, nel concedere l’ultima proroga, ha annunciato che non avrebbe più concesso proroghe, di fatto mettendo il governo con le spalle al muro e obbligandolo ad approvare una legge in materia.
Ma, tra l’opposizione della destra religiosa al governo e la crisi di governo che ha portato allo scioglimento del Parlamento e all’indizione di nuove elezioni, non c’è stata nessuna legge e la scadenza del primo febbraio è arrivata. Gantz, come aveva già annunciato, non ha chiesto alcuna proroga.
La cosa però non ha portato all’automatico reclutamento degli haredim, per una serie di ragioni. In primo luogo perché ovviamente le strutture militari devono adeguarsi per ospitare persone che hanno regole alimentari e di vita molto particolari e rigide; inoltre perché una legge fondante della Costituzione israeliana, prevede che tutta la legislazione che scade entro quattro mesi dallo scioglimento della Knesset, il parlamento israeliano, viene automaticamente prorogata per i primi tre mesi della nuova sessione parlamentare che esce dalle elezioni. Ed è a questo che si è appellato il governo, Gantz escluso, ed è quanto successo. Ma il problema si ripresenterà dopo le elezioni. Come dicevamo, sia gli haredim ma anche gli arabi israeliani, non partecipano alla vita militare del paese.
I primi non considerano lo Stato di Israele e pertanto non partecipano alle sue sorti, anche se ricevono sovvenzioni per continuare a studiare quotidianamente nelle yeshiva, le scuole talmudiche. In base alla legge, possono rinviare il servizio militare fino a quando studiano nelle yeshiva, praticamente tutta la vita.
I secondi, musulmani o cristiani, sono esentati per legge, a meno che non si arruolino volontariamente, a differenza di altre minoranze come drusi o circassi che invece sono obbligati.
Sul tavolo ci sono diverse bozze che saranno oggetto di battaglia elettorale per i prossimi mesi. In una, la comunità ortodossa dovrebbe assicurare un certo numero di ragazzi nell’esercito ogni anno. In un’altra invece, questi potrebbero scegliere di impegnarsi in servizio civile anche nelle loro comunità, cosa che potrebbe essere più vicina al loro modo di vita.
Ovviamente, né l’una né l’altra ipotesi piace ai partiti politici che rappresentano la comunità ortodossa e che, fino ad ora, sono seduti nella maggioranza di governo e che facilmente lo saranno pure nel prossimo esecutivo.
Il problema è molto politico, anche perché si basa sull’identità stessa dello stato di Israele. Le recenti scene di guerriglia nei quartieri ultra ortodossi a causa del fatto che questi, pure in pieno lockdown hanno tenute aperte le scuole o il non rispetto delle misure di distanziamento sociale o l’uso delle mascherine, comune anche agli arabi, hanno dimostrato una profonda frattura nella società israeliana tra le comunità religiose e il resto laico del paese. Frattura che si dimostra, in tutta la sua drammaticità, anche nella vita politica e che difficilmente potrà essere risolta con le elezioni.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Per il capo di Stato maggiore israeliano, Aviv Kochavi, tornare a un accordo con l’Iran sarebbe una pessima idea. Una convinzione, quella di Kochavi, che non è piaciuta a molti in Israele, soprattutto al Ministro della Difesa, Benny Gantz. Per il militare, che ha parlato alla conferenza annuale dell’Istituto per gli studi sulla sicurezza nazionale, il Paese degli ayatollah sta facendo progressi enormi verso l’acquisizione di armi nucleari, grazie alle centrifughe in sue possesso. Con questi strumenti, per il capo dell’esercito israeliano, l’Iran potrebbe costruire ordigni nucleari nel giro di settimane. Pertanto è necessario mantenere le sanzioni nei confronti di Teheran, anche perché Kochavi è convinto che il Paese islamico sia più debole e sul punto di cedere verso concessioni reali.
Il generale ha rivelato di aver ordinato di preparare i piani per colpire il programma nucleare iraniano. La nuova amministrazione americana ha fatto intendere di voler rientrare nell’accordo sul nucleare con l’Iran, interrotto da Donald Trump. Una scelta che appare oramai indiscutibile, dal momento che Teheran ha mostrato un riavvicinamento e la mancanza di dialogo non può che compromettere l’intera stabilità mediorientale. Le dichiarazioni di Kochavi hanno sparigliato le carte in Medio Oriente.
Se da un lato, infatti, la posizione del Governo israeliano è sempre stata di avversione all’accordo con l‘Iran, spinti dalla convinzione, non proprio infondata, che da Teheran partano armi per Siria, Libano e Gaza, quella dell’esercito è stata sempre più moderata. Secondo quanto riferisce la stampa israeliana, lo stesso Aviv Kochavi, quando dirigeva l’intelligence militare, si opponeva all’idea di un attacco all’Iran e credeva che l’accordo nucleare fosse l’ultimo di tutti i mali. “In ogni briefing di gabinetto – scrive Haaretz – o altro briefing sulla sicurezza, la sua posizione era che l’Iran non aveva rotto l’accordo fino a che gli Stati Uniti lo hanno abbandonato”. In quella occasione, l’attuale capo di Stato maggiore riteneva anzi che bisognasse convincere gli americani a non abbandonare il tavolo, perché bisognava verificare se la cessazione dell’accordo, e le sanzioni successive, non avessero invece portato ad aumentare la velocità con la quale l’Iran, per razione verso le difficoltà economiche, si sarebbe potuto dotare di un’arma nucleare.
La dichiarazione di Kochavi, che azzera la distanza tra il capo dell’esercito e quelle del premier, sono state avversate dal Ministro della Difesa Gantz e da molti altri esponenti sia dell’esercito che analisti, sia per la convinzione che sia necessario tornare a trattare con l’Iran, sia perché le dichiarazioni sono state viste come politiche, non attinenti al ruolo del generale. Quasi come Kochavi avesse voluto lanciare un messaggio agli Usa verso la nuova e legittima strada verso il dialogo tracciata da Biden. Tra l’altro, la dichiarazione del capo dell’Idf (Israeli defence force) è arrivata alla vigilia della visita in Israele del generale americano Kenneth McKenzie, comandante in capo del Centcom (United States Central Command), il comando combattente che sovrintende il Medio Oriente, al quale da poco è stato affidato anche Israele che invece pria faceva parte del comando europeo. McKenzie è alla sua prima visita ed è in qualche modo il primo esponente, seppur alla lontana, dell’amministrazione Biden ad arrivare in Israele. Ovviamente, anche la risposta degli iraniani non si è fatta attendere.
Il portavoce dell’esercito di Teheran, brigadiere generale Abolfazl Shekarchi, ha respinto le dichiarazioni del capo dell’Idf soprattutto nei passaggi relativi al piano di azione contro Teheran e della pericolosità dell’accordo. Per Shekarchi le dichiarazioni di Kochavi sono “guerra psicologica” e ha avvertito che il “minimo errore” da parte di Israele avrebbe portato la repubblica islamica a “livellare Haifa e Tel Aviv”. È chiaro che le dichiarazioni del capo dell’esercito israeliano da un lato portano acqua al mulino, soprattutto in chiave elettorale di Netanyahu, dal momento che la lotta al terrorismo e la difesa sono sempre stati suoi cavalli di battaglia; dall’altro, in questo momento di crisi, hanno l’intento di spostare risorse sull’esercito e magari prolungare anche l’incarico del generale. Israele, ha spiegato Kochavi, è pronto a difendersi e continuerà ad operare per tagliare l’approvvigionamento di armi all’Iran ad altri Paesi come Siria, Libano e Gaza.
Per quanto riguarda gli altri scenari, Kochavi ha detto che negli ultimi tempi è aumentata la pratica, in Libano e a Gaza, da parte di Hezbollah e Hamas, di nascondere armi nelle case dei civili. Lo scoppio al porto di Beirut e l’esplosione di qualche giorno fa a Gaza ne sono la dimostrazione. Il capo dell’esercito israeliano ha detto che comunque i suoi uomini, in caso di attacco, non si tireranno indietro rispetto alla pratica di questi avversari di utilizzare scudi umani. “Se i civili si prestano, è colpa loro”, ha detto Kochavi, chiedendo che venga ridefinito il modo in cui il diritto internazionale concepisce le guerre, cambiando il principio di “proporzionalità” con la “relazione relativa” tra gli obiettivi di un attacco e l’impatto sui civili. La strada verso la pacificazione dell’area e un nuovo accordo con l’Iran si fa sempre più in salita.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

In questo periodo, Israele è sulle prime pagine dei giornali e dei notiziari di tutto il mondo per lo straordinario successo della sua campagna vaccinale, che lo porta a essere il primo Paese al mondo per numero di vaccinati in base alla popolazione. Cominciata il 20 dicembre, un giorno dopo che il premier Benjamin Netanyahu dinanzi alle telecamere si fece inoculare la prima dose, la campagna procede a ritmo spedito e in questi giorni si stanno vaccinando gli over 40.
Il tutto, grazie soprattutto a un collaudato sistema sanitario fatto di mutue molto presenti sul territorio e di una logistica eccellente, oltre che della scelta politica di pagare di più il prezzo delle dosi per essere sicuri di ottenere in tempo tutte quelle necessarie. Anche io, 48nne, straniero e senza assicurazione o mutua locale, ho potuto avere la prima dose del vaccino. Sono già quasi 2,8 milioni le dosi inoculate in Israele, su una popolazione di poco più di 9 milioni di abitanti, così che oltre il 25% della popolazione ha già ricevuto almeno una dose; 550.000 hanno anche già ricevuto la seconda dose. Si va spediti a ritmi di 200.000 dosi inoculate al giorno e una delle mutue, la Meuhedet, ha annunciato che comincia ora a vaccinare gli over 35, mentre si sta per introdurre il vaccino alle donne incinte. Il 77% della popolazione over 60 è stata già vaccinata.
Ma, nonostante il successo di questa campagna vaccinale, Israele registra un notevole aumento di casi di contagio. Nei giorni scorsi si sono registrati anche oltre 10mila contagi al giorno, un record neanche mai toccato durante la prima fase (qui si parla di quarta), con un tasso di positività del 10%. È aumentato, all’inizio della settimana, anche il numero dei pazienti in condizioni serie, oltre 1000 in totale, con 334 in condizioni critiche, mentre le vittime totali sono 4142, 800 solo dall’inizio dell’anno. In questi giorni i numeri sono in discesa rispetto alla settimana scorsa, anche se il Governo ha deciso di estendere il lockdown fino alla fine di gennaio.
Era cominciato il 27 dicembre e sarebbe dovuto finire il 21 gennaio, ma l’aumento del tasso di morbilità (il numero dei casi di malattia registrati durante un periodo dato in rapporto al numero complessivo delle persone prese in esame), ha fatto propendere per l’estensione della misura restrittiva, per la quale non si può uscire di casa se non per ragioni urgenti o per fare la spesa, questa non a più di un chilometro di distanza da casa. La polizia controlla e si sta pensando anche a uno stop dei voli. Sono in molti a chiedersi come si concilino i dati dei vaccinati con l’aumento dei contagi.
I fattori dietro all’aumento dei casi in Israele sono molteplici. In primo luogo, la presenza di comunità chiuse. Sia la comunità araba che, soprattutto, quella ebrea ortodossa, sono alquanto refrattarie non solo alla vaccinazione, ma anche all’osservanza delle misure di contenimento del virus. Il problema è anche politico: è difficile pure per gli agenti far rispettare le regole in queste comunità che, infatti, hanno il dato più basso di multe comminate per violazioni alle regole di coronavirus. In questi gruppi, la vita continua nonostante la pandemia e riunioni, eventi, matrimoni e altro si celebrano e avvengono come se il Covid non ci fosse. Un altro problema riscontrato è la troppa confidenza nel vaccino.
La Pfizer, che insieme a BioNTech ha sviluppato e prodotto il vaccino che si sta inoculando in Israele, stima nel 52% l’efficacia dello stesso dopo la prima dose che sale al 95% dopo la seconda. Studi preliminari effettuati proprio sugli israeliani dagli ospedali in loco, mostrano che dal 14mo giorno dopo l’inoculazione della prima dose, il rischio di contagio scende in un range dal 33% al 60%. Fino ad oggi, circa 12.000 persone sono risultate positive in Israele dopo l’inoculazione della prima dose di vaccino. Questo perché sono in molti coloro che, dopo la prima dose, abbassano la guardia e non rispettano più le regole di contenimento, come mascherine o distanze. Inoltre, in questo periodo anche in Israele circolano le nuove varianti del Covid, in particolare quella inglese e sudafricana che, pur risultando meno letali, sono più contagiose.
Queste varianti sarebbero state portate dall’estero, in particolare dai voli provenienti dagli Emirati, divenuta meta preferita dagli Israeliani dopo la stipula degli accordi di Abramo. Tanto che il Governo ha per il momento bloccato la possibilità di recarsi senza visto nel Golfo. Proprio la variante inglese, ha causato almeno il 40% dei contagi attualmente registrati in Israele. Un altro dato che influisce sull’aumento del numero di contagi, risiede paradossalmente nella ottima risposta che il Paese ha dato all’epidemia, in particolare al numero di tamponi. Secondo i dati ufficiali, l’8 gennaio si sono eseguiti in Israele 12,26 test ogni mille abitanti mentre, per fare un esempio, lo stesso giorno non festivo per entrambi, in Italia se ne sono fatti 1,95 sempre per migliaio di abitanti.
L’11 gennaio in Israele sono stati eseguiti 126.292 tamponi, mentre in Italia, nello stesso giorno, erano stati effettuati 91.656 tamponi, 139.758 il giorno prima. In Italia il numero record di tamponi è 215.000. Il principio israeliano risiede nell’assunto “più tamponi si eseguono, più casi si scoprono”. Tra l’altro in Israele non si eseguono i tamponi rapidi, gli antigenici, ma solo i molecolari, che paiono essere più accurati e la cui risposta arriva dopo 24 ore almeno.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Sedici anni dopo le elezioni che hanno eletto Mahmoud Abbas (Abu Mazen) Presidente dell’Autorità Palestinese e 15 anni dopo le consultazioni politiche che hanno visto trionfare Hamas, nei Territori potrebbero tenersi di nuovo le elezioni. Abbas ha annunciato che entro il 20 gennaio comunicherà le date nelle quali si terranno le consultazioni per, nell’ordine di svolgimento, i membri del Consiglio Legislativo Palestinese (il Parlamento dell’Autorità Palestinese), per il Presidente e poi per il Consiglio Nazionale Palestinese, che è l’organo legislativo dell’Organizzazione di Liberazione della Palestina. Ci vorranno almeno sei mesi per organizzare il tutto, ma entro l’anno, stando all’accordo raggiunto in Turchia da una delegazione di Hamas, il gruppo che controlla Gaza e Fatah, il partito del Presidente Abbas, dovrebbero tenersi le consultazioni.
Le prime elezioni presidenziali palestinesi si tennero nel 1996 e videro la vittoria schiacciante di Yasser Arafat contro il suo unico rivale Samiha Khalil. Successive elezioni si tennero nel 2005, un anno dopo la morte del leader palestinese, e Abu Mazen vinse contro altri sei contendenti. Da allora, nonostante il suo mandato sia scaduto nel 2009 e nonostante abbia più volte detto di voler convocare elezioni, l’ottuagenario Presidente palestinese è rimasto sempre al suo posto, prolungando il suo mandato. Le ultime elezioni parlamentari invece si tennero a gennaio del 2006 e video Hamas superare Fatah. Un anno dopo, il gruppo ritenuto terroristico da molti Paesi, prese con un colpo di Stato il controllo di Gaza, decretando da un lato il confinamento della Striscia per sicurezza da parte di Israele, dall’altro l’isolamento e l’embargo da parte dell’Autorità Palestinese. In questi anni, diverse volte i due gruppi palestinesi si sono riconciliati e hanno annunciato un accordo sulle elezioni, ma non si è mai raggiunto nulla. Nel 2019, parlando all’assemblea dell’Onu, Mahmoud Abbas aveva annunciato che avrebbe tenuto le elezioni in Palestina presto, altra promessa caduta nel vuoto, fino all’accordo raggiunto dalle parti nello scorso settembre in Turchia.
Da settembre ad oggi, i vertici di Fatah e di Hamas si sono accordati e hanno limato le loro posizioni sul come e quando tenere le elezioni. Ci si incontrerà di nuovo a Il Cairo per definire gli ultimi dettagli. Ma la diffidenza da entrambe le parti è notevole. Hamas non crede fino in fondo che Abu Mazen rispetti l’impegno e molti esponenti di Ramallah non credono che Hamas sia in grado di tenere elezioni democratiche a Gaza. La preoccupazione di Hamas, che poi è la preoccupazione di Fatah, è la leadership del Paese. Allo Stato, non si è mai lavorato per una successione ad Abu Mazen che, oramai 85nne, è anche sfiduciato da gran parte della sua popolazione che lo vorrebbe dimissionario. Il vecchio leone però non cede, ed è pronto a ricandidarsi, contano su una serie di relazioni soprattutto esterne, a cominciare da quella con Joe Biden, che aveva stretto quando questi era vice Presidente Usa. Abbas è visto da molti palestinesi come amico di Israele, anche se ha sfruttato questa amicizia solo per liberarsi di avversari politici, come esponenti Hamas o membri del suo stesso partito ma avversari come Mohammed Dhalan.
Proprio quest’ultimo è uno dei papabili a guidare il Paese. Questi nasce nel 1961 in un campo profughi della striscia di Gaza e qui fa crescere il movimento giovanile di Fatah. È ovviamente arrestato diverse volte dagli israeliani, ma mai per attività terroristiche e ha la possibilità, nei suoi soggiorni forzati in carcere, di imparare bene l’ebraico. Diventa capo della forza di sicurezza preventiva di Gaza durante gli accordi di Oslo, contando su oltre 20.000 uomini e avendo, ovviamente, contatti con le intelligence di mezzo mondo, in particolare israeliana e americana. Alla fine degli anni ’90, comincia la sua parabola discendente, con l’accusa di essersi appropriato di enormi quantità di soldi delle tasse. Inoltre, poco dopo, comincerà a minare la leadership di Arafat, chiedendo più riforme, tanto da essere accusato successivamente da Abu Mazen, di aver avvelenato l’anziano leader. Con il colpo di Stato di Hamas a Gaza, perde gran parte dei suoi poteri, anche se pare abbia avuto un ruolo nell’organizzare un piano, poi non attuato, dagli americani per sovvertire Hamas. Si sa che sia gli Usa che l’Unione europea lo hanno sempre visto come il successore naturale di Abbas, tanto che fu chiesto da alcuni Governi la sua ufficiale nomina a vice.
Ma nel 2011 le accuse di frode furono rinvigorite da Abu Mazen, unendole a quelle per l’uccisione di Arafat, tanto da spingere l’uomo a scappare prima in Giordania e poi negli Emirati Arabi Uniti e la sua condanna in absentia ad alcuni anni di carcere e alla restituzione di somme. Da allora, Dahlan è consulente per gli affari palestinesi dell’emiro dell’Uae e non ha mai negato di essere dietro alla riconciliazione tra l’Emirato e Israele con gli accordi di Abramo. Nei giorni scorsi, Dahlan è stato anche pubblicamente ringraziato da Hamas perché ha girato a Gaza fondi propri e aiuti da Abu Dhabi. No solo: in uno dei media che possiede, ha diffuso un documentario nel quale accusa Abu Mazen non solo di aver condannato Fatah alla sconfitta e di aver dimenticato il popolo palestinese ma anche di essersi appropriato di più di 2 miliardi di dollari, oltre ad aver attentato alla sua vita. Alla finestra c’è pure Jibril Rajoub, l’uomo dietro l’accordo tra Fatah e Hamas. Segretario generale del movimento di Ramallah, Rajoub è anche popolare per essere il Presidente del comitato olimpico palestinese ma, soprattutto, della federazione gioco calcio della Palestina. Anche lui in carcere israeliano ha imparato bene a parlare ebraico ed è amico di Saleh al-Arouri, vice capo di Hamas, con il quale ha trascorso molti anni nelle carceri israeliane. Proprio il rapporto tra i due ha portato alla quasi riconciliazione (almeno per le elezioni) tra Fatah e Hamas.
Nei primi ani ‘90, ai tempi degli accordi di Oslo, Dahlan, che è ben visto da molti palestinesi soprattutto per gli aiuti che invia e per essere il collante (grazie alla sua origine) con Gaza, era il vice di Rajoub che in più di una occasione negli ultimi tempi gli ha lanciato segnali distensivi. Dall’altro lato, al-Arouri aspira a prendere presto il posto di Ismail Haniyeh, il leader di Hamas, nelle elezioni che si dovrebbero tenere nel movimento. La tornata quindi, soprattutto quella presidenziale, semmai si dovesse tenere (sono in molti a non crederci fio in fondo, sia in Palestina che all’esterno), passa per Gaza. Difficilmente Hamas, anche in questo momento di distensione, sosterrebbe Mahmoud Abbas o qualche suo sodale. Potrebbe fare una eccezione per Rajoub, visti i suoi rapporti con il movimento e potrebbe sostenere (in mancanza di un proprio candidato) il gazawi Dahlan. Anche se significherebbe fare un ampio passo avanti verso Israele e Usa. Non a caso gli esponenti di Hamas negli ultimi tempi hanno dichiarato che per loro il candidato ideale è Marwan Barghouti, l’ex leader di Tanzim, uno dei bracci armati di Fatah, leader nella seconda intifada, in carcere in Israele perché condannato a svariati ergastoli per diversi attentati.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Sono i vaccini anti Covid l’ultima arma politica di Benjamin Netanyahu per restare alla guida di Israele e mostrarsi come leader efficiente e benevolo. Il suo Governo, caduto alla fine di dicembre, è stato infatti in grado di organizzare e gestire la più fruttuosa campagna vaccinale del mondo, portando Israele a essere il primo Paese al mondo per dosi inoculate in percentuale alla popolazione (superato il 15% in due settimane) e il terzo per il totale di dosi (quasi 1,5 milioni).
Il tutto, grazie a un potente e collaudato apparato che vede centri vaccinali aperti 24 ore su 24 tutti i giorni, alcuni anche di Shabbat e capacità di stoccaggio e distribuzione notevoli. Non solo: Israele, tra i primi Paesi al mondo, ha sottoscritto accordi con tutti i produttori di vaccini, assicurandosi, spesso a caro prezzo, le dosi necessarie per vaccinare l’intera popolazione e più.
Solo da Pfizer, Netanyahu ha acquistato 8 milioni di dosi, capaci di vaccinare quasi la metà della popolazione israeliana che assomma a poco più di 9 milioni di persone. Dosi molte delle quali già consegnate e conservate negli hangar refrigerati militari nel deserto del Neghev. Per assicurarsi queste dosi, Israele ha pagato 60 dollari a dose, il doppio del prezzo solito, lasciando però gratuito ai suoi abitanti il vaccino come gratuiti sono i test. Altri vaccini sono stati acquistati da Moderna e dovrebbero arrivare nei prossimi giorni, dopo che si era temuto che la campagna che viaggia a ritmi di 150.000 vaccini al giorno, si sarebbe dovuta fermare per carenza di dosi.
Tra i più riluttanti, le comunità arabe, tanto che molti israeliani non arabi si sono fatti vaccinare nelle città arabe per non aspettare troppo. Proprio sul successo di questa campagna, Netanyahu punterà a marzo quando si ripresenterà per le quarte elezioni in due anni. Ma nonostante la campagna vaccinale, i contagi non solo continuano a salire ma addirittura raggiungono cifre record di 8mila al giorno, rendendo necessario un lockdown di due settimane, il terzo dall’inizio della pandemia.
Il Paese si è già chiuso a febbraio e poi a ottobre in occasione delle feste religiose ebraiche e da stasera si chiuderà di nuovo. Impossibile per i non israeliani, anche con permessi, entrare nel Paese da settimane e tutti gli israeliani che fanno ritorno sono soggetti a quarantena in un Covid hotel. Proprio il nuovo lockdown ha spinto Netanyahu a chiedere alla corte il rinvio dell’ultima udienza preparatoria del suo processo, prevista per il 13 febbraio. Questa dovrebbe essere l’ultima udienza prima che a febbraio si vada in aula con i testimoni, nel processo per il quale in tre casi Netanyahu è accusato di frode, violazione della fiducia e di corruzione.
Ma i vaccini potrebbero anche essere un’arma politica di Netanyahu nei confronti dell’Autorità Palestinese. Questa infatti sta vivendo una grave crisi a causa del coronavirus, con circa 2000 casi al giorno su 5milioni di abitanti ma con sette volte in meno il numero di tamponi eseguiti in Israele (che sono quattro volte in più in percentuale di quelli fatti in Italia). Alcune Ong, tra le quali Amnesty International, accusano Israele di non voler offrire il vaccino ai palestinesi. Ma secondo gli accordi di Oslo del 1993, che regolano i rapporti tra i due Stati, è l’Autorità Palestinese, non Israele, responsabile per la salute dei palestinesi in Cisgiordania, tant’è vero che i palestinesi residenti a Gerusalemme est, sotto controllo israeliano, riescono a vaccinarsi in Israele.
Fino ad oggi, l’Autorità Palestinese non ha chiesto aiuto a Israele per l’approvvigionamento di vaccini anti Covid e ha provveduto autonomamente. Ieri sera la televisione israeliana ha dato notizia di alcune dosi inviate da Israele verso Ramallah per scopi umanitari e che questa sarebbe anche pronta a chiedere molte più dosi, ma non ci sono conferme da parte palestinese. L’AP avrebbe una accordo con la Russia per l’acquisto di 4 milioni di dosi del vaccino, che però arriveranno a fine gennaio per cominciare le vaccinazioni a febbraio. Inoltre, il Governo di Ramallah confida sull’aiuto di diversi donatori, tra i quali anche Cina, Gran Bretagna e Unione europea, per vaccinare almeno il 20% dei 2,5 milioni di palestinesi (Gaza esclusa). L’Autorità Palestinese spera di ottenere vaccini attraverso Covax, una partnership guidata dall’Oms con organizzazioni umanitarie che mira a fornire vaccini gratuiti fino al 20% della popolazione dei Paesi poveri, molti dei quali sono stati particolarmente colpiti dalla pandemia. Ma il programma si è assicurato solo una frazione dei due miliardi di dosi che spera di acquistare quest’anno, non ha ancora confermato alcun accordo effettivo ed è a corto di liquidità.
A complicare le cose è il fatto che i palestinesi hanno una sola unità di refrigerazione, nella città di Gerico, in grado di conservare il vaccino Pfizer/BioNTech. Per tutte queste difficoltà Ramallah sarebbe pronta a chiedere aiuto a Israele sui vaccini e Netanyahu pronto anche a concederli. Ma non senza un tornaconto. Vaccinare anche i palestinesi, per Israele significa essenzialmente tre cose: 1) aumentare il credito e la benevolenza dei Paesi arabi con i quali ha siglato gli Accordi di Abramo e assicurarsi quella dei Paesi arabi che sono alla finestra pronti a siglare l’intesa; 2) favorire le imprese israeliane che adoperano la manodopera della Cisgiordania e impedire il diffondersi del contagio in Israele; 3) favorire l’apertura turistica di Israele visto che i luoghi sacri palestinesi legati al cristianesimo, come Betlemme, sono parte integrante del circuito turistico di Terra Santa. In ogni caso, è una vittoria per Netanyahu. L’ennesima in questi anni.
Inserendo il codice che hai trovato nel numero cartaceo del nuovo numero di eastwest puoi scaricare anche la versione digitale in PDF gratis