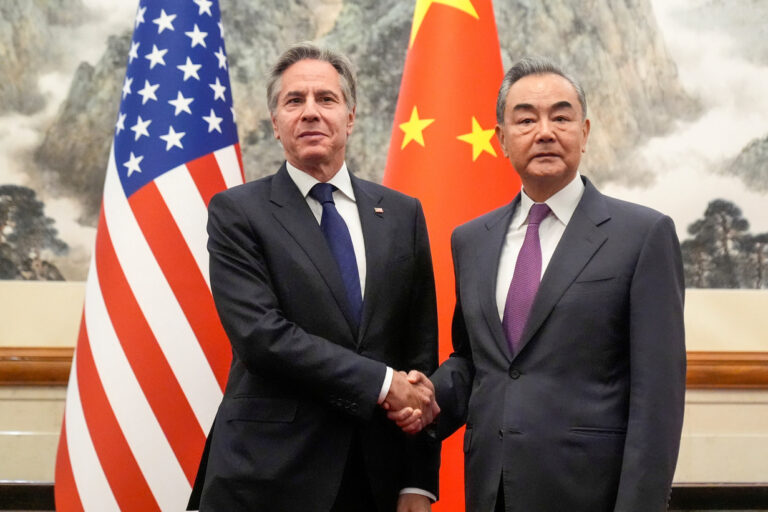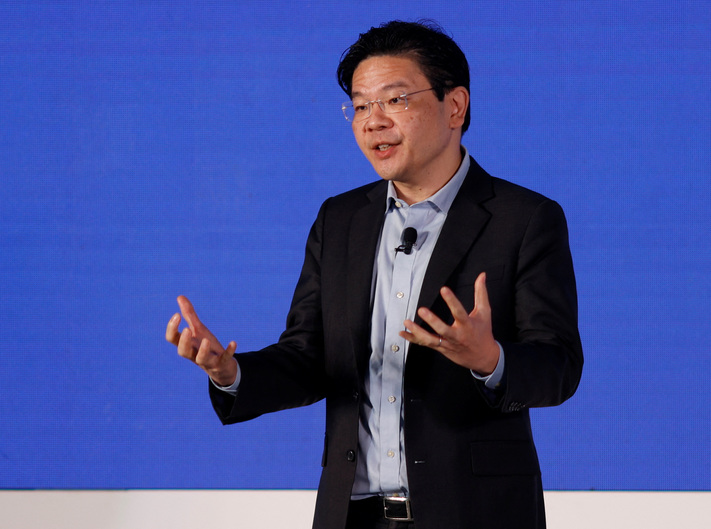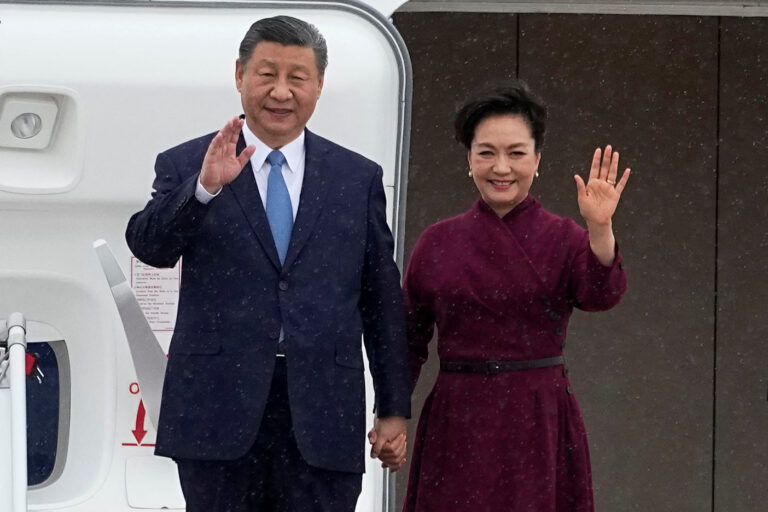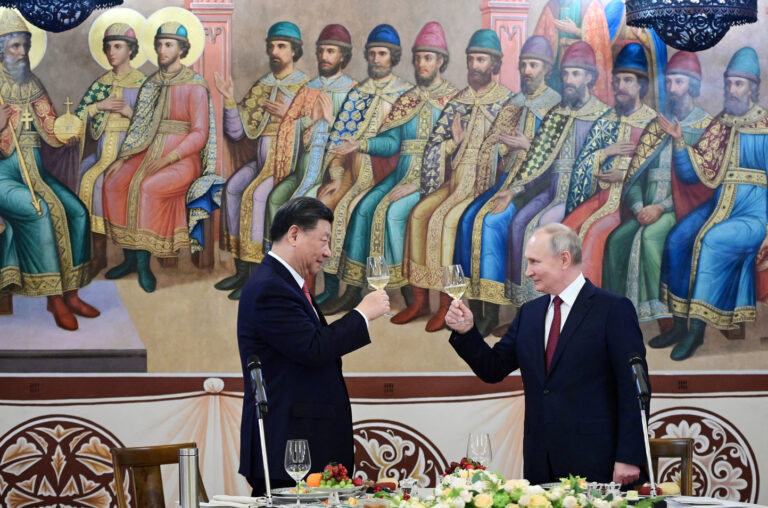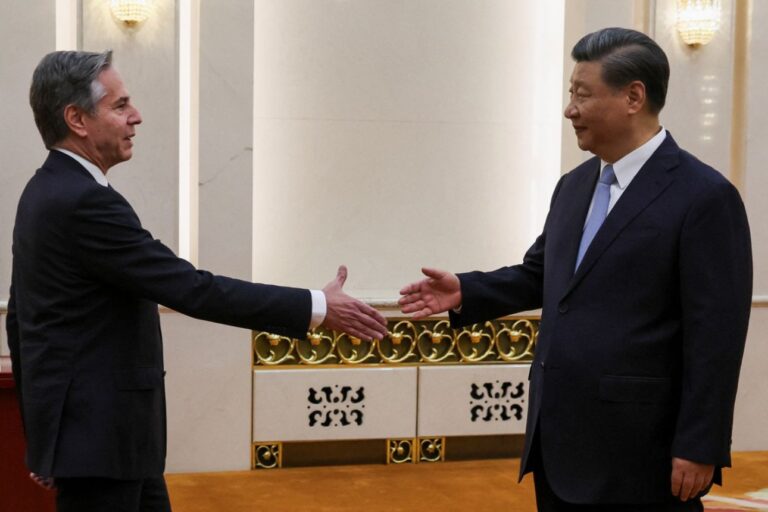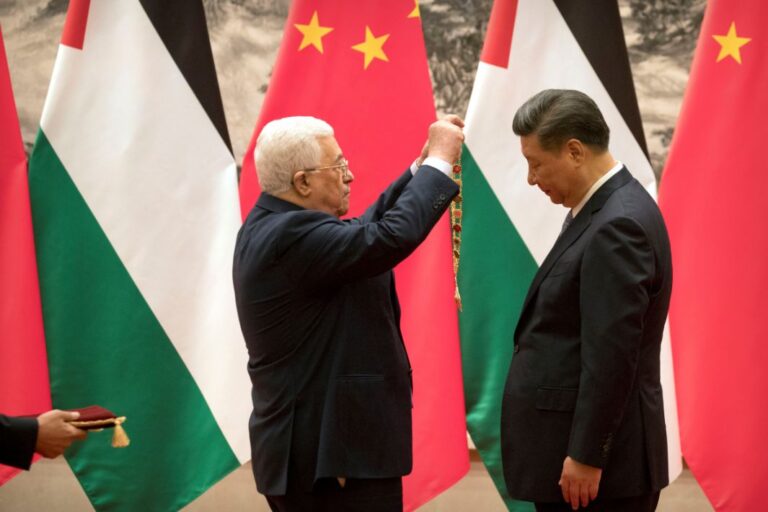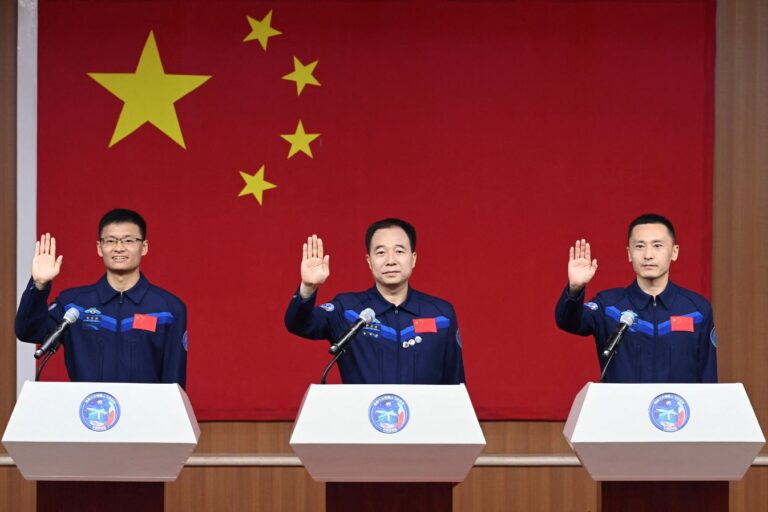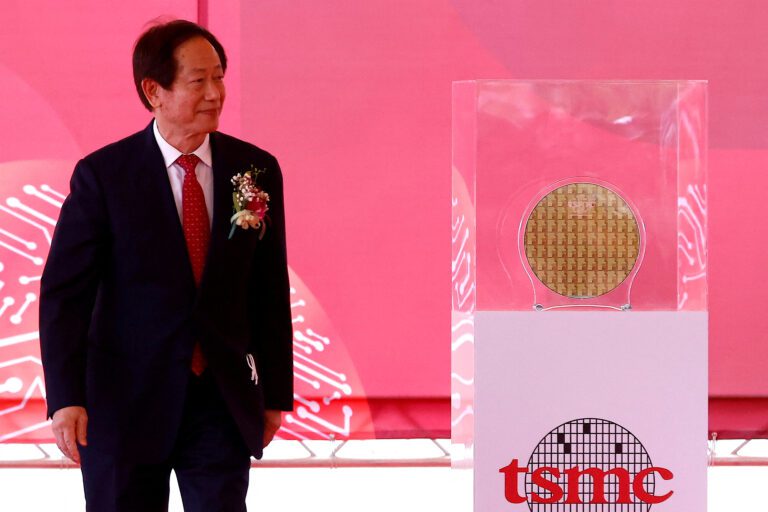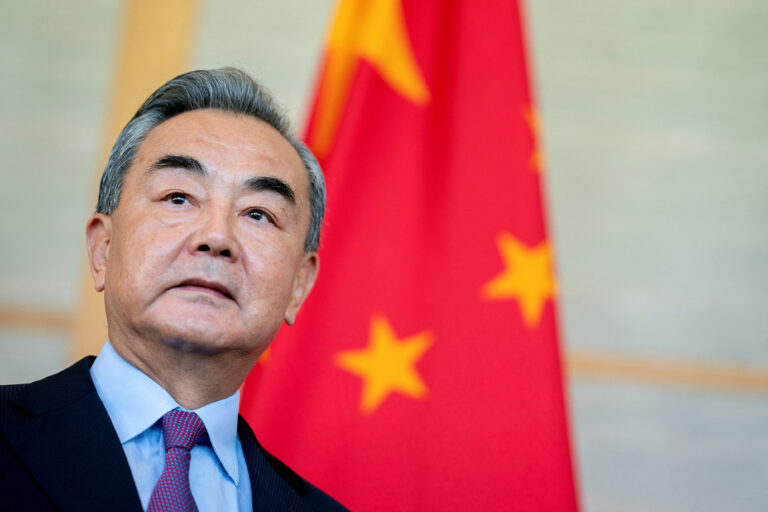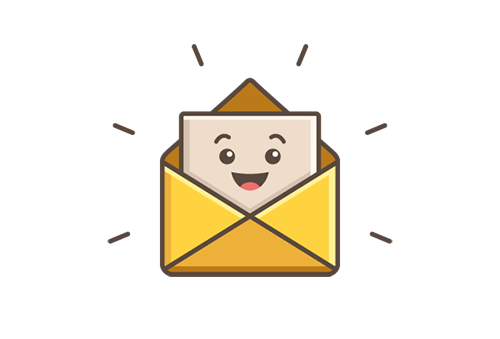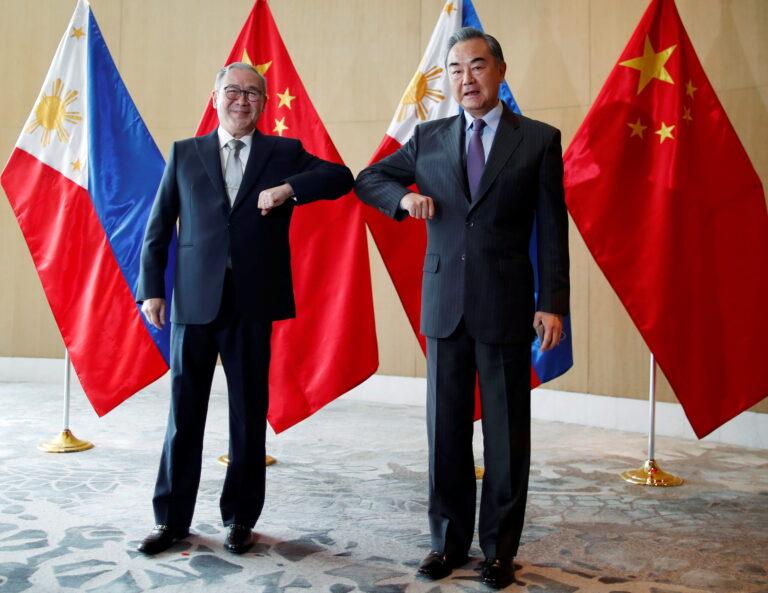Giornalista. Direttore editoriale di China Files. Collabora con diverse testate tra cui Eastwest, La Stampa, RSI, Il Manifesto, Wired. Attualmente di base a Taipei.

Giornalista. Direttore editoriale di China Files. Collabora con diverse testate tra cui Eastwest, La Stampa, RSI, Il Manifesto, Wired. Attualmente di base a Taipei.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
204 sì. Poco prima delle 17 di sabato 14 dicembre, diventa ufficiale: la mozione di impeachment contro Yoon Suk-yeol è stata approvata. Yoon diventa così il terzo presidente della Corea del Sud a finire in stato d’accusa, 11 giorni dopo aver imposto la tredicesima legge marziale della storia del Paese asiatico, la prima da quando è una democrazia. È stato dunque ribaltato l’esito del voto sulla prima mozione di sabato 7 dicembre. In quell’occasione, il Partito del Potere Popolare (PPP) aveva deciso di boicottare il voto contro il suo presidente conservatore. All’opposizione guidata dal Partito Democratico (PD), servivano infatti almeno otto voti della forza di governo per far approvare l’impeachment, per cui sono necessari almeno i due terzi dei voti sui 300 seggi dell’Assemblea nazionale. Nel secondo voto ne sono arrivati 12, con 85 esponenti del PPP che hanno invece votato contro l’impeachment di Yoon. Il cambio di linea sembrava difficilmente pronosticabile, almeno fino a qualche giorno fa. Il leader di partito Han Dong-hoon e il premier Han Duck-soo avevano infatti pensato a una via d’uscita per il blocco conservatore e lo stesso Yoon: una sorta di commissariamento dell’amministrazione, con poteri informalmente trasferiti ai due Han e tabella di marcia verso le dimissioni e un’uscita ordinata, che lasciava intravedere qualche possibile tutela a beneficio del presidente.
Ma Yoon ha respinto l’ipotesi. In un discorso alla nazione, giovedì 12 dicembre ha rigettato lo scenario delle dimissioni e ha promesso di “lottare fino alla fine”, rivendicando peraltro come un “legittimo atto di governo” l’imposizione della legge marziale, resasi a suo dire necessaria per garantire il funzionamento delle istituzioni democratiche di fronte al “sabotaggio” dell’opposizione parlamentare. Insomma, nessun cedimento e nessuna scusa, ma un muro contro muro. Il PPP è stato costretto a modificare approccio, nonostante i grandi svantaggi strategici. Il leader dell’opposizione, Lee Jae-myung del PD, è infatti in attesa di un processo d’appello che potrebbe confermare la sua condanna per dichiarazioni false in occasione della campagna elettorale del 2022. In caso di condanna, Lee sarebbe escluso delle prossime presidenziali. Per questo al PPP serviva prendere tempo, lasciando inoltre libera la Corte costituzionale di prendersi in carico le vicende giudiziarie riguardanti Lee, piuttosto che la procedura di impeachment di Yoon. E invece ora i giudici dovranno concentrarsi proprio sul dossier riguardante la destituzione del presidente.
Dopo il voto di sabato, Yoon è stato immediatamente sospeso dall’incarico e privato dei suoi poteri, trasferiti al premier e ora presidente ad interim Han. Si attende ora la Corte costituzionale, chiamata a confermare o respingere la destituzione di Yoon entro 180 giorni. Affinché la Corte possa confermare l’impeachment, sei dei suoi nove giudici dovranno votare a favore della mozione. Per avere una sentenza ci vorrà un massimo di 180 giorni. Nel 2017 ci vollero in realtà tre mesi per confermare l’impeachment dell’allora presidente Park Geun-hye, rimossa per uno scandalo di corruzione, ma stavolta l’attesa potrebbe essere più lunga visto che l’Assemblea nazionale deve ancora nominare i sostituti di tre giudici. Qualora la Corte costituzionale confermasse l’impeachment, ci sarebbero nuove elezioni presidenziali entro 60 giorni dalla sentenza. Si può dunque immaginare che la Corea del Sud potrebbe essere chiamata a scegliere un nuovo presidente tra la primavera e l’estate dell’anno prossimo. Nel frattempo, si stringe sempre il cerchio della giustizia. Yoon è indagato per insurrezione e abuso di potere: il suo passaporto è stato confiscato e le autorità hanno cercato già in due occasioni di perquisire i suoi uffici. L’ex ministro della Difesa Kim Yong-hyun, fedelissimo di Yoon, ha tentato il suicidio in carcere dove si trova con l’accusa di tradimento. Sono emerse presunte prove sul fatto che sarebbe stato predisposto già a novembre un piano per imporre la legge marziale, con l’ipotesi di una crisi indotta con la Corea del Nord attraverso l’invio di droni militari oltreconfine.
Sul piano interno, si tratterebbe dell’epilogo auspicato dalla maggioranza, come dimostrano le enormi manifestazioni di protesta anti Yoon, mai interrotte dopo la legge marziale del 3 dicembre. Ma la realtà è che la Corea del Sud, dopo aver salvato il proprio sistema democratico, entra in una fase di grande incertezza. Le conseguenze possono essere notevoli anche sul piano internazionale. Negli ultimi anni, Seul aveva rafforzato l’alleanza con gli Stati Uniti e rilanciato quella col Giappone, adottando una linea dura con la Corea del Nord e aprendo all’invio di armi in Ucraina dopo l’accordo militare sottoscritto da Kim Jong-un e Vladimir Putin. Lee, che in caso di elezioni sarebbe il grande favorito, propone invece il tentativo di riaprire il dialogo con Pyongyang, mette in discussione il disgelo con Tokyo e si posiziona in modo più conciliante nei confronti della Cina. Forse non a caso, subito dopo la conferma dell’impeachment di Yoon, alti diplomatici sudcoreani hanno incontrato gli ambasciatori di Cina, Stati Uniti e Giappone, per evidenziare la determinazione di Seul a mantenere la postura internazionale di questi anni e rafforzare i legami con partner e alleati. Almeno per ora.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
È stata incredibile la settimana vissuta a Seul e dintorni: il presidente Yoon Suk-yeol che dichiara la legge marziale, l’esercito che prende d’assalto l’Assemblea nazionale mentre i parlamentari votano la richiesta di revoca, il voto senza quorum sulla procedura di impeachment, le immense proteste che stanno riempiendo le strade della capitale, il commissariamento del leader da parte del partito di governo, in quello che l’opposizione definisce un secondo tentativo di golpe. E la sensazione, o meglio la certezza, è che si sia solamente all’inizio.
Tutto comincia martedì 3 dicembre, poco prima delle dieci e mezza di sera, quando Yoon convoca un’improvvisa conferenza stampa. Nel suo discorso, attacca i tentativi dell’opposizione di “minare” il suo governo, prima di dichiarare che stava dichiarando la legge marziale per “schiacciare le forze anti statali che stanno creando scompiglio”. Una decisione, dice, obbligata per “proteggere il Paese dalle forze comuniste nordcoreane”. In realtà, la mossa non è legata al rischio di un attacco imminente del regime di Kim Jong-un, ma a ragioni interne. Secondo il presidente conservatore, l’opposizione “ha paralizzato il governo” trasformando il parlamento “in un rifugio per criminali che cercano di paralizzare il sistema amministrativo-giudiziario e di rovesciare il nostro ordine democratico liberale”. A partire dalle 11 di martedì sera, era entrato in vigore un decreto che predisponeva la creazione di un comando militare preposto a mettere in atto la legge marziale. Fuorilegge qualsiasi attività politica, comprese quelle dell’Assemblea nazionale e ogni forma di protesta o assembramento. Media ed editori vengono posti sotto controllo, mentre si prevede la possibilità di procedere ad arresti anche senza mandato. In tanti pensano addirittura a un deepfake, ipotesi non così remota in un paese dove i veleni politici hanno raggiunto un apice assai pericoloso. E invece è tutto vero. I sudcoreani lo capiscono quando vedono in tv gli elicotteri sopra l’Assemblea nazionale, coi blindati dell’esercito all’esterno. Immagini che evocano inevitabilmente i tempi bui della dittatura e delle 12 leggi marziali del passato, di cui l’ultima imposta nel 1980 portò a conseguenze sanguinose.
Opposizione politica e società civile non restano però a guardare. Il Partito Democratico di Lee Jae-myung, che ha un’ampia maggioranza parlamentare dopo aver stravinto le elezioni legislative dello scorso aprile, riesce a votare verso l’una di notte un provvedimento di richiesta di revoca della legge marziale. I 190 deputati presenti sono costretti a votare asserragliati dentro l’aula, mentre oltre 200 militari fanno irruzione nell’edificio. All’esterno, migliaia di persone protestano contro la legge marziale e cercano di impedire ai soldati di entrare. Alla fine, la richiesta di revoca passa e i militari lasciano lentamente il parlamento. Verso le quattro e trenta del mattino, Yoon esegue la richiesta del parlamento.
La cronaca di una notte folle non basta, però, a raccontare quanto sta accadendo e quanto potrebbe accadere in Corea del Sud. Da mercoledì scorso, il Paese è in subbuglio. Le proteste si susseguono tutti i giorni, con i sindacati (elemento centrale della democratizzazione coreana) che hanno dichiarato uno sciopero generale a oltranza fino a quando Yoon non si dimetterà o non verrà rimosso. A livello politico, nonostante abbia subito criticato la legge marziale e abbia chiesto al presidente di farsi da parte, il Partito del Potere Popolare di Yoon ha scelto di boicottare il voto sull’impeachment di sabato sera. L’opposizione aveva bisogno di otto dissidenti nella forza di maggioranza per ottenere la rimozione immediata del presidente, ma solo in tre sono rimasti in aula a votare. Non sufficienti per raggiungere il quorum.
Lee ha già annunciato una seconda procedura di impeachment, che approderà in parlamento mercoledì 11 dicembre per essere poi votata tra il 13 e il 14 dicembre. Ma il rischio è di un muro contro muro totale, assai pericoloso. Questo perché il partito di governo ha scelto di compattare le sue fila con un originale commissariamento di Yoon. In una controversa conferenza stampa domenicale, il premier Han Duck-soo e il leader del partito di governo Han Dong-hoon hanno infatti annunciato di averlo messo sotto tutela. “Non prenderà più parte agli affari di stato, politica estera inclusa”, ha detto il premier, che ha prospettato un’uscita di scena ordinata per Yoon, senza però specificare le tempistiche delle sue dimissioni. La mossa era forse volta a tranquillizzare chi teme un’ipotetica seconda legge marziale di Yoon, ma in realtà ha fatto arrabbiare quasi tutti. L’opposizione sostiene che si tratti di un secondo golpe, visto che non esistono norme costituzionali che prevedono il passaggio dei poteri presidenziali a un leader di partito. E le proteste proseguono. Resta anche poco chiaro capire chi gestisce i rapporti diplomatici e chi controlla davvero l’esercito, visto che per costituzione è il presidente l’unico capo delle forze armate. La maggioranza vuole evitare elezioni immediate, dove la débacle sarebbe praticamente una certezza, e ha già dato segnali di voler provare un dialogo con l’opposizione, proponendo delle riforme costituzionali basate sulla riduzione del mandato presidenziale a quattro anni invece di cinque, consentendo però un secondo mandato. Difficile però immaginare che questo funzioni. La pressione dell’opposizione e di una società civile infuriata per la legge marziale è destinata ad aumentare.
Nel frattempo, la giustizia inizia a fare il suo corso. Già finito in manette Kim Yong-hyun, il ministro della Difesa che avrebbe suggerito di imporre la legge marziale a Yoon, di cui è grande amico sin dai tempi in cui erano compagni di liceo. Kim avrebbe anche ordinato l’arresto dei leader dell’opposizione. Nei giorni scorsi gli era stato già confiscato il passaporto, dopo che era circolata la voce di un suo piano di fuga in Giappone. Emerge tra l’altro l’ipotesi che fosse allo studio un piano per alimentare una crisi militare con la Corea del Nord per avere la scusa di sospendere la democrazia. Si è invece dimesso il ministro dell’Interno, Lee Sang-min, su cui era stata aperta un’ulteriore procedura di destituzione. Ma il cerchio rischia di chiudersi anche intorno a Yoon. Sul piano giudiziario, gli inquirenti hanno annunciato un’indagine a suo carico con le accuse di insurrezione e abuso di potere.
Attenzione anche alle conseguenze internazionali. Vista la grande debolezza sul fronte interno, Yoon si era molto concentrato sul rafforzare la presenza di Seul sulla scena internazionale. Ha rafforzato l’alleanza con gli americani, visitando a più riprese gli Stati Uniti e cantando anche “American Pie” durante la visita di Stato alla Casa Bianca. Ha sottoscritto uno storico documento di partnership con la Nato e ha riavviato i rapporti col Giappone, ottenendo il disgelo anche a costo di cancellare le richieste di risarcimento per gli abusi del periodo della dominazione coloniale. Ha adottato una linea da “occhio per occhio” con Pyongyang, in cui ha sempre provato a rispondere colpo su colpo alle mosse e provocazioni di Kim. Infine, si è decisamente schierato contro la Russia sulla guerra in Ucraina e proprio nei giorni scorsi ha aperto per la prima volta all’invio di armi a Kiev, dopo aver ricevuto il ministro della Difesa di Volodymyr Zelensky. Tutti elementi che hanno peggiorato i rapporti della Corea del Sud con la Cina e che hanno prodotto forti critiche dell’opposizione. Yoon è stato accusato di essere un “servo dei giapponesi” e di rischiare di trascinare il Paese in guerra.
Il caos improvviso rischia di lasciare Washington con un fondamentale alleato distratto. E soprattutto rischia di lasciare Seul esposta a eventuali mosse rivali, dopo che la Corea del Nord ha siglato con la Russia un trattato di mutua difesa che Pyongyang ha comunicato essere entrato in vigore il 4 dicembre. Esattamente nelle ore in cui Seul era ancora sotto choc per quella legge marziale che ha riaperto le ferite del suo passato, aprendo incognite sul suo futuro.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
2 dicembre 2016. Donald Trump accetta la telefonata di Tsai Ing-wen. Il presidente eletto degli Stati Uniti, meno di 50 giorni prima dell’ingresso alla Casa Bianca, riceve le congratulazioni della presidente taiwanese. È il colloquio ufficiale più alto in grado da quando i rapporti bilaterali tra Washington e Taipei sono stati recisi, vale a dire nel 1979.
L’episodio inquieta la Cina, che da lì in avanti alza le pressioni sull’isola che continua a rivendicare come parte del suo territorio. È forse quello il momento che mette in moto una serie di processi che si vedono ancora oggi, acuiti dalle rispettive manovre per testare le cosiddette linee rosse di tutte e tre le parti. Gli Stati Uniti non vendono solo armi, iniziano a mandarle. Eliminano le restrizioni autoimposte nelle relazioni con ufficiali taiwanesi e svolgono una serie di visite di alto livello, su tutte quella dell’allora presidente della Camera del Rappresentanti, Nancy Pelosi, che nell’agosto 2022 si presenta a Taipei.
La Cina non esercita solo la tradizionale coercizione diplomatica sui Paesi che continuano a intrattenere rapporti diplomatici con Taipei, ma inizia ad affilare il proprio arsenale normativo e militare, conducendo sempre più frequenti esercitazioni sullo Stretto. E poi Taiwan, che dopo l’approccio moderato di Tsai passa a una postura più assertiva su sovranità e identità con il presidente Lai Ching-te, entrato in carica lo scorso maggio. Tutte e tre le parti, insomma, sembrano in parte impegnate a erodere l’ambiguità strategica che ha consentito il mantenimento dello status quo finora.
2 dicembre 2024. Otto anni dopo quella telefonata, Trump è ancora una volta il presidente eletto. E Lai si trova alle Hawaii nel suo primo passaggio in territorio statunitense da quando è il leader. Ancora una volta, sembra di trovarsi all’alba di un potenziale nuovo cambio di passo sugli equilibri del luogo su cui si concentrano le attenzioni delle due più grandi potenze di questo inizio di terzo millennio. Già dalla scorsa estate si era iniziato a parlare di un possibile “transito”, così come vengono etichettate queste visite che gli Stati Uniti definiscono “non ufficiali” per restare dentro un perimetro diplomatico consueto. D’altronde, non si tratta di un episodio così inusuale. Nei suoi otto anni da presidente, Tsai ha compiuto nove “transiti” su territorio statunitense, sempre durante delle visite ad alcuni dei 12 alleati diplomatici rimasti in giro per il mondo, concentrati soprattutto tra America latina e Pacifico meridionale. Il numero avrebbe potuto essere anche più alto, se non ci fosse stata la pandemia. L’ultima volta, Tsai è stata alle Hawaii nel 2019, mentre a Guam era stata nel 2017. Lai effettuerà invece un doppio transito in entrambi i territori sotto amministrazione americana. Quasi 48 ore alle Hawaii, prima di arrivare alle Isole Marshall il 3 dicembre e passare a Tuvalu il 4 dicembre. Previsto poi un passaggio a Guam il 5 dicembre, prima dell’ultima tappa del viaggio a Palau.
Lai aveva fretta di effettuare questo viaggio, per non terminare il 2024 (primo anno da presidente) senza visite internazionali. Secondo quanto risulta, Washington avrebbe indicato a Lai che l’unica opzione erano le isole del Pacifico e non una tappa sul “continente”. Andare alle Hawaii è considerato meno sensibile di una visita sul “continente”, anche se a Honolulu e dintorni c’è anche la sede del comando Indo-Pacifico dell’esercito statunitense. Sulle tempistiche, però, ha alla fine avuto ragione Lai. L’indicazione iniziale era quella di un viaggio a metà gennaio, in occasione dell’insediamento del presidente di Palau, evento che offriva una “scusa” di agenda diplomatica più concreta. Ma Lai non voleva sforare al 2025, soprattutto ai giorni immediatamente precedenti all’insediamento di Trump, quando presumibilmente tutte le attenzioni sarebbero state sulla Casa Bianca.
C’è anche una logica interna. Per la prima volta, un presidente taiwanese ha un predecessore dello stesso partito, di cui dunque non può squalificare o criticare le mosse o i viaggi internazionali. Nonostante siano entrambi esponenti del Partito progressista democratico (DPP), non è un mistero che in passato Lai e Tsai non si siano per niente amati. La ex presidente è molto attiva, grazie anche all’assenza di incarichi ufficiali che le rende più semplice ottenere il via libera dei Paesi ospitanti. Tsai è reduce da due viaggi in Europa e in Canada e prossima a una nuova visita negli Stati Uniti. Lai aveva bisogno di fare a sua volta qualcosa.
In passato, la Cina ha sempre condannato i transiti dei presidenti taiwanesi. Celeberrimo il caso delle esercitazioni e lancio di missili che diedero vita alla terza crisi sullo Stretto del 1995-1996, dopo che gli Usa accolsero il primo presidente democraticamente eletto a Taiwan, Lee Teng-hui. Più di recente, sono state inviate invece ampie esercitazioni militari nell’aprile 2023, dopo l’ultimo passaggio negli Usa di Tsai. Si trattava però di un caso particolare. Arrivava infatti dopo il “nuovo status quo” creato dalla visita di Pelosi. E, soprattutto, nel suo doppio transito Tsai ha anche incontrato proprio il successore di Pelosi, Kevin McCarthy. Resta da capire in questo caso quale sarà l’agenda di Lai e chi andrà a incontrarlo.
Nel 2019, Tsai alle Hawaii era stata ricevuta da un alto ufficiale dell’esercito americano e aveva visitato l’agenzia di gestione delle emergenze e il centro di risposta ai disastri. Le voci di colloqui al comando dell’Indo-Pacifico non sono mai state ufficializzate. Da vedere se questo accadrà invece con Lai, che potrebbe anche annunciare l’intenzione di acquistare un vasto pacchetto di armi nei prossimi mesi. Mossa che sarebbe finalizzata all’alba del secondo mandato di Trump, proprio per ingraziarsi il tycoon che ha più volte criticato Taipei, chiedendo un aumento delle spese di difesa.
Ma la sensazione è che la Cina risponderà in ogni caso. Da quando si è insediato Lai, il Partito comunista ha comunicato più volte il suo malcontento per Lai, definito un “secessionista radicale”. Assai rilevante che, durante l’ultimo recente incontro a Lima con Joe Biden, il presidente cinese Xi Jinping abbia menzionato esplicitamente Lai. Circostanza assai inusuale. Motivo? Pechino vuole incanalare la responsabilità di tutte le tensioni sul leader taiwanese, personalizzando dunque i problemi esistenti. La logica è doppia. Sul piano interno, si vuole segnalare che la “riunificazione pacifica” è un obiettivo ancora possibile, intralciato al momento da un singolo e dal suo partito piuttosto che da tutta la società taiwanese. Sul piano internazionale, serve invece a giustificare eventuali azioni coercitive. Difficile dunque attendersi un trattamento da “business as usual” per il doppio transito di Lai.
È ritenuto probabile che Pechino dia il via a un nuovo round di esercitazioni militari, dopo il rientro di Lai a Taipei, previsto per il 6 dicembre. Sarebbero le terze manovre nel giro di sette mesi, dopo quelle di maggio in reazione al discorso di insediamento di Lai e quelle di ottobre in risposta al primo discorso in occasione della festa nazionale della Repubblica di Cina. Mentre nei due casi precedenti le logiche erano quasi esclusivamente interne e intrastretto, stavolta le possibili esercitazioni “Spada Congiunta 2024 C” avrebbero come destinatario anche gli Stati Uniti. E in particolare Trump, con la Cina che marcherebbe ancora una volta il territorio prima del suo insediamento per rendere chiaro che su Taiwan non è possibile negoziare.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Se c’erano ancora dei dubbi, ora davvero il fronte europeo e quello asiatico sembrano connessi come mai prima. Non solo migliaia di soldati della Corea del Nord sono già impegnati nei combattimenti al fianco della Russia nella guerra in Ucraina. Ora, Mosca inizia a contraccambiare il “favore” di Pyongyang inviando nel Paese asiatico missili antiaerei e attrezzature di difesa aerea.
Lo ha detto esplicitamente, ed è la prima volta, il consigliere per la sicurezza nazionale della Corea del Sud, Shin Won-sik. Vladimir Putin starebbe dunque garantendo a Kim Jong-un sostegno economico e tecnologia militare in cambio di truppe, razzi e munizioni di artiglieria. D’altronde, proprio nelle scorse settimane è stato ratificato l’accordo di mutua difesa siglato dal presidente russo e dal leader supremo nordcoreano lo scorso giugno, durante la storica visita del capo del Cremlino in Corea del Nord.
L’agenzia di intelligence ha affermato che Pyongyang ha inviato più di 13 mila container di artiglieria, missili e altre armi convenzionali in Russia dall’agosto 2023. Un modo anche per testare armi e uomini in combattimento, in vista di possibili conflitti in Asia orientale. L’intelligence della Corea del Sud ritiene che le truppe dispiegate in Russia siano state assegnate a una brigata aviotrasportata e a un corpo di marina a terra, e che alcuni dei soldati siano già entrati in combattimento.
Il ministro degli Esteri nordcoreano Choe Son Hui ha recentemente visitato Mosca e ha dichiarato che il suo Paese “resterà fermamente al fianco dei nostri compagni russi fino al giorno della vittoria”. Nei giorni scorsi c’è stata invece una delegazione russa a Pyongyang, guidata dal ministro delle Risorse naturali. Visita culminata con la firma di un protocollo che prevede un rafforzamento della cooperazione in materia commerciale, tecnologica e turistica.
Il tutto accade in un momento davvero delicato per gli equilibri nella penisola coreana. I territori all’interno della zona demilitarizzata sarebbero anche stati spianati, una possibile violazione della tregua sottoscritta nel 1953 al termine della guerra di Corea. Il conflitto è stato sospeso ma ufficialmente non si è peraltro mai davvero concluso, visto che non è stato sottoscritto alcun accordo di pace. Il fragile status quo si è fin qui retto sulla costituzione di questa zona demilitarizzata, quattro chilometri da una e dall’altra parte in cui non sono consentite installazioni militari e i movimenti sono ampiamente controllati. Per sfociare in una zona di controllo congiunto, il gruppo di casette presidiato da truppe di una e dell’altra parte dove si sono tenuti i vari vertici tra le due Coree.
Poche settimane fa, Kim ha fatto esplodere le strade di collegamento intercoreano. Nonostante fossero inutilizzate da tempo, il messaggio è di una totale indisponibilità al dialogo con Seul. Dopo di che, è stata emendata la costituzione in modo da rinnegare lo storico obiettivo della riunificazione e identificare la Corea del Sud come un “Paese straniero e ostile”. Più di recente, il leader supremo si è fatto ritrarre durante un’ispezione al lancio dei nuovi droni suicidi. Il timore concreto è che l’asse con Mosca possa portare Kim a compiere mosse anche più audaci.
Attenzione però alla variante Trump. Durante il suo primo mandato, il presidente eletto degli Stati Uniti fu protagonista di due vertici con Kim, tra Singapore e Hanoi (Vietnam). Per poi andarlo anche a incontrare lungo la zona demilitarizzata il 30 giugno 2019. Da lì, la situazione è precipitata e le tensioni sono aumentate a dismisura. Con una delle nomine annunciate nei giorni scorsi, Trump pare segnalare l’interesse a riaprire il dialogo con Pyongyang. Il nome è quello di Alex Wong, scelto come vice consigliere principale per la sicurezza nazionale. Si tratta dell’uomo chiave delle comunicazioni tra la Casa Bianca e il leader supremo nordcoreano durante il primo mandato del tycoon. “Come vice rappresentante speciale per la Corea del Nord, ha aiutato a negoziare i miei vertici con il leader nordcoreano, Kim Jong-un”, ha detto Trump annunciando la nomina di Wong. Secondo quanto scrivono i media della Corea del Sud, che seguono ovviamente con grande attenzione, la scelta di Wong da parte di Trump per il posto alla Casa Bianca è di buon auspicio per la ripresa della diplomazia con il Nord. Anche se nei giorni scorsi Kim ha alzato il volume della sua retorica. “Mai prima d’ora le parti in conflitto nella penisola coreana hanno affrontato un confronto così pericoloso e acuto che potrebbe degenerare nella più distruttiva guerra termonucleare”, ha detto il leader supremo parlando a una conferenza di comandanti di battaglione e alti ufficiali dell’esercito, definendo l’ostilità degli Stati Uniti come “immutabile”.
Potrebbe anche essere un modo per migliorare la propria posizione negoziale. Di certo, se il dialogo dovesse riaprirsi, lo farebbe in un mondo completamente diverso da quello del 2019. Un mondo in cui dietro la Corea del Nord si staglia piuttosto chiaramente anche la sagoma della Russia.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
“Il mondo è entrato in un nuovo periodo di turbolenze e cambiamenti, l’unilateralismo e il protezionismo si stanno diffondendo, la frammentazione dell’economia mondiale si è intensificata. Ostacolare la cooperazione economica con vari pretesti, insistendo sull’isolamento del mondo interdipendente, sta invertendo il corso della storia”.
È il passaggio più accorato del discorso di Xi Jinping al ceo summit dell’Apec (Cooperazione Economica Asia-Pacifico) di Lima. Il presidente cinese è arrivato in Perù pochi giorni dopo la vittoria di Donald Trump alle elezioni negli Stati Uniti. Non è un caso che Xi stia dando grande importanza alla sua visita in Sudamerica, che comprende anche una visita di Stato sia in Perù sia in Brasile, dove partecipa al vertice del G20 ospitato da Lula.
Proprio mentre Trump è pronto a rilanciare dazi e protezionismo, la Cina si racconta dunque come baluardo del libero commercio, potenza responsabile di fronte alle incognite e potenziali instabilità del secondo mandato del tycoon alla Casa Bianca. All’Apec, come da tradizione, si è concentrato sul lato economico e commerciale. Xi ha elencato una serie di misure recenti adottate dal governo cinese per attrarre investimenti esteri, tra cui l’aumento del numero di industrie cinesi che possono ricevere investimenti esteri, nonché l’esenzione unilaterale dal visto per gli stranieri che visitano il gigante asiatico.
“La Cina attuerà politiche di apertura più indipendenti e unilaterali, espanderà la rete di zone di libero scambio di alto livello di fronte al mondo e aprirà ancora di più la porta verso la Cina”, ha affermato il leader cinese.
Non a caso, Xi e la presidente peruviana Dina Boluarte hanno firmato un rafforzamento dell’accordo di libero scambio siglato già nel 2009. E, soprattutto, hanno inaugurato il mega porto di Chancay. La città, che si trova a 80 chilometri a nord di Lima, è destinata secondo i media cinesi e peruviani a diventare la “Singapore del Sudamerica”. Il nuovo scalo portuale gestirà un milione di container all’anno, dimezzando i tempi di consegna da 45 a 23 giorni sulla rotta con Shanghai. Grazie a Chancay, le navi non richiederanno più uno scalo al porto di Manzanilla in Messico o a Long Beach in California. Anche i carichi brasiliani, che a volte viaggiano verso est verso l’Asia o attraverso il Canale di Panama, potranno risparmiare almeno 10 giorni di tempo di viaggio, ha affermato Cosco. Si calcola un ulteriore risparmio del 20% sui costi logistici e la creazione di oltre ottomila posti di lavoro. La Cina è stabilmente il primo partner commerciale del Perù, rappresentando il 40% delle esportazioni del paese e il 25% delle importazioni nel 2023.
Ma il ruolo sempre più centrale giocato da Pechino in Sudamerica, tradizionalmente più vicino agli Stati Uniti, si estende a tutto il continente. “I veri amici si sentono sempre vicini, non importa la distanza che li separa”, ha scritto Xi citando un antico poema cinese in un articolo pubblicato sui media peruviani. Da quando è diventato capo di stato, Xi è stato cinque volte in America Latina e ha visitato 11 Paesi della regione. Dal 2012, anno del suo insediamento come segretario generale del Partito comunista, la Cina è il secondo partner commerciale dell’America Latina. Nel 2023, il commercio tra le due parti è cresciuto del 7,7% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 485,7 miliardi di dollari. Secondo un rapporto pubblicato di recente dalla Commissione economica delle Nazioni Unite per l’America Latina e i Caraibi, quest’anno la Cina sarà il mercato di esportazione più in crescita della regione.
Anche in Brasile sono previsti diversi accordi. Il commercio bilaterale è aumentato di quasi il 10% nei primi 10 mesi del 2024. Il Brasile è stato il principale partner commerciale della Cina in America Latina per un lungo periodo di tempo, diventando il primo Paese della regione a superare i 100 miliardi di dollari di valore delle esportazioni verso la Repubblica Popolare. Il ministero degli Esteri cinese ha inviato una delegazione a Brasilia alla fine di ottobre per prepararsi alla visita di Xi. Pechino è disposta a rafforzare i suoi investimenti nel Paese, che già spaziano dall’agricoltura ai veicoli elettrici. Includono la più vasta attività di BYD nel settore dei veicoli elettrici al di fuori dell’Asia, con sede in un ex stabilimento Ford Motor nello stato di Bahia, e una partnership locale con il produttore cinese di smartphone Oppo. Il Brasile sta anche corteggiando SpaceSail, un produttore di satelliti con sede a Shanghai, per competere con il servizio Internet Starlink di Musk. Secondo i media cinesi, Pechino vede il Brasile come una base ideale per la produzione e come una porta verso altri paesi dell’America Latina con cui ha accordi di libero scambio.
Ma attenzione, perché dal Brasile ci si possono aspettare passaggi più puramente politici, con Xi che spingerà senz’altro la sua posizione a favore del negoziato sulla guerra in Ucraina, grazie anche alla sponda di Lula. Il presidente cinese ne approfitterà per chiedere anche il cessate il fuoco immediato a Gaza, con l’attuazione della soluzione dei due Stati per la Palestina. La sfida retorica e strategica con il Trump 2.0 è appena cominciata.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Donald Trump, dunque. Sarà di nuovo lui l’inquilino della Casa Bianca, a partire dal prossimo gennaio. L’Asia inizia a studiare le possibili conseguenze del ritorno del tycoon come presidente degli Stati Uniti dopo le elezioni vinte la scorsa settimana. Di certo, non ci sarà la continuità con Joe Biden che avrebbe invece garantito Kamala Harris. Ma è da capire il grado della potenziale discontinuità.
Nel frattempo, arriva un segnale molto rilevante sul fronte delle nomine. In un post sui social media, Trump ha fatto sapere che non inviterà l’ex ambasciatrice Nikki Haley, né l’ex segretario di Stato Mike Pompeo. “Ho molto apprezzato e gradito lavorare con loro in precedenza e vorrei ringraziarli per il loro servizio al nostro Paese”, ha aggiunto, dandogli di fatto il benservito. Si trattava di due nomi molto quotati. Pompeo sembrava il favorito per andare a dirigere il Pentagono in veste di segretario della Difesa. Un ruolo assai delicato e che secondo diversi analisti cinesi avrebbe potuto portare a un netto aumento delle tensioni tra le due potenze. Pompeo è infatti noto per le sue posizioni molto ostili nei confronti di Pechino e assai favorevoli nei confronti di Taiwan, così come Haley. L’ex segretario di Stato ha visitato due volte Taipei negli scorsi anni, chiedendo persino all’amministrazione Biden di riconoscere la sovranità della Repubblica di Cina, nome ufficiale con cui Taiwan è indipendente de facto. Anche Haley ha visitato più volte Taipei, attaccando a più riprese la Cina con una retorica molto colorita.
L’esclusione di questi due nomi dà un segnale rilevante, anche se va considerato che entrambi sono entrati in rotta di collisione con Trump in passato, soprattutto Haley. Dunque, la loro esclusione potrebbe dipendere più da logiche interne che esterne. Nonostante questo, Pechino interpreta la loro assenza come un problema in meno nel riaprire il dialogo con la nuova amministrazione. Attenzione, però, perché potrebbero comunque entrare figure note per la loro ostilità al Partito comunista, come Tom Cotton o Marco Rubio.
In realtà, al momento la preoccupazione numero uno nei rapporti è il commercio. Il presidente eletto ha proposto una tariffa del 60% su tutte le importazioni statunitensi dalla Cina. Se dovesse mantenere queste promesse, ciò ridurrebbe in modo significativo la competitività dei prodotti cinesi, pesando sulle esportazioni e sulla crescita economica di Pechino. Se Robert Lighthizer, rappresentante del commercio americano nel primo mandato di Trump e grande sostenitore dei dazi, dovesse tornare come sembra, la Cina potrebbe interpretarla come una volontà di disaccoppiamento. È probabile che l’amministrazione Trump separi ulteriormente i settori high-tech, puntando in particolare a nuove restrizioni sui semiconduttori, sulla tecnologia quantistica e sull’intelligenza artificiale. Secondo Caixin, le sanzioni potrebbero estendersi ad altre forme di produzione avanzata e alla tecnologia biomedica. Questa volta ci si aspetta una Cina in grado di reagire diversamente all’ipotetico muro contro muro, ben più aggressivamente del passato, usando anche diverse leve come: vendita dei titoli del Tesoro americano, svalutazione yuan, blocco delle terre rare e risorse cruciali a tecnologia e industria verde.
Ma c’è anche chi crede che Trump, la cui amministrazione ha negoziato la prima fase dell’accordo commerciale sino-statunitense, potrebbe anche continuare a spingere per accordi economici e commerciali nel suo secondo mandato, anche sugli investimenti. Potrebbe dare ordine alla sua amministrazione entrante di avviare nuovi negoziati con la Cina sulle politiche di sovvenzione, sui problemi di sovraccapacità e sugli squilibri commerciali. E potrebbe condurre negoziati per accordi commerciali di seconda o terza fase sulla base della prima.
Come ha scritto Wang Huyiao, presidente del think tank non governativo Center for China Globalization, Trump ha inoltre stretti legami con la comunità imprenditoriale, comprese molte aziende come Tesla, Blackstone e Apple. “Queste aziende hanno investimenti a lungo termine in Cina e questo potrebbe indurre un po’ di razionalità nella nuova amministrazione Trump, che potrebbe anche eliminare alcuni limiti sulle aziende di proprietà cinese, come TikTok, e le sanzioni sui singoli individui”, sostiene Wang. Una figura rilevante nel dialogo potrebbe essere Elon Musk, quasi presidente-ombra durante la campagna elettorale e apparentemente molto influente nel circolo di Trump. Musk ha enormi interessi in Cina e si è più volte espresso a favore delle rivendicazioni di Pechino su Taiwan. La sensazione è che possa fare da tramite tra il governo cinese e la presidenza Trump, elemento che preoccupa non poco Taipei. Anche Giappone e Corea del Sud hanno qualche timore. Tutti nella regione sanno che, soprattutto con Trump, le parole sono una cosa e i fatti un’altra. In questo caso, è un fattore positivo perché nonostante le ripetute minacce durante il suo primo mandato il tycoon non ha mai davvero spaccato il sistema di alleanze americano. Certo, il rinvigorimento ottenuto da Biden potrebbe essere a rischio sfilacciamento, con le più che probabili richieste di aumenti di spese della difesa e una retorica meno salda. Ci sono anche altri due aspetti importanti. Il desiderio di arrivare alla fine della guerra in Ucraina potrebbe spingere Trump a riaprire ufficialmente il dialogo con la Russia, togliendo molta della pressione presente in questi anni sulla Cina per i suoi rapporti con Mosca. Questo potrebbe rimuovere un ostacolo fondamentale alle relazioni tra Pechino e l’Europa, ma anche inserirsi in un contesto più ampio in cui la contrapposizione ideologica tra le due potenze potrebbe affievolirsi, dando uno spazio di manovra politico più flessibile.
Non si possono certo escludere turbolenze, visto che una delle caratteristiche di Trump è la parziale imprevedibilità. Sulla stessa Taiwan, potrebbero arrivare uscite retoriche forti e sostanziose vendite di armi. Ma sulla svolta americana Xi Jinping vede anche qualche possibile opportunità.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
L’Asia si prepara alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Quanto accadrà a Washington e dintorni avrà un forte impatto anche sul fronte orientale. Sia Kamala Harris sia Donald Trump sembrano voler mettere l’Indo-Pacifico al centro della propria politica estera, ma i due candidati hanno un approccio assai diverso al sistema di alleanze americano nella regione. Un sistema di alleanze che è stato molto rafforzato da Joe Biden durante il suo mandato. È presumibile attendersi che un’eventuale amministrazione Harris resti su quel solco.
I risultati raggiunti dalla Casa Bianca in materia, aiutata anche dagli effetti collaterali della guerra in Ucraina, sono diversi: lancio dell’AUKUS, il patto per sviluppare in modo congiunto sottomarini a propulsione nucleare con Regno Unito e Australia, allo scopo di schierarli nelle acque del Pacifico. È stata rivitalizzata ed estesa l’alleanza con il Giappone, mentre gli accordi militari con Corea del Sud e Filippine sono stati ampliati e rafforzati. La Casa Bianca ha anche favorito la creazione di un’architettura di sicurezza regionale attraverso la promozione di iniziative minilaterali. Per esempio, attraverso il disgelo tra Giappone e Corea del Sud, certificato dal summit di Camp David dell’agosto 2023 col premier (poi diventato ex) Fumio Kishida e il presidente Yoon Suk-yeol. Ma anche la creazione di un nuovo asse tra Giappone e Filippine col più recente summit di Washington con lo stesso Kishida e il presidente Ferdinand Marcos Junior. Non solo. Giappone e Corea del Sud si sono inseriti nei meccanismi di partnership della Nato, con cui hanno siglato due documenti di cooperazione. Dopo una storica visita a Hanoi nel settembre 2023, gli Usa hanno iniziato anche a stabilire legami in materia di difesa e sicurezza con il Vietnam.
Allo stesso tempo, le tensioni si sono inasprite su diversi teatri. Primo: lo Stretto di Taiwan, con la Cina che ha aumentato il pressing strategico e militare dopo la visita di Nancy Pelosi dell’agosto 2022. Secondo: il mar Cinese meridionale, con i frequenti incidenti nelle acque contese tra Cina e Filippine, nonché alcuni incidenti sfiorati tra jet e navi di Pechino e Washington. Terzo: la penisola coreana, con Biden che non è riuscito in alcun modo a riavviare il dialogo con Pyongyang, che anzi ha alzato enormemente il tiro e ha stretto un preoccupante accordo di mutua difesa con la Russia.
Ciononostante, diversi Paesi vedono in Harris un potenziale conforto e segnale di stabilità, una rassicurazione sull’impegno di Washington nella regione. Elemento ancora più importante dopo che le elezioni della scorsa settimana hanno restituito un Giappone in preda all’incertezza politica.
Per la stessa Cina, Harris significherebbe probabilmente continuità. Vero che lo status quo delle relazioni non entusiasma di certo Pechino, ma allo stesso tempo i democratici hanno mostrato il desiderio di provare a gestire la competizione tra le due grandi potenze, mantenendo sempre aperto il dialogo a tutti i livelli.
I sentimenti cinesi verso Trump sono ambivalenti. Dal punto di vista strategico, la Cina potrebbe avere qualche vantaggio. Diversi governi regionali temono che il possibile ritorno di Trump possano mettere in discussione la rete di sicurezza intessuta da Biden. Già durante il primo mandato, il leader repubblicano chiese aumenti esponenziali delle spese di difesa agli alleati, Corea del Sud in primis. Rischiando di far saltare intese decennali. Non a caso, Seul ha spinto per mesi con l’amministrazione Biden per rinnovare l’accordo quinquennale sulle spese di difesa, necessarie tra le altre cose a mantenere i 28mila e 500 soldati statunitensi presenti sul suo territorio. Dopo otto cicli di negoziati, condotti per lo più con un basso profilo e con grande riservatezza ecco l’intesa, nonostante l’accordo in essere scada solo alla fine del 2025. Il nuovo accordo entrerà in vigore nel 2026 e durerà fino al 2030. Lo stesso schema potrebbe ripetersi con Taiwan. In campagna elettorale, Trump ha ammonito Taipei, sostenendo che in cambio della tutela difensiva gli Usa dall’isola “non ricevono nulla”. Per poi attaccare sul fronte dei microchip, che secondo il candidato repubblicano i colossi taiwanesi avrebbero “sottratto” agli States. Taipei è fiduciosa di restare una priorità dell’approccio globale di Washington anche in caso di un Trump bis, ma sa che ha bisogno di essere posta all’interno di un’architettura regionale le cui fondamenta devono essere periodicamente rafforzate dagli Stati Uniti.
Per la Cina, un altro potenziale effetto positivo di un ritorno di Trump potrebbe arrivare sulla guerra in Ucraina. Un pressing americano per mettere fine al conflitto e trovare un accordo con Vladimir Putin toglierebbe Xi Jinping dall’imbarazzo per il suo rapporto privilegiato con la Russia, appianando uno dei principali ostacoli alle relazioni con l’Europa.
La parte negativa riguarda invece l’economia. Trump ha promesso un aumento monstre delle tariffe su tutte le tipologie di prodotti cinesi. Pechino teme molto un nuovo inasprimento della guerra commerciale, anche perché in questo momento l’economia è la sua vera priorità. Per questo c’è anche chi ritiene che Harris potrebbe essere il male minore, anche per la sua maggiore prevedibilità rispetto a Trump. Ancora poco e in Asia sapranno chi sarà il nuovo volto del principale rivale, o principale alleato.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Continua l’allargamento dei BRICS. “Abbiamo un ruolo fondamentale nella creazione di un nuovo ordine mondiale”. Era il 2010, quando Lula pronunciò queste parole durante il suo discorso al vertice dei BRIC di Brasilia. Da allora è cambiato tanto. A partire dall’acronimo, diventato BRICS dopo che il Sudafrica si è aggiunto a Brasile, Russia, India e Cina. Ma ora la piattaforma delle economie emergenti diventa sempre più popolata.
Al summit di Kazan, Russia, della scorsa settimana hanno partecipato per la prima volta come membri effettivi del gruppo anche Egitto, Etiopia, Emirati Arabi Uniti e Iran. Le economie dei membri rappresentano oltre 28,5 trilioni di dollari, pari a circa il 28% dell’economia globale. E durante il vertice altre 13 nazioni sono diventate Paesi partner, il primo passo necessario all’adesione piena. Si tratta di Algeria, Bielorussia, Bolivia, Cuba, Kazakistan, Nigeria, Turchia, Uganda e Uzbekistan. Assai rilevante che ci siano anche quattro Paesi del Sud-Est asiatico, nonostante le grandi turbolenze geopolitiche degli ultimi anni, con gli Stati Uniti impegnati a cercare di formare una “rete di contenimento” della Cina. Si tratta di Malesia, Indonesia, Thailandia e Vietnam.
Tra questi, almeno i primi tre hanno fatto domanda di adesione completa. Il ministro degli Affari Esteri della Malesia, Mohamad Hasan, ha dichiarato che la Malesia può ora godere di migliori opportunità commerciali, dato che il blocco ha una popolazione combinata di 3,2 miliardi di persone. “Il desiderio della Malesia di entrare a far parte dei BRICS rappresenta il suo sforzo di sostenere le politiche e l’identità di un Paese indipendente e neutrale, trovando un equilibrio con le grandi potenze e aprendo nuove opportunità di business e di investimento”, ha dichiarato il governo di Kuala Lumpur.
La Thailandia aveva annunciato già nei mesi scorsi di aver inviato la richiesta di adesione. Dal summit di Kazan, è emerso che la stessa domanda è stata fatta dall’Indonesia. Si tratta di uno sviluppo assai significativo, visto che Giacarta è la principale economia della regione e suo fulcro diplomatico, ospitando il quartier generale dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN). Al termine del vertice annuale in Russia, il ministero degli Esteri indonesiano ha spiegato che il processo di adesione al gruppo è iniziato. “L’adesione dell’Indonesia ai BRICS è una manifestazione della sua politica estera indipendente e attiva”, ha dichiarato Sugiono. “Questo non significa che ci uniamo a un certo blocco, ma che partecipiamo attivamente a tutti i forum”.
L’Indonesia, la quarta nazione più popolosa del mondo, ha una politica estera non allineata. Il neo Presidente Prabowo Subianto, insediatosi il 20 ottobre, ha ribadito più volte che sarà amico di tutti i Paesi, siano essi Cina o Stati Uniti, e che l’Indonesia non aderirà a nessun blocco militare. Sugiono ha aggiunto che i BRICS si adattano ai principali programmi di governo di Prabowo “soprattutto per quanto riguarda la sicurezza alimentare ed energetica, l’eliminazione della povertà e l’avanzamento delle risorse umane”, aggiungendo che l’Indonesia vede il gruppo come un “veicolo” per promuovere gli interessi del sud globale.
Il Vietnam, rappresentato a Kazan per la prima volta dal premier Pham Minh Chinh, non ha chiarito se intende diventare membro a pieno titolo.
È probabile che i quattro Paesi dell’ASEAN vogliano aumentare le opportunità commerciali e diversificare le loro relazioni estere in un contesto di incertezza geopolitica e di guerra in Ucraina e in Medio Oriente. Lo scenario è comunque assai interessante, visto che i quattro governi potrebbero dare una grande voce al blocco ASEAN in seno ai BRICS e anche nella cooperazione con la Cina, vero motore della piattaforma. Non è un caso che sia proprio la Cina a spingere più di tutti per l’allargamento del gruppo.
In realtà, i BRICS restano ancora una piattaforma piuttosto disarticolata, con i Paesi membri che hanno agende piuttosto diverse. Alcuni obiettivi sono anche complicati da raggiungere, a partire da una completa de-dollarizzazione. I media cinesi insistono però molto sul tema, definendo la costruzione di un sistema di pagamento alternativo una “necessità storica”. Lo stesso presidente Xi Jinping ne ha parlato nel suo discorso alla plenaria del summit di Kazan: “Gli attuali sviluppi rendono ancora più urgente la riforma dell’architettura finanziaria internazionale. I Paesi BRICS dovrebbero svolgere un ruolo guida nella riforma. Dovremmo approfondire la cooperazione fiscale e finanziaria, promuovere la connettività delle nostre infrastrutture finanziarie e applicare standard elevati di sicurezza finanziaria”.
L’apparente disgelo tra Pechino e l’India, favorito da un accordo sulla gestione di parte del confine conteso e dal primo bilaterale ufficiale tra Xi e Narendra Modi dopo cinque anni, potrebbe rendere meno complicato un maggiore coordinamento all’interno dei BRICS, che ampliano la loro presenza nel Sud-Est asiatico e in Asia centrale, due regioni ritenute cruciali dalla diplomazia cinese per il rafforzamento di una piattaforma che Pechino sostiene non essere anti occidentale. Di certo, è non occidentale. E sta attraendo diversi Paesi insoddisfatti degli attuali equilibri globali su una serie di dossier, compresa l’energia e il contrasto al cambiamento climatico. Si tratta di un capitale politico che la Cina è intenzionata a far pesare.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Si chiama Roccaforte 26 ed è uno dei tanti “fortini” che compongono il panorama di Nangan, l’isola principale dell’arcipelago delle Matsu. Siamo a meno di 20 chilometri dalle coste del Fujian cinese, ma queste isole sono amministrate dal governo di Taiwan. È qui, insieme all’altro mini arcipelago di Kinmen, che si è combattuto durante le prime due crisi dello Stretto, negli anni Cinquanta. A lungo avamposti militari del regime nazionalista del Kuomintang di Chiang Kai-shek, oggi restano la manifestazione plastica della Repubblica di Cina, nome ufficiale con cui Taiwan è de facto autonoma. È proprio alla Roccaforte 26 di Nangan che ora Taipei invita Pechino a tenere dei nuovi colloqui. L’annuncio è arrivato a sorpresa, meno di 48 ore dopo la conclusione del nuovo round di esercitazioni militari cinesi intorno a Taiwan, che si sono svolte lunedì 14 ottobre. La proposta arriva dalla Straits Exchange Foundation (SEF), l’entità semi governativa di Taipei che si occupa degli scambi concreti con la Cina continentale. Quello con l’omologa di Pechino, Association for Relations Across the Taiwan Straits, è sostanzialmente l’unico canale di comunicazione aperto tra le due sponde, in assenza di dialogo politico tra i due governi. Sono proprio queste due entità che, più di 30 anni fa, siglarono il controverso “consenso del 1992” su mandato del Partito comunista cinese e Kuomintang, il partito che fu di Chiang Kai-shek oggi all’opposizione a Taipei. Non è mai stato chiarito del tutto il contenuto di quell’accordo, da molti interpretato come un artificio politico utile a mantenere lo status quo. Secondo la versione di Pechino, il “consenso del 1992” riconosce l’esistenza di una “unica Cina”, con l’inclusione di Taiwan. Secondo la versione del Kuomintang, riconosce sì l’esistenza di una “unica Cina”, ma con “diverse interpretazioni”, consentendo dunque la temporanea coabitazione tra Repubblica Popolare e Repubblica di Cina.
Il direttore della SEF, Luo Wen-jia, ha ora proposto un nuovo round di negoziati a oltre 30 anni di distanza. L’obiettivo di Luo sarebbe quello di raggiungere un “Two Six Consensus, dal nome della roccaforte. Su quali basi, rimane da capire. Luo ha suggerito che il nuovo consenso “sarebbe più lungimirante” di quello del 1992. La sensazione è che la proposta di Taipei segua la linea del presidente Lai Ching-te, secondo cui Repubblica Popolare e Repubblica di Cina sono “due entità
separate e non subordinate l’una all’altra”. Si tratterebbe sostanzialmente di una cristallizzazione della separazione attuale, fornendo però presumibilmente qualche garanzia sulla mancata dichiarazione di indipendenza formale come Repubblica di Taiwan, che opererebbe una cesura definitiva non solo politica ma anche culturale e persino storica.
Assai difficile immaginare che Pechino possa mai accettare, per ragioni contenutistiche e di opportunità politica. L’Ufficio cinese per gli Affari di Taiwan, attiguo al governo di Pechino, ha respinto l’idea. Il portavoce Chen Binhua ha ribadito che Taipei dovrebbe accettare il “consenso del 1992” e che dunque non c’è bisogno di negoziare un nuovo accordo. Inoltre, il Partito comunista sa che accettando le trattative darebbe al rivale Partito progressista democratico (DPP) un grande vantaggio sulla scena politica interna taiwanese. Sull’isola, l’unica forza politica fin qui in grado di mantenere il dialogo con la Cina continentale è sempre stato il Kuomintang. Dare spazio al DPP potrebbe dare un’arma retorica fondamentale a Lai, spesso criticato per la sua linea troppo chiusa al dialogo.
Mentre si prova a immaginare una qualche forma di dialogo, Taipei rafforza le proprie difese. Il giorno dopo le esercitazioni “Spada Congiunta 2024 B”, il ministero della Difesa taiwanese ha annunciato di aver firmato contratti per l’acquisto di quasi mille droni killer dagli Stati Uniti, con l’obiettivo di rafforzare le capacità di guerra asimmetrica. I contratti, del valore complessivo di 163,9 milioni di dollari, prevedono l’acquisto di due tipi di droni killer: 685 Switchblade 300 e 291 Altius 600M-V. La consegna dei droni Switchblade è prevista per la fine di novembre 2029, mentre quella dei droni Altius per la fine del 2027. I droni saranno dispiegati in luoghi strategici chiave, tra cui Taoyuan nel nord dell’isola, Taichung nel centro di Taiwan, Kaohsiung nel sud e Hualien nell’est. Il leggero Switchblade 300 ha una gittata di 30 chilometri e secondo il suo produttore statunitense si è dimostrato efficace nella guerra in Ucraina. Il più grande Altius 600M, con un raggio d’azione di 440 chilometri e un tempo di attesa di quattro ore, può essere lanciato da piattaforme terrestri, aeree e marine.
Nel frattempo, però, l’esercito cinese continua a erodere lo spazio di manovra di Pechino. L’ultimo round di manovre militari ha visto l’impiego di un numero record di jet nella regione intorno a Taiwan, 153 nel giro di 24 ore, e una nutrita flotta di navi della guardia costiera che ha circumnavigato l’isola. La portaerei Liaoning è stata schierata al largo della fronte orientale, l’unica da cui potrebbero arrivare aiuti dall’esterno in caso di conflitto. In tal modo, lo Stretto di Taiwan, che si affaccia sulla costa nord occidentale dell’isola, è stato trasformato in una sorta di “mare interno” cinese. Non è certo l’ultima puntata, già nel prossimo futuro sono ipotizzabili nuovi scossoni.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
“Nei prossimi tre mesi verranno emessi 2300 miliardi di yuan di obbligazioni speciali da utilizzare in vari settori”. È stato questo l’annuncio più rilevante dell’attesa conferenza stampa di Lan Foan, il ministro delle finanze cinese, di sabato 12 ottobre. Il governo ha dunque deciso di fornire bond del tesoro per circa 325 miliardi di dollari statunitensi. Obiettivo: rilanciare l’economia e raggiungere l’obiettivo del 5% di crescita del pil fissato per il 2024.
Negli ultimi mesi un’ampia gamma di dati economici ha disatteso le previsioni, sollevando il timore di economisti e investitori che l’obiettivo fosse a rischio e che potesse essere in gioco un rallentamento strutturale a più lungo termine.
Le obbligazioni serviranno soprattutto a sostenere le grandi banche statali e rafforzare la loro capacità di erogare prestiti, nella speranza di riuscire finalmente a stimolare i consumi.
Impresa non semplice, vista l’ampia mancanza di fiducia da parte di cittadini e imprese, spesso pessimisti a causa dell’aumento della disoccupazione giovanile, calo demografico e l’accresciuto controllo statale sul settore privato. Non a caso, è stato predisposto anche l’aumento del tetto del debito per le province. La speranza di osservatori e analisti è che si tratti del preludio all’aumento del deficit fiscale oltre il 3% per il 2025, una mossa che avrebbe pochi precedenti.
Fin qui, si resta però sulle misure graduali e chi si aspettava annunci più drastici potrebbe restare deluso. L’omissione da parte di Lan di una cifra in dollari per il pacchetto probabilmente prolungherà la nervosa attesa degli investitori per una roadmap politica più chiara fino alla prossima riunione dell’organo legislativo cinese, che approva le emissioni di debito extra. La data dell’incontro non è ancora stata annunciata, ma è prevista per le prossime settimane.
La conferenza di Lan segnala l’urgenza percepita dal governo sul fronte economico ed è solo l’ultimo step di una serie di annunci. A fine settembre la Banca centrale e il governo cinese hanno annunciato misure di stimolo ben più convinte di quelle, timide, degli ultimi anni. Xi Jinping sembrava aver impugnato il bazooka proprio alla vigilia dei dieci giorni di festività per l’anniversario della fondazione della Repubblica Popolare, quando in una riunione (inusuale per le tempistiche) del Partito comunista sono state predisposte diverse misure: 142 miliardi di dollari per le banche statali, emissione di bond sovrani per 284 miliardi, destinati soprattutto allo stimolo dei consumi. E ancora: una finestra di finanziamento per incoraggiare il riacquisto di azioni da parte delle società quotate e la riduzione dell’acconto minimo necessario all’acquisto di seconde case per stabilizzare il mercato immobiliare. Ma, per ora, il whatever it takes di Xi non si è concretizzato. “Il pacchetto di stimoli potrebbe non produrre grandi benefici immediati per l’economia reale”, ha ammesso il capo economista della Bank of China International, Xu Gao, in un commento sul media finanziario Caixin.
Il governo potrebbe peraltro non avere enormi margini di manovra. Come sottolinea il South China Morning Post, la lentezza delle vendite di terreni e il calo delle entrate fiscali stanno ampliando pericolosamente il deficit. Preoccupa soprattutto l’indebitamento delle province, “svuotate” a causa dell’esposizione verso i colossi dell’immobiliare e il tentacolare sistema dei fondi fiduciari. Contando i loro “debiti nascosti”, secondo Standard Chartered il rapporto debito/pil potrebbe sfiorare il 100%. I dati negativi sulla disoccupazione giovanile, che ha superato il 18% ad agosto, e il timore sulla tenuta delle casse statali ha peraltro portato a toccare dossier precedentemente mai nemmeno sfiorati. Il riferimento è all’età pensionabile, che di recente è stata innalzata per la prima volta dagli anni Cinquanta, per evitare lo spauracchio di uno svuotamento dei fondi che istituti statali cinesi avevano previsto per il 2035. Le nuove generazioni temono per la prima volta dopo diverso tempo che il loro futuro non sarà migliore e che non staranno meglio dei loro genitori, come invece era sempre accaduto dall’epoca delle grandi riforme economiche di Deng Xiaoping in poi.
Non è un caso che, dopo la chiusura di dieci giorni per le festività nazionali, le borse cinesi abbiano chiuso la scorsa settimana in perdita, nonostante i vari annunci a sostegno del mercato azionario e del settore privato. Segnale che, almeno fin qui, le misure non sono ritenute sufficienti. Pechino sa che le esigenze immediate in parte confliggono con quelle di lungo termine, che includono l’obiettivo di trasformare la Cina da fabbrica del mondo a società di consumi e autosufficiente a livello tecnologico. Ma Xi Jinping è chiamato a trovare un complicato equilibrio per evitare che un previsto rallentamento diventi una frenata eccessiva.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Piano, ma qualcosa si muove. Dopo tre anni e otto mesi di guerra civile, cominciata dopo il golpe militare che ha deposto il governo civile guidato da Aung San Suu Kyi, arrivano segnali diplomatici sul Myanmar. I movimenti si osservano in due snodi cruciali, entrambi nella regione del Sud-Est asiatico. Intanto dal Laos, dove in questi giorni si svolgono le riunioni del summit annuale dell’ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico), con la partecipazione dei Paesi partner, comprese le grandi potenze Cina e Stati Uniti. Vientiane proverà ad accelerare sul consenso in cinque punti raggiunto già nel 2021 per la tregua, ma mai messo in pratica dalle autorità birmane. Il blocco si è detto aperto ad altre strade per sostenere il suo piano, compresa la mediazione dei Paesi vicini e di organizzazioni esterne all’ASEAN.
Ma i segnali arrivano anche dall’Indonesia, che sempre in questi giorni ospita un incontro internazionale al massimo livello. Ai colloqui sono presenti l’ASEAN, l’Unione Europea, il governo ombra di unità nazionale del Myanmar e le Nazioni Unite. Giacarta ha dichiarato di aver ricevuto segnali positivi per un dialogo preliminare dalle principali parti in conflitto, ma non ci sono stati ancora segnali di avanzamento. La giunta ha sin qui rifiutato di impegnarsi in colloqui con i suoi rivali, definendoli terroristi intenzionati a distruggere il Paese. Anzi, il mese scorso ha esortato i suoi oppositori armati a fermare la loro ribellione e a scegliere la strada politica in vista delle elezioni annunciate per il prossimo anno. Un appello che è stato respinto da quasi tutti i gruppi, che ritengono sia impossibile fidarsi.
Sul campo, dove dal 1° febbraio 2021 ci sono stati oltre seimila morti civili con svariate migliaia di prigionieri politici, le tensioni restano forti. Poco dopo l’offerta di colloqui agli insorti, l’esercito birmano è accusato di aver bombardato una città controllata dall’opposizione. Si tratta di Lashio, nello Stato settentrionale dello Shan, un grande centro urbano conquistato in passato dai ribelli. L’offerta di colloqui appare dunque soprattutto un segnale tattico e formale, mentre nella pratica resta assai difficile immaginare qualsiasi forma di dialogo.
La giunta militare ha inoltre iniziato nei giorni scorsi un censimento a livello nazionale, affermando che servirà a compilare le liste degli elettori per le elezioni. La mossa è ampiamente vista come un tentativo di raccogliere informazioni per monitorare ancora più da vicino gli oppositori del governo militare. Il gruppo che guida la lotta contro il regime militare, il governo ombra di unità nazionale, ha consigliato alla popolazione di usare “cautela” nel partecipare al censimento. Tra i guerriglieri più convinti, c’è anche chi ha avvertito che coloro che aiutano a raccogliere informazioni andranno incontro a rappresaglie. L’Alleanza della Fratellanza Chin, che comprende cinque milizie di etnia Chin dello Stato Chin nord-occidentale, e il Dawei Defense Team, un gruppo della regione meridionale di Tanintharyi, hanno avvertito che intraprenderanno azioni forti contro il personale governativo militare che partecipa al censimento. Già a gennaio 2023 erano stati compiuti attacchi durante un sondaggio di tre settimane per la compilazione delle liste degli elettori.
I negoziati restano dunque ancora assai complicati. Qualche mese fa, sembravano essere stati fatti dei passi avanti dopo una tregua siglata dall’esercito e da alcuni gruppi ribelli, con la mediazione della Cina. Ma anche quella tregua è durata ben poco e i combattimenti sono ripresi, spesso con violenza ancora maggiore di prima.
Ora il tentativo dell’Indonesia, che va letto anche come il desiderio del presidente uscente Joko Widodo di ottenere un ultimo risultato del suo decennio al potere, stavolta in una politica estera che spesso i detrattori hanno considerato un po’ troppo timida. Il 20 ottobre, infatti, è previsto il passaggio di consegne tra Widodo e il suo erede designato, l’ex generale e ministro della Difesa Prabowo Subianto, vincitore alle elezioni dello scorso febbraio.
Sarà però difficile arrivare a risultati concreti, anche perché l’ostilità tra le parti si è del tutto sedimentata, riacutizzando una serie di conflitti e fronti interni che sembravano in parte essere stati stabilizzati con l’azione del governo civile di Suu Kyi. La molteplicità di attori in campo rende anche complicato riuscire a raggiungere un accordo quadro che possa reggere all’evoluzione della situazione sul campo.
L’Occidente, che si è interessato alla vicenda birmana in modo piuttosto discontinuo, così come anche le stesse potenze regionali asiatiche, sono chiamati a mostrare tra Giacarta e Vientiane che hanno l’intenzione di provare a contribuire seriamente alla soluzione di una crisi di cui resta molto difficile intravedere la fine.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Il Partito liberaldemocratico giapponese ha scelto il suo nuovo leader, che martedì 1° ottobre viene nominato premier. Quali sono gli scenari? Intervista a Jeffrey W. Hornung di RAND
Martedì 1° ottobre, Shigeru Ishiba diventa il 102esimo premier del Giappone. È il risultato delle elezioni interne al Partito liberaldemocratico di venerdì 27 settembre, mai così incerte e combattute. Ishiba, ex ministro della Difesa e dell’Agricoltura, ha prevalso al secondo turno contro l’ultranazionalista Sanae Takaichi, nome di riferimento dell’area che un tempo faceva riferimento al premier Shinzo Abe. In passato, Ishiba era stato sconfitto quattro volte in passato nel voto per la leadership del partito che governa quasi ininterrottamente dal secondo dopoguerra. Stavolta, dopo che il premier uscente Fumio Kishida ha sciolto quasi tutte le fazioni interne in seguito a un maxi scandalo sui finanziamenti, ce l’ha invece fatta. Si ferma invece al primo turno Shinjiro Koizumi, 43enne figlio dell’ex premier Junichiro. Per analizzare il risultato e gli scenari del governo Ishiba, abbiamo intervistato Jeffrey W. Hornung, Japan Lead della National Security Research Division di RAND Corporation.
Quanto è sorprendente la vittoria di Ishiba al quinto tentativo?
Conosco Ishiba dal 2005 e sono stato in passato nel suo ufficio durante una delle votazioni che ha perso. Devo dire la verità, non sono sorpreso. O meglio, quando è iniziato il processo che avrebbe portato alle elezioni, non pensavo che avesse possibilità. Credevo che i suoi giorni migliori fossero alle spalle perché ci sono molte persone nel partito che non lo amano, visto che ha sempre avuto una posizione di critica interna. Ma quando i rivali hanno iniziato a salire e scendere, da Kobayashi a Koizumi, ho iniziato a pensare che Ishiba avesse una possibilità concreta. Soprattutto nell’ultima settimana dopo che Koizumi è affondato nei sondaggi. Ho iniziato a pensare che avrebbe vinto anche perché, nonostante sia una discepola di Abe, un eventuale governo Takaichi avrebbe messo a disagio molte persone per le sue posizioni estremamente conservatrici. Credo si sia iniziato a vedere Ishiba come l’alternativa comoda, anche se non è completamente amato all’interno del partito, perché è popolare tra il pubblico. E perché non è un conservatore.
Ishiba ha vinto perché il partito pensa alle prossime elezioni generali?
Certo. Come ogni partito politico, cercano la sopravvivenza elettorale. E sanno che lui è estremamente popolare tra il pubblico. Takaichi non porta necessariamente la stessa popolarità elettorale. Aveva degli aspetti positivi, come il fatto di poter diventare la prima donna premier, ma Ishiba è molto popolare nelle prefetture locali. E quindi penso che alla fine il partito si sia guardato intorno e abbia detto: “Va bene, se vogliamo vincere le elezioni questo è ciò che dobbiamo fare”.
Si aspetta una politica estera in continuità con quella di Kishida?
Mi aspetto una sorta di fusione. Nel segno della continuità, ovviamente sarà data priorità all’alleanza USA-Giappone. A differenza che con Takaichi, credo che vedremo continuare il trilateralismo con la Corea del Sud perché non ha alcun bagaglio storico negativo riguardo al santuario Yasukuni (luogo controverso dove vengono commemorati tra i caduti anche 14 criminali di guerra dell’era coloniale) o commenti sprezzanti su Seoul, al contrario della destra radicale a cui appartiene l’avversaria. La differenza, però, è che credo che con Ishiba ci possa essere un potenziale di attrito con gli Stati Uniti. E la ragione per cui lo dico è che per quanto dia priorità all’alleanza, ha parlato apertamente di rivedere l’accordo sullo status delle forze. Ha parlato apertamente di creare una NATO asiatica. Ha parlato di condivisione del nucleare. Sono tutte cose a cui gli Stati Uniti si oppongono fermamente. Quindi, soprattutto per quanto riguarda l’accordo sullo status delle forze, se si presenterà ai negoziati o al prossimo vertice con gli Stati Uniti dicendo che vuole davvero negoziare si arriverebbe a degli attriti. Ma in termini di strategia generale della politica estera giapponese non mi aspetto grandi cambiamenti.
Forse con Ishiba ci si può aspettare una maggiore spinta sul ruolo regionale del Giappone? Anche per cercare probabilmente di ottenere una parziale autonomia strategica dagli Stati Uniti, se posso usare questo termine.
Sì, credo che sia corretto. Anche se non pronuncia questa parola, credo che sia proprio questo suo desiderio che causerà attriti con gli Stati Uniti. Perché gli Stati Uniti dicono sempre, nei vertici e nelle dichiarazioni congiunte, che stanno difendendo il Giappone, comprese le isole Senkaku. Gli Stati Uniti fanno di tutto per rassicurare il Giappone che sono impegnati nella difesa del Paese. E poi quando hai un candidato che parla di tutte queste cose sta essenzialmente comunicando che non si fida degli Stati Uniti. C’è la preoccupazione che gli Stati Uniti non siano presenti. E penso che sia valida, a seconda del candidato che diventerà presidente degli Stati Uniti alle elezioni di novembre. Ma se si spinge su questo punto, ci sono persone negli Stati Uniti che lo leggeranno come se il Giappone stesse cercando un’autonomia strategica. E questo causerà attriti.
Pensa che questa dinamica possa intensificarsi se Donald Trump sarà il prossimo presidente?
Sì. Lo penso. La cosa che ha funzionato bene per il Giappone l’ultima volta, era il fatto che anche se Trump criticava gli alleati questo non impattava su Tokyo, perché Abe era molto forte politicamente. Non ha lasciato che le critiche lo colpissero personalmente. E se lo chiamava piccolo Abe o se sbagliava il suo nome in una conferenza stampa, se metteva dazi sull’alluminio, Abe non l’ha mai presa sul personale. Non ha mai risposto a Trump per quello che riteneva l’interesse del Giappone. Il test per Ishiba sarà capire se avrà la stessa personalità per essere in grado di sopportare quelli che potrebbero essere anche attacchi molto personali, sanzioni o tariffe sui prodotti giapponesi. Credo che Ishiba abbia la capacità di non prenderla sul personale, ma di continuare a guidare la nave nella giusta direzione, indipendentemente da quanto gli Stati Uniti lo critichino? Questo non lo so.
La personalità del nuovo primo ministro potrebbe essere ancora più importante dopo che il sistema delle fazioni si è in parte dissolto?
Sì, è vero. In un certo senso, la personalità è sempre stata importante, anche nel sistema delle fazioni, ma si poteva avere una pessima personalità e, nonostante ciò, poiché le fazioni ritenevano che fosse il tuo momento, potevi diventare primo ministro. Poiché ora è necessario entrare in contatto con il pubblico, avere una popolarità elettorale, la personalità è molto importante. Conoscendolo, in passato Ishiba mi era spesso sembrato acido. Negli ultimi anni invece mostra anche il suo lato più leggero, mostrandosi in eventi mondani in una sorta di operazione di ringiovanimento. Penso che abbia funzionato. Ha dimostrato che può entrare in contatto con la gente. Ma fare campagna elettorale e governare sono due cose diverse. Riuscirà a mantenere quel lato leggero quando sarà martellato dal partito di opposizione? E penso che per certi versi sarà davvero interessante per il sistema politico giapponese perché c’è l’ex primo ministro Noda a capo del partito di opposizione. Noda è un avversario molto temibile perché conosce bene la politica e sa governare. Se c’è qualcuno che può bucare il palloncino del Partito liberaldemocratico, questo è Noda.
Si aspetta una nuova spinta da parte di Ishiba al processo di revisione della costituzione pacifista?
Non credo che ci sarà una spinta, almeno all’inizio, perché deve assicurarsi che la sua posizione politica sia solida nel partito. E l’unica cosa che potrebbe facilmente buttarlo fuori dal partito in fretta è se cerca di fare qualcosa di affrettato con la revisione costituzionale. Se il partito vincerà alla grande alle prossime elezioni, quando si terranno, penso che allora lo si potrà vedere immergersi in queste acque. Ma finché non saprà di essere solido politicamente nel partito, non credo che lo farà. Credo che la sua priorità sarà l’economia. Ha detto che vuole cercare di aumentare i salari, di affrontare la deflazione. È su questi temi che si giocherà nel breve termine la sua posizione politica. E poi potrà dedicarsi anche ad altre cose.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
La svolta è totale, il legame col passato è stato reciso in maniera drastica. Lo Sri Lanka ha scelto come suo nuovo presidente Anura Kumara Dissanayake, candidato marxista che non era ritenuto uno dei più favoriti alla vigilia delle elezioni di sabato 21 settembre. Tra i 39 candidati alla presidenza, tutti uomini, i nomi più caldi erano altri. A partire da quello di Ranil Wickremesinghe, il leader uscente entrato in carica al culmine del collasso economico del 2022.
L’ormai ex presidente è uomo di fiducia della potentissima dinastia politica dei Rajapaksa, costretta al passo indietro al culmine delle proteste di due anni fa per il tracollo economico. Wickremesinghe ha saputo in parte rialzare lo Sri Lanka, migliorando i numeri, ma lo ha fatto seguendo dure politiche di austerità imposte dal contestato piano di salvataggio del Fondo monetario internazionale. Ed è questo che lo ha punito, visto che si è fermato al terzo posto al 17,27% dei consensi.
Male anche anche Namal Rajapaksa, figlio dell’ex presidente Mahinda e ultimo rampollo della famiglia che ha dominato per anni la politica del Paese dell’oceano Indiano. D’altronde, la maggior parte del partito di famiglia, Fronte del Popolo dello Sri Lanka, aveva optato per sostenere la candidatura di Wickremesinghe. A nulla è servito il suo programma pieno di promesse sulla riduzione della pressione fiscale: troppo stretto il legame tra il suo ingombrante cognome e quanto accaduto negli scorsi anni. Così come il legame dello stesso Wickremesinghe, veterano della politica nazionale sulla scena già da oltre tre decenni. In ogni occasione, a partire dalla prima volta tra il 1993 e il 1994, era stato chiamato a governare in un frangente di grave crisi economica. Ma la sua fama da “aggiustatore” ed “equilibratore” non è bastata, perché il popolo dello Sri Lanka ha mostrato con chiarezza di aspirare al cambiamento.
Ed ecco allora che la vittoria è andata a Dissanayake, leader del Fronte popolare di liberazione, il più radicale tra i partiti strutturati in gara. Dissanayake, 55 anni, ha ottenuto il 42,31% dei voti, con la commissione elettorale che ha annunciato la sua vittoria dopo una intensa due giorni di spoglio visto che non è arrivato al 50% necessario per salire al governo al primo conteggio. Dopo l’esame delle preferenze, la sentenza che pareva comunque già scontata dopo il grande vantaggio rispetto ai rivali emerso già nella serata di sabato. Al secondo posto Sajith Premadasa, figlio del defunto presidente Ranasinghe Premadasa con un forte seguito tra la minoranza tamil. La sua proposta di una piattaforma socialdemocratica gli ha consentito di arrivare davanti a Wickremesinghe, con il 32,76% dei voti, ma lontano da Dissanayake.
“Questa vittoria appartiene a tutti noi. Insieme, siamo pronti a riscrivere la storia dello Sri Lanka, ha scritto il neo presidente X. Dissanayake, professione originaria avvocato, non ha mai nascosto quella che vuole essere l’etichetta sulle sue convinzioni politiche, vale a dire “marxista”. Aveva già sfidato Wickremesinghe nel 2022, quando il parlamento aveva dovuto nominare il successore di Gotabaya Rajapaksa, raccogliendo la miseria di tre voti.
Ben più forte il consenso raccolto tra gli elettori, soprattutto tra i giovani. Dissanayake ha saputo attirare l’attenzione su di sé quando ha partecipato attivamente alla caduta del governo Rajapaksa e negli ultimi due anni è stato in una sorta di campagna elettorale permanente, in cui ha accusato senza riserbo le mosse del governo e l’austerità imposta dal FMI. Da parte sua, Dissanayake ha presentato un programma in cui si parla di trasformazione sociale, economica e politica, con un rafforzamento del welfare, la lotta alla corruzione e un forte accento sulla digitalizzazione. Non è tutto. Sul fronte politico, propone l’abolizione del sistema presidenziale per tornare a una democrazia parlamentare. Un modo, a suo dire, per ridurre la possibilità che lo Sri Lanka finisca “ostaggio” di potentati quasi dinastici come i Rajapaksa. In campagna elettorale, Dissanayake ha anche promesso di affrontare la corruzione e di ridurre i privilegi della classe dirigente, come le generose pensioni e i permessi per le auto, e si è impegnato a riaprire tutti i casi di presunte violazioni dei diritti umani verificatisi durante la brutale guerra civile, terminata nel 2009.
Di certo, all’FMI chiederà di rinegoziare alcune condizioni del piano di salvataggio, per fare ricadere meno gli effetti collaterali sulla popolazione. In cambio, verrebbe messa in piedi una riforma fiscale. L’accordo originario, messo a punto nel marzo 2023, ha una durata prevista di quattro anni e sinora è arrivato circa un miliardo di dollari dei tre previsti in totale.
Da capire quale sarà l’approccio sul fronte internazionale. Il suo posizionamento ideologico potrebbe renderlo affine alla Cina, che negli anni ha già sviluppato importanti interessi nello Sri Lanka, a partire dalla controversa gestione del porto di Hambantota dopo che il Paese non era riuscito a ripagare i debiti accumulati per gli ingenti investimenti e prestiti promossi da Pechino negli anni. Nei giorni scorsi, uno dei massimi consiglieri del neo presidente, Anil Jayantha, ha però provato a dipingere una linea equilibrata tra Cina e India. “Il nostro partito e il nostro leader vogliono impegnarsi con Nuova Delhi. L’India è certamente un nostro vicino e una grande potenza. Recentemente siamo stati invitati dall’India per un vertice sull’agricoltura. Abbiamo visitato Delhi e il Kerala. Il nostro leader vuole trattare con tutte le grandi potenze per stabilizzare l’economia dello Sri Lanka”, ha dichiarato in un’intervista. Narendra Modi e Xi Jinping osservano con attenzione.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
C’era una volta il mito della popolazione sempre in crescita dell’Asia orientale. La Cina, soprattutto, che fino al 2023 è stato il Paese più popoloso del mondo. Un ruolo che le è stato tolto dall’anno scorso dall’India. Giappone e Corea del Sud sono protagoniste di un calo, che assume spesso le caratteristiche di un crollo, già da ben prima. I governi stanno provando a reagire con diverse misure, comprese le più fantasiose, per provare a sostenere le nascite. Il tramonto demografico rischia infatti di ripercuotersi in maniera consistente anche sull’economia e il welfare. Ma la tendenza, intrecciata talvolta con elementi storici o socioculturali, appare in ampia parte “naturale” e molto probabilmente irreversibile.
Il Partito comunista è passato dal cercare di contenere l’eccessiva natalità con la politica del figlio unico, a un calo demografico che preoccupa il governo. La popolazione della Repubblica popolare è diminuita nel 2023 per il secondo anno consecutivo. Nel 2022 si erano perse 850 mila persone, primo storico calo dal 1961, tempi di carestia in seguito al “grande balzo in avanti” di Mao Zedong. L’anno scorso il calo si è persino intensificato, arrivando a toccare i 2,08 milioni. Seppur preventivata, l’inversione della curva demografica non era attesa così presto ed è stata probabilmente accelerata dalla pandemia. Già oggi il 21% della popolazione cinese (circa 297 milioni di persone) ha più di 60 anni, ma nel 2040 la percentuale dovrebbe arrivare al 28%. Nel lungo termine, gli esperti delle Nazioni Unite sostengono che la popolazione cinese perderà 109 milioni di unità entro il 2050, più del triplo rispetto alla stima del 2019.
Secondo un dossier di Yi Fuxian, demografo cinese e ostetrico della University of Wisconsin-Madison, “alla radice del problema c’è la politica del figlio unico che, seppur rimossa, continua ad avere effetti”. Celebre per il libro del 2007 Big Country With an Empty Nest, Yi sostiene che “dal punto di vista economico, la politica del figlio unico ha ridotto la capacità genitoriale di provvedere al mantenimento dei figli. Dal punto di vista psicologico, ha cambiato in modo irreversibile il punto di vista cinese sulla maternità e resta ancora profondamente radicata nel cuore delle famiglie”. Una parziale conferma dei problemi creati dalla politica del figlio unico sembra arrivare dai dati sulla distribuzione di genere. Secondo il censimento del 2020, la Cina conta 722 milioni di uomini e 690 milioni di donne, con lo squilibrio di genere più evidente tra i nati durante la politica del figlio unico dal 1980 al 2015. E non sembra essere bastato né il via libera al secondo figlio, né la politica del terzo figlio che non solo consente, ma incentiva, la formazione di una famiglia numerosa.
Ma le ragioni del calo demografico vanno ben oltre la politica del figlio unico. A pesare sono anche e soprattutto i costi della maternità e del settore educativo, a partire dalle scuole primarie. C’è poi un impatto molto forte anche sui guadagni delle famiglie, in particolare su quelli delle donne. Non a caso un numero crescente di donne sceglie di non avere figli per non essere costrette a mettere in pausa la carriera.
Oltre ai numeri, c’è anche un fondamentale aspetto socioculturale. Con l’ampliamento della classe media e il miglioramento del tenore di vita, i cinesi si sposano meno e più tardi. La stessa parabola già vissuta da diversi Paesi occidentali, Italia compresa, o anche asiatici come Giappone e Corea del Sud. Di recente, il presidente Xi Jinping ha chiesto alle donne di coltivare una nuova cultura del matrimonio e della maternità, ma in realtà secondo un sondaggio del 2021 della Lega della gioventù comunista, il 44% delle donne tra i 18 e i 26 anni non è certo di volersi sposare.
Il calo demografico potrebbe avere non banali ripercussioni sul mondo del lavoro, con un netto abbassamento della popolazione in età di impiego. Con un effetto domino su welfare e sanità. L’Accademia cinese delle scienze sociali ha previsto che nel 2035 si potrebbe arrivare al potenziale esaurimento del sistema pensionistico.
Nel 2023 è stato registrato un aumento dei matrimoni, che sembra però collegato soprattutto alla riapertura post Covid che in Cina è avvenuta dopo rispetto all’Europa. Insomma, troppo presto per pensare che si tratti di una tendenza piuttosto che di un caso isolato. Secondo l’Istituto di ricerca cinese YuWa, c’è “urgente bisogno” a livello nazionale di introdurre al più presto politiche per ridurre il costo della maternità, come ad esempio migliori servizi di assistenza all’infanzia, parità di congedo di maternità e paternità, possibilità di lavorare in modo flessibile e concessione alle donne single degli stessi diritti riproduttivi delle donne sposate. La Cina è il secondo tra i Paesi al mondo dove è più costoso crescere un figlio. Il costo per allevare un figlio fino ai 18 anni in rapporto al Pil pro capite è di circa 6,3 volte, contro le 2,08 volte dell’Australia, le 2,5 volte della media dei 27 Paesi dell’Unione Europea, le 4,11 volte degli Stati Uniti e le 4,26 volte del Giappone.
C’è un solo Paese dove è più costoso che in Cina crescere un figlio: la Corea del Sud. Seul ha il tasso di fertilità più basso del mondo. Ora il numero medio di figli per ogni donna sudcoreana è di 0,72, anche qui un minimo storico. Il numero è di gran lunga inferiore ad altri Paesi con un andamento demografico negativo, basti pensare all’1,3 del vicino Giappone. Il tasso medio tra i Paesi dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico si attesta intorno a 1,58. E si prevede che il calo proseguirà. Per diversi analisti è inevitabile che si arrivi a mettere mano al settore sanitario, peraltro già vittima di alcuni tagli negli ultimi anni. Si stima che entro il 2050 il numero di bambini e di persone di età compresa tra i 15 e i 64 anni diminuirà di un terzo, mentre il numero di anziani dovrebbe più che raddoppiare. Secondo un recente sondaggio di Statistics Korea, solo il 40,6% dei ventenni e il 42,3% dei trentenni ritengono di doversi sposare. Un calo del 20% rispetto al 2008.
Il governo sudcoreano sta provando a intervenire. Il presidente Yoon Suk-yeol ha etichettato il calo demografico una “emergenza nazionale” e ha di recente annunciato la creazione di un ministero dedicato al sostegno delle nascite. Anche qui, sussidi e incentivi non hanno per ora funzionato. Le amministrazioni locali organizzano addirittura degli incontri al buio di gruppo tra single, una sorta di matchmaking di Stato. La recente apertura di una una nuova linea ferroviaria ad alta velocità che collegherà il distretto di Suseo, sull’immenso territorio della capitale Seul, alla città di Dongtan è stata spiegata anche col tema demografico. La riduzione dei tempi di percorrenza “consentirà alle persone di trascorrere più tempo con la famiglia al mattino e alla sera”, ha dichiarato il governo. La speranza delle autorità è quella di incoraggiare un maggior numero di giovani a prendere in considerazione l’idea di una casa fuori città e mettere su famiglia. Ci sono anche proposte controverse, come quella del Korea Institute of Public Finance, che ha suggerito che le bambine femmine inizino la scuola primaria un anno prima dei bambini maschi. La logica si basa sull’idea che gli uomini sono naturalmente attratti dalle donne più giovani perché maturano più lentamente. Con le donne che, in teoria, preferirebbero sposare uomini più anziani. La proposta, inutile dirlo, ha scatenato un’ondata di polemiche.
Le polemiche sono all’ordine del giorno anche in Giappone, un Paese che ha più volte detto di aver bisogno di immigrati ma che poi continua a fare pochissimo per accoglierli e integrarli. La popolazione resta ancora lontana dal diventare multiculturale e multietnica, come dimostrano le discussioni dei mesi scorsi per la vittoria di una ragazza di origine ucraina al concorso di Miss Giappone, nonostante sia nata a Tokyo. Dopo diverse polemiche riguardanti la sua vita privata, la ragazza ha dovuto riconsegnare il premio.
Per Tokyo, il 2023 è stato l’ottavo anno consecutivo in cui il numero di nascite è diminuito. In questo caso del 5,1%, precipitando al minimo storico. Si tratta di una tendenza ormai di vecchia data. Il picco della popolazione è stato raggiunto nel 2017 con i 128 milioni di abitanti. Da lì, il calo. Ma è addirittura dagli anni Settanta, dopo la recessione causata dalla crisi petrolifera globale del 1973, che il tasso di fertilità è in calo. Continua a precipitare anche il numero di matrimoni. Lo scorso anno sono stati meno di 500 mila per la prima volta dopo 90 anni. Secondo le ultime proiezioni, la popolazione giapponese diminuirà addirittura del 30% entro il 2070. Per allora, le persone con più di 65 anni saranno il 40% della popolazione.
Il governo del premier Fumio Kishida sta provando a correre ai ripari con sussidi e facilitazioni all’assistenza sanitaria, ma anche qui non ha finora funzionato e la situazione viene descritta come “critica”. Difficile che per invertire la tendenza basti il suggerimento giunto qualche tempo fa da Narise Ishida, membro del Partito liberaldemocratico al governo pressoché ininterrottamente da decenni. Secondo il politico proveniente dalla prefettura di Mie (a est di Kyoto e Osaka) “il tasso di natalità non sta diminuendo perché avere figli costa”, ma perché “il romanticismo è diventato un tabù prima del matrimonio”. I giovani giapponesi di oggi, secondo Ishida, non saprebbero flirtare né dare sfogo a pulsioni romantiche. Il problema, ahinoi, appare ben più complesso di così.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Ko Wen-je resta accusato in una vicenda che potrebbe produrre serie conseguenze sul panorama partitico dell’isola. Con l’opposizione che ora rievoca persino i fantasmi dell’era del “terrore bianco” e della legge marziale di Chiang Kai-shek, durante la quale tutti gli oppositori all’allora partito unico venivano incarcerati o eliminati.
Chi è Ko? Ex chirurgo ed ex sindaco di Taipei, si è lanciato pochi anni fa nell’avventura del Taiwan People’s Party (TPP), un partito costruito su misura per lui. Dopo che una sua fedelissima ha conquistato la poltrona di sindaca di Hsinchu, la capitale mondiale dei microchip, lui si è candidato alle presidenziali di gennaio 2024. Dopo un fugace accordo sottoscritto e poi strappato col Kuomintang, Ko ha corso da solo, ottenendo un sorprendente 26%. Il dato significa terzo posto dietro Lai Ching-te, il neo presidente del Partito progressista democratico (DPP) entrato in carica a maggio, e Hou Yu-ih del Kuomintang.
Ma è la prima volta che Taiwan ha una seria alternativa allo storico bipolarismo tra i due partiti storici, col DPP ritenuto “secessionista” da Pechino e il Kuomintang che è invece dialogante con la Cina continentale. In uno yuan legislativo (il parlamento unicamerale di Taipei) diviso e senza maggioranza assoluta, gli 8 seggi del TPP sono decisivi per qualsiasi riforma. Tanto che Ko è ritenuto il vero “ago della bilancia” della politica taiwanese per i prossimi anni, anche se nei primi mesi della nuova legislatura si è per la verità piuttosto appiattito sulle posizioni dell’opposizione del Kuomintang, appoggiando una riforma del potere legislativo contestata dal governo e finita ora alla Corte Costituzionale.
Ko ha costruito la sua proposta con un piano basato appunto su una terza via “pragmatica e non ideologica”. Aperto al dialogo con il Partito comunista, ma senza il retaggio storico del “consenso del 1992” (principio che riconosce l’appartenenza di Taiwan alla Cina, pur senza stabilire quale secondo il Kuomintang), le sue posizioni sono viste da molti come più realistiche e meno radicali dei due tradizionali contendenti. Anche perché mentre i due partiti storici litigano in continuazione sul tema dei rapporti intrastretto e dell’identità tra Taiwan e Repubblica di Cina (nome ufficiale con cui Taipei è indipendente de facto, pur se riconosciuta solo da 12 Paesi al mondo), Ko continua a parlare di temi più concreti.
Si tratta degli argomenti che più interessano soprattutto ai giovani: prezzi delle case, lavoro, economia e giustizia. Ko si è costruito una fama di incorruttibile, attaccando invece i partiti tradizionali per i loro presunti guai con corruzione e malaffare.
Ecco perché quanto sta accadendo in questi giorni rischia di colpire la reputazione di Ko ancora più in profondità. Sabato 31 agosto, i pubblici ministeri hanno presentato al Tribunale distrettuale di Taipei una richiesta di detenzione ufficiale di Ko per il presunto coinvolgimento dello scandalo di corruzione riguardante il progetto di riqualificazione di Core Pacific City durante il suo mandato di sindaco di Taipei.
Ko ha presentato una petizione contro l’ordine di arresto dei pubblici ministeri che è stata respinta inizialmente dal tribunale distrettuale di Taipei. Ko è stato arrestato sabato mattina presto, quando ha rifiutato di essere interrogato ulteriormente dopo una giornata di interrogatori e ha tentato di andarsene. Nel frattempo, i sostenitori di Ko si sono riuniti fuori dall’ufficio sabato e hanno esposto cartelli con la scritta “Le procedure devono essere giuste, la giustizia deve essere equa”.
Alcuni sostenitori hanno anche scandito slogan come “Terrore verde”, in riferimento al “terrore bianco” e al verde, colore di riferimento del DPP. “Dov’è finita ora la vostra democrazia?” hanno accusato a ripetizione gli account social del TPP, che sostiene che l’arresto sia avvenuto in totale assenza di prove a carico di Ko.
Le indagini sulla presunta corruzione che coinvolge Ko e altre persone nella riqualificazione del centro commerciale Core Pacific City, nel centro di Taipei, sono iniziate tra i sospetti sul significativo aumento del rapporto di superficie dal 560% all’840% durante il suo mandato come sindaco, dal 2014 al 2022. Già negli scorsi mesi, i pubblici ministeri hanno iniziato a interrogare ex funzionari, tra cui l’ex vice sindaco Pong Cheng-sheng. Le voci sul coinvolgimento di Ko sono aumentate, fino ad arrivare a venerdì quando gli agenti hanno fatto irruzione nella casa e nell’ufficio di Ko e nella sede del TPP.
Lunedì mattina, il nuovo colpo di scena: il tribunale ha stabilito che le prove fornite dai pubblici ministeri non erano sufficienti a giustificare la detenzione di Ko e ha ordinato il suo rilascio senza cauzione, mentre il suo ex vice sindaco resta in cella. La Procura distrettuale di Taipei intende appellarsi alla decisione. Il tribunale ha affermato che la chiave dell’innocenza o della colpevolezza di Ko risiede nel fatto che fosse o meno consapevole dell’illegalità della risoluzione approvata durante il suo mandato per aumentare la superficie del progetto immobiliare “senza seguire l’interesse pubblico” e se fosse consapevole che la risoluzione mirava a ottenere guadagni illeciti. Poiché Ko non ha partecipato al comitato o alla riunione della risoluzione, né possiede competenze rilevanti in materia, la sua affermazione di essersi fidato della risoluzione degli esperti e dell’opinione professionale di Pong non pare infondata, ha aggiunto il tribunale. Dopo essere stato rilasciato lunedì mattina, Ko è stato accolto da una folla festante, dalla moglie Chen Pei-chi e dal capogruppo del TPP Huang Kuo-chang.
Il finale di questa vicenda è ancora da scrivere. Qualora la posizione di Ko tornasse critica, il TPP (che ancora manca di struttura e si basa sulla sua figura) potrebbe subire una pesante battuta d’arresto. Qualora invece, come sembra dopo il rilascio, Ko dovesse uscirne pulito il TPP potrebbe ricevere un’ulteriore spinta dall’opinione pubblica grazie all’immagine (che il partito sta già usando) di “martire” dell’opposizione, colpito per ragioni politiche. Da questa storia dipende tanto anche il futuro della politica taiwanese, divisa tra il ritorno allo storico bipolarismo oppure la nascita di una seria alternativa in grado di sparigliare le carte.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
In pochi giorni, la politica thailandese è stata stravolta: dissolto il principale partito di opposizione (vincitore delle elezioni), è stato rimosso il premier Srettha Thavisin, e sostituito dalla giovane esponente della dinastia Shinawatra.
Il partito vincitore delle elezioni di maggio 2023, seppure costretto all’opposizione, dissolto. Il primo ministro individuato dopo mesi di trattative, rimosso. La figlia e nipote di due ex premier vittime di colpi di Stato militari che diventa improvvisamente leader. Agosto caldissimo in Thailandia, dove l’ecosistema politico ha prodotto significative turbolenze, con l’attiva partecipazione dei militari e l’attenta osservazione della monarchia. Domenica 18 agosto, quando il re Maha Vajiralongkorn ha ufficialmente conferito il mandato da premier a Paetongtarn Shinawatra, è stato solo il passo finale. O almeno, il passo finale del capitolo di una vicenda ancora tutta da scrivere.
Facciamo un passo indietro. Il 14 maggio 2023 le elezioni restituiscono un risultato clamoroso. Per la prima volta, dopo diverse tornate elettorali, non vince il Pheu Thai della celeberrima dinastia politica dei Shinawatra, ma Move Forward, un partito nato sull’onda delle proteste giovanili degli ultimi anni ma che ha saputo catalizzare evidentemente le preferenze della maggior parte di coloro che vogliono il cambiamento. A premiare Move Forward anche presso le generazioni più adulte è stata una linea chiara e priva di compromessi, critica sia dei militari sia della monarchia. A dir poco significativo, un segnale che i thailandesi hanno veramente voglia di un’aria nuova. Così il partito è riuscito a catalizzare consensi che tradizionalmente sarebbero andati al Pheu Thai,
Il giovane Pita Limjaroenrat prova l’assalto alla posizione di premier nel ruolo di grande vincitore alle urne. Assalto fallito. Oltre ai 500 membri della Camera, la costituzione prevede che 250 senatori di nomina militare siano inclusi nel voto per il primo ministro. E l’establishment militare sbarra la strada a Pita, ritenuto troppo imprevedibile e a tratti anche pericoloso per la sua proposta di riforma della durissima legge di lesa maestà. E così si trova un accordo tra militari e Shinawatra, gli ex rivali che decidono di adottare una strada di riformismo controllato e “addomesticato”, con un’ampia coalizione che comprende anche partiti satellite a sostegno delle forze armate.
L’uomo d’affari Srettha Thavisin viene eletto premier il 22 agosto, proprio mentre l’ex premier e multimiliardario Thaksin Shinawatra torna a Bangkok dopo un lungo esilio. Avvio di compromesso messo a punto, ma addio al Pheu Thai simbolo del cambiamento come era stato un tempo.
Un anno dopo, cambia improvvisamente tutto, a completamento di quel compromesso su cui ora sono stati messi punti più chiari. Il primo snodo è la dissoluzione di Move Forward, decisa a inizio agosto dalla Corte Costituzionale. Dieci dei più alti dirigenti del partito, incluso il leader Pita, vengono esclusi dal parlamento e dalla vita politica per i prossimi dieci anni. Subito dopo, gli oltre 140 membri del partito rimasti in parlamento hanno fondato una nuova forza politica, il People’s Party. Un nome che rimanda alla rivoluzione siamese anti monarchica del secolo scorso: una chiara sfida, dunque, alla massima istituzione del Paese.
Una settimana dopo, la Corte Costituzionale ha stabilito con un voto a maggioranza risicata (5 contro 4) che Srettha Thavisin andava rimosso dal suo incarico. Il premier era accusato di aver nominato ministro un avvocato che nel 2008 era stato condannato a sei mesi di carcere per corruzione. Secondo i giudici, la nomina ha violato gli standard etici imposti dalla costituzione, che prevede in questo caso l’esaurimento immediato della carica. La sentenza è definitiva e non può essere appellata. Srettha, magnate del settore immobiliare diventato politico, lascia il posto dopo nemmeno un anno. Incompiute diverse politiche chiave, a partire dal programma di portafoglio digitale chiamato a rilanciare l’economia.
Passano due giorni e il 16 agosto viene individuata l’erede. Si tratta di Paetangtorn Shinawatra. 319 voti a favore, 145 contrari e 27 astenuti alla camera per l’ultima esponente della potente dinastia politica. Con appena 37 anni è la leader di governo più giovane di sempre. “E’ il momento di fare qualcosa per il Paese e anche per il partito, spero di poter fare il mio meglio per far andare avanti il il Paese”, dice visibilmente emozionata pochi minuti dopo la nomina.
Prima di lei sono stati premier la zia Yingluck e il padre Thaksin, multi miliardario, magnate delle telecomunicazioni ed ex proprietario della squadra di calcio inglese Manchester City. Entrambi sono stati rovesciati da colpi di stato militari, nel 2006 e nel 2014. Lei ha spesso ricordato le difficoltà legate alla rimozione del padre, quando all‘università nessuno le rivolgeva la parola.
Ha scarsa esperienza politica, e non ha mai ricoperto un ruolo di governo. Durante la campagna elettorale dell’anno scorso, ha guadagnato popolarità tenendo comizi nonostante fosse incinta. Dopo le urne, ha dialogato con Move Forward, per poi lasciare il posto di premier al compagno di partito Srettha Thavisin.
Paetongtarn ha ora il difficile compito di governare una coalizione con diverse anime e mantenere un complicato equilibrio con l’esercito. Sulla sua nomina si era espresso con scetticismo il padre Thaksin, sottolineando la sua giovane età. Ma il compromesso finale sembra aver favorito questa soluzione, quasi come se i militari avessero dato il via libera alla permanenza di Thaksin in Thailandia per proseguire i suoi affari, in cambio di una sorta di “pegno”, la giovane figlia in un ruolo di primo piano, dunque esposta a grandi pressioni e a un forte controllo.
La vera sfida di Paetongtarn sarà rilanciare l’economia, mai ripartita davvero dopo il Covid. E provare ad ampliare il consenso in un’opinione pubblica che non vede più nella famiglia Shinawatra una speranza di cambiamento. Il tutto sperando di evitare nuove rotture traumatiche in un equilibrio tra politica e militari che in Thailandia resta sempre precario.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Una nuova era. È difficile definire diversamente la fase che si è appena aperta in Vietnam, dopo la morte di Nguyen Phu Trong. Il segretario generale del Partito comunista vietnamita, scomparso il 19 luglio dopo tante voci sulla sua malattia, era il più potente da diversi decenni. Prima ancora di Xi Jinping in Cina, Nguyen era riuscito nel 2021 a ottenere un inedito terzo mandato, rompendo la prassi dei due mandati introdotta negli anni Ottanta dal leader delle riforme Le Duan.
Il suo posto è stato preso da To Lam, che ricopre anche la carica di presidente, di natura soprattutto cerimoniale. Nel giro di poco più di due mesi, To Lam prende così possesso di due delle quattro principali posizioni del sistema di potere vietnamita, che comprende anche il primo ministro e il presidente del parlamento. Prima, a maggio, era subentrato al posto di Vo Van Thuong, dimessosi dopo che uno scandalo di corruzione aveva toccato alcuni uomini della sua cerchia. La stessa sorte che era toccata anche al predecessore Nguyen Xuan Phuc, che ambiva alla poltrona di segretario generale al Congresso del 2021 e che era stato “accompagnato” alle dimissioni nella primavera del 2023.
Ma il 3 agosto è arrivato il bersaglio grosso, col Comitato centrale del Partito che ha confermato la sua nomina a segretario generale, valida fino al XIV congresso del gennaio 2026. Per allora non è ancora detto quali potranno essere gli equilibri. La vastità e ampiezza della campagna anticorruzione in corso negli ultimi anni testimoniano che gli equilibri interni non sono ancora del tutto definiti e potrebbero spuntare nuovi sfidanti. In molti credono, per esempio, che possa fare una mossa il premier Pham Minh Chinh, molto attivo di recente anche sul piano diplomatico.
Nel frattempo, il passaggio da Trong a To Lam rappresenta già un cambio netto. Trong era prima di tutto un ideologo. Da convinto marxista-leninista, Trong ha coltivato il legame storico-ideologico con Pechino, preservando quello di sicurezza con la Russia. E avviando uno storico disgelo con Washington col suo storico viaggio alla Casa Bianca nel 2015, il primo per un leader vietnamita. Una mossa utile a diversificare i rapporti internazionali. Come Xi in Cina, Trong ha costruito la sua reputazione su una ostentata inflessibilità in materia di sicurezza e incorruttibilità, medaglia che ha utilizzato per sconfiggere il rivale Nguyen Tan Dung al Congresso del 2016. Una vittoria dell’ideologia sul mercato, si era detto all’epoca. Ma Hanoi ha poi firmato gli accordi di libero scambio con Unione Europea e Regno Unito, promuovendo il RCEP in Asia-Pacifico. Intanto, la campagna anticorruzione della cosiddetta “fornace ardente” proseguiva senza sosta.
Una delle figure chiave a dirigere quella campagna era proprio To Lam, protagonista di una lunga carriera nelle forze di polizia per poi arrivare a essere nominato ministro della Pubblica Sicurezza nel 2016, ruolo mantenuto per otto anni sino alla promozione a presidente dello scorso maggio. Mentre era ministro, è stato nominato anche vice-capo del Comitato direttivo centrale per la lotta alla corruzione del Partito comunista. Ciò significa che di fatto era il numero 2 del leader Trong nella sua campagna della “fornace ardente”. Questo lo ha fatto entrare nelle grazie del segretario generale, nonostante la battuta d’arresto del 2021, quando sull’account TikTok del famoso chef Nusret Gökçe, noto con il soprannome di Salt Bae, è stato pubblicato un video che mostra Lâm e il suo entourage mentre cenano alla Nusr-Et Steakhouse di Gökçe a Londra, dopo aver partecipato alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici a Glasgow.
Nella clip, Gökçe dà da mangiare a Lâm un pezzo di bistecca placcata. Il video è stato cancellato dall’account TikTok di Gökçe 30 minuti dopo, ma nel frattempo un attivista vietnamita lo aveva condiviso sulla sua pagina Facebook, suscitando indignazione visto che in quel momento la maggior parte dei vietnamiti era alle prese con un blocco economico durato mesi a causa della pandemia di coronavirus.
To Lam ha resistito e ha anzi rilanciato, completando la sua ascesa ai vertici della politica vietnamita. Rispetto a Trong, i cui sforzi erano tesi a rendere il Vietnam un hub di produzione globale, potrebbe avere un maggiore focus sulla sicurezza e il mantenimento dell’ordine pubblico. Il cambio della guardia avviene in un momento delicato per Hanoi e la sua posizione nel mondo. Sempre più giganti stanno delocalizzando ad Hanoi e dintorni nel processo di diversificazione dalla Cina. Tra le altre, anche Samsung, Foxconn, Amazon e Apple. Il tutto eleva il Vietnam a una posizione più alta di quella di semplice hub manifatturiero, con lo stabilimento di produzioni tecnologiche e di alta qualità.
A livello diplomatico, il Vietnam è riuscito a mantenere ottimi rapporti con tutti. Basti pensare che nel giro di nove mesi Trong ha ospitato Joe Biden, Xi Jinping e Vladimir Putin. Nessun altro ha fatto lo stesso. La guerra in Ucraina e il timore di un crescente allineamento tra Cina e Russia ha comunque portato Hanoi ad approfondire i rapporti con gli Stati Uniti, tanto che proprio in queste settimane si sta trattando il primo storico acquisto di velivoli militari dalle aziende della difesa dell’ex storico nemico. Non solo. Il Vietnam ha anche firmato accordi di libero scambio con l’Unione Europea e il Regno Unito. Questa nuova fase di incertezza e potenziale instabilità verrà seguita con enorme attenzione da tutte le potenze globali.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Lungo viaggio in Asia di Blinken dopo il ritiro di Biden e in vista di un possibile ritorno di Trump. Il centro del viaggio di Blinken è stato il confronto di sabato 27 luglio con Wang Yi, ministro degli Esteri della Cina e capo della diplomazia del Partito comunista.
Undici giorni. È la durata del nuovo, ennesimo, viaggio in Asia orientale di Antony Blinken. Il segretario di Stato americano è partito per la regione lo scorso 24 luglio e vi rimarrà fino al 3 agosto con un obiettivo: rassicurare i partner e gli alleati regionali della tenuta dell’impegno degli Stati Uniti. Un’esigenza resa impellente dall’annuncio del ritiro di Joe Biden dalla corsa per le presidenziali e dal potenziale ritorno di Donald Trump, che ha sì nel mirino la Cina ma che nel suo primo mandato aveva molto allentato la rete di alleanze statunitensi in Asia. L’amministrazione Biden le ha invece rafforzate con una serie di mosse: ha lanciato l’AUKUS, il patto per sviluppare in modo congiunto sottomarini a propulsione nucleare con Regno Unito e Australia, allo scopo di schierarli nelle acque del Pacifico. Ha rivitalizzato ed esteso l’alleanza con il Giappone, ha ampliato gli accordi militari con Corea del Sud e Filippine, che durante il primo mandato di Trump sembravano traballare. Ma poi, anche e soprattutto attraverso il lavoro di Blinken, l’amministrazione Biden ha favorito il disgelo tra Giappone e Corea del Sud, certificato dal summit di Camp David dell’agosto 2023 col premier Fumio Kishida e il presidente Yoon Suk-yeol, ha stimolato un nuovo asse tra Giappone e Filippine col recente summit di Washington con lo stesso Kishida e il presidente Ferdinand Marcos Junior. Giappone e Corea del Sud sono stati inseriti in questo modo negli ingranaggi di partnership della Nato, con la quale entrambi i Paesi hanno siglato documenti di partnership nel 2023.
Il centro gravitazionale del viaggio di Blinken è stato però il confronto di sabato 27 luglio con Wang Yi, ministro degli Esteri della Cina e capo della diplomazia del Partito comunista. I media di Pechino hanno presentato l’incontro un po’ come “l’ultimo ballo” del segretario di Stato, di cui malignamente si ricorda l’approssimarsi della “data di scadenza” e se ne mettono dunque in dubbio affidabilità e credibilità, visto l’annuncio del ritiro di Biden dalle elezioni. Il confronto si è svolto a Vientiane, capitale del Laos, a margine della ministeriale degli Esteri dell’ASEAN, l’associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico.
Sono emersi con ancora maggiore evidenza rispetto al passato i tre temi davvero divisivi nelle relazioni politiche e strategiche tra le due potenze. Il primo è ovviamente Taiwan. Blinken ha espresso preoccupazione per quelle che ha definito “azioni provocatorie intraprese di recente, tra cui un blocco navale simulato in occasione dell’insediamento” del presidente taiwanese Lai Ching-te. La risposta di Wang è stata secca: “Taiwan fa parte della Cina, non è mai stato e mai sarà un Paese indipendente”, ribadendo che Pechino “contrasterà qualsiasi provocazione delle forze per l’indipendenza di Taiwan”, affermando che il governo cinese sta lavorando per raggiungere la “riunificazione completa”. Nessuno spazio negoziale, come già chiaro ed evidente, ma al massimo un accordo di essere in disaccordo. Possibili nei prossimi mesi nuove turbolenze in corrispondenza di un probabile transito negli Usa da parte dello stesso Lai nell’ambito di un potenziale viaggio in America latina.
Il secondo fronte è la guerra in Ucraina. Blinken ha accusato la Cina di fornire sostegno alla base industriale russa e ha avvertito che “se non agirà per affrontare questa minaccia alla sicurezza europea, gli Stati Uniti continueranno a prendere misure appropriate in tal senso”. Riferendosi a un possibile ampliamento delle sanzioni. La risposta di Wang parte proprio denunciando l’uso “unilaterale” delle sanzioni e chiarendo che Pechino non accetterà “pressioni e ricatti”. Complice l’incontro con l’omologo ucraino Dmytro Kuleba, nella sua prima visita in Cina dall’inizio della guerra, Wang ha sostenuto che la posizione di Pechino sul conflitto è “giusta e trasparente”, mentre gli Usa “gettano benzina sul fuoco”. Stessa accusa rivolta a Washington in merito alle dispute nel mar Cinese meridionale, su cui Blinken era intervenuto esplicitamente in sessione coi colleghi dei Paesi del Sud-Est asiatico poche ore prima sempre a Vientiane. Il segretario di Stato ha parlato di “azioni illegali” e di escalation, soprattutto in riferimento ai ripetuti incidenti nei pressi dell’atollo di Second Thomas tra le navi della guardia costiera cinese e quelle filippine, su cui è stato comunque siglato la scorsa settimana un fragile accordo di de-escalation.
Dopo il confronto con Wang, definito “franco e costruttivo” e servito più che altro a ribadire le rispettive posizioni sui temi divisivi, Blinken prosegue il suo viaggio con un calendario molto fitto e teso a rafforzare ulteriormente la tela di sicurezza asiatica, che gli alleati sperano regga anche con un potenziale Trump bis. Domenica 28 luglio, ha partecipato a una ministeriale 2+2 con il segretario della Difesa Lloyd Austin e i due omologhi giapponesi a Tokyo, dopo che il capo del Pentagono aveva già siglato un memorandum di intesa sulla sicurezza con Giappone e Corea del Sud riguardante il programma missilistico della Corea del Nord. Washington e Tokyo hanno concordato di rafforzare ulteriormente la cooperazione militare, migliorando il comando e il controllo delle forze statunitensi nel Paese dell’Asia orientale e rafforzando la produzione di missili con licenza americana, descrivendo la crescente minaccia della Cina come “la più grande sfida strategica”.
Lunedì 29 luglio, Blinken incontra sempre a Tokyo i ministri degli Esteri di Australia, India, Giappone e Stati Uniti per l’ottava ministeriale del Quad per discutere di sicurezza economica, informatica e marittima nell’Indo-Pacifico. Martedì 30 luglio, Blinken si sposta invece a Manila per la ministeriale 2+2 con le Filippine. Il segretario di Stato è invece già stato anche in Vietnam, dove ha portato gli omaggi dell’amministrazione per la scomparsa di Nguyen Phu Trong, segretario generale del Partito comunista vietnamita scomparso una decina di giorni fa. Le aziende della difesa americana stanno per la prima volta negoziando la vendita di dispositivi militari al vecchio rivale Hanoi.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
In Bangladesh è l’ora del sangue. Oltre 150 morti nel giro di una settimana, per le strade e nelle piazze del Paese dell’Asia meridionale, per lo più concentrati nella capitale Dacca. Le vittime sono soprattutto studenti.
Da alcune settimane gli studenti protestano contro un antico sistema di quote di accesso ai posti di lavoro pubblici, abolito nel 2018 e reintrodotto da una sentenza dell’Alta Corte lo scorso 5 giugno.
Il sistema di quote riserva fino al 30% dei posti di lavoro statali ai familiari dei veterani che hanno combattuto nella guerra d’indipendenza del 1971 contro il Pakistan. I manifestanti vogliono abolire questo sistema, che secondo loro è discriminatorio e avvantaggia i sostenitori del partito Awami League del primo ministro Sheikh Hasina, figlia di un eroe-martire della guerra d’indipendenza, primo presidente del Bangladesh. Hasina, d’altronde, basa molta della sua autorità sul nazionalismo. Il sistema di quote prevede anche il 10% dei posti per le donne, il 10% in base ai distretti di provenienza, il 5% alle minoranze etniche e l’1% per i disabili.
Il tema è particolarmente sentito, visto che gli impieghi statali sono considerati più stabili e remunerativi di quelli privati. Un particolare da non sottovalutare, visto che in un Paese dove l’età media si aggira intorno ai 27 anni sono in tantissimi i giovani che restano senza occupazione. Ogni anno, circa 400 mila laureati competono per circa tremila posti di lavoro nell’esame per il servizio civile. E moltissimi giovani tra i 15 e i 24 anni, per l’esattezza quasi il 40%, non studia né lavora.
Le proteste, che hanno portato in piazza decine di migliaia di persone, sono iniziate alla fine del mese scorso, ma le tensioni sono aumentate lunedì 15 luglio quando gli studenti attivisti dell’Università di Dacca si sono scontrati con la polizia e con i contro-manifestanti sostenuti dalla Lega Awami al governo.
Dal giorno successivo, mentre la violenza continuava a infuriare nei campus di tutto il Bangladesh, la situazione è sfuggita di mano con diverse decine di morti. Da giovedì è stato imposto un durissimo coprifuoco che chiede agli agenti di polizia persino di “sparare a vista” in casi estremi. La connessione internet è stata bloccata in larga parte di Dacca, ma anche le comunicazioni sono difficoltose da giorni.
Nel frattempo, Hasina ha difeso il sistema delle quote, affermando che i veterani meritano il massimo rispetto per il loro contributo alla guerra, indipendentemente dalla loro affiliazione politica. Il suo governo ha anche accusato i principali partiti di opposizione, il Bangladesh Nationalist Party e il partito di destra Jamaat-e-Islami, di alimentare il caos. Le autorità hanno fatto irruzione nella sede del BNP e hanno arrestato diversi attivisti dell’ala studentesca del partito. Di più. Hasina ha anche tacciato parte di chi protesta come filopakistano.
Dopo l’imposizione del coprifuoco, alcuni scontri sono proseguiti lo stesso, compreso il fine settimana. Gli ospedali hanno continuato a ricevere morti e feriti. Poi, dalla Corte Suprema, è arrivata quella che assomiglia a una sorta di mano tesa per un compromesso. La massima corte del Bangladesh ha infatti deciso di abbassare quella quota dal 30 al 5% o al 2% a seconda delle categorie di lavoro, invitando poi gli studenti a “tornare in classe” e mettere fine alla violenta protesta che ha in realtà causato una ben più violenta repressione. Ma ai manifestanti non pare bastare. La richiesta esplicita è infatti quella di abolire le quote, che sono state invece “solo” abbassate, seppur drasticamente. “Non fermeremo le manifestazioni finché il governo non si sarà impegnato a prendere una decisione che accolga le nostre istanze”, ha riferito a France Presse un portavoce degli “Studenti contro la discriminazione”.
La vicenda pare di difficile soluzione e ha costretto Hasina a cancellare un agognato viaggio all’estero, destinato a portarla in Spagna e Brasile per rafforzare l’immagine. La premier si trova invece costretta a difendersi sul fronte interno nel primo grande test dopo la sua quarta nomina consecutiva, giunta dopo le controverse elezioni dello scorso gennaio, quando l’Awami League di Hasina si è assicurato 223 dei 299 seggi del parlamento. I candidati indipendenti, molti dei quali selezionati dallo stesso partito di maggioranza e dai gruppi associati, hanno conquistato 62 seggi. Il tutto mentre attivisti e membri dell’opposizione, anche dall’estero, denunciano le elezioni come una “farsa”. Migliaia di esponenti dell’opposizione sono stati arrestati nei mesi che hanno preceduto le urne, compreso il segretario generale del Partito nazionalista, Mirza Fakhrul Islam Alamgir. L’ex premier Khaleda Zia è in regime di residenza sorvegliata, mentre il figlio Tarique Rahman si trova in esilio a Londra, da dove attacca a ripetizione il governo. Persino il premio Nobel Muhammad Yunus ha definito come “politicamente motivata” la condanna ricevuta a inizio 2024 per violazione delle leggi sul lavoro.
Il potere di Hasina, 76 anni, nasce lontano: è la figlia di Sheikh Mujibur Rahman, padre fondatore del Bangladesh. Già premier dal 1996 al 2001, dopo il ritorno al potere nel 2009 ha adottato una linea progressivamente più assertiva, tanto che il suo governo è stato più volte accusato di abusi dei diritti umani e di repressione dell’opposizione. Allo stesso tempo, in molti le riconoscono il merito di aver risollevato il Bangladesh dalla povertà rilanciando l’economia del Paese. Ora, però, sembra aver perso il controllo di una nutrita parte della popolazione più giovane, quella più numerosa. Il campanello d’allarme era peraltro già suonato alle elezioni di gennaio, quando l’affluenza si era fermata al 40%, vale a dire la metà dell’80% registrato al voto del 2018.
Senza una rapida soluzione, le proteste degli studenti e la loro repressione rischiano di generare ancora altro sangue.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Nel giro di pochi giorni, il Nepal ha visto cadere il governo guidato dall’ex guerrigliere maoista Pushpa Kamal Dahal, in arte Prachanda, e tornare al potere il suo grande amico-nemico K.P. Sharma Oli.
L’ennesimo colpo di scena di una storia politica assai frammentata e complessa, che rende il Paese incastonato tra Cina e India instabile sin dal 2008, quando venne abolita la monarchia stabilita alla fine del 1700. Nel giro di 16 anni si sono succeduti ben 14 governi, compreso quello appena insediatosi di Oli.
Ma che cosa è successo e perché l’esecutivo di Prachanda è caduto? Un passo indietro. Prachanda era diventato premier il 26 dicembre 2022, nel giorno del 129esimo anniversario della nascita di Mao Zedong. Un finale a sorpresa dopo che nelle elezioni del 20 novembre precedente il suo Centro maoista aveva totalizzato solo poco più dell’11% dei voti e 32 dei 275 seggi della camera bassa del parlamento. Sher Bahadur Deuba era convinto della nomina, forte del fatto che il suo Partito del Congresso Nepalese aveva conquistato il maggior numero di poltrone. E invece Prachanda, che ha abbandonato a sorpresa l’alleanza con Deuba per disaccordi su chi avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di premier, torna per la terza volta alla guida di Kathmandu dopo le precedenti (brevi) esperienze tra 2008/2009 e 2016/2017. A risultare decisivo è stato l’inatteso supporto del Partito comunista unitario marxista-leninista, guidato proprio da Oli, e di altri 7 piccoli partiti.
Nel suo terzo mandato come primo ministro, iniziato nel dicembre 2022, Prachanda ha cambiato tre volte il suo principale partner di coalizione e ha dovuto chiedere un voto di fiducia cinque volte, compresa quella persa venerdì scorso, con Oli che ha ritirato il sostegno al governo di Prachanda, dopo mesi di scontri e dissidi sempre più espliciti. Oli, che è già stato primo ministro due volte, ha trovato un accordo con il centrista Partito del Congresso Nepalese alla fine di giugno, assicurandosi un numero di seggi sufficiente per la maggioranza. In un discorso pronunciato prima del voto di venerdì, Prachanda ha affermato che la coalizione di Oli tra i due maggiori partiti politici è contraria alla pratica democratica. “Sono preoccupato che questo possa portare alla regressione e all’autoritarismo”, ha persino accusato. Ma gli avversari parlano di un’alleanza obbligata dalla necessità di stabilità politica.
Oli è entrato in politica da adolescente e ha trascorso 14 anni in prigione per aver fatto una campagna per rovesciare la monarchia. Dopo il suo rilascio, nel 1987, si è unito al partito comunista e ha scalato costantemente i ranghi. Eletto per la prima volta come primo ministro nel 2015, Oli è stato rieletto nel 2018 e riconfermato per un breve periodo nel 2021. Conosciuto per le sue posizioni nazionaliste in un Paese schiacciato dai giganteschi vicini Cina e India, Oli è visto come più favorevole a Pechino. Il cambio di governo avviene peraltro in un momento complicato per le relazioni tra i due colossi asiatici, con Nepal e Bhutan a giocare ruoli non secondari di sponda nella diatriba sull’enorme confine conteso.
Prachanda aveva in passato etichettato l’India come una potenza “espansionista” e denunciato un presunto piano per ucciderlo, ma negli ultimi anni aveva provato a proiettare un’immagine più equilibrata rispetto al passato. Prima della sua nomina era stato a Nuova Delhi dove aveva incontrato esponenti del Bharatiya Janata Party del primo ministro Narendra Modi, che però non lo ha ricevuto. Alla cerimonia d’insediamento, l’ex guerrigliero ha indossato un daura-suruwal, abito tradizionale nepalese che in precedenza aveva evitato. Episodio letto dai media indiani come un segnale di maggiore equilibrio e minore legame all’ideologia maoista.
Anche Oli ha in passato avuto una forte retorica anti indiana. Durante la pandemia di Covid-19 in Nepal, il neo premier si è scagliato contro l’India, affermando che il “virus indiano” era più pericoloso del “virus cinese” e ha persino preso in giro l’emblema nazionale indiano durante un discorso al Parlamento in cui ha attribuito la colpa del crescente numero di casi di coronavirus a persone che hanno violato il blocco nazionale, in particolare a coloro che si sono introdotti in Nepal dall’India.
Ma il nuovo governo potrebbe essere ben più equilibrato. La Cina ha sempre sostenuto l’alleanza tra il partito maoista e quello comunista: la rottura dell’accordo tra Oli e Prachanda potrebbe preoccupare Pechino, anche perché il neo alleato del premier, Deuba, è considerato un leader pro indiano. Di certo, Modi e Xi Jinping osserveranno con attenzione quanto accadrà sulle turbolente cime himalayane.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
L’India conferma il suo storico non allineamento, che le consente di far parte nello stesso momento del Quad (la piattaforma di sicurezza dell’Indo-Pacifico con Usa, Giappone e Australia), ma anche dei BRICS e dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO).
L’aumento degli scambi commerciali dell’India con la Russia non deve essere visto come un “fenomeno temporaneo”. Difficile trovare una frase piu esemplificativa di quella del ministro degli Esteri indiano S. Jaishankar sui rapporti tra Nuova Delhi e Mosca.
In Occidente, qualcuno sembra ancora stupirsi per l’arrivo al Cremlino di Narendra Modi, in una visita in programma lunedì 8 e martedì 9 luglio. Ma la realtà dei fatti è che le relazioni tra India e Russia sono molto radicate nella storia e nella politica estera dei rispettivi Paesi. Nonostante questo, il primo viaggio a Mosca di Modi dall’inizio della guerra in Ucraina rappresenta una doccia gelata per chi sperava, o meglio si illudeva, di poter “arruolare” l’India tra le fila delle cosiddette democrazie liberali in un’ottica di confronto con la Russia e (soprattutto) con la Cina.
Delhi conferma invece il suo storico non allineamento, che le consente di far parte nello stesso momento del Quad (la piattaforma di sicurezza dell’Indo-Pacifico con Usa, Giappone e Australia), ma anche dei BRICS e dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO). Modi ha preferito saltare il summit della SCO, che si è tenuto la scorsa settimana in Kazakistan, forse anche per evitare un faccia a faccia con Xi Jinping, di cui ricorda ancora lo sgarbo dell’anno scorso quando il presidente cinese non si presentò al G20 indiano. Modi ha invece preferito andare direttamente a Mosca per incontrare Putin.
Il viaggio è ufficialmente teso a discutere di un “ulteriore sviluppo delle relazioni russo indiane, tradizionalmente amichevoli, e di questioni rilevanti nell’agenda internazionale”. In programma un bilaterale con Putin e colloqui con ampie delegazioni. Secondo gli analisti di Nuova Delhi, l’incontro è teso a contrastare la percezione di una deriva dei legami con l’alleato di lunga data, mentre l’India costruisce una partnership più stretta con gli Stati Uniti. Una sorta di rassicurazione a Mosca, anche alla vigilia delle elezioni presidenziali americane che possono portare nuovi elementi di imprevedibilità. Sebbene i leader indiani e russi abbiano tenuto vertici annuali dal 2000, non se ne sono più tenuti dopo la visita di Putin a Nuova Delhi nel 2021. Il viaggio di Modi, poco piu di un mese fa la sua faticosa conferma per un terzo mandato, vuole dunque dare qualche garanzia all’antico partner.
Non solo l’India non ha mai condannato l’invasione russa, pur esprimendo “preoccupazione” in diverse occasioni, ma in questi anni ha intensificato in modo netto i rapporti commerciali. Il commercio bilaterale di energia ha registrato un boom grazie all’aumento degli acquisti di petrolio russo a basso costo dopo le sanzioni occidentali. Tuttavia, mentre le esportazioni totali di Mosca verso l’India ammontano a 65 miliardi di dollari, le esportazioni indiane sono di soli 4 miliardi di dollari circa, causando preoccupazione a Nuova Delhi. La bilancia commerciale è a dir poco sbilanciata a favore della Russia.
C’è anche un aspetto fondamentale che riguarda la difesa. Nonostante la diversificazione degli acquisti di hardware militare negli ultimi anni, l’India continua a dipendere dalle armi russe: circa un terzo delle importazioni indiane nel settore della difesa proviene da Mosca, rispetto ai due terzi di cinque anni fa. Dal febbraio 2022, come accaduto anche in Vietnam, sono cresciute però le preoccupazioni sulla capacità della Russia di fornire pezzi di ricambio e munizioni. Tanto che Nuova Delhi ha intensificato le acquisizioni dagli Stati Uniti. Ma l’eventuale processo di transizione e cambio di sistemi sarà lungo e difficoltoso. Ed è tutt’altro che scontata la volontà dell’India di operare una sorta di “disaccoppiamento” militare da Mosca.
Nella visita di Modi in Russia c’è anche un altro elemento. L’India vuole evitare che il crescente allineamento tra Mosca e Pechino si ripercuota negativamente sui propri interessi. Nuova Delhi continua a essere impegnata in un’aspra contesa territoriale con la Cina, che negli scorsi anni ha provocato anche alcuni scontri con diversi morti tra i militari dei due Paesi. Mantenere legami favorevoli con Putin significa per Modi assicurarsi qualche garanzia da parte russa nei burrascosi rapporti con Pechino. Allo stesso tempo, il Cremlino può dare un segnale alla Cina di non essere un mero junior partner ma di essere in grado di continuare a coltivare le sue relazioni diplomatiche, non per forza in perfetta sincronia coi desideri di Xi.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Il Vietnam cresce più del previsto e più dei vicini asiatici, nonostante il caos politico interno. Con la cosiddetta “diplomazia del bambù“, il Paese sa coltivare i rapporti internazionali come pochi. Un esempio vivente di multipolarità, che, per ora, fa rima anche con sviluppo economico.
C’è un Paese che nel giro di nove mesi ha ricevuto i leader delle tre principali potenze mondiali: Joe Biden, Xi Jinping e Vladimir Putin. C’è un Paese in cui la campagna anticorruzione e i giochi di potere all’interno del governo e del Partito comunista continuano senza sosta, tanto da portare alla rimozione di due presidenti nel giro di un anno. E c’è un Paese che continua a crescere e lo fa piu velocemente anche dei suoi vicini asiatici.
Questo Paese è in tutti e tre i casi sempre lo stesso: il Vietnam. L’economia di Hanoi ha registrato un’espansione del 6,93% nel secondo trimestre rispetto all’anno precedente, superando il 5,66% del trimestre gennaio-marzo. Confermando il suo ruolo sempre piu da protagonista di hub delle catene di approvvigionamento del Sud-Est asiatico, il Vietnam ha mantenuto una crescita costante delle esportazioni del 12,5% nel secondo trimestre, favorita dall’elettronica e dai frutti di mare. I consumi interni sono rimasti un po’ indietro, con un aumento del 5,78% nei primi sei mesi rispetto a un anno prima. Tra le economie in più rapida crescita al mondo, il Vietnam punta a un aumento del prodotto interno lordo del 6-6,5% nel 2024.
Il processo di crescita economica è ormai di vecchia data. I suoi semi sono stati gettati nel 1986, con il lancio delle riforme del Doi Moi, programma che ha consentito il passaggio da una pianificazione centralizzata a un’economia di mercato a orientamento socialista, con qualche anno di ritardo dalla “grande apertura” di Deng Xiaoping. Da allora molto è cambiato. Il Vietnam, sempre con qualche anno di ritardo rispetto alla Cina, è entrato nell’Organizzazione mondiale del commercio nel 2007 e nel nuovo millennio ha elevato 45 milioni di persone da una condizione di povertà assoluta. Il basso costo del lavoro, nonché la guerra commerciale e tecnologica tra Stati Uniti e Cina, sono stati elementi a favore di Hanoi, che ha accolto e continua ad accogliere la delocalizzazione di linee produttive in fuga dai dazi di Washington.
Il Vietnam ha uno storico legame politico e militare con la Russia, sin dai tempi dell’Unione Sovietica. E ne ha uno ideologico e commerciale con la Cina, da cui è però divisa a livello strategico da una contesa territoriale nel mar Cinese meridionale. Ma negli ultimi anni, Hanoi ha elevato i rapporti con Giappone, Corea del Sud e Australia. Ha sottoscritto accordi di libero scambio con Unione Europea e Regno Unito, ha patrocinato il Partenariato economico globale regionale (RCEP), che unisce la maggior parte dei Paesi dell’Asia-Pacifico. Il Vietnam è diventato il nuovo Eldorado degli investimenti dei colossi tecnologici internazionali. Sempre più giganti stanno delocalizzando ad Hanoi e dintorni nel processo di diversificazione dalla Cina. Tanto da far guadagnare al Paese il titolo di “piccolo Dragone”. Tra le altre, anche Samsung, Foxconn, Amazon e Apple. Il tutto eleva il Vietnam a una posizione piu alta di quella di semplice hub manifatturiero, con lo stabilimento di produzioni tecnologiche e di alta qualità.
Il risultato viene raggiunto nonostante la perdurante battaglia politica interna. Il complesso sistema politico-statale vietnamita si poggia sui cosiddetti “quattro pilastri”. Il principale è quello rappresentato dal segretario del Partito comunista, Nguyen Phu Trong, al terzo mandato come Xi Jinping. Sempre come il presidente cinese, Trong ha costruito la sua reputazione su una ostentata inflessibilità in materia di sicurezza e di anticorruzione, promossa attraverso la spietata campagna della “fornace ardente” che gli ha consentito di sbarazzarsi dei rivali politici sconfitti al 12 esimo congresso del 2016. La campagna anticorruzione prosegue sotto la regia del primo ministro Pham Minh Chinh, ex generale di polizia proveniente dal potente ministero di pubblica sicurezza. Nel giro di dodici mesi sono stati messi da parte due presidenti: Nguyen Xuan Phuc, che ambiva alla poltrona di segretario generale al Congresso del 2021, e Vo Van Thuong, che era considerato il delfino di Trong. Alla presidenza, ruolo soprattutto cerimoniale, c’è ora To Lam, che nelle scorse settimane ha fatto gli onori di casa ricevendo Putin.
Le turbolenze interne non traspaiono all’esterno e non condizionano la cosiddetta “diplomazia del bambù” di Hanoi, guidata dal principio “amici di tutti, arruolati da nessuno”. La visita di Putin era prevista sin da quando lo scorso settembre c’era stata quella di Biden, seguita poi a dicembre da quella di Xi, per riequilibrare i rapporti internazionali che il Vietnam sa coltivare come pochi. Un esempio vivente di multipolarità, che per ora fa rima anche con sviluppo economico.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Lai Ching-te ha vinto, ma non il suo Partito progressista democratico (DPP). Il risultato delle elezioni presidenziali e legislative di Taiwan dello scorso 13 gennaio è molto meno netto e molto più sfaccettato di come potrebbe sembrare a un primo sguardo. Certo, il candidato più inviso a Pechino è il presidente eletto ed entrerà in carica il prossimo 20 maggio. Ma per la prima volta dopo 16 anni non c’è una maggioranza parlamentare e il consenso popolare intorno al DPP appare in erosione.
Una tendenza che pare aver recepito anche la Cina, che nella sua prima reazione al voto (una nota firmata dal portavoce dell’Ufficio per gli Affari di Taiwan, Chen Binhua) ha sì ribadito che la “riunificazione è inevitabile”, ma anche sottolineato che “stavolta il DPP non rappresenta l’opinione pubblica maggioritaria dell’isola”. Una prospettiva che potrebbe portare Xi Jinping ad attendere ancora, sperando di fare leva sulle divisioni interne per avvicinare una “riunificazione pacifica” che, osservando l’orgoglio con cui i Taiwanesi si recavano sabato 13 gennaio ai seggi per votare il candidato preferito (a prescindere da quale fosse) resterà comunque difficile da ottenere.
Ma chi è Lai? Rimasto orfano quando era molto piccolo del padre minatore e cresciuto in una famiglia non certo agiata, ha saputo farsi strada prima negli studi di medicina e poi in politica. Durante una lunga carriera tra Yuan legislativo (il parlamento unicamerale di Taiwan) e Tainan (l’antica capitale precedente alla dominazione giapponese e feudo del DPP di cui è stato sindaco), si è costruito una fama di “indipendentista”. Un termine col quale si intende il perseguimento di una dichiarazione di indipendenza formale come Repubblica di Taiwan, superando dunque la cornice della Repubblica di Cina entro cui Taipei è indipendente de facto.
Anche a causa delle sue posizioni radicali sul tema identitario, espressione di una posizione più tradizionale del DPP, Lai è entrato in passato in rotta di collisione con la presidente uscente Tsai Ing-wen. Nonostante Pechino li consideri entrambi “secessionisti”, si tratta di due figure parecchio diverse. Prima di entrare in politica, Tsai ha anche guidato l’Ufficio per gli Affari della Cina continentale, l’organismo di Taipei che si occupa dei rapporti intrastretto. Ruolo che le ha dato la capacità di sapersi muovere tra le complicate pieghe della relazione con Pechino.
Tsai ha spostato nettamente la posizione del DPP verso il centro, riuscendo a conquistare il voto di molti moderati che in passato votavano il Kuomintang (KMT). In che modo? In sostanza appropriandosi dello status quo, la cui tutela viene chiesta sostanzialmente dal 90% dei Taiwanesi. Secondo Tsai, Taiwan non ha bisogno di dichiarare l’indipendenza perché “è di fatto già indipendente come Repubblica di Cina”. Una posizione che può non sembrare molto diversa da quella del KMT, ma che invece aggiunge una sfumatura decisiva: il mancato riconoscimento del “consenso del 1992”, cioè un accordo tra le due sponde dello Stretto secondo cui esiste “una unica Cina”, seppure il KMT aggiunga la dicitura “con diverse interpretazioni”. In sostanza, si tratta del riconoscimento che Taiwan fa parte della Cina, pur senza stabilire quale tra Repubblica di Cina e Repubblica Popolare Cinese. Una posizione accettabile per il Partito comunista, che forte del riconoscimento di quasi la totalità dei Paesi del mondo ritiene che di fatto tutto ciò significhi che Taiwan fa o farà parte della Repubblica Popolare.
Per Tsai, invece, Taipei e Pechino sono di fatto due entità separate non interdipendenti l’una dall’altra. A questa posizione che già non consente il dialogo, seppur rispetti la cornice della Repubblica di Cina, Lai ha garantito di allinearsi. Per tutta la campagna elettorale ha ripetuto che seguirà la posizione di Tsai. Eppure, non tutti si fidano.
Pechino si ricorda delle sue passate dichiarazioni in cui si definiva un “lavoratore pragmatico per l’indipendenza di Taiwan”. A Washington c’è qualche perplessità sulla sua retorica ben più esuberante di quella della cauta Tsai. Un esempio? In campagna elettorale, ha espresso il desiderio che in futuro il presidente taiwanese possa entrare alla Casa Bianca. Cosa che presupporrebbe il riconoscimento ufficiale di Taipei e la fine dell’ambiguità strategica. Non a caso, il DPP ha scelto come sua vice Hsiao Bi-khim, ex rappresentante di Taipei negli Usa e figura di cui l’amministrazione statunitense si fida molto. Non solo. Hsiao è anche considerata la vera erede di Tsai, nonché addirittura la sua “confidente”. Niente di meglio per contenere la potenziale imprevedibilità di Lai, che pare aver spento alcuni dei timori interni sulla sua posizione meno accomodante e dunque più rischiosa di quella di Tsai, tanto che il KMT presentava il voto come una “scelta tra guerra e pace”, sostenendo che una sua vittoria avrebbe potuto avvicinare il rischio di un conflitto sullo Stretto.
Resta però il fatto che tra 2020 e 2024 il DPP ha perso oltre due milioni e mezzo di voti alle presidenziali. Un’enormità, considerando che le preferenze totali raccolte da Lai sono state cinque milioni e mezzo.
“Se la Cina non parla con Tsai, non parlerà nemmeno con Lai”, dice Yen Chen-shen, politologo dell’Università Nazionale di Taipei e tra i massimi esperti dei rapporti tra Taipei e Pechino. “Non avremo nessuna comunicazione tra le due sponde dello Stretto. Se Lai fosse davvero in linea con Tsai potrebbe andare bene, ma ha una retorica molto più populista un po’ come Donald Trump, senza la prudenza di Tsai. Questo potrebbe causare dei problemi”, aggiunge Yen, che non si aspetta comunque un’azione irreversibile dopo le elezioni. “Credo comunque che la Cina stavolta sarà paziente, cercheranno di assicurarsi che Lai non proceda verso l’indipendenza. Chiederanno anche maggiori garanzie agli Usa, che penso faranno capire a Lai che c’è la necessità di mantenere forti comunicazioni con Pechino. E il DPP ha già garantito che non cambierà il nome del Paese, la bandiera o l’inno nazionale”.
Anche perché non potrebbe farlo. La sconfitta alle legislative toglie di fatto i numeri a Lai per operare grandi riforme senza un appoggio esterno, per non parlare delle già esigue possibilità di emendare la costituzione. Il DPP ha perso non solo la maggioranza assoluta, ma anche quella relativa, scendendo da 61 a 51 seggi. Uno in meno del KMT, che ne ha guadagnati 14 rispetto alla legislatura passata, ma non abbastanza per raggiungere i 57 necessari per avere la maggioranza assoluta. A fare da ago della bilancia tra i due protagonisti dello storico bipolarismo taiwanese, che dalla sfera politica sfocia spesso in quella identitaria, sarà il Partito del Popolo di Taiwan (TPP) di Ko Wen-je.
Ex chirurgo ed ex sindaco di Taipei, Ko rappresenta una novità sulla scena politica taiwanese, abituata a un duopolio che sembrava quasi impossibile da scalfire. Lui è invece arrivato terzo alle presidenziali, ma con un più che ragguardevole 26%, solo sette punti sotto il candidato del KMT, l’ex poliziotto Hou Yu-ih. Ko si è presentato come una “terza via” basata sul “pragmatismo” e su un programma “anti ideologico”. Piuttosto che dei rapporti con la Cina continentale, con cui ha comunque rivendicato la necessità di riaprire il dialogo, durante la campagna ha parlato di temi molto concreti come il prezzo delle case, i salari minimi, l’occupazione e il dilemma energetico. Un approccio che ha convinto soprattutto i più giovani, che ormai vedono il DPP come espressione del “sistema” e se ne sono allontanati rispetto agli anni delle proteste del “movimento dei girasoli” contro l’allora amministrazione KMT targata Ma Ying-jeou, il presidente taiwanese più dialogante di sempre con Pechino.
Con il suo “tesoretto” parlamentare, Ko potrebbe decidere di restare l’uomo copertina per i prossimi quattro anni, senza formalizzare una coalizione di opposizione col MT, nonostante le promesse in tal senso durante la campagna elettorale. Alternare aperture e chiusure al governo del DPP potrebbe consentire a Ko di tenere il pallino in mano, risultando decisivo per l’approvazione di leggi, riforme e budget di difesa. Giocando il ruolo del “responsabile” e provando a spolpare ulteriormente i partiti tradizionali in vista delle presidenziali del 2028, che, subito dopo la fine dello spoglio del 13 gennaio, Ko ha detto che vincerà sicuramente, di fronte ai suoi sostenitori delusi per la sconfitta.
Questo frazionamento interno potrebbe incidere non solo sulle dinamiche politiche taiwanesi, ma anche sulla postura della Cina, che guardando sul medio periodo potrebbe non vedere come del tutto negativo il risultato del voto. Certo, Lai non ha di fronte un mandato che sarà contraddistinto da calma e tranquillità. Né sul fronte interno, dove dovrà venire a patti con l’opposizione, né sullo Stretto. Subito dopo le elezioni, Pechino ha sottratto uno dei pochi alleati diplomatici ufficiali di Taipei, Nauru. Difficilmente si fermerà qui. In molti prevedono manovre commerciali, dopo che già sono state abolite le agevolazioni tariffarie per l’importazione di alcuni prodotti taiwanesi. Sul fronte militare, la regolarizzazione delle manovre di jet e navi intorno a Taiwan è destinata a proseguire o persino a intensificarsi.
I funzionari e gli analisti indicano in particolare due momenti delicati. Uno imminente, l’insediamento di Lai del 20 maggio, con Pechino che ascolterà con attenzione il suo primo discorso da presidente in carica. Il secondo, guardando più avanti, nel 2027. Già, perché quell’anno ci sarà un incrocio di eventi molto sensibile. Da una parte il XXI Congresso del Partito comunista cinese, dove Xi potrebbe cercare un quarto mandato da segretario generale oppure ritagliarsi un nuovo ruolo. In ogni caso, potrebbe voler mostrare qualche passo avanti sul dossier taiwanese e come in ogni Congresso la retorica resterà difficilmente di basso profilo. Proprio nello stesso momento, a Taiwan si sarà in piena campagna elettorale per le prossime elezioni del 2028. Con Lai impegnato a ottenere un secondo mandato, e con un DPP che potrebbe aver bisogno di una scossa per risalire la china di un trend recentemente negativo, anche qui la retorica potrebbe non essere delle più concilianti. Un incrocio reso ancor più insidioso dal fatto che da qui ad allora è previsto l’arrivo a Taiwan di una lunga serie di spedizioni di armi dagli Stati Uniti, alcune delle quali acquistate negli anni scorsi ma in ritardo.
Tutto ciò non significa che quello sarà l’anno della inevitabile resa dei conti, ma senz’altro potrebbe risultare un passaggio più decisivo di quello di questo 13 gennaio, che a molti taiwanesi è parso più interlocutorio. Non sono pochi, tra coloro che si sono recati al seggio, ad aver già fatto valutazioni in vista del 2028.
C’era chi diceva di votare Hou per veder perdere Lai e favorire così la candidatura della più apprezzata Hsiao per il DPP tra quattro anni. Al contrario, tra gli elettori del KMT si faceva già per il futuro il nome di Chiang Wan-an, pronipote di Chiang Kai-shek e sindaco di Taipei.
Nonostante i taiwanesi non percepissero le elezioni come un momento così cruciale per decidere le sorti del loro futuro e soprattutto delle prospettive su “guerra e pace” o “democrazia e autoritarismo”, lo Stretto è destinato a restare al centro dell‘attenzione per i prossimi anni. Una variabile fondamentale è rappresentata anche dalle prossime elezioni presidenziali degli Stati Uniti.
Vero che il sostegno a Taipei è bipartisan, dalle parti di Washington e soprattutto tra Dipartimento di Stato e Pentagono, ma certo le dinamiche regionali potrebbero cambiare molto con un ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, otto anni dopo quella telefonata con Tsai che in un certo senso avviò la lunga e complicata serie di eventi che ha reso Taiwan il tema principale di tutti i confronti tra Washington e Pechino.
I taiwanesi, intanto, sembrano voler respingere il peso che molti attribuiscono sulle loro spalle di attori decisivi per il futuro globale. Per loro, quelle del 13 gennaio sono state “solo” delle elezioni.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Dopo il viaggio di Putin in Corea del Nord e alla vigilia di nuove esercitazioni navali congiunte di Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone, l’interconnessione tra il fronte europeo e quello asiatico rischia di farsi sempre più forte.
La tensione nella penisola coreana ha appena fatto un salto di qualità. Il viaggio di Vladimir Putin in Corea del Nord ha prodotto la firma di un accordo di partnership strategica tra Mosca e Pyongyang, che prevede “assistenza reciproca” in caso di “aggressione interna” contro uno dei due Paesi. L’etichetta “assistenza” comprende anche quella militare, nel pieno solco tracciato dai trattati di mutua difesa e dallo stesso accordo che legava precedentemente Corea del Nord e Unione Sovietica durante la guerra fredda.
Uno sviluppo che fa temere alla Corea del Sud un coinvolgimento diretto della Russia nel confronto sempre piu acceso con il regime di Kim Jong-un al confine. D’altra parte, proprio a cavallo della visita del presidente russo, sono successe diverse cose. Poche ore prima dell’atterraggio del capo del Cremlino, dei militari nordcoreani hanno tentato di oltrepassare il confine, salvo poi ritirarsi dopo gli spari di avvertimenti delle truppe sudcoreane. Non solo. Diversi soldati di Pyongyang sarebbero rimasti feriti e uccisi nell’esplosione di alcune mine. L’incidente sarebbe avvenuto nella zona demilitarizzata, mentre i militari nordcoreani erano intenti a costruire delle fortificazioni non meglio precisate.
Pochi giorni dopo la partenza di Putin, il copione si è ripetuto. Altri sconfinamenti dei militari nordcoreani, altri colpi di avvertimento di Seul. Non solo. Si è anche chiarito di che cosa si trattasse a proposito delle fortificazioni. Secondo immagini satellitari ad alta risoluzione che interessano un tratto di 7 chilometri di confine, commissionate dalla Bbc, emergono almeno tre sezioni in cui sono state erette barriere vicino alla zona demilitarizzata, per un totale di circa un chilometro vicino all’estremità orientale del confine. È possibile che siano state costruite altre barriere lungo altri tratti del confine.
La data esatta di inizio della costruzione non è chiara a causa della mancanza di precedenti immagini ad alta risoluzione dell’area. Tuttavia, queste strutture non erano visibili in un’immagine catturata nel novembre 2023. Una sorta di muro, insomma. Una novità assoluta nelle complicate dinamiche del confronto coreano. I territori all’interno della zona demilitarizzata sarebbero anche stati spianati, una possibile violazione della tregua sottoscritta nel 1953 al termine della guerra di Corea.
Il conflitto è stato sospeso ma ufficialmente non si è peraltro mai davvero concluso, visto che non è stato sottoscritto alcun accordo di pace. Il fragile status quo si è fin qui retto sulla costituzione di questa zona demilitarizzata, quattro chilometri da una e dall’altra parte in cui non sono consentite installazioni militari e i movimenti sono ampiamente controllati. Per sfociare in una zona di controllo congiunto, il gruppo di casette presidiato da truppe di una e dell’altra parte dove si sono tenuti i vari vertici intercoreani, o anche dove nel giugno 2019 Donald Trump incontrò Kim Jong-un per una stretta di mano e una breve passeggiata che si rivelò una photo opportunity.
La costruzione del muro ha un valore innanzitutto simbolico. Segnala all’esterno che Kim non ha alcuna intenzione di trattare, né con Seul né con gli Usa. La mossa va anche letta nell’ambito dello storico cambio di politica intercoreana, visto che a gennaio il leader supremo ha chiesto di emendare la costituzione per definire la Corea del Nord “nemico principale e immutabile”, rinnegando dunque il tradizionale perseguimento del negoziato per la riunificazione. Aprendo dunque al tentativo di sottomissione del Sud, non solo di separazione. Da allora, il Nord ha anche iniziato a rimuovere i simboli che rappresentano l’unità dei due Paesi, come la demolizione di monumenti e la cancellazione di riferimenti alla riunificazione sui siti web del governo.
La visita di Putin potrebbe rendere piu audaci le manovre di Kim anche sul piano militare. Consapevole di avere un sostegno esterno, il leader supremo potrebbe segnalare con sempre maggiore forza di non apprezzare il rafforzamento dei legami tra Seul, Washington e Tokyo.
In tutto questo, una portaerei statunitense a propulsione nucleare, la Theodore Roosevelt, è arrivata sabato nella città portuale sudcoreana per le esercitazioni navali congiunte nei prossimi giorni con la Corea del Sud e il Giappone. Le manovre di questo mese, denominate “Freedom Edge”, coinvolgeranno le marine dei tre Paesi e comprenderanno esercitazioni marittime, di guerra antisommergibile e di difesa aerea, ha dichiarato il contrammiraglio statunitense Christopher Alexander, comandante del Carrier Strike Group Nine.
Kim reagirà con una forte retorica. Già in passato ha denominato le esercitazioni congiunte dei “preparativi all’invasione”. E potrebbe anche solo evocare quella possibilità di assistenza russa in caso di “aggressione”. Putin non ha d’altronde escluso la fornitura di armi di precisione a Pyongyang, portando Seul a dichiarare che potrebbe riformare la vecchia legge che le impedisce di esportare armi verso Paesi coinvolti in conflitto, allo scopo di inviare assistenza militare all’Ucraina. L’interconnessione tra il fronte europeo e quello asiatico rischia di farsi sempre piu forte.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
L’Asia resta distante dalla prospettiva europea. Seppure diversi Paesi abbiano mostrato vicinanza e solidarietà all’Ucraina, le idee su come raggiungere la pace non sono le stesse di quelle dell’Occidente.
Se il suo scopo era quello di ottenere un appoggio ampio dalla regione dell’Asia-Pacifico, Volodymyr Zelensky esce senz’altro deluso dalla conferenza sulla pace in Ucraina che si è svolta in Svizzera nel fine settimana.
A inizio giugno, il presidente ucraino era apparso all’improvviso allo Shangri-La Dialogue di Singapore, il vertice asiatico sulla sicurezza, proprio per provare a convincere più Paesi possibili a inviare delle delegazioni a Lucerna. Eppure, l’unico leader a essersi aggiunto alla lista da allora è stato José Ramos-Horta, presidente della piccola Timor Est. L’unico altro capo di governo presente in terra svizzera era Fumio Kishida, la cui presenza non è mai stata in discussione. Non solo perché nei giorni precedenti si trovava in Italia per il summit del G7, ma anche per la postura internazionale adottata dal Giappone negli ultimi anni.
Kishida è stato il primo, proprio dallo Shangri-La Dialogue del 2022, a paventare il rischio che in futuro l’Asia possa diventare la “prossima Ucraina”, schierandosi con decisione al fianco di Kiev e contro Mosca. Kishida ha anche visitato la capitale ucraina e Bucha nel marzo 2023, proprio in contemporanea (forse non casuale) con la visita a Mosca del presidente cinese Xi Jinping, suo rivale regionale. Kishida ha enormemente rafforzato l’alleanza militare con gli Stati Uniti e ha potenziato la partnership con la Nato. Insomma, la presenza giapponese in Svizzera era scontata e rappresenta davvero il minimo indispensabile.
Passando in rassegna gli altri Paesi, spicca ovviamente l’assenza della Cina. Anche questa non è una sorpresa. Pechino aveva già ampiamente annunciato che non ci sarebbe stata. A livello ufficiale, non viene criticata l’iniziativa svizzera ma si sottolinea che per portare davvero alla pace una conferenza o un vertice deve prevedere la partecipazione di entrambe le parti coinvolte. La Cina ha posto sostanzialmente tre condizioni per la sua presenza a conferenze di pace: riconoscimento sia di Mosca sia di Kiev, partecipazione in eguale misura e ascolto a entrambe le proposte di pace.
Nella retorica cinese, la stessa sin dall’inizio della guerra, vanno tutelate sia l’integrità territoriale che le “legittime preoccupazioni di sicurezza” di tutti i Paesi. Ciò significa che va ascoltato anche il punto di vista di Mosca, dandole delle garanzie. Non è un mistero che nella narrativa cinese gli Stati Uniti e la Nato abbiano gettato “benzina sul fuoco” della crisi ucraina, favorendo la prosecuzione della guerra piuttosto che una sua soluzione pacifica. La Cina continua a negare di aver fornito sostegno militare alla Russia e anzi ritiene che gli invii di armi americane e occidentali in Ucraina allontanino la soluzione negoziale. Insomma, la Cina pensa che la conferenza svizzera sia in qualche modo servita più a “continuare la guerra” che a raggiungere la pace, promuovendo una divisione in blocchi. Sottotraccia, si lavora per una seconda conferenza, riconosciuta sia dalla Russia sia dall’Ucraina. Un progetto ancora embrionale ma che vedrebbe la sponda del Brasile e che potrebbe ricevere maggiore impulso a cavallo del G20 di novembre, quando Xi Jinping sarà da Lula in Brasile.
L’assenza cinese pesa parecchio, ma colpisce il basso profilo mantenuto da altri Paesi come la Corea del Sud, che ha inviato solo un vice ministro. Seul ha seguito le orme di Tokyo “giapponesizzando” la sua politica estera con il presidente conservatore Yoon Suk-yeol e ci si aspettava forse un sostegno più forte. Parziale delusione anche dalle Filippine, in rotta di collisione con la Cina. Il presidente Ferdinand Marcos ha ricevuto Zelensky a Manila due settimane fa, ma alla fine non si presenta in prima persona, mandando comunque il suo consigliere su pace e riconciliazione, Carlito Galvez Jr. Singapore, primo Paese asiatico a emanare sanzioni verso Mosca a tutela degli Stati più piccoli di non essere invasi da quelli più grandi, non manda il premier Lawrence Wong come sembrava ma la ministra degli Esteri Ann Sim.
Non si è presentato neppure Narendra Modi, nonostante come Kishida si trovasse al G7 pugliese. Il premier indiano pare voglioso di continuare a bilanciare la sua postura mantenendo i legami storici con la Russia, peraltro partner di Nuova Delhi in ambito BRICS. Non è un caso che né l’India né l’Indonesia (anche lei con una presenza di non altissimo profilo) abbiano deciso di non sottoscrivere il documento finale della conferenza.
Interessante e inattesa invece la partecipazione, seppur solo con l’ambasciatore in Svizzera, della Thailandia. Bangkok ha appena chiesto ufficialmente l’adesione ai Brics ma il governo civile di Srettha Thavisin sta tentando di rafforzare i legami con l’Occidente dopo i vari golpe militari degli ultimi anni. Obiettivo: presentare la Thailandia come un partner affidabile e un porto sicuro per gli investimenti. Non sorprendono invece le assenze di Cambogia, Laos e Vietnam, che mantengono relazioni forti con la Russia. Nei prossimi giorni, Putin dovrebbe peraltro arrivare ad Hanoi in visita ufficiale. Prevista una tappa anche in Corea del Nord, il Paese che più di tutti appoggia esplicitamente la guerra del Cremlino, che nei giorni scorsi Kim Jong-un ha definito “missione sacra”.
Insomma, l’Asia resta ancora in qualche modo distante dalla prospettiva europea. Seppure diversi Paesi abbiano mostrato vicinanza e solidarietà all’Ucraina, le idee su come raggiungere la pace non sono sempre le stesse di quelle dell’Occidente.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Il 2024 è il 75esimo anniversario della Repubblica Popolare Cinese. Come sta la seconda potenza mondiale? Rallentamento economico, disoccupazione giovanile, crisi demografica e turbolenze geopolitiche.
L’anno del drago. Il 10 febbraio comincia il conto alla rovescia che porterà al 75esimo anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese, che ricorre il prossimo 1° ottobre. L’avvicinamento avverrà all’ombra del segno più amato dell’astrologia cinese, quel drago simbolo di potenza e che da sempre contraddistingue la simbologia del gigante asiatico, sin dai tempi imperiali. Mancheranno dunque solo 25 anni al centenario del 2049. Sì, “solo”, perché il Partito comunista è abituato a pensare sul lungo termine, a maggior ragione se all’orizzonte si intravede la data limite individuata per completare il “grande ringiovanimento nazionale” e rendere la Cina una “moderna potenza socialista”. D’altronde, all’alba del terzo millennio l’ex presidente Jiang Zemin aveva profetizzato un “ventennio di opportunità strategiche”, prontamente materializzatosi tra post 11 settembre, crisi finanziaria soprattutto occidentale e deterioramento del sistema democratico. Un ventennio finito forse con qualche anticipo, tra pandemia di Covid-19 e guerra in Ucraina, che hanno accelerato le dinamiche della competizione strategica con gli Stati Uniti.
Eppure, nell’ultimo quarto di secolo che la Repubblica Popolare fondata da Mao Zedong nel 1949 ha davanti prima dello storico giro di boa, le sfide sembrano più delle opportunità. Basti rileggere il rapporto di lavoro di Xi Jinping al XX Congresso del Partito comunista cinese dell’ottobre 2022, quello in cui ottiene il suo terzo mandato da segretario generale, così come il suo discorso di chiusura: la “nuova era” è fatta da “acque turbolente” e “sfide senza precedenti”. O ancora: “Lungo il percorso, siamo destinati a incontrare dei venti contrari. Alcune imprese hanno avuto difficoltà. Alcune persone hanno avuto difficoltà a trovare lavoro e a soddisfare i bisogni primari”, ha detto Xi nel suo discorso di fine anno lo scorso dicembre, quando tutti i media internazionali si sono concentrati soprattutto sulle dichiarazioni (per la verità tutt’altro che inedite) a proposito di Taiwan e alla “riunificazione” come “necessità storica”.
Il presidente cinese ha di fatto ammesso che la Cina sta incontrando e incontrerà ancora dei problemi sulla strada della ripresa economica. Una ripresa che è stata più lenta del previsto dopo la fine delle restrizioni anti Covid, rimosse da gennaio 2023. La crescita del Pil è stata del 5,2%. Il dato è in linea con l’obiettivo “superiore al 5%” fissato dal governo, considerato però molto cauto dopo che nel 2022 il target era stato mancato di parecchio. Pechino rivendica che la sua crescita è la più alta tra le grandi economie mondiali. Vero, ma se si escludono gli anni della pandemia è il dato più basso dal 1990, l’anno dopo piazza Tiananmen.
Significativo che nel discorso tradizionalmente dedicato ai risultati conseguiti nell’anno appena trascorso, Xi non si sia tirato indietro nel citare anche alcune difficoltà. “Alcuni luoghi sono stati colpiti da inondazioni, tifoni, terremoti o altri disastri naturali. Tutti questi aspetti rimangono in primo piano nella mia mente. Quando vedo che le persone sono all’altezza della situazione, che si tendono la mano nelle avversità, che affrontano le sfide a testa alta e superano le difficoltà, mi commuovo profondamente”, ha proseguito. “Ricorderemo quest’anno come un anno di duro lavoro e perseveranza”, una delle parole chiave della retorica di Xi negli ultimi due anni.
D’altronde, gli ostacoli che sembrano pararsi di fronte a Pechino non sono pochi. Secondo le principali banche d’investimento internazionali, nel 2024 la crescita del Pil cinese sarà inferiore al 5%. “Turbolenze esterne e scarsa fiducia dei cittadini: abbiamo di fronte diversi rischi e incognite”, ha ammesso l’Ufficio nazionale di statistica presentando i dati del 2023. Sul piano interno, c’è da affrontare una crisi immobiliare che non sembra accennare a concludersi. Fin qui il governo ha evitato maxi interventi di salvataggio. D’altronde, fu lo stesso Xi a tracciare alcune “linee rosse” per l’operato del settore immobiliare, abituato a crescere in modo poco regolato e, soprattutto, con un modello di investimenti a debito altamente rischioso.
Pechino è intervenuta in modo intenzionale, consapevole di poter perdere qualche decimale a fronte di un cambio di paradigma per rendere settore e crescita più stabili. Ma dopo la caduta di Evergrande anche tanti altri colossi sono finiti in difficoltà, contagiando il sistema bancario ombra e dei fondi fiduciari, tradizionalmente legati a doppio filo proprio col settore immobiliare. Il gigante tentacolare Zhongzhi è finito in bancarotta.
Tutto ciò si ripercuote in modo negativo sui consumi. L’obiettivo indicato da tempo di Xi, cioè trasformare la cosiddetta fabbrica del mondo in una società di consumi interna, è rimasto ancora parzialmente inevaso. Anche perché nel frattempo la fiducia di cittadini e imprese non sembra tornata ai livelli pre Covid. A completare il quadro, un problema che è forse tra i principali sul medio lungo termine: il calo demografico.
La popolazione della Repubblica popolare è diminuita nel 2023 per il secondo anno consecutivo. Nel 2022 si erano perse 850 mila persone, primo storico calo dal 1961, tempo di carestia in seguito al “grande balzo in avanti” di Mao Zedong. Nel 2023 il calo è stato di 2,08 milioni, con l’India che ha operato il sorpasso su Pechino laureandosi nazione più popolosa al mondo. L’alta disoccupazione giovanile e i prezzi delle case stanno affossando i tentativi del governo di invertire il trend negativo. Agevolazioni fiscali, sussidi per l’acquisto delle case e congedi di maternità prolungati non stanno fin qui bastando a sollevare un tasso di natalità che ha raggiunto il minimo di 6,39 nascite ogni mille persone.
Non pare sin qui funzionare nemmeno la cosiddetta “politica del terzo figlio”: non solo perché è difficile scalfire una prassi divenuta anche culturale come quella del figlio unico, ma soprattutto per un mutamento profondo nella società cinese che da rurale è diventata urbana. Con l’aumento esponenziale della classe media, sono anche cambiati gli stili di vita. Sebbene il numero di matrimoni nel 2023 sia aumentato, aumentano anche le separazioni. Sposarsi meno e più tardi è poi una conseguenza naturale di una società più sviluppata economicamente e culturalmente, come già visto in tante altre società asiatiche e occidentali.
Già oggi il 21% della popolazione cinese (circa 297 milioni di persone) ha più di 60 anni, ma nel 2040 la percentuale dovrebbe arrivare al 28%. L’Accademia cinese delle scienze sociali ha previsto qualche anno fa che nel 2035 si potrebbe arrivare al potenziale esaurimento del sistema pensionistico. Tanto che Xi Jinping potrebbe essere costretto prima o poi a operare delicate riforme e aprire il dossier delle pensioni. L’età pensionabile in Cina è d’altronde tra le più basse al mondo: 60 anni per gli uomini, 55 per le impiegate e 50 per le donne che lavorano nelle fabbriche. Norme non più in linea con l’andamento economico e demografico del gigante asiatico.
Oltre all’economia, che già rappresenta un dossier cruciale, non mancano questioni di politica interna. Dopo aver rimodellato Comitato centrale e Politburo a sua immagine e somiglianza al Congresso del 2022, Xi ha dovuto rimuovere in rapida successione due ministri e consiglieri di Stato promossi lo scorso marzo. Soprattutto, due figure che gli sarebbero state vicine.
A fine luglio è stato rimosso il ministro degli Esteri Qin Gang. Ex ambasciatore negli Stati Uniti, Qin era stato protagonista di una rapida ascesa politica dovuta anche e soprattutto ai suoi rapporti con Xi. Qin ha perso il posto in mezzo a insistenti voci di una relazione extraconiugale con una reporter televisiva cinese, con importanti agganci internazionali. Una relazione che sarebbe nata mentre si trovava a Washington a ricoprire il ruolo più delicato della diplomazia cinese, cioè quello di ambasciatore negli Stati Uniti. Poche settimane dopo è toccato a Li Shangfu, il ministro della Difesa. In questo caso, la decisione sarebbe legata a un’indagine scaturita sulla precedente posizione di Li come responsabile delle forniture militari. E sarebbe all’interno di una vicenda molto più ampia, la stessa che ha portato Xi a silurare all’improvviso i vertici delle forze missilistiche dell’Esercito popolare di liberazione a inizio agosto. Mossa a cui sono seguiti altri avvicendamenti e allontanamenti a fine dicembre sia nelle forze armate che a capo di alcune delle industrie chiave per lo sviluppo aerospaziale. Mentre Qin è stato sostituito subito col ritorno di Wang Yi, il buco di ministro della Difesa è rimasto aperto per diversi mesi prima di venire coperto nelle ultime ore del 2023 con Dong Jun. Per la prima volta la Cina sceglie un ministro proveniente dalla Marina. Per la prima volta viene scelto un ufficiale che non fa parte, per ora, della Commissione militare centrale. Prima del centenario della Repubblica Popolare ci sarà quello dell’Esercito popolare di liberazione, nel 2027. Entro allora Xi ha chiesto dei passi avanti concreti sulla modernizzazione delle forze armate e sulla prontezza di combattimento. I recenti sconvolgimenti e la campagna anticorruzione dimostrano che di lavoro da fare ce n’è ancora parecchio, anche se la forza di fuoco di Pechino (soprattutto sul fronte navale) è in rapida e netta espansione.
Non mancano ovviamente le sfide strategiche. Al centro dell’attenzione resta sempre Taiwan, a maggior ragione dopo la vittoria di Lai Ching-te del Partito progressista democratico (DPP, il più inviso a Pechino) alle elezioni presidenziali del 13 gennaio. Lo status quo sullo Stretto traballa da un po’ e sulla sua stabilità inciderà in modo rilevante anche il voto per la Casa Bianca del prossimo novembre, ma in generale anche l’andamento dei rapporti con Washington.
Sul fronte internazionale, resta caldo il confine con l’India. Come svelato nelle scorse settimane, anche nel 2022 ci sono stati diversi episodi di scontri tra le truppe dei due Paesi lungo la frontiera contesa, anche durante i colloqui per stabilizzare una situazione resa volatile dalle violenze del giugno 2020, quando per la prima volta dopo tanti anni ci furono diversi morti da entrambe le parti.
Non da meno (anzi) le tensioni sul mar Cinese meridionale. In particolare, con le Filippine. Dall’estate del 2023 si sono succeduti scontri, incidenti, speronamenti e cannoni ad acqua tra le navi di Pechino e di Manila, quasi sempre in prossimità della secca di Second Thomas, ogni qualvolta le Filippine avviano missioni di rifornimento o sostituzione del piccolo drappello di militari di stanza sulla Sierra Madre, il relitto di una nave statunitense della Seconda Guerra Mondiale arenato volontariamente nei pressi di un atollo conteso e trasformato in una piccola base.
Attenzione poi al Myanmar, dove la guerra civile prosegue e anzi si è intensificata, coi gruppi ribelli armati che hanno conquistato diverse postazioni proprio al confine con la Cina. L’esercito birmano ha bombardato nei pressi della frontiera, facendo finire qualche colpo su territorio cinese come già accaduto in passato. Pechino non apprezza e pur mantenendo fitto il dialogo col regime golpista non disdegna la comunicazione coi gruppi etnicamente cinesi suoi rivali.
La Cina osserva con qualche apprensione anche quanto accade sui suoi mari orientali. La tensione crescente sulla penisola coreana pare destinata ad attirare ancora più attenzione degli Usa nell’area, con il rafforzamento delle manovre militari con Corea del Sud e Giappone. La Corea del Nord di Kim Jong-un rinsalda invece l’asse con la Russia, con Vladimir Putin che sembrerebbe presto visitare Pyongyang. Sarà interessante vedere i movimenti di Xi, che nel corso del 2024 dovrebbe incontrare il premier giapponese Fumio Kishida e il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol per riesumare il meccanismo di dialogo trilaterale rimasto inattivo dal 2019.
L’anno del drago si presenta turbolento e Pechino spera di non dover sputare fiamme.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Nel giro di un paio di settimane, la Corea del Nord ha inviato più di mille palloni aerostatici per far cadere tonnellate di rifiuti e letame nel Sud, come rappresaglia contro le campagne di propaganda sudcoreane
Da una parte, palloni aerostatici pieni di rifiuti e persino escrementi. Dall’altra, gli altoparlanti con messaggi anti regime e musica K-Pop. Il confine tra le due Coree torna caldissimo e non solo per le manovre militari, ma ancor prima per azioni a metà tra l’ampliamento della zona grigia e la propaganda. Nel giro di un paio di settimane, la Corea del Nord ha inviato più di mille palloni aerostatici per far cadere tonnellate di rifiuti e letame nel Sud, come rappresaglia contro le campagne di volantinaggio civile sudcoreane. Qualche giorno fa, Pyongyang aveva comunicato che avrebbe interrotto l’invio di palloni, ma la Corea del Sud ha sospeso l’accordo militare intercoreano del 2018, che prevedeva alcune misure per abbassare le tensioni.
In una controreplica, nel fine settimana il regime di Kim Jong-un ha ricominciato gli invii. E lo ha fatto in modo consistente. Lo Stato Maggiore della Corea del Sud ha dichiarato di aver rilevato che il Nord ha lanciato circa 330 palloni verso il Sud da sabato sera e che circa 80 sono stati trovati in territorio sudcoreano domenica mattina.
I militari hanno detto che sabato sera i venti soffiavano verso est, il che potrebbe aver fatto sì che molti palloni galleggiassero lontano dal territorio sudcoreano. I militari del Sud hanno detto che i palloni che sono atterrati hanno lasciato cadere rifiuti, tra cui plastica e carta, ma non sono state scoperte sostanze pericolose. L’esercito, che ha mobilitato unità di pronto intervento chimico e di bonifica degli esplosivi per recuperare i palloni e i materiali nordcoreani, ha avvertito la popolazione di fare attenzione alla caduta di oggetti e di non toccare i palloni trovati a terra, ma di segnalarli alla polizia o alle autorità militari. Nei giorni precedenti molti palloni contenevano letame, mozziconi di sigarette, brandelli di stoffa, batterie esauste e carta straccia. Alcuni sono stati fatti scoppiare e sparsi su strade, aree residenziali e scuole.
Ma Seul, dopo la sospensione dell’accordo è passata al contrattacco. La decisione di cancellare le disposizioni di sei anni fa, sottoscritte nel momento di massimo dialogo tra le due parti che sfociò nei due summit tra Kim Jong-un e Donald Trump tra Vietnam e Singapore, consente alla Corea del Sud di ricominciare le esercitazioni militari a fuoco vivo e le trasmissioni di propaganda anti-nordcoreana nelle aree di confine.
Sono ripresi i lanci di palloni contenenti all’incirca 200 mila volantini con messaggi anti regime e chiavette usb contenenti musica K-Pop e serie televisive sudcoreane, i cosiddetti K-Drama ormai celebri in tutto il mondo ma che in Corea del Nord sono tutti severamente vietati. Non solo. Le autorità di Seul hanno comunicato l’immediato ritorno in funzione degli storici altoparlanti lungo il confine. Verrà trasmessa musica K-Pop ma anche e soprattutto messaggi di propaganda. Era dal gennaio 2016 che non accadeva. Allora la decisione fu presa in risposta al quarto test nucleare di Pyongyang.
Ma attenzione perché la vicenda rischia seriamente di non fermarsi qui. Diversi analisti ritengono che la reazione di Seul possa portare a delle manovre militari nordcoreane nei pressi della frontiera. D’altronde, il contesto in cui si inserisce questo nuovo incidente è parecchio teso. Lo scorso novembre la Corea del Sud aveva già sospeso una parte dell’accordo del 2018 in risposta al lancio del primo satellite spia da parte di Pyongyang. Il ritorno a manovre contrapposte militari nei pressi della zona demilitarizzata ha già avuto delle conseguenze. Nei primi giorni del 2024, sono stati sparati dei colpi di artiglieria, alcuni oltre la zona cuscinetto tracciata sul confine marittimo conteso.
Nel mirino c’era l’isola sudcoreana di Yeonpyeong, dove vivono circa duemila civili. Per la prima volta dopo diversi anni è stata ordinata l’evacuazione. In un bombardamento del 2010, sulla stessa isola rimasero uccise quattro persone.
Poche settimane dopo, Kim Jong-un ha dato un’importante svolta politica e retorica, chiedendo di emendare la costituzione per cui la Corea del Sud verrà etichettata come “nemico principale e immutabile”. Alla separazione territoriale fa seguito anche una separazione quasi identitaria, visto che con la modifica costituzionale i sudcoreani non sarebbero più chiamati compatrioti ma appunto nemici.
Secondo alcuni analisti, la svolta è di portata storica perché di fatto disconosce la storica linea della Corea del Nord, secondo cui l’obiettivo ultimo è sempre stato fin qui quello della riunificazione col Sud. Un cambio di paradigma che ha delle conseguenze non solo retoriche ma anche molto pratiche. Sono state subito chiuse e abolite tutte le agenzie che promuovono la cooperazione intercoreana e il dialogo. Come già era accaduto nel 2020 con l’ufficio di collegamento di Kaesong, Kim ha poi imposto la distruzione del monumento alla riunificazione nella capitale. Nelle scorse settimane è stato invece distrutto un segmento della ferrovia intercoreana. Sembra di più di una semplice mossa tattica o propagandistica, anche perché nel frattempo la Corea del Nord è sempre più esplicitamente alleata alla Russia. Dopo averlo incontrato a settembre nell’Estremo Oriente Russo, Kim si appresta anche a ricevere Vladimir Putin a Pyongyang nel prossimo futuro. Una visita che probabilmente porterà nuovi motivi di tensione in uno scenario già teso e nel quale è difficile immaginare come si possa ottenere una de-escalation.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
L’obiettivo di Modi per queste elezioni era stravincere. Domani i risultati ma già sembra certo il suo terzo mandato. 969 milioni di elettori avrebbero consegnato al partito BJP del Primo Ministro la vittoria con più seggi della scorsa legislatura, secondo gli exit poll
Ci siamo. Dopo un mese e mezzo di operazioni, martedì 4 giugno è il momento in cui verranno annunciati i risultati delle elezioni generali in India. Sabato 1° giugno si è svolta l’ultima delle tante sessioni di voto che si sono succedute ad aprile, uno sforzo mastodontico per un Paese da 1,4 miliardi di abitanti e 969 milioni di cittadini aventi diritto di voto. Con ogni probabilità, Narendra Modi sarà confermato primo ministro per uno storico terzo mandato, anche se durante la campagna elettorale pare siano salite le quotazioni dell’ampia coalizione di opposizione che gravita intorno al Partito del Congresso guidato da Rahul Gandhi, appartenente alla dinastia politica più nota del Paese.
Negli scorsi giorni hanno iniziato a circolare i primi exit poll. Secondo un aggregato con sei fonti diverse, la coalizione di governo guidata dal Bharatiya Janata Party (BJP) di Modi sarebbe proiettata a una netta vittoria. Servono almeno 272 seggi in parlamento per formare un governo e si prevede che possano essere raggiunti tra i 355 e i 380 seggi, sopra i 353 della scorsa legislatura. Il BJP potrebbe arrivare da solo a 327 seggi mentre, secondo Reuters, il blocco di opposizione India dovrebbe ottenere tra i 125 e i 165 seggi.
Va ricordato e sottolineato che gli exit poll in India sono raramente affidabili, anche perché spesso macchiati da una netta partigianeria. Tanto che dall’opposizione sostengono di poter persino vincere. Ma se i dati fossero in qualche modo confermati si tratterebbe di una vittoria netta che consoliderebbe ulteriormente la presa del BJP. Anche se gli obiettivi annunciati alla vigilia da Modi e dai suoi alleati erano persino più ambiziosi. Il premier ultranazionalista indù ha infatti indicato in 370 seggi il target del BJP da solo e 400 seggi per la coalizione. Solo una volta, nei 77 anni di indipendenza dell’India, un partito o un’alleanza ha ottenuto più di 400 seggi: il Partito del Congresso, ora all’opposizione, nel 1984, all’indomani dell’assassinio del primo ministro Indira Gandhi.
In ogni caso, il terzo mandato di Modi sembra pressoché scontato. Di certo il BJP conquisterà i suoi Stati roccaforte, tra cui Gujarat, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Delhi, Uttarakhand e Himachal Pradesh. La coalizione d’opposizione dovrebbe ottenere buoni risultati negli Stati meridionali del Paese, ma la maggior parte degli exit poll suggerisce che il BJP potrebbe ottenere risultati ottimi anche lì. Sarebbe parzialmente una sorpresa, visto che si tratta di un’area del Paese tradizionalmente complessa da conquistare per il BJP.
Diversi exit poll prevedono che il partito di Modi potrebbe conquistare da due a tre seggi in Kerala, l’ultima roccaforte della sinistra indiana dove il partito di Modi non ha mai vinto. Alla portata anche da uno a tre seggi in Tamil Nadu, dove aveva subito una rara batosta alle ultime elezioni. Si tratterebbe di successi fondamentali che darebbero a Modi una nuova proiezione in aree a lui solitamente ostili. Non a caso, durante la campagna elettorale Modi ha visitato sei volte nel giro di pochi mesi il Tamil Nadu, che da solo esprime ben 39 seggi. Anche qui ha utilizzato un tema storico-culturale per attrarre consensi, riesumando una vecchia contesa territoriale con lo Sri Lanka sull’isola Katchatheevu. Una mossa ad alto contenuto strategico per erodere i consensi di cui gode nell’area il Congresso, visto che l’alleato Dravida Munnetra Kazhagam non ha mai approvato la cessione dell’isola effettuata dal partito della dinastia Gandhi.
L’obiettivo di Modi è stravincere. Modi afferma che un’altra vittoria schiacciante per l’Alleanza Nazionale Democratica, guidata dal BJP, è fondamentale per raggiungere il suo obiettivo di portare l’India a un’economia sviluppata entro il 2047, partendo da livelli di reddito medio. La quinta economia mondiale è cresciuta rapidamente negli ultimi anni e Modi ha “garantito” di portarla alla terza posizione se vincesse le elezioni.
La campagna per la rielezione di Modi è stata contraddistinta dall’utilizzo dell’arma retorica del timore: lui e il BJP hanno continuamente proiettato il primo ministro come salvatore della popolazione indù contro una cospirazione dell’opposizione a favore dei musulmani, che nei comizi elettorali ha definito “infiltrati” e “quelli con più figli”. Non sorprende, visto che sin dall’inizio della sua ascesa politica ha solleticato i sentimenti ultranazionalisti indù e una volta entrato in carica ha eroso i diritti delle minoranze musulmane con mosse come la nuova legge sulla cittadinanza e la revoca dell’autonomia del Kashmir. A gennaio, Modi ha dato il via alla campagna elettorale con l’inaugurazione del tempio di Ayodhya, confermando l’ostilità verso la minoranza musulmana. Il tempio è stato infatti costruito sul terreno dove una moschea di epoca Moghul, chiamata Babri Masjid, sorgeva per secoli prima di essere demolita nel 1992 da una folla mobilitata da organizzazioni ultraindù. Negli ultimi giorni prima del voto ha anche detto che lui “è stato scelto da Dio”. E pare proprio che verrà scelto anche dagli indiani per la terza volta.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Nuove esercitazioni militari cinesi e battaglia politica per la riforma del potere legislativo. Questa volta le esercitazioni sono durate solo 2 giorni, senza missili balistici e senza portaerei, ma è stato creato un effetto di accerchiamento e il messaggio è chiaro.
Era difficile immaginare un inizio più movimentato per Lai Ching-te. Il nuovo presidente della Repubblica di Cina (Taiwan) ha dovuto far fronte nel giro di una settimana alle esercitazioni militari della Repubblica Popolare Cinese e al caos interno dovuto alla proposta di riforma del parlamento che ha portato a estese proteste per le strade di Taipei. Il suo obiettivo dichiarato, vale a dire quello di tutela dello status quo, appare dunque piu complicato da raggiungere del previsto.
A Taipei ci si aspettava una reazione da parte di Pechino al discorso di insediamento di Lai. A prescindere da quello che avrebbe detto, visto che per il Partito comunista cinese qualsiasi cosa che non sia riconoscere il principio della “unica Cina” non basta. A maggior ragione ci si aspettava però una reazione dopo che Lai ha pronunciato un discorso molto assertivo, lasciando subito capire che il suo stile di governo sarà piuttosto diverso da quello della ex leader Tsai Ing-wen.
Abbandonando molte delle cautele retoriche e lessicali della compagna di partito (ed ex rivale interna), Lai ha elaborato in maniera rilevante il concetto di sovranità e quello di indipendenza.
Vero che non si tratta di una novità, visto che tutti i presidenti hanno sempre rivendicato la sovranità di Taipei, ma rispettando almeno formalmente il perimetro della Repubblica di Cina. Lai ha invece molto taiwanesizzato l’approccio, equiparando il nome con cui Taipei è indipendente de facto (Repubblica di Cina, appunto) a quello che perseguirebbe in caso di dichiarazione di indipendenza formale (Taiwan). Di più. Non ha riaffermato la guida della costituzione nel regolare i rapporti intrastretto, una delle rassicurazioni principali che Tsai ha invece sempre fornito a Pechino.
Ed ecco allora la due giorni delle esercitazioni “Spada Congiunta 2024A”. Si tratta delle terze grandi esercitazioni intorno a Taiwan degli ultimi anni, dopo quelle di agosto 2022 dopo la visita di Nancy Pelosi e quelle di aprile 2023 in risposta al doppio scalo di Tsai negli Usa, con annesso incontro col successore di Pelosi alla presidenza della Camera dei Rappresentanti, Kevin McCarthy. Rispetto alle due precedenti, non sono stati lanciati missili balistici (come ad agosto 2022) e non è stata utilizzata una portaerei (come ad aprile 2023) e la durata è stata inferiore: due giorni invece dei tre di aprile 2023 e i dieci di agosto 2022. Ma questo non significa che la qualità delle esercitazioni sia stata minore.
Almeno su carta, è stato ricreato un effetto di accerchiamento. Navi e jet si sono mossi in cinque aree dislocate su tutti i lati dell’isola: nord, sud, ovest, est. Particolarmente critico il presidio della costa orientale, quella cioè da dove potrebbero ipoteticamente arrivare aiuti dall’esterno. L’Esercito popolare di liberazione ha dunque voluto mostrare di essere in grado di interdire azioni di attori terzi. Concetto rafforzato dalla simulazione di attacchi missilistici contro navi straniere e l’impiego della guardia costiera per la prima volta a est di Taiwan. La guardia costiera si è mossa contemporaneamente anche in corrispondenza delle isole minori Kinmen, Matsu e Wuqiu, a reiterare le sovranità su quelle acque e trasformando concettualmente lo Stretto in una sorta di mare interno.
La sensazione, confermata da diversi analisti cinesi e taiwanesi, è che sia stato testato soprattutto uno scenario ipotetico di blocco navale, quantomeno come disposizione delle forze “in campo”. Oltre al presidio totale della regione sono stati infatti condotti attacchi simulati contro obiettivi chiave, sia civili sia militari, dell’isola. Uno scenario che ben si sposa con un blocco, che avrebbe il vantaggio di colpire due gravi vulnerabilità di Taipei: la dipendenza della sua economia dalle esportazioni e la totale dipendenza delle sue riserve energetiche dall’approvvigionamento esterno.
Nel frattempo, a Taiwan si parla soprattutto delle grandi proteste di fronte al parlamento, dove venerdì si sono radunate circa 100 mila persone che si oppongono alla riforma che mira ad ampliare il potere del ramo legislativo e aumentare lo scrutinio dell’operato del governo. Una riforma voluta dall’opposizione (che in parlamento ha però la maggioranza unita) e osteggiata dal partito di governo di Lai, che prova a ricompattare il consenso rievocando le grandi proteste del 2014 del Movimento dei Girasoli, girando la questione su “resistenza all’autocrazia”.
L’opposizione sostiene invece che in passato gli stessi che oggi protestano erano a favore della riforma. Martedì è prevista la ripresa delle discussioni allo yuan legislativo, dove si temono nuove tensioni e nuovi scontri (anche fisici) come nelle scorse settimane. Di certo non mancheranno le proteste, mentre Lai deve capire come evitare che le frammentazioni interne abbiano un impatto negativo sulla sua già complicata presidenza.
E intanto a Taipei è arrivata anche la delegazione di Michael McCaul, capo della Commissione Affari Esteri della Camera dei Rappresentanti Usa. Se la prima settimana di presidenza Lai è un indicatore, di fronte a Taiwan ci sono quattro anni piuttosto movimentati.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Ci siamo. Lai Ching-te ora non è solo il presidente eletto, ma il presidente in carica di Taiwan. O meglio, della Repubblica di Cina, il nome ufficiale con cui Taipei è indipendente de facto e retaggio della sconfitta dei nazionalisti di Chiang Kai-shek nella guerra civile contro i comunisti di Mao Zedong.
Vincitore delle presidenziali dello scorso 13 gennaio, Lai si insedia lunedì 20 maggio, poco più di quattro mesi dopo le urne. A lasciargli il posto è Tsai Ing-wen, che ha governato per otto turbolenti anni cominciati nel 2016. Lai è stato il suo vicepresidente per il secondo mandato, cominciato nel 2020.
Si tratta della prima volta che il passaggio di consegne avviene all’interno dello stesso partito, visto che dalle prime elezioni libere del 1996 c’era sempre stata un’alternanza al massimo dopo due mandati. Ma stavolta il Partito progressista democratico (DPP) è riuscito a vincere un voto presidenziale per la terza volta consecutiva.
Non è stato solo merito di Lai, visto che una buona parte del suo successo si deve alla divisione dell’opposizione in due diverse candidature tra Kuomintang (KMT, lo stesso partito che ha governato ininterrottamente fino al 2000 grazie anche alla legge marziale rimasta in vigore fino al 1987) e il Taiwan People’s Party dell’ex sindaco di Taipei, Ko Wen-je. Ma la vittoria di Lai non è stata una passeggiata, visto che il DPP ha perso circa cinque milioni di voti rispetto alle elezioni del 2020. E, soprattutto, ha perso la maggioranza parlamentare. Allo yuan legislativo, il parlamento unicamerale di Taiwan, ha infatti un seggio in meno del KMT.
Lai ha di fronte a sé una lunga lista di delicate sfide per il suo mandato di quattro anni. La prima e più complicata, ovviamente, è la gestione delle relazioni intrastretto con la Repubblica Popolare Cinese. Negli ultimi otto anni, i rapporti sono precipitati.
Dopo la vittoria di Tsai, qualsiasi dialogo politico tra governi è stato interrotto, mentre Pechino ha aumentato la pressione militare e diplomatica per ridurre lo spazio di manovra di Taipei. Il motivo originario è rappresentato da due posizioni inconciliabili. Il Partito comunista cinese (PCC) si dice pronto al dialogo solo col rispetto del “consenso del 1992”, un accordo raggiunto tra le due sponde che riconosce l’esistenza di una “unica Cina”.
L’interpretazione che PCC e KMT danno a quell’accordo è diversa: il primo ritiene che sia la de facto accettazione da parte di Taiwan di far parte del territorio della Cina, dunque della Repubblica Popolare che è quella riconosciuta da quasi la totalità dei governi nel mondo. Il secondo aggiunge invece una coda alla formula “unica Cina”, vale a dire “diverse interpretazioni”. Lasciando dunque aperta la possibilità di una coesistenza, seppure temporanea, di due diverse Cine. Un concetto che non lascia in ogni caso spazio a una indipendenza formale di Taiwan.
Il DPP non riconosce invece il “consenso del 1992” e si dice pronto al dialogo, qualora il PCC non ponga precondizioni e riconosca che Pechino e Taipei sono due entità separate e non interdipendenti l’una con l’altra. Posizioni inconciliabili, anche perché l’obiettivo originario del DPP era il raggiungimento di un’indipendenza formale come Repubblica di Taiwan.
Il primo presidente del partito, Chen Shui-bian (2000-2008) ha provato a istituire un referendum, senza riuscirci. E la sua capacità di cambiare la costituzione è stata quasi del tutto assente, visto che ha governato per due mandati con il suo partito in minoranza allo yuan legislativo, il parlamento unicamerale di Taipei.
Tsai ha invece spostato il DPP verso il centro. Secondo la prima presidente donna, a Taiwan non serve dichiarare l’indipendenza formale ma basta quella de facto, seppure entro la cornice della Repubblica di Cina. Un cambio di prospettiva che le ha consentito di impadronirsi in parte della retorica dello “status quo”, che quasi il 90% dei taiwanesi dice di preferire come soluzione ai rapporti con Pechino. Fino a qualche anno fa, solo il KMT era percepito come garante dello status quo, perché l’unico in grado di mantenere il dialogo con il PCC.
Lai pare dunque intenzionato a mantenere la stessa linea di Tsai, anche se per lui si tratta di un cambiamento. In passato si è infatti esposto a favore dell’indipendenza formale. La sua frase più citata in tal senso è datata 2017, quando si definì un “lavoratore pragmatico per l’indipendenza”. Pechino non se lo è certo scordato e non a caso etichetta Lai come un “pericoloso secessionista”.
Pur non avendo mai aperto il dialogo con Tsai in questi otto anni, il PCC ha lasciato intendere di comprendere che fra i due esistono delle differenze. È prevedibile che Lai, pur mantenendo la stessa sostanza della postura intrastretto di Tsai, possa cambiarne leggermente la forma. In particolare sul fronte comunicativo, dove è solito rilasciare dichiarazioni meno misurate. Anche durante la campagna elettorale si è lasciato sfuggire un paio di dichiarazioni al di fuori della prassi istituzionale.
Nel primo caso ha confessato che il suo desiderio è che in futuro il presidente di Taiwan possa entrare alla Casa Bianca, eventualità che implicherebbe un riconoscimento ufficiale di Taipei da parte di Washington. Nel secondo caso ha invece detto che gli piacerebbe poter andare a cena con Xi Jinping, offrendogli un bubble tea. Pechino e Washington non hanno apprezzato.
Un ruolo importante sarà quello occupato dalla vicepresidente, Hsiao Bi-khim, molto popolare tra l’opinione pubblica e considerata una sorta di “garante” visti gli strettissimi rapporti con Tsai e la sua esperienza come rappresentate di Taipei negli Stati Uniti, dove è molto apprezzata.
Per il resto, Lai ha praticamente confermato buona parte della squadra di Tsai nei ruoli chiave. L’ex ministro degli Esteri Joseph Wu è passato alla Sicurezza Nazionale. Una nomina che potrebbe far presagire qualche acceso scontro retorico con Pechino, visto che Wu si è contraddistinto negli ultimi anni per una linea molto assertiva e ostile al governo cinese anche sui social.
Uno dei problemi principali di Lai sarà un parlamento frammentato e in cui il DPP non ha la maggioranza. Di fatto, il presidente rischia di essere una “anatra zoppa” sin dal primo giorno. Un antipasto di quanto potrebbe accadere è arrivato venerdì 17 maggio, con una clamorosa rissa in aula dopo un litigio furibondo su una bozza di riforma del potere legislativo, appoggiata da KMT e TPP ma osteggiata dal partito di governo.
Un episodio che ha fatto nuovamente scatenare divisioni interne all’opinione pubblica taiwanese, che negli ultimi anni sembravano in larga parte sopite. Elemento che può chiaramente diventare positivo per la Repubblica Popolare, che ha mostrato di voler fare leva sul KMT per mettere in difficoltà il DPP e conquistare qualche punto politico sul dossier taiwanese. In tal senso va letto il recente incontro tra Xi Jinping e l’ex presidente taiwanese Ma Ying-jeou, ancora un nome rilevante all’interno del KMT, a cui il leader cinese ha fatto seguire delle concessioni sul turismo.
Lai ha di fronte a sé anche diversi problemi interni. Tra tutti, l’altissimo prezzo delle case sempre più fuori portata per i salari minimi. Risultato: sempre meno giovani sono in grado di acquistare un’abitazione e di costruirsi una famiglia, come testimonia il continuo e irreversibile calo demografico. Attenzione poi anche all’energia: il DPP è tradizionalmente contro il nucleare, ma la dipendenza quasi totale dalle importazioni sta alimentando le richieste dell’opposizione che vorrebbe inserire l’atomo nel mix energetico taiwanese.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Da mercoledì 15 maggio Wong sarà il nuovo Premier e prenderà il posto dell’ultimo leader della dinastia Lee. Riuscirà a navigare tra le acque turbolente della competizione internazionale per mantenere il ruolo di Singapore, tradizionale ponte tra Occidente e Asia orientale?
Trentuno, tredici e diciannove. Sono gli anni passati al potere dai suoi predecessori. Difficile però immaginare ora se Lawrence Wog riuscirà a essere così longevo come primo ministro di Singapore. La città-Stato si prepara al suo quarto passaggio di potere dal 1965, anno dell’indipendenza dalla Malesia.
Mercoledì 15 maggio, Wong prenderà il posto di Lee Hsien Loong, in carica dal 2004. E lo fa in un momento particolarmente delicato per Singapore, sempre più stretta nella competizione globale e regionale tra Stati Uniti e Cina. Wong era stato da tempo annunciato come successore di Lee, ultimo erede della dinastia del padre della patria Lee Kuan Yew, ma i tempi sono stati affrettati.
Inizialmente, il cambio della guardia doveva avvenire in autunno. Ma il 15 aprile è arrivato l’annuncio che la sostituzione sarebbe invece avvenuta solo trenta giorni più tardi. Alle otto di sera è prevista la cerimonia di giuramento presso il palazzo presidenziale. Dopo Goh Chok Tong, Wong diventerà così il secondo premier a non far parte della famiglia Lee.
Wong, che compirà 53 anni l’anno prossimo, ha origini umili e non ha frequentato scuole d’élite. Suo padre è nato in Cina ma si è trasferito a Singapore e sua madre era un’insegnante. La sua ascesa politica è stata rapida. È stato il principale segretario privato di Lee dal 2005 al 2008, è entrato in politica nel 2011 e da allora ha ricoperto diversi incarichi ministeriali. In particolare, ha guidato i ministeri dell’Istruzione e dello Sviluppo nazionale prima di diventare ministro delle Finanze nel 2021.
Dopo aver guidato con successo Singapore in risposta alla pandemia di Covid-19 nel ruolo di co-presidente della task force istituita in materia del governo, Wong è stato scelto dai suoi colleghi di gabinetto all’inizio del 2022 come leader della prossima generazione. Poco dopo, Lee lo ha nominato vice primo ministro. I diversi portafogli che Wong ha ricoperto gli hanno permesso di acquisire un’ampia esperienza politica.
Tuttavia, il suo periodo come vice primo ministro è stato breve, tanto che si prevede che per i prossimi anni la sua squadra includerà molti dei leader della sua generazione, la terza secondo i canoni del Partito d’Azione Popolare (PAP), al potere ininterrottamente dal 1965.
Wong dovrà affrontare diversi problemi. Dall’aprile 2022, momento in cui viene di fatto indicato come futuro successore di Lee, le spaccature nella società di Singapore si sono allargate con l’aumento del costo della vita e una maggiore disuguaglianza.
Il risentimento dei lavoratori stranieri, una parte consistente della forza lavoro della città, è aumentato. Questo sta portando i singaporiani a fare sempre meno figli o a lasciare la città-stato, mentre la percezione del paese come centro finanziario stabile sta venendo intaccata dall’incremento della corruzione e dal riciclaggio di denaro “sporco”. Il tutto mentre il PAP deve affrontare diverse pressioni per passare da una leadership illiberale a un governo più inclusivo.
Wong è sempre stato piuttosto schivo, ma per farsi conoscere dall’opinione pubblica ha postato un video su TikTok in cui suonava con la chitarra “Love Story”, una canzone di Taylor Swift. Scelta non casuale, visto che la cantante americana è stata a Singapore per diverse date del suo tour, che nel Sud-Est asiatico si è fermato solo nella città-Stato rilanciando il turismo e facendo arrabbiare i Paesi vicini che aspiravano a ospitare anche loro Swift.
Ma un’altra ombra, ingombrante, sul mandato di Wong è senz’altro la rivalità tra Stati Uniti e Cina, che si sta ripercuotendo sempre più sulla sicurezza della regione. Basti pensare alle tensioni tra Pechino e Filippine nel mar Cinese meridionale. Singapore appare uno tra i Paesi più preoccupati, anche perché la sua storica postura neutrale viene messa a dura prova.
In un’intervista rilasciata all’Economist a inizio maggio, Wong ha dichiarato che non è né pro-Cina né pro-America, ma “pro-Singapore”. Secondo Wong, l’ordine globale sta cambiando e la transizione sarà difficile perché, sebbene il momento unipolare dell’America sia terminato, questa rimane una potenza preminente in un mondo che avrà più di una grande potenza.
“La Cina vede certamente negli Stati Uniti il tentativo di contenerli, accerchiarli e sopprimerli, cercando di negare il posto che spetta alla Cina nel mondo”, ha dichiarato. “Sentono che c’è questo contenimento per mettere in ginocchio la Cina; c’è questa sensazione, e per ogni azione, ci sarà una reazione opposta”, ha aggiunto.
Singapore ha messo in atto delle sanzioni contro la Russia dopo l’invasione dell’Ucraina, ma Wong lascia intendere che in un ipotetico confronto con la Cina potrebbe comportarsi diversamente. “Taiwan è fondamentalmente molto diversa dall’Ucraina, anche se si è cercato di fare un parallelismo tra le due. L’Ucraina è un Paese sovrano e l’invasione russa è stata una grave violazione della Carta delle Nazioni Unite e una violazione della sovranità e dell’integrità territoriale”.
Ma la preoccupazione di Singapore è anche e soprattutto economico-finanziaria. Wong ha più volte affermato che mentre i militari sono molto attenti ai danni collaterali, alle ritorsioni e all’escalation nella guerra convenzionale, è meno semplice valutare le ricadute dell’uso di strumenti economici e finanziari a fini geopolitici. Riuscire a navigare tra le acque turbolente della competizione internazionale per mantenere il ruolo di tradizionale ponte tra Occidente e Asia orientale sarà tutt’altro che semplice.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Il viaggio di Xi Jinping in Europa inizia a Parigi, dove torna dopo 5 anni. Ai colloqui francesi parteciperà anche Ursula von der Leyen, invitata da Macron per affermare l’unità europea sui temi più spinosi, come quello del commercio.
Xi Jinping torna in Europa. Prima che, nel pomeriggio di domenica 5 maggio, il presidente cinese mettesse piede a Parigi, erano passati oltre cinque anni dall’ultima visita. Nel frattempo, è cambiato davvero tutto.
Giunto all’aeroporto di Orly della capitale francese, Xi è stato accolto dal primo ministro Gabriel Attal. Lunedì 6 maggio in programma l’incontro con il presidente Emmanuel Macron, utile a celebrare i 60 anni dell’avvio delle relazioni diplomatiche tra Francia e Repubblica Popolare Cinese. In mattinata, ai due leader si unirà anche Ursula von der Leyen.
Come già accaduto nell’aprile 2024, infatti, Macron ha chiesto alla presidente della Commissione europea di partecipare ai colloqui con Xi. Un modo per mostrare unità europea, ma secondo qualche maligno anche una strategia per lasciare a lei il dovere di affrontare i temi più scomodi. Basti ricordare la diversa accoglienza riservata ai due l’anno scorso per capire come Pechino percepisce o quantomeno descrive le due figure.
Sul tavolo dell’incontro trilaterale peseranno diverse questioni controverse. In primis il commercio. L’imminente chiusura dell’indagine dell’Unione Europea sui presunti sussidi di Stato alle aziende private potrebbe portare all’introduzione di nuovi dazi sulle importazioni di auto elettriche cinesi nel Vecchio Continente.
La Germania è più scettica, come dimostra il recente viaggio in Cina del cancelliere Olaf Scholz in compagnia dei manager delle grandi case automobilistiche tedesche. La Francia appare invece più convinta. Pechino, non a caso, ha risposto all’ipotesi delle tariffe sui suoi veicoli elettrici con dei dazi sull’import di brandy europeo, che per la quasi totalità dei casi proviene proprio da Parigi.
Non è tutto. L’Ue ha infatti messo nel mirino altri comparti dell’industria tecnologica verde cinese, dalle batterie ai pannelli solari. Non mancano le frizioni anche sulle attrezzature mediche e sui dispositivi di sicurezza della Nuctech. Motivo di contesa anche le critiche europee sull’eccesso di produzione cinese, col timore dell’immissione di prodotti in grado di distorcere i prezzi globali. Dall’altra parte, Pechino contesta la “politicizzazione” dei rapporti commerciali e la strategia di “riduzione del rischio” che considera una sorta di “disaccoppiamento mascherato”.
Dal pomeriggio in poi, il clima dovrebbe però distendersi. Dopo un cerimonia ufficiale di benvenuto agli Invalides, spazio all’incontro bilaterale tra Xi e Macron. Si discuterà sulla base del documento congiunto firmato lo scorso anno durante la visita del presidente francese, che per Pechino simboleggia un modello di “coesistenza pacifica e cooperazione win-win” tra Paesi con sistemi diversi. Insomma, quello che persegue con tutti i Paesi occidentali.
In seguito, ci sarà la cena di Stato all’Eliseo. Martedì poi Macron accompagnerà Xi in una tappa dalle forte tinte “personali”, sul Tourmalet nella regione dei Pirenei. Proprio qui il presidente francese ha trascorso diverso tempo durante la sua infanzia. È in questa sede che Macron cercherà un dialogo più diretto e intimo con Xi, anche sulla guerra in Ucraina. Era successa la stessa cosa a parti invertite lo scorso anno, quindi Xi aveva inusualmente abbandonato Pechino per accompagnare Macron a Guangzhou.
Il presidente francese mira all’aiuto cinese per ottenere una tregua durante le Olimpiadi della prossima estate, che si svolgeranno proprio a Parigi. “Sarebbe un messaggio forte per il mondo intero”, ha detto Macron in un’intervista al quotidiano francese La Tribune. Xi ribadirà la sua disponibilità a sostenere un percorso di pace, che per Pechino però passa attraverso il dialogo con Vladimir Putin e il rispetto delle “legittime preoccupazioni di sicurezza” della Russia.
Comunque vada, Xi ha preparato altre due tappe dove le eventuali critiche lasceranno il posto agli elogi. Basti guardare a come si sta preparando al suo arrivo il presidente serbo Aleksandar Vucic, che ha spiegato nei giorni scorsi come il presidente cinese andrebbe ascoltato di più dall’Occidente perché in grado “di fermare alcune guerre e stabilire una pace duratura”.
In Serbia, Xi arriverà nei giorni del 25esimo anniversario del bombardamento della Nato sull’ambasciata cinese di Belgrado. Fu un errore, ma dalla capitale serba il presidente cinese potrebbe più o meno esplicitamente rivolgere delle critiche alla Nato. Un modo per individuare i presunti colpevoli della “benzina sul fuoco” dei conflitti internazionali.
In Ungheria, invece, Xi potrà incontrare un altro leader non allineato come Viktor Orban. Insieme a lui parlerà della linea ferroviaria Belgrado-Budapest, uno dei progetti europei di punta della Belt and Road Initiative. Ma dovrebbe anche inaugurare una fabbrica di Great Wall Motors, una delle case cinesi di auto elettriche.
Non molto tempo dopo il rientro a Pechino, Xi riceverà poi per la terza volta in poco più di due anni il presidente russo Vladimir Putin. A conferma di una partnership che non è sin qui in discussione.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Al di là dell’esito degli incontri, la Cina punta a rafforzare la propria immagine di garante di stabilità e potenza responsabile in grado di dialogare con tutti. E sul Medio Oriente le sta riuscendo meglio che sulla guerra in Ucraina.
La Cina entra con decisione sulla crisi del Medio Oriente. E in particolare sulla questione palestinese. Le delegazioni del gruppo islamista Hamas e del movimento politico Fatah si trovano infatti a Pechino, per una serie di colloqui mirati alla creazione di un governo di unità nazionale. Hamas è responsabile degli attacchi dello scorso 7 ottobre contro Israele, mentre Fatah controlla politicamente la Cisgiordania ed esprime il presidente dell’Autorità Palestinese riconosciuta dall’Occidente, vale a dire Mahmoud Abbas. Le due fazioni palestinesi rivali non sono riuscite a sanare le loro dispute politiche da quando i combattenti di Hamas hanno espulso Fatah da Gaza nel 2007.
Da alcuni giorni, i media libanesi e arabi avevano anticipato il viaggio cinese delle delegazioni delle due fazioni. Venerdì è arrivata la sostanziale conferma, seppure implicita, di Pechino. “La Cina ha sempre sostenuto il rafforzamento dell’Autorità palestinese e appoggia la riconciliazione interna delle fazioni palestinesi”, ha dichiarato in conferenza stampa Wang Wenbin, portavoce del ministero degli Esteri cinese.
Le due delegazioni, guidate da alti funzionari, sono arrivate nella capitale cinese tra venerdì sera e sabato mattina. E gli incontri sarebbero già iniziati. Quella di Fatah è guidata dall’alto funzionario Azzam Al-Ahmed. Quella di Hamas invece dal vice capo dell’ufficio politico, Moussa Abu Marzouk. È la prima volta che una delegazione di Hamas si reca pubblicamente in Cina dall’inizio della guerra a Gaza.
Proprio venerdì, al termine del suo viaggio in Cina, il segretario di stato americano Antony Blinken aveva riconosciuto il possibile ruolo di Pechino nel ridurre le tensioni in Medio Oriente. Ma gli Stati Uniti diffidano dei tentativi di riconciliazione tra le fazioni palestinesi, visto che ritengono Hamas un gruppo terroristico. La Cina ha invece sempre tenuto aperto un canale di dialogo. E a marzo, l’inviato Wang Kejian ha incontrato i vertici politici di Hamas in Qatar, trovando l’accordo per ospitare i colloqui.
Negli ultimi anni, d’altronde, la Cina ha nettamente aumentato la sua influenza diplomatica e commerciale in Medio Oriente. Nel dicembre 2022, Xi Jinping ha effettuato il suo secondo viaggio all’estero dopo la pandemia di Covid-19 in Arabia Saudita. In quella sede ha firmato 34 accordi bilaterali per un valore di circa 30 miliardi di dollari, ma soprattutto Xi ha partecipato anche a un incontro multilaterale coi Paesi del Consiglio del Golfo.
Nel 2023, Xi ha ricevuto il presidente iraniano Ebrahim Raisi, mentre proprio a Pechino si sono svolti i colloqui decisivi sfociati in un accordo tra Arabia Saudita e Iran per il riavvio delle relazioni diplomatiche tra i due rivali regionali.
Sempre lo scorso anno, a Pechino è stato in visita anche Abbas. Dopo gli attacchi di Hamas del 7 ottobre, la Cina ha subito ribadito la sua storica posizione a favore della soluzione dei due Stati e nelle settimane successive ha detto di sostenere l’unità e il coordinamento dei Paesi musulmani sulla questione palestinese. Nei mesi scorsi è stata ricevuta una delegazione di ministri degli Esteri di Paesi a maggioranza musulmana: Arabia Saudita, Egitto, Giordania, Indonesia e Autorità Nazionale Palestinese. In quell’occasione, il ministro degli Esteri Wang Yi ha dichiarato: “Siamo un buon amico e un fratello dei paesi arabi e islamici”.
A febbraio, Pechino ha sollecitato la Corte internazionale di giustizia a pronunciarsi sull’occupazione israeliana dei territori palestinesi. Nelle scorse settimane, ha fatto invece pressioni per l’attuazione della soluzione dei due Stati e per l’ingresso della Palestina nelle Nazioni Unite. Tutte azioni che potrebbero portare dei vantaggi sulla posizione cinese in Medio Oriente, ma anche sui suoi rapporti con altri Paesi a maggioranza musulmana. A partire da quelli più vicini, vale a dire nel Sud-Est asiatico, con Malesia e Indonesia.
In questo contesto si inserisce la nuova iniziativa sui colloqui tra Hamas e Fatah. Al di là dell’esito degli incontri, la Cina punta a rafforzare l’immagine che prova a dare di sé di garante di stabilità e potenza responsabile in grado di dialogare con tutti. E sul Medio Oriente le sta riuscendo meglio che sulla guerra in Ucraina.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Antony Blinken torna in Cina meno di un anno dopo la visita di giugno. Tanti i dossier divisivi tra cui lo stop Usa a TikTok e gli aiuti a Taiwan. Ma resta importante che continuino a dialogare per gestire in modo responsabile un rapporto cruciale per gli equilibri globali
Non sono più i tempi del presunto pallone spia che fece saltare la visita di Antony Blinken nel febbraio 2023. Ma non sono nemmeno quelli delle palline da ping pong che lanciarono le diplomazie tra i due Paesi durante la guerra fredda. Stati Uniti e Cina continuano a parlarsi, anche senza andare d’accordo. È già qualcosa, certo. Ma sui dossier più spinosi delle relazioni bilaterali più importanti del pianeta non sono previste svolte, nemmeno in occasione della nuova visita di Blinken in Cina. Il segretario di Stato americano sarà a Shanghai e Pechino tra il 24 e il 26 aprile, dieci mesi dopo la visita dello scorso giugno.
Il tempismo è molto delicato. Sia per le vicende internazionali, dalla guerra in Ucraina alle tensioni sempre maggiori in Medio Oriente, sia per quelle bilaterali, con le manovre contrapposte sul mar Cinese meridionale e sullo Stretto di Taiwan, per non parlare del fronte commerciale e tecnologico. Alla vigilia della partenza di Blinken, la Camera dei Rappresentanti degli Usa ha peraltro approvato un pacchetto di aiuti esteri che oltre a Ucraina e Israele include anche Taiwan, a cui saranno destinati otto miliardi di dollari. Non solo. Nello stesso pacchetto è stata inserita la norma anti TikTok, che impone alla casa madre cinese ByteDance di vendere la sua creatura internazionale entro nove mesi per evitarne la messa al bando su territorio americano. Come se non bastasse, l’amministrazione Biden ha reso chiaro che oltre a triplicare i dazi sull’acciaio cinesi, è pronta a inserire tariffe sui pannelli solari di Pechino nell’ambito della battaglia sull’industria tecnologica verde che pare destinata a includere presto anche le auto elettriche.
Da parte americana, si lascia trapelare che in cima all’agenda di Blinken ci saranno i rapporti tra Cina e Russia. Blinken intende “ribadire le nostre profonde preoccupazioni riguardo al sostegno della Repubblica Popolare Cinese alla base industriale della difesa russa”, nonché alle sue violazioni dei diritti umani e alle “pratiche economiche e commerciali sleali”, ha dichiarato un battagliero ma anonimo funzionario del Dipartimento di Stato ai media statunitensi in preparazione del viaggio.
Nelle ultime settimane la retorica di Blinken e in generale dell’amministrazione Biden si è fatta più esplicita in materia del presunto sostegno cinese alla Russia. Ne ha parlato anche la segretaria al Tesoro Janet Yellen durante il suo recente viaggio in Cina, avvenuto peraltro quasi in contemporanea con quello del ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov. E lo stesso Joe Biden si è detto preoccupato a riguardo nella telefonata di qualche settimana fa con Xi Jinping.
Nel mirino ci sono soprattutto le esportazioni di dispositivi dual use che potrebbero avere un’applicazione militare. La scorsa settimana, alti funzionari statunitensi hanno reso noto un elenco di tecnologie che la Cina avrebbe inviato alla Russia. Nel 2023, hanno dichiarato che il 90% dei chip importati dalla Russia proveniva dalla Cina ed era utilizzato per produrre missili, carri armati e aerei. Il 70% delle importazioni di macchine utensili russe nell’ultimo trimestre dello scorso anno proveniva dalla Cina ed era “probabilmente utilizzato” per produrre missili balistici.
Pechino ha sempre negato e sostiene che esagerare il rischio di utilizzo militare dell’export di prodotti civili rientra in una strategia di “diffamazione” della Cina, che si professa invece neutrale e l’unica in grado di mantenere il dialogo con tutte le parti in causa. Su queste basi, è molto difficile che si ottengano risultati in materia. Blinken potrebbe provare a convincere Pechino a partecipare alla conferenza sulla pace in programma a giugno in Svizzera, ma la Cina ha fatto capire che la sua presenza è legata a quella della Russia, che pare pressoché impossibile.
Si parlerà anche di Medio Oriente. Anche qui le posizioni sono distanti. La Cina critica il sostegno degli Usa a Israele, in particolare per i nuovi aiuti militari. La retorica è la stessa utilizzata sull’Ucraina. In sostanza, Washington starebbe gettando “benzina sul fuoco” dei conflitti, invece che contribuire ad allentare la tensione e favorire la pace.
Attenzione poi ai dossier più attigui ai rapporti bilaterali. La visita di Blinken in Cina è prevista poche settimane prima dell’insediamento del presidente eletto di Taiwan Lai Ching-te, che Pechino considera un “secessionista”. Per l’inaugurazione, prevista per il 20 maggio, gli Stati Uniti invieranno una delegazione non ufficiale che comprende l’ex vicesegretario di Stato Richard Armitage e Laura Rosenberger, che presiede l’American Institute in Taiwan. L’approvazione dei nuovi aiuti aggiunge tensioni su un dossier sul quale è impossibile trovare un accordo.
Blinken e il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ribadiranno le rispettive linee rosse, ma il massimo che si può sperare è una stabilizzazione del disaccordo e una ripartenza piena del dialogo anche sul fronte militare, che pare essere avvenuta con la telefonata dei giorni scorsi tra il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin e il ministro della Difesa cinese Dong Jun.
Non meno importante, e certamente non meno tesa, la situazione sul mar Cinese meridionale. In particolare intorno alle isole contese tra Cina e Filippine, dove da mesi si verificano incidenti tra le navi di Pechino e Manila. Di recente, Pechino ha osservato con fastidio il summit trilaterale alla Casa Bianca tra Biden, il premier giapponese Fumio Kishida e il presidente filippino Ferdinand Marcos Junior, con una serie di misure per rafforzare i rapporti di sicurezza.
Blinken chiarirà i confini oltre i quali Washington sarebbe forzata a intervenire per il trattato di mutua difesa che la lega a Manila, mentre i funzionari cinesi chiederanno di non interferire su una vicenda che ritengono essere di interesse esclusivo dei Paesi asiatici.
Blinken parlerà anche di fentanil, la principale causa di morte degli americani tra i 18 e i 49 anni. Secondo la U.S. Drug Enforcement Administration, la Cina rimane la principale fonte di sostanze legate al fentanil trafficate attraverso le operazioni internazionali di spedizione per posta e per espresso. Blinken chiederà maggiore sostegno nella lotta al traffico della sostanza.
Anche se le due potenze non si troveranno improvvisamente d’accordo su una lunga serie di tematiche, resta importante che continuino a dialogare per gestire in modo responsabile un rapporto cruciale per gli equilibri globali.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Il risultato era atteso ma la sua proporzione è andata al di là delle previsioni. Le conseguenze politiche sono state immediate. Yoon, in carica fino al 2027, sarà un’anatra zoppa, con riflessi anche sulla politica estera, tema su cui i due principali partiti sono agli antipodi.
Avrebbe dovuto mettere a punto una risposta dopo la pesante sconfitta incassata alle elezioni legislative di mercoledì 10 aprile. Invece ha trascorso la domenica in una riunione d’emergenza per la sicurezza, organizzata di fretta dopo l’attacco dell’Iran contro Israele. Yoon Suk-yeol è in difficoltà.
Il presidente della Corea del Sud ha assistito inerte alla batosta subita dal suo Partito del Potere Popolare: solo 108 seggi su 300 dell’Assemblea Nazionale, conquistati peraltro in tandem con il partito satellite. I restanti 192 sono tutti finiti all’opposizione. Ben 176 solo al Partito democratico, la principale forza d’opposizione guidata dal grande rivale Lee Jae-myung, sconfitto al fotofinish da Yoon alle presidenziali del 2022.
Il risultato era atteso, almeno secondo i sondaggi della vigilia, ma la sua proporzione è andata al di là delle previsioni. Le conseguenze politiche sono state immediate. Il leader del partito conservatore al governo, Han Dong-hoo, si è dimesso. Non è bastato il suo appello all’ultimo comizio, secondo cui una vittoria dell’opposizione avrebbe potuto rendere la Corea del Sud un “Paese filocinese”. Hanno rimesso il proprio incarico anche il primo ministro Han Duck-soo, il capo di gabinetto Lee Kwan-sup e tutti gli alti segretari presidenziali. Resta da vedere se Yoon accetterà tutte le dimissioni, rischiando un pericoloso vuoto gestionale. Ma di certo il presidente è azzoppato fino al 2027, per i suoi restanti tre anni di mandato.
L’agenda interna dell’amministrazione Yoon pare destinata a restare bloccata. Una delle idee che Yoon aveva promesso di perseguire, cioè l’unione amministrativa della città di Gimpo (nella provincia di Gyeonggi), con la capitale Seul, sarà, salvo sorprese, archiviata. Il cosiddetto progetto “Megacity Seoul” ha infatti bisogno di un sostegno che l’opposizione non è intenzionata a concedere.
Anche diverse altre iniziative governative sono destinate a incontrare ostacoli, tra cui un piano che prevede un allentamento dei regolamenti immobiliari per favorire la riqualificazione degli appartamenti più vecchi in tutto il Paese. L’opposizione si è opposta ai piani immobiliari dell’amministrazione Yoon, definendoli iniziative che “avvantaggiano solo i ricchi”. Una retorica, questa, molto presente nei discorsi di Lee, che non a caso non disdegna il soprannome di “Bernie Sanders sudcoreano”.
Anche il tentativo di Yoon di evitare l’implementazione del sistema di tassazione dei redditi finanziari, previsto per il 1° gennaio del prossimo anno, potrebbe andare a vuoto. Il sistema mira a imporre una tassa del 20% agli investitori che hanno guadagnato plusvalenze superiori a 50 milioni di won (38.000 dollari) da investimenti azionari, mentre coloro che hanno guadagnato più di 300 milioni di won saranno soggetti a una tassa del 25%. L’opposizione ha chiesto l’attuazione programmata della tassazione, che è già stata ritardata di due anni, sostenendo che un eventuale scarto potrebbe comportare una perdita di 1.500 miliardi di won all’anno in termini di tasse.
Nel frattempo, è probabile che il blocco dell’opposizione lavori per l’approvazione di un disegno di legge speciale per un’indagine sui sospetti che il governo e la polizia abbiano esercitato un’influenza nel ritardare le indagini sulla morte di un giovane marine, travolto il 19 luglio dell’anno scorso mentre si trovava in una missione di soccorso durante un’alluvione.
Previsto anche un aumento delle pressioni per fare luce sullo scandalo che ha visto protagonista Kim Keon-hee, la moglie di Yoon, che avrebbe accettato in regalo una borsa Dior da un pastore protestante divenuto una sorta di confidente. La stessa Kim non ha accompagnato il marito al seggio nel giorno del voto, attirando nuove polemiche.
L’opposizione continuerà poi a chiedere l’istituzione di una commissione speciale d’inchiesta sulla strage di Itaewon del 29 ottobre 2022. Durante i festeggiamenti per Halloween, 156 persone morirono nella calca del noto quartiere notturno di Seul. In molti hanno additato la quasi totale assenza di misure di sicurezza, con il quasi contemporaneo dispiegamento di polizia nei pressi dell’ufficio presidenziale per una piccola protesta. Ufficio presidenziale che lo stesso Yoon ha voluto spostare dalla più lontana Casa Blu all’edificio del ministero della Difesa, non lontano proprio dal luogo della tragedia.
I contorni della vicenda non sono ancora stati chiariti, di certo nessun componente del governo ha pagato le conseguenze o si è preso la responsabilità. E Yoon ha più volte opposto il veto presidenziale contro le richieste di istituire una commissione d’indagine.
La buona notizia per il presidente è che l’opposizione non ha raggiunto la maggioranza dei due terzi dei seggi, necessaria per avviare la procedura di impeachment. Ma di fatto Yoon sarà un’anatra zoppa. Un aspetto che potrebbe avere qualche riflesso anche sulla politica estera, tema su cui i due principali partiti sono agli antipodi.
Da quando è presidente, Yoon ha rafforzato drasticamente l’alleanza militare con gli Stati Uniti, operato il disgelo col Giappone e adottato una linea dura sulla Corea del Nord, rispondendo “colpo su colpo” alle “provocazioni” di Pyongyang.
L’opposizione ha invece una linea più equidistante tra Usa e Cina, persegue il dialogo con Pyongyang e ritiene una “umiliazione nazionale” il riavvicinamento con Tokyo, giunto a costo di rinunciare alla richiesta di risarcimenti per gli abusi del periodo della dominazione coloniale giapponese.
Proprio a causa della batosta interna, Yoon potrebbe anche provare a proiettarsi con maggiore decisione sul fronte internazionale. Ma i problemi in casa potrebbero offuscare le sue manovre all’estero. A Washington, Tokyo, Pechino e Pyongyang hanno preso senz’altro nota.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Si vota il 10 aprile per le legislative. La campagna elettorale è stata piena di scandali. Il costo della vita e l’inflazione sono temi chiave tra gli elettori, oltre alla crisi delle nascite. La Corea del Sud è il Paese col più basso tasso di fertilità al mondo, e le più alte spese per crescere un figlio.
La lunga stagione dei veleni prosegue alle urne. In una Corea del Sud sempre più polarizzata, mercoledì 10 aprile si svolgono le elezioni legislative. Verranno rinnovati tutti e 300 i seggi dell’Assemblea nazionale, il parlamento unicamerale di Seul. Nonostante il voto abbia connotati soprattutto di politica interna, quantomeno nella mente degli elettori, l’esito della tornata elettorale potrebbe avere qualche riflesso sul fronte internazionale.
Alle precedenti legislative, svoltesi nell’aprile del 2020, il Partito Democratico dell’allora presidente Moon Jae-in conquistò una maggioranza storica con 163 seggi più 17 del partito satellite. Da allora è cambiato tutto.
Il dialogo con la Corea del Nord è definitivamente naufragato, soprattutto dopo che la guerra in Ucraina ha avvicinato ulteriormente Pyongyang a Mosca. Ma anche i rapporti con la Cina si sono fatti più tesi, per timore di un crescente allineamento sinorusso. Soprattutto, alla guida della Corea del Sud c’è ora il conservatore Yoon Suk-yeol, che ha vinto in modo risicato le presidenziali della primavera del 2022: il suo rivale Lee Jae-myung, soprannominato il “Bernie Sanders sudcoreano”, è stato sconfitto solamente dello 0,73%. Praticamente nulla. Yoon ha dato una netta svolta alla diplomazia di Seul: linea dura su Pyongyang, disgelo con il Giappone, netto rafforzamento dell’alleanza con gli Stati Uniti e grandi passi di avvicinamento alla Nato.
Ma la vittoria così risicata del 2022 ha, se possibile, ulteriormente polarizzato la scena politica. Lo stesso Lee guida oggi il Partito democratico alle legislative, tre mesi dopo aver subito un accoltellamento dal quale si è fortunatamente salvato. A settembre scorso, Lee era stato a lungo in ospedale a causa di uno sciopero della fame avviato per protestare contro la linea (definita “antidemocratica”) dell’amministrazione. Il parlamento si è opposto all’ultimo momento a un mandato di arresto per corruzione contro di lui, che l’opposizione riteneva motivato politicamente.
Negli scorsi mesi l’opposizione è più volte scesa in piazza contro le politiche economico-sociali del governo. Ma anche contro la traiettoria diplomatica intrapresa da Seul, che ha abbandonato il già complicato dialogo con la Corea del Nord rafforzando l’alleanza militare con Washington e operando un contestato disgelo col Giappone su pressing della Casa bianca. Il tutto persino a patto di rinunciare alla pretesa dei risarcimenti per gli abusi della dominazione coloniale: per tanti sudcoreani una “umiliazione”.
La campagna elettorale è stata piena di scandali. L’ambasciatore in Australia si è dimesso il mese scorso in seguito alle polemiche sulla sua nomina mentre era sotto inchiesta per corruzione, mentre ad attirare l’attenzione dell’opinione pubblica è stato soprattutto il caso delle borsa Dior che ha coinvolto nientemeno che la first lady.
Kim Keon-hee ha stretto un rapporto con il pastore coreano-americano Choi Jae-young, che ha più volte visitato la Corea del Nord e si è proposto come una sorta di “consigliere” sui rapporti con Pyongyang. Ma in un incontro del 2022, Choi sostiene di aver sentito Kim impegnata in una conversazione telefonica che riguardava questioni di Stato delicate. Allarmato dalla natura della presunta discussione, decide di registrare segretamente il loro successivo incontro, utilizzando una telecamera spia nascosta in un orologio da polso. Durante il secondo incontro con Kim, Choi le avrebbe regalato una borsa Dior del valore di 3 milioni di won (2240 dollari), ma su imboccamento del sito di notizie di sinistra Voice of Seoul. Un trappolone, secondo Yoon, che invece ricorda spesso l’inchiesta che vede coinvolto Lee, costretto ad apparire a delle udienze anche durante la campagna.
Il costo della vita e l’alta inflazione sono emersi come temi chiave tra gli elettori. In particolare, si è parlato molto del prezzo delle cipolle verdi, alimento importante per i sudcoreani, dopo che Yoon è stato contestato durante una visita a un mercato.
Un altro problema è la questione dei medici di formazione, in sciopero da diverse settimane insieme ai professori di medicina. All’inizio, la linea ferma mantenuta da Yoon sulla sua riforma di accesso alla professione aveva portato dei frutti nei sondaggi, ma ora gli ultimi rilevamenti mostrano un crescente sostegno pubblico per un compromesso tra i medici e il governo, che prevede di aumentare le ammissioni alle scuole di medicina di duemila unità a partire dal 2025.
Entrambi i partiti principali hanno messo in cima alla loro agenda elettorale la crisi delle nascite. La Corea del Sud è allo stesso tempo il Paese col più basso tasso di fertilità al mondo, ma anche le più alte spese per crescere un figlio. Sia conservatori sia democratici promettono misure quali alloggi pubblici e agevolazioni fiscali.
Nei sondaggi, l’opposizione democratica appare in vantaggio, ma non di molto. La vittoria netta del 2020 appare difficile da ripetere. Anzi, i conservatori sperano nel sorpasso. Attenzione all’inedito ruolo che potrebbero giocare i partiti minori. La politica sudcoreana è quasi sempre stata dominata dai due partiti principali, ma ora c’è almeno un terzo incomodo serio.
Si tratta del Partito della Ricostruzione, lanciato solo pochi mesi fa dall’ex ministro della Giustizia Cho Kuk, anche lui peraltro indagato per frode. Se davvero dovesse arrivare a sfiorare il 20% come suggeriscono alcuni sondaggi, potrebbe togliere voti fondamentali all’opposizione democratica.
L’esito del voto dirà se Yoon avrà pieno mandato per portare avanti le sue politiche nella seconda parte del suo mandato, aprendo anche a riforme precedentemente impensabili, oppure se sarà azzoppato fino al 2027. Washington, Pechino e Tokyo osservano con grande interesse. E, ovviamente, anche Pyongyang.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
A meno di un mese dalle elezioni, arrestato Arvind Kejriwal, leader di uno dei partiti di opposizione e capo del governo locale a Nuova Delhi. Kejriwal è il candidato alla guida di una coalizione di 27 partiti che si sono uniti per combattere Modi.
A meno di un mese dalle elezioni generali al via il 19 aprile, in India cade un altro leader dell’opposizione. E la strada per Narendra Modi si fa sempre più spianata verso il suo terzo mandato da premier.
L’oppositore in questione è Arvind Kejriwal, capo del governo locale di Delhi, che è stato arrestato con l’accusa di corruzione. Si tratta del più alto funzionario eletto nella capitale indiana ed è la prima volta che una figura della sua portata finisce in manette mentre è ancora in carica.
Kejriwal è accusato di essere coinvolto in un’indagine su una presunta truffa che riguardava tangenti da circa 12 milioni di dollari per la concessione di licenze di alcolici. Il tribunale ha stabilito una custodia cautelare di sei giorni. Dopo di che, il 28 marzo, sarà riportato davanti al giudice per riesaminare il caso.
Si tratta di un bruttissimo colpo per lui, visto che nel 2015 ha vinto le elezioni locali a Delhi proprio con una forte retorica anti corruzione. La vicenda rischia di avere un impatto sulle elezioni, visto che Kejriwal è il candidato alla guida del suo partito Aam Aadmi (AAP), movimento che fa parte di una coalizione di 27 partiti che si sono uniti per combattere Modi e il suo Bharatiya Janata Party (BJP) .
La dirigenza dell’AAP non ha perso tempo nel sostenere che l’arresto è motivato politicamente e che l’inchiesta sia una “cospirazione per impedire a Kejriwal di partecipare alle elezioni”. L’agenzia che ha trattenuto Kejriwal è sotto il controllo del governo centrale. Secondo i critici del governo, è una delle numerose agenzie che sono state utilizzate contro l’opposizione politica del BJP. Ma secondo l’accusa sarebbe proprio lui il “perno” della cosiddetta truffa dei liquori.
I leader dell’AAP hanno giurato che Kejriwal rimarrà come capo ministro e continuerà a governare anche dal carcere. E intanto sono esplose le proteste. Nel fine settimana si sono succedute le manifestazioni nelle strade della capitale per chiedere il rilascio. La folla ha intonato diversi slogan tra cui “Kejriwal è la rovina di Modi” e “La dittatura non sarà tollerata”.
I manifestanti hanno accusato Modi di governare il Paese in stato di emergenza e di utilizzare le forze dell’ordine federali per soffocare i partiti di opposizione prima delle elezioni. Diversi tra i presenti alle proteste, compresi alcuni politici, si sono anche scontrati con la polizia. “L’arresto di Kejriwal è un omicidio della democrazia”, ha dichiarato Balbir Singh, ministro della Sanità del Punjab, all’Associated Press. “Per i leader dell’opposizione, il carcere è la regola e la cauzione è l’eccezione”, ha aggiunto. Singh ha anche accusato il partito di Modi di “aver stravolto lo stato di diritto”.
Il BJP nega di aver preso di mira l’opposizione e afferma che le forze dell’ordine agiscono in modo indipendente. Ma intanto l’arresto di Kejriwal è avvenuto nello stesso giorno in cui il Partito del Congresso, anch’esso parte della coalizione anti Modi, ha affermato che il BJP ha congelato i suoi conti in un caso fiscale “inventato” di oltre due decenni fa, impedendogli di fare campagna elettorale. Circa 20 milioni di dollari (16 milioni di sterline) appartenenti al Congresso sono stati congelati dal dipartimento delle imposte sul reddito, ha dichiarato il partito. La leader del Congresso, Sonia Gandhi, ha descritto questo come uno “sforzo sistematico per paralizzare il partito dal punto di vista finanziario”.
Rahul Gandhi ha affermato che “un dittatore spaventato vuole creare una democrazia morta”. Lo stesso Gandhi è stato espulso dal Parlamento l’anno scorso, a causa di una condanna per diffamazione derivante da un suo discorso molto critico nei confronti di Modi risalente ad anni prima. Di fatto, l’espulsione ha pregiudicato le possibilità elettorali di Gandhi, che in quel momento era da poco reduce da una vasta marcia per il Paese nel tentativo di rilanciare l’opposizione.
Modi, nel frattempo, prosegue la sua campagna elettorale fin qui ricca anche di elementi ultranazionalisti. Basti pensare a quanto accaduto lo scorso 22 gennaio, quando Modi ha inaugurato il tempio indù di Ayodhya, costruito sul terreno dove si trovava una moschea di epoca Moghul poi demolita nel 1992 da una folla mobilitata da organizzazioni ultraindù.
Nelle ultime settimane, il premier è stato in vari territori lungo il confine con la Cina e col Pakistan, fomentando il sentimento nazionalista. Modi è stato anche in Kashmir: era il suo primo viaggio nell’area dopo che nel 2019 il suo governo ne aveva improvvisamente revocato l’autonomia, scorporandone il territorio in due parti.
Tutto lascia pensare che Modi otterrà il suo terzo mandato. Certo, con la caduta dei suoi rivali gli ostacoli rischiano di diventare ancora inferiori a quanto si potesse pensare.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Il Segretario di Stato americano prova a dare qualche segnale di rassicurazione ai partner e alleati in Asia orientale. Oggi al summit in Corea del Sud e domani dal Presidente Marcos nelle Filippine per rafforzare l’asse con Manila.
Ancora una volta, Antony Blinken va in Asia orientale. È successo tante volte, dopo il 24 febbraio 2022 e l’invasione su larga scala dell’Ucraina. La necessità è sempre la medesima: comunicare ad alleati e partner della regione che gli Stati Uniti continuano a dare grande rilevanza, se non priorità, a quel quadrante.
Per Washington è necessario fugare i dubbi sul nascere, soprattutto dopo che oltre al fronte ucraino si è aperto quello del Medio Oriente dopo gli attacchi di Hamas del 7 ottobre e la durissima azione militare di Israele contro Gaza.
In un momento nel quale le tensioni con la Cina sono tutt’altro che risolte, sia per alcuni degli attori regionali sia per gli stessi Usa, e in cui la Corea del Nord continua a rafforzare e “istituzionalizzare” la sua alleanza con la Russia, il segretario di Stato americano prova dunque a dare qualche segnale di rassicurazione.
Lunedì 18 marzo, Blinken si trova in Corea del Sud, per partecipare al summit per la democrazia di Seul. Non si tratta di un summit qualsiasi, ma della terza edizione della piattaforma lanciata da Joe Biden nel 2021 durante il suo primo anno alla Casa Bianca. Dopo le prime due edizioni in “casa”, la Corea del Sud è il primo Paese straniero a ospitare il summit voluto dal presidente statunitense.
Il tema prescelto è “Democrazia per le generazioni future” e si svolge in un anno in cui oltre 60 Paesi si sono recati o si recheranno alle urne, da ultimo la Russia lo scorso fine settimana.
A Seul sono riuniti circa 300 delegati, tra cui funzionari governativi, rappresentanti di organizzazioni internazionali, del mondo accademico e della società civile. Il primo giorno di incontri è guidato dalla politica, il secondo proprio dalla società civile.
L’apertura del summit è affidata a Yoon Suk-yeol, il presidente sudcoreano alle prese con la campagna elettorale delle legislative di aprile. Insieme a Yoon parlano anche la premier danese Mette Frederiksen e il presidente kenyota William Ruto.
Nella prima sessione si parla principalmente di società inclusive e di empowerment dei giovani, nella seconda di tecnologia, elezioni e fake news. La terza e ultima sessione esplora i temi del Sud globale e dei partenariati di governance. Prevista anche una conferenza ministeriale e una tavola rotonda sul tema dell’intelligenza artificiale.
È proprio nella sede della conferenza ministeriale che Blinken incontra il ministro degli Esteri sudcoreano Cho Tae-yul, con cui ha in programma un bilaterale a margine dei lavori. I due discutono di come rafforzare l’alleanza, mentre Washington e Seul esplorano come migliorare la cosiddetta “deterrenza estesa” contro la Corea del Nord. Previsto anche un incontro con lo stesso Yoon.
Gli argomenti sul tavolo sono tantissimi, dopo che la scorsa settimana sono state concluse le esercitazioni militari congiunte più importanti ed estese da diversi anni a questa parte. Blinken e Cho, che si sono incontrati a Washington solo a febbraio, parleranno anche del tema delle spese militari. I colloqui sulla condivisione dei costi per il mantenimento delle oltre 28 mila truppe americane in Corea del Sud sono già in corso e sono peraltro in anticipo rispetto alla tabella di marcia.
Ma la sensazione è che entrambe le parti vogliano arrivare a una soluzione prima delle elezioni presidenziali di novembre. A Seul ricordano bene il duro confronto avvenuto durante il mandato di Donald Trump, che chiedeva un aumento esponenziale dei contributi sudcoreani. L’accordo fu poi chiuso con l’arrivo di Biden con un aumento del 4%. Ecco perché la Corea del Sud, conscia dell’approccio più concreto ed economicista di Trump, preferirebbe evitare di dover trattare di nuovo sul dossier con il leader repubblicano qualora tornasse alla Casa Bianca. Sono stati già nominati degli inviati per arrivare a un accordo, nonostante quello attuale scada solo a fine 2025.
Martedì 19 marzo Blinken si sposta nelle Filippine. A Manila verrà ricevuto dal presidente Ferdinand Marcos Junior, reduce peraltro da un tour europeo che lo ha portato in Germania e in Repubblica Ceca. Marcos è stato di recente anche in Vietnam e Australia, nel tentativo di rafforzare le relazioni internazionali delle Filippine, mai come in questo periodo decise nel reiterare le proprie pretese di sovranità sulle acque contese con la Cina nel mar Cinese meridionale.
Negli ultimi mesi sono stati molti gli incidenti tra le navi dei due Paesi, tra collisioni e cannoni ad acqua. Se ne parlerà senz’altro con Blinken, visto il trattato di mutua difesa che lega Washington e Manila, che con l’avvento di Marcos ha archiviato la parentesi filocinese del suo predecessore Rodrigo Duterte per tornare in forte allineamento con gli States.
Nelle scorse settimane, il governo filippino ha annunciato un accordo con gli Usa per ammodernare e ampliare un porto civile che si affaccia sul canale di Bashi, vale a dire il punto più vicino a Taiwan del territorio filippino. Già lo scorso anno, Manila ha concesso l’ingresso alle truppe americane a quattro ulteriori basi militari sul proprio territorio.
Blinken e Marcos parleranno di sicurezza e mar Cinese meridionale, con Pechino che osserva le dichiarazioni frutto dell’incontro. I due prepareranno anche la nuova visita del presidente filippino alla Casa Bianca, che dopo esserci entrato lo scorso maggio ci entrerà di nuovo in un significativo vertice trilaterale insieme a Biden e al premier giapponese Fumio Kishida.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
L’India sposta migliaia di truppe nei pressi del confine con la Cina. Si riaccendono gli animi lungo la cosiddetta linea MacMahon, una diatriba che ha origine da un accordo del secolo scorso tra il Tibet autonomo e l’India britannica, non riconosciuto da Pechino.
Torna ad agitarsi la frontiera tra Cina e India. Secondo i media indiani, Nuova Delhi ha infatti previsto l’invio di un’unità di ben diecimila soldati nella regione, precedentemente dislocati nelle periferie occidentali del Paese, per rafforzare le difese sul confine conteso. Il contingente esistente di circa 9000 soldati, già designato per il confine con la Cina, sarà portato sotto il comando di combattimento della nuova unità. La forza combinata sorveglierà un tratto di confine di 532 chilometri che separa la regione autonoma cinese del Tibet dagli Stati settentrionali indiani di Uttarakhand e Himachal Pradesh.
L’assegnazione senza precedenti di truppe, sostenute da artiglieria e supporto aereo, a questo tratto di confine evidenzia sia l’importanza strategica della regione sia la sua crescente sensibilità agli occhi del governo indiano.
Non va peraltro dimenticato che l’India è in periodo di campagna elettorale e il primo ministro Narendra Modi ha alzato i livelli della sua retorica nazionalista in vista delle urne di aprile dove è a caccia del terzo mandato.
L’area interessata dal provvedimento, viene fatto non a caso notare dai media indiani, ospita alcuni dei santuari più sacri dell’induismo. Proprio qualche settimana fa Modi ha inaugurato un controverso tempio indù sul sito dove un tempo sorgeva una moschea. E negli scorsi giorni ha visitato il Kashmir per la prima volta da quando, nel 2019, lo ha privato dell’autonomia di cui godeva precedentemente.
La reazione di Pechino è stata tutt’altro che positiva, come prevedibile. “La Cina è impegnata a collaborare con l’India per salvaguardare la pace e la stabilità delle zone di confine”, ha dichiarato nei giorni scorsi Mao Ning, portavoce del ministero degli Esteri cinese. “Riteniamo che la pratica dell’India non favorisca la salvaguardia della pace e non sia favorevole all’allentamento delle tensioni”.
Ma quali sono esattamente i termini di questa contesa territoriale? Si tratta di una vicenda che ha più di un secolo e trova la sua origine nella cosiddetta “linea McMahon”, non riconosciuta da Pechino perché frutto di un accordo tra il Tibet autonomo e l’India britannica, con cessioni di una parte importante di territorio da quella che sarebbe poi diventata una regione autonoma della Repubblica Popolare.
Una contesa che riguarda diverse aree. In primis l’Aksai Chin, regione montuosa del Kashmir in mano alla Repubblica Popolare dalla guerra sino-indiana del 1962, nella quale sono morti circa duemila soldati. Si tratta di un’area montuosa che funge da strategico collegamento tra Tibet e Xinjiang e che Nuova Delhi continua a rivendicare come parte del Ladakh, una delle divisioni dello stato di Jammu e Kashmir.
La coda allungata dell’Aksai Chin tocca anche la zona strategica del lago himalayano Pangong Tso, che dal territorio indiano arriva a toccare il principale snodo stradale del Tibet. Il tutto dopo essere passata anche a toccare altri due stati indiani, l’Himachal Pradesh (dove col benestare di Nuova Delhi risiede, nella città di Dharamsala, il Dalai Lama fuggito dal Tibet dopo l’arrivo di Mao nel 1950) e l’Uttaranchal.
Scendendo a sud est, invece, si trovano altre due aree contese, La prima è quella del Sikkim, incastonato tra Nepal e Bhutan ed entrato a far parte dell’India nel 1975 con un referendum. La seconda, andando ancora più verso oriente dopo il Bhutan, è quella dell‘Arunachal Pradesh, controllato dall’India ma rivendicato da Pechino.
Le tensioni tra Cina e India si sono riaccese nel giugno 2020, quando uno scontro tra le truppe delle due parti risultò nella morte di diversi soldati di ambo le parti. Da allora, sono stati condotti diversi round negoziali per risolvere la situazione. Colloqui che hanno evitato altre morti ma che non hanno allentato del tutto le tensioni, visto che a più riprese ci sono stati scontri anche violenti.
A inizio 2024 è emerso che i militari dei due Paesi si sono scontrati almeno due volte nel 2022. I dettagli dei nuovi scontri sono stati rivelati dopo che l’esercito indiano ha conferito medaglie al valore ad alcuni dei suoi soldati, i quali avrebbero sfidato le truppe cinesi che cercavano di entrare in territorio indiano in almeno due incidenti nel 2022.
Nel frattempo, entrambe le parti proseguono a costruire strade ed edifici, fomentando la paranoia avversaria. Lo scorso settembre, le autorità di Pechino hanno rilasciato un elenco con denominazioni in mandarino di diverse località contese, comprese alcune sotto controllo indiano. La reciproca diffidenza è stata resa visibile anche a livello diplomatico, quando Xi Jinping ha evitato di partecipare al summit del G20 di Nuova Delhi, inviando al suo posto il premier Li Qiang. Ciò non impedisce ai due Paesi di sedere insieme all’interno dei Brics, peraltro appena allargati a dieci membri. Interessante anche incrociare le nuove manovre al confine con la sfida indiretta che sta andando in scena nell’oceano Indiano.
Le Maldive, che hanno di recente cambiato presidente, hanno imposto il ritiro entro maggio del drappello di militari indiani da tempo presente sull’arcipelago. Contestualmente, Malé ha firmato un accordo di assistenza militare con la Cina, suscitando fastidio a Nuova Delhi.
La partita del confine conteso pare destinata per ora a restare aperta e potrebbe anzi arricchirsi di un nuovo delicato dossier quando si dovrà stabilire la controversa successione del Dalai Lama.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Inizio marzo, tempo di lianghui. Cioè le “due sessioni”, uno dei principali appuntamenti politici dell’anno in Cina e centro nevralgico della sua vita legislativa. Lunedì 4 marzo si aprono le riunioni della Conferenza politica consultiva del popolo cinese. Martedì 5 marzo è invece la volta dell’Assemblea nazionale del popolo.
La prima riunisce grandi personalità cinesi, provenienti da ogni sfera della vita economica, sociale, scientifica e sportiva. E, appunto, ha funzioni consultive. La seconda è invece quanto di più simile a un parlamento esista in Cina. La stragrande maggioranza dei suoi 2980 componenti è iscritta al Partito comunista, ma ci sono anche membri indipendenti e rappresentanti degli altri otto partiti legali (di certo non di opposizione) insieme nel Fronte unito. L’Assemblea nazionale del popolo ha funzioni legislative, anche se nella pratica si limita sostanzialmente a ratificare le decisioni prese dal Consiglio di Stato e dal Partito comunista.
Nel 2023, le “due sessioni” avevano certificato l’inizio del nuovo capitolo dell’era di Xi Jinping, conferendogli il terzo mandato da presidente della Repubblica Popolare Cinese dopo che nell’ottobre 2022 gli era stato già consegnato il terzo mandato da segretario generale del Partito.
Tanto è cambiato da allora. A presentare il suo primo rapporto di lavoro da premier sarà infatti Li Qiang, ex capo del Partito a Shanghai e fedelissimo di Xi. È lui il numero due della gerarchia del Partito e ha preso il posto di Li Keqiang, l’ex premier deceduto improvvisamente qualche mese fa.
Li presenterà i risultati di governo, soprattutto quelli economici, dell’anno appena trascorso. Verrà evidenziato che l’obiettivo fissato di 5% di crescita del prodotto interno lordo è stato raggiunto e anzi superato, visto che Pechino ha registrato un +5,2%. Anche se gli analisti sottolineano che la stima era stata volutamente molto cauta, per evitare che si ripetesse il fallimento dell’obiettivo del 2022, quando i lockdown e le restrizioni della strategia zero Covid avevano abbattuto l’economia.
Un’economia che non si è ancora ripresa del tutto. A zavorrare un completo rilancio è soprattutto il settore immobiliare, dopo che Evergrande ha ricevuto un ordine di liquidazione e anche il primo costruttore privato, Country Garden, si trova in profonda crisi. Previsti diversi annunci con pacchetti di stimolo all’economia, ma chi si aspetta grandi riforme o maxi piani di sostegno resterà probabilmente deluso.
Grande attenzione ovviamente anche ai segnali in arrivo sulla politica estera. Lo scorso anno i toni furono molto foschi. Nel suo discorso alla Conferenza politica consultiva del popolo, Xi fu molto esplicito nel citare il tentativo degli Stati Uniti di fermare l’ascesa cinese. Ma aveva anche prefigurato una postura più proattiva sulla scena internazionale, ritoccando la celebre dottrina di Deng Xiaoping (“osserviamo con calma, nascondiamo i punti di forza e aspettiamo il nostro tempo, non rivendichiamo mai il comando”) in una nuova versione: “Manteniamo la calma e la determinazione, progrediamo nella stabilità, raggiungiamo proattivamente gli obiettivi, stiamo uniti e osiamo combattere“.
Xi sembra aver tenuto fede a quella promessa, visto che dopo aver espresso la propria (ambigua) posizione sulla guerra in Ucraina, Pechino ha commentato in maniera molto più decisa la crisi in Medio Oriente e il conflitto tra Israele e Hamas. Non solo. Ha anche favorito l’allargamento dei Brics con l’adesione di cinque nuovi Paesi. Allo stesso tempo, mentre rafforzava la presa sul cosiddetto Sud globale, la Cina ha anche riannodato alcuni fili dei rapporti con gli Stati Uniti, come dimostra il summit di San Francisco fra Xi e Joe Biden. Interessante sarà dunque osservare i toni di Wang Yi, dopo quelli durissimi del predecessore Qin Gang lo scorso anno.
Dalle parole di Wang e Xi emergeranno segnali importanti su come Pechino intende porsi a livello globale nei prossimi mesi.
A proposito di Qin, nei giorni scorsi sono state accettate le sue dimissioni da deputato, dopo che lo scorso luglio era stato rimosso da ministro degli Esteri per ragioni mai chiarite. Si è parlato di una relazione extraconiugale con una giornalista televisiva mentre era ancora ambasciatore cinese a Washington.
Anche l’altra grande nomina delle “due sessioni” dell’anno scorso, Li Shangfu, è stata un insuccesso. Il ministro della Difesa è stato rimosso in autunno per uno scandalo legato alle forniture militari, che ha visto peraltro cadere diverse teste anche nell’esercito e in particolare nelle forze missilistiche.
Nei prossimi giorni ci si aspettano dunque nuove nomine, anche se alla Difesa è stato già piazzato Dong Ju a fine anno. Wang potrebbe però cedere il ruolo di ministro degli Esteri, già ricoperto fino all’anno scorso e poi di nuovo dopo la rimozione di Qin, per “limitarsi” a guidare la diplomazia del Partito. Al suo posto potrebbe essere promosso Liu Jianchao, capo del dipartimento internazionale del Partito ed ex guida della commissione disciplinare. Negli scorsi mesi Liu ha effettuato molti viaggi tra Europa, Stati Uniti, Russia e Asia. Evenienza che ha fatto pensare a molti che la sua promozione sia ormai imminente.
Attenzione anche a eventuali segnali su Taiwan e il mar Cinese meridionale. Lo scorso anno, Xi chiese all’Esercito popolare di liberazione, come già fatto a luglio 2021 in occasione del centenario del Partito, di diventare una “grande muraglia d’acciaio” a difesa della sicurezza nazionale. Negli ultimi 12 mesi si sono verificate nuove grandi esercitazioni intorno a Taiwan (lo scorso aprile, in occasione del doppio scalo americano della presidente uscente Tsai Ing-wen) e soprattutto le elezioni presidenziali di gennaio sono state vinte da Lai Ching-te, il più inviso a Pechino.
A cavallo del suo insediamento del prossimo 20 maggio sono possibili nuove manovre, fermo restando che nelle ultime settimane si è già alzata la tensione su Kinmen, mini arcipelago amministrato da Taipei ma a pochi chilometri di distanza dalle coste del Fujian cinese. Visto che siamo nel 75esimo anniversario della fondazione della Repubblica Popolare e della fine della guerra civile, ci si potrebbe aspettare qualche messaggio quantomeno sul fronte retorico.
Di recente, al forum presieduto da Wang Huning (numero tre della gerarchia), il Partito si è impegnato a “combattere” i tentativi di “secessione”, mentre in passato la formula ufficiale era quella della “opposizione risoluta”. Negli ultimi mesi è aumentata in modo esponenziale la tensione con le Filippine sui territori contesi nel mar Cinese meridionale.
Al centro pare destinato comunque a restare il concetto di “sicurezza nazionale”, formula ripetuta più volte da Xi in tutti i discorsi degli ultimi anni, nonché etichetta apposta a una legge entrata in vigore a Hong Kong nel 2020, che potrebbe presto venire ulteriormente inasprita. Sempre in ossequio alla sicurezza nazionale, è stata appena emendata anche la legge sul segreto di Stato.
Altro concetto chiave da seguire è quello dell’autosufficienza tecnologica, che si prevede verrà ulteriormente menzionata durante i lavori della densa settimana delle “due sessioni”.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Sei mesi. Tanto è durato il presunto passo indietro di Hun Sen. Il leader eterno della Cambogia è pronto a tornare in sella. Dopo aver lasciato il ruolo di primo ministro al figlio Hun Manet in seguito alle elezioni dello scorso luglio, è pronto a diventare presidente del Senato, la seconda carica dello Stato dopo il re.
Risultati delle elezioni di domenica 25 febbraio. Dei 62 seggi del Senato, 58 sono votati da 125 parlamentari e più di 11mila amministratori locali. Il re Norodom Sihamoni nomina due senatori, mentre l’Assemblea nazionale (eletta a suffragio universale lo scorso luglio) ne nomina altri due. Come più che ampiamente atteso, il Partito Popolare Cambogiano ha dichiarato di aver ottenuto una vittoria schiacciante. Il portavoce Sok Eysan ha detto che i primi risultati hanno mostrato che il partito di maggioranza ha vinto almeno 50 dei 58 seggi. Ha poi subito confermato che il partito nominerà Hun Sen come presidente del Senato, ruolo che di fatto gli consentirà di agire come capo di Stato quando il re si trova all’estero.
Sulle schede elettorali erano presenti quattro partiti, tra cui il monarchico Funcinpec, ma nessuna vera opposizione. Non una sorpresa, visto che Hun Sen ha operato una stretta a partire dal grande spavento del 2013, quando alle elezioni fu quasi sconfitto dal Partito di Salvezza Nazionale di Sam Rainsy. Da allora decise che non poteva più mettere a rischio la sua posizione, soprattutto mentre iniziava a programmare la successione col figlio Hun Manet.
Lo scorso luglio, il Candlelight Party (nato sulle ceneri del movimento di Rainsy) è stato estromesso dal voto con la scusa di problemi burocratici. Le due grandi figure dell’opposizione erano già state messe fuori gioco in precedenza. Kem Sokha è stato condannato nel 2022 a 27 anni di carcere per tradimento: l’accusa è quella di aver organizzato un presunto complotto per rovesciare il governo. Rainsy si trova invece in autoesilio all’estero e non potrà candidarsi per altri due decenni.
Impossibile dunque pensare a una composizione diversa del Senato. Ma è significativo che Hun Sen abbia deciso di tornare in prima fila. Secondo molti analisti, diventare presidente del Senato gli può garantire di proteggere ulteriormente il figlio Hun Manet, la cui nomina anticipata è motivata proprio dal desiderio del padre di supervisionare la transizione mentre è ancora in forze, per spegnere sul nascere le eventuali velleità degli altri leader più anziani del partito che si sentono sorpassati da una figura in larga parte priva di esperienza politica.
Il ritorno sulla scena di Hun Sen arriva peraltro dopo pochi giorni dalla nomina di un altro membro della sua dinastia, l’ultimo rampollo Hun Many, diventato il più giovane vice premier cambogiano di sempre. Many, 41 anni, ha iniziato la sua carriera politica lavorando come assistente del padre. È stato deputato in rappresentanza della provincia di Kampong Speu e presidente della commissione dell’Assemblea nazionale per l’Istruzione, la gioventù e lo sport, il culto e gli affari religiosi, la cultura e il turismo nel 2013, prima di diventare ministro della Funzione pubblica lo scorso agosto.
Many è anche il presidente dell’Unione delle Federazioni giovanili della Cambogia. Anche per lui si prospetta un futuro politico di primo piano in una Cambogia sempre più a immagine e somiglianza di Hun Sen, quasi nello stile della famiglia Kim in Corea del Nord, seppure i media statali continuino a elogiare il “sistema democratico” cambogiano. Nel quale ormai non è però più prevista opposizione.
L’Occidente lascia comunque la porta socchiusa. Nelle scorse settimane Hun Manet (che ha un passato nell’esercito ma anche studi economici condotti in Occidente) è stato in Svizzera per il World Economic Forum di Davos e si è poi recato in Francia, dove ha incontrato il presidente Emmanuel Macron. Il viaggio a Parigi è stato visto come un successo per Manet, che è tornato con 235 milioni di dollari in accordi di sviluppo con la Francia per costruire infrastrutture energetiche e di acqua potabile e sostenere la formazione professionale in Cambogia e l’impegno a lavorare per un “partnership strategica”. Gli Stati Uniti avevano inizialmente “sospeso” un pacchetto di aiuti da 18 milioni di dollari dopo le elezioni, che un funzionario del Dipartimento di Stato descrisse come “né libere né giuste”. Ma la decisione di sospendere gli aiuti è stata revocata due mesi dopo per “incoraggiare il nuovo governo a tener fede alle sue intenzioni dichiarate di essere più aperto e democratico”.
Visto il ritorno da protagonista di Hun Sen, qualcuno potrebbe temere che le speranze siano destinate a essere deluse.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
L’ex controverso generale Prabowo Subianto ha trionfato alle elezioni presidenziali del 14 febbraio e sarà il prossimo presidente della più grande nazione a maggioranza musulmana, più grande economia del Sud-Est asiatico e quarto paese più popoloso del mondo.
Dopo le elezioni del 2019, in pochi si aspettavano che Prabowo Subianto sarebbe diventato presidente dell’Indonesia. Già sconfitto nel 2014, il controverso ex generale rientrato anni prima da un esilio in Giordania era stato battuto nuovamente da Joko Widodo. Il 14 febbraio, invece, Prabowo ha vinto le elezioni presidenziali proprio insieme al figlio del suo (ex) rivale Widodo, Gibran Rakabuming Raka. L’ex capo delle forze speciali, ruolo in cui venne accusato di varie violazioni dei diritti umani negli anni Novanta, era il favorito della vigilia. Ma la maggior parte degli osservatori si aspettavano che non riuscisse a superare lo sbarramento de 50% necessario per vincere al primo turno. Il pronostico più diffuso era quello che sarebbe servito il ballottaggio, da tenersi a fine giugno, contro Ganjar Pranowo, ex governatore di Giava centrale e (molto) teorico erede designato del presidente uscente Widodo.
E invece, secondo tutti i dati non ufficiali, Prabowo è arrivato vicino addirittura al 60%. Un trionfo che lo renderà il prossimo presidente del quarto Paese più popoloso al mondo, nonché più grande nazione a maggioranza musulmana. Sì, perché i risultati ufficiali non si avranno prima di metà marzo, ma non c’è nessun dubbio sul fatto che Prabowo abbia vinto.
“Assembleremo un governo composto dai migliori figli e figlie dell’Indonesia”, ha promesso Prabowo nel suo primo discorso dopo la pubblicazione dei risultati, promettendo di governare per “tutti gli indonesiani”.
Ganjar, che si era impegnato a creare 17 milioni di nuovi posti di lavoro, a espandere l’assistenza sociale e ad aumentare l’accesso all’istruzione superiore per i poveri, è stato sonoramente sconfitto arrivando addirittura terzo, sotto il 20%. Davanti a lui è arrivato persino Anies Baswedan, un esponente dell’élite intellettuale indonesiana ed ex collaboratore di Widodo, scrivendone addirittura i discorsi, per poi essere nominato ministro dell’Istruzione e governatore della capitale Giacarta. Ma anche Anies sarebbe arrivato a oltre il 30% di distanza da Prabowo.
Un successo costruito proprio sul sostegno di Widodo al suo ex rivale, che già nel 2019 era stato nominato ministro della Difesa. Inizialmente si poteva pensare che la mossa fosse utile a neutralizzare la sua opposizione, che poteva diventare anche aggressiva. Nel 2014, Prabowo non aveva inizialmente riconosciuto la sconfitta. E nel 2019 si era legato a gruppi islamisti radicali per provare a insidiare Widodo, senza riuscirci. Invece non era solo un calcolo del momento, Widodo ha davvero puntato su Prabowo, mandando addirittura il figlio a fargli da vice. Gibran ha solo 36 anni e teoricamente non avrebbe potuto candidarsi secondo la legge indonesiana. A pochi mesi dal voto, però, la Corte suprema ha rimosso il vincolo dei 40 anni per candidarsi a presidenza e vicepresidenza per chi ha già vinto una tornata elettorale locale. Cosa accaduta a Gibran, che ha potuto così candidarsi. Piccolo particolare: la Corte costituzionale è guidata nientemeno che dal marito della sorella di Widodo. Insomma, un affare di famiglia.
Così come Prabowo era nella famiglia dell’ex dittatore Suharto, essendo un tempo suo genero. I risultati hanno suscitato negli attivisti il timore che la responsabilità per le atrocità del passato si affievolisca ulteriormente e che il suo futuro governo abbia scarsa considerazione per i diritti umani. “L’inverno sta arrivando, qualunque sia il nome”, ha dichiarato al Guardian Usman Hamid, direttore esecutivo di Amnesty International Indonesia. “Ma la lotta deve continuare… tutti i responsabili devono essere consegnati alla giustizia”.
Il riferimento è agli studenti e attivisti politici rapiti nel 1998. Dei 22 attivisti rapiti quell’anno, 13 sono ancora dispersi. Prabowo ha sempre negato di aver commesso illeciti e non è mai stato incriminato in relazione alle accuse, anche se molti dei suoi uomini sono stati processati e condannati. Prabowo è anche accusato di essere coinvolto in abusi dei diritti in Papua e Timor Est, tra cui un massacro del 1983 in cui centinaia di persone, per lo più uomini, furono uccise nel villaggio timorese di Kraras.
Osservano con attenzione anche gli Stati Uniti, che in passato proprio per queste accuse avevano negato l’ingresso a Prabowo. Le posizioni del ministro della Difesa uscente su alcune crisi internazionali hanno suscitato più di una perplessità in Occidente. In particolare sulla guerra in Ucraina, a proposito della quale Prabowo ha proposto una pace alla coreana, con la creazione di una zona cuscinetto e un referendum nei territori occupati dai russi per lasciare decidere alla popolazione (occupata) da che parte stare.
I mercati non sembrano invece preoccupati. Anzi, il giorno dopo le elezioni il mercato azionario del Paese è salito fino al 2,2%, mentre la rupia si è rafforzata dello 0,3%, raggiungendo il valore più alto da un mese a questa parte. La ragione è semplice: Prabowo ha promesso di seguire le politiche di Widodo (rimasto popolarissimo tra la popolazione e sui mercati per la sua inclinazione favorevole agli investimenti) nella più grande economia del Sud-Est asiatico.
Tra le sfide più impellenti di Prabowo ci sarà quella di ridurre la disoccupazione giovanile, che si attesta al 17% tra gli under 24. Una fetta importante della popolazione, tanto da essere al centro delle strategie elettorali di Prabowo, lanciatosi anima e corpo su Instagram e TikTok per far dimenticare il suo controverso passato e presentarsi come il “nonno della porta accanto”. Operazione riuscita, per ora.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Il PTI di Khan è il primo partito con 93 seggi ma è difficile che gli sarà consentito governare. Lo scenario più probabile appare quello di un governo di coalizione che includa tutti i partiti politici, meno il PTI di Khan
Squalificato, condannato più volte, eppure vincente. Imran Khan rivendica la vittoria alle elezioni nazionali in Pakistan di giovedì 8 febbraio. Dopo diversi rallentamenti e dubbi, la commissione elettorale di Islamabad ha annunciato i risultati finali: il Pakistan Tehreek-e-INsaf (PTI) di Khan è il primo partito, nonostante l’impossibilità a utilizzare i propri simboli. Conquistati 93 seggi. Comunque troppo pochi per governare, visto che il parlamento conta 264 poltrone.
Il risultato è comunque a dir poco sorprendente, vista la campagna giudiziaria e securitaria lanciata contro l’ex premier ed ex campione di cricket che si definisce vittima di un complotto ordito insieme agli Stati Uniti. L’altro ex premier, Nazaw Sharif, è arrivato secondo con 75 seggi. Una delusione per un altro leader che era stato in esilio volontario per evitare condanne e che è rientrato in patria ottenendo il sostegno dell’establishment militare rivoltatosi contro Khan.
Il risultato finale è stato annunciato dopo giorni di tensione, in cui entrambi i rivali si erano dichiarati vincitori, Khan addirittura tramite un video creato con l’intelligenza artificiale. Il partito PTI di Khan aveva minacciato di organizzare dimostrazioni pacifiche a livello nazionale domenica se il conteggio dei voti non fosse stato reso noto nella notte. E circa 300 sostenitori di Khan hanno bloccato per ore l’autostrada principale che collega Islamabad a Peshawar. Ma alla fine, dopo 60 ore di attesa, i risultati sono arrivati.
Il governo provvisorio del Pakistan ha dichiarato che il ritardo nel conteggio dei voti è stato causato da problemi di comunicazione dovuti a un’interruzione della connessione internet mobile nel giorno delle elezioni. L’interruzione, che le autorità hanno dichiarato essere dovuta a motivi di sicurezza, ha suscitato la preoccupazione di gruppi per i diritti umani. Alla vigilia del voto si sono infatti verificate diverse violenze, soprattutto nel Baluchistan e spegnere internet è diventata una prassi di diversi governi della regione per “regolare” i conti con le proteste.
Ora si apre una fase altrettanto delicata e molto incerta. Nonostante la vittoria alle urne, è difficile pensare che al PTI sarà consentito di governare. Complicato che il partito di Khan riesca a trovare altre forze disponibili ad allearsi con un movimento entrato chiaramente nel mirino della giustizia pakistana. Tra l’altro, uno degli svantaggi che gli indipendenti devono affrontare nel tentativo di formare un governo è che, non essendosi candidati come partito, non hanno diritto all’assegnazione di nessuno dei 70 seggi riservati del Parlamento, che vengono distribuiti in base alla forza del partito nel computo finale. Il partito di Sharif potrebbe ottenere fino a 20 di questi seggi, arrivando dunque persino a superare i seggi del PTI.
Non è un caso che Sharif si stia già muovendo per provare ad assicurarsi degli accordi di coalizione. Per primi ha incontrati i dirigenti del Pakistan People’s Party (PPP) di Bilawal Bhutto Zardari e suo padre Asif Ali Zardari, giunto terzo con 54 seggi. Secondo la dichiarazione rilasciata dopo l’incontro, è stato annunciato che è stato raggiunto un consenso di “principio sulla cooperazione politica” tra il PPP e la Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N) di Sharif. Sarebbe l’ennesima giravolta della politica pakistana, visto che in passato Bhutto si è più volte messo in contrapposizione con Sharif. L’ex premier ha incontrato anche i rappresentanti del partito nazionalista Muttahida Qaumi Movement (MQM), concordando di “lavorare insieme, in linea di principio, nell’interesse del Paese”. Anche se ancora non c’è un accordo formale.
Lo scenario più probabile appare proprio quello di un governo di coalizione che includa tutti i partiti politici, meno il PTI di Khan. Un secondo scenario, meno probabile ma tecnicamente possibile, è che il PPP si unisca al PTI per formare un governo. Sempre che ciò venga consentito. Il capo dell’esercito Syed Asim Munir, dal canto suo, ha affermato che il Pakistan deve “rompere con la politica di anarchia e polarizzazione che non si addice a un paese progressista”. Una sorta di indicazione alla grande coalizione.
Da osservare anche la questione legata all’ordine pubblico. Nel video diffuso dal PTI, Khan rivendica un successo maggiore di quello certificato dal conteggio: “Abbiamo vinto 150 seggi nell’Assemblea nazionale prima che la manipolazione iniziasse. A cavallo del voto ci sono stati attacchi e attentati di natura politica, con oltre 40 morti“.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
L’8 febbraio i seggi elettorali saranno aperti. Il grande favorito è Nawaz Sharif, ex premier. È il candidato della Lega Musulmana del Pakistan e potrebbe godere dell’appoggio di vari partiti integralisti islamici
Dopo il Bangladesh e prima dell’India, tocca al Pakistan. Giovedì 8 febbraio il Paese dell’Asia meridionale va alle urne per le elezioni generali, in un anno record a livello di urne sul fronte globale. Le autorità hanno confermato il voto, nonostante il clima sia tutt’altro che idilliaco. Il Pakistan sta infatti affrontando due diverse insurrezioni armate: una nel nord-ovest del Khyber-Pakhtunkhwa da parte di gruppi islamisti e una nel sud-ovest da parte di gruppi etno-nazionalisti Baloch.
Un candidato indipendente all’assemblea nazionale, Rehan Zaib Khan, è stato ucciso mercoledì 31 gennaio nel Khyber-Pakhtunkhwa. Lo stesso giorno, un altro politico è stato ammazzato a colpi di pistola nell’ufficio elettorale del suo partito in Balochistan. Martedì 30 gennaio, un attentato dinamitardo dopo un comizio elettorale ha ucciso quattro persone in Balochistan. L’attacco è stato rivendicato dall’Isis.
Le elezioni si sarebbero dovute tenere a novembre dopo lo scioglimento del Parlamento ad agosto, ma sono state rinviate a febbraio a causa di un censimento. A gennaio, i membri del Senato pakistano hanno chiesto ulteriori ritardi per motivi di sicurezza, con un pensiero ai possibili (o forse probabili) disordini per l’assenza dalla campagna elettorale dell’ex premier Imran Khan, ancora molto popolare nel Paese. Non a caso domenica 28 gennaio ci sono stati duri scontri tra la polizia e i sostenitori del Movimento per la Giustizia del Pakistan (PTI), il partito di Khan. In quell’occasione ci sono stati almeno 25 arresti. Tra le persone finite in manette c‘è anche il segretario generale del partito nel Sindh, Ali Pal.
La Commissione elettorale e il ministero dell’Interno hanno però deciso di andare avanti. Il tutto proprio mentre a Khan veniva inflitta una serie incredibile di condanne. Martedì 30 gennaio è stato condannato a 10 anni per aver diffuso segreti di stato, mentre il giorno successivo è stato condannato a ulteriori 14 anni per corruzione. Contestualmente, gli è stato vietato di detenere incarichi pubblici (e dunque di candidarsi) fino al 2034. Si tratta di condanne di primo grado, ma tanto basta per tenere lontano Khan dalle urne. Anche lo stesso PTI non potrà presentarsi alle elezioni coi suoi simboli e i suoi candidati dovranno correre da indipendenti. Khan e i suoi sostenitori sono convinti che le motivazioni dei vari provvedimenti siano politiche.
D’altronde Khan, ex campione di cricket, è convinto di aver perso il posto a causa di un complotto internazionale. Da qui nasce la sua condanna per diffusione di segreti di stato. Secondo la sentenza, Khan sarebbe colpevole di aver reso pubblico, “nonché di aver maneggiato, abusato e manomesso” un cablogramma segreto inviato dall’ambasciatore del Pakistan a Washington al governo di Islamabad. Khan ha affermato a più riprese che quel cablogramma era la prova di una cospirazione da parte dell’esercito e del governo statunitense per rovesciare il suo governo nel 2022, dopo la sua visita a Mosca poco prima dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Washington e l’esercito pakistano negano questa ipotesi, ma i sostenitori di Khan ne sono convinti.
Come se non bastasse, sabato 3 febbraio è arrivata un’altra sentenza contro l’ex premier. Lui e la moglie Bushra sono stati condannati a sette anni di carcere e a una multa da un tribunale che ha stabilito che il loro matrimonio del 2018 ha violato la legge. Bushra è stata accusata di non aver completato il periodo di attesa previsto dall’Islam, chiamato “Iddat”, dopo aver divorziato dal precedente marito e aver sposato Khan. La coppia ha firmato il contratto di matrimonio, o “Nikkah”, nel gennaio 2018 in una cerimonia segreta, sette mesi prima che Khan diventasse primo ministro per la prima volta. Lui nega qualsiasi accusa e la sua difesa parla di un altro caso “fasullo” messo in piedi senza “testimoni né prove”.
Fatto sta che l’8 febbraio i seggi elettorali saranno aperti. Il grande favorito è Nawaz Sharif, a sua volta ex premier. È il candidato della Lega Musulmana del Pakistan e potrebbe godere dell’appoggio di vari partiti integralisti islamici. Sharif ha smussato i problemi avuti in passato con l’esercito, che mantiene una presa molto stretta sulla vita politica del Pakistan. Tanto che oggi le forze armate sembrano sostenerlo. Non sembrano esserci avversari in grado di impensierire fino in fondo Sharif, che fronteggia una schiera di indipendenti ma può approfittare dell’assenza di Khan, il cui partito è ora guidato dall’avvocato Gohar Ali Khan.
I pachistani vanno alle urne con una serie di problemi, tra cui ai primi posti ci sono senz’altro l’inflazione e la moneta debole, mentre Islamabad prova a barcamenarsi nel piano di salvataggio da tre miliardi del Fondo monetario internazionale. L’esito delle urne, seppur appaia scontato a livello generale, è da seguire anche sulle dinamiche locali. A partire dal Baluchistan, zona di interesse chiave anche per la Cina.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Il tempismo dell’incontro in terra thailandese è interessante. A due settimane dalle elezioni presidenziali di Taiwan, dopo l’intensificarsi della crisi del Mar Rosso e in previsione della prossima visita in Corea del Nord di Vladimir Putin.
La prima volta si sono incontrati a maggio 2023, a Vienna, tre mesi dopo la crisi del pallone aerostatico che ha portato al rinvio della visita a Pechino del Segretario di Stato americano Antony Blinken. E hanno riaperto ufficialmente il dialogo tra Stati Uniti e Cina. Di lì a poco una serie di componenti dei due governi hanno effettuato viaggi incrociati. La seconda volta si sono visti a Malta, lo scorso settembre. È stato l’incontro che ha posto le basi per il summit di San Francisco tra i due leader, Xi Jinping e Joe Biden. Questa volta si sono parlati, per oltre 12 ore, a Bangkok, in Thailandia. E hanno concordato su un nuovo colloquio, stavolta virtuale, tra Biden e Xi.
I protagonisti sono sempre loro due: Jack Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, e Wang Yi, ministro degli Esteri cinese nonché capo della diplomazia del Partito comunista. Quando parlano loro, la comunicazione è davvero strategica. Non è un caso che i primi due incontri, quelli di Vienna e di Malta, fossero stati annunciati solo a cose fatte.
In molti hanno infatti legato l’efficacia dei colloqui alla loro forma privata, lontani da sguardi indiscreti e dalle domande dei giornalisti. Sono loro a decidere le carte che poi i leader si giocano a favore di telecamere.
Stavolta, l’annuncio è arrivato alla vigilia, anche perché la notizia era stata diffusa dal Financial Times e dal Wall Street Journal. Il tempismo dell’incontro in terra thailandese è interessante. A due settimane dalle elezioni presidenziali di Taiwan, dopo l’intensificarsi della crisi del Mar Rosso e in previsione della prossima visita in Corea del Nord di Vladimir Putin.
Sono presumibilmente questi tre, i dossier internazionali ad aver dominato le 12 ore di discussione di venerdì 26 e sabato 27 gennaio. Rigorosamente a porte chiuse e senza conferenza stampa. Nel loro resoconto, gli Stati Uniti forniscono maggiori dettagli sulle relazioni bilaterali, evidentemente sui fronti più prodighi di progressi. “L’incontro rientra nello sforzo di mantenere aperte le linee di comunicazione e di gestire responsabilmente la concorrenza nelle relazioni, come stabilito dai leader”, si legge nel comunicato della Casa Bianca.
Sullivan ha sottolineato che, sebbene Stati Uniti e Cina siano in competizione, “entrambi i Paesi devono evitare che la competizione sfoci in conflitto o scontro”. Le due parti hanno discusso le prossime tappe di una serie di aree di cooperazione discusse a Woodside da Biden e Xi riconoscendo “i recenti progressi nella ripresa delle comunicazioni militari” e hanno sottolineato l’importanza di mantenere questi canali.
Hanno inoltre discusso i prossimi passi per l’organizzazione di un dialogo tra Stati Uniti e Cina sull’intelligenza artificiale in primavera. Non solo. Sullivan e Wang hanno accolto con favore i progressi nella cooperazione sulle questioni relative agli stupefacenti, tra cui il lancio del gruppo di lavoro Usa-Cina in programma il 30 gennaio. Al centro, ovviamente, il fentanyl. Non a caso, si danno già per probabili nuove visite di membri dell’amministrazione Biden a Pechino: su tutti, Blinken e Yellen.
Wang ha invece sottolineato che quest’anno ricorre il 45esimo anniversario dell’avvio dei rapporti diplomatici tra Pechino e Washington. “Le due parti dovrebbero cogliere questa opportunità per riassumere l’esperienza e trarre insegnamenti, trattarsi alla pari invece che in modo condiscendente, costruire un terreno comune e accantonare invece di evidenziare le differenze, e rispettare invece di minare gli interessi fondamentali dell’altra parte”, ha detto Wang. “Entrambe le parti dovrebbero lavorare insieme per il rispetto reciproco, la coesistenza pacifica e la cooperazione win-win, trovando il modo giusto per far andare d’accordo Cina e Stati Uniti”, ha osservato.
Ma nel 2024 ricorre anche il 45esimo anniversario del Taiwan Relations Act e Washington pare intenzionata a mandare diversi segnali di rassicurazione a Taipei. La scorsa settimana si sono registrati sia il primo passaggio di una nave militare americana sullo Stretto, sia la prima delegazione bipartisan del Congresso, dopo le elezioni presidenziali taiwanesi del 13 gennaio. La vittoria di Lai Ching-te, il candidato più inviso a Pechino, potrebbe mettere ulteriormente a prova la tenuta dello status quo. Non a caso, proprio Taiwan è il tema su cui la parte cinese si dilunga di più. Durante l’incontro, Wang ha sottolineato che la questione di Taiwan “è un affare interno della Cina” e che le elezioni “non possono cambiare il fatto fondamentale che Taiwan fa parte della Cina. L’indipendenza di Taiwan rappresenta il rischio maggiore per la pace e la stabilità tra le due sponde dello Stretto e la sfida più grande per le relazioni tra Cina e Stati Uniti. Gli Stati Uniti devono rispettare il principio di una sola Cina e i tre comunicati congiunti Cina-Usa, tradurre in pratica il loro impegno a non sostenere l’indipendenza di Taiwan e sostenere la riunificazione pacifica della Cina”.
Una richiesta in linea con quella espressa da Xi a Biden a novembre. Sullivan si è fermato al riconoscere “l’importanza di mantenere pace e stabilità sullo Stretto di Taiwan”, senza aggiungere dettagli. Nelle scorse settimane, Biden ha ribadito che gli Usa non sostengono l’indipendenza di Taiwan e per la prima volta dopo tanto tempo un comunicato di un funzionario della Casa Bianca alla vigilia delle elezioni a Taipei ha evidenziato che Washington “non si oppone a qualsiasi risoluzione della questione, purché sia pacifica”. Le scintille sul tema sembrano comunque destinate a restare, visto che nei prossimi mesi Pechino potrebbe aumentare la pressione militare, diplomatica e commerciale in concomitanza con l’insediamento del presidente eletto Lai, previsto per il 20 maggio.
Molti meno dettagli sono stati forniti dalle due parti sugli altri dossier, ma senz’altro Sullivan avrà provato a capire il ruolo che la Cina sta giocando o vorrà giocare sulle tensioni nella penisola coreana, che hanno raggiunto un nuovo picco dopo l’emendamento costituzionale approvato da Kim Jong-un secondo cui la Corea del Sud viene identificata come “nemico principale e immutabile”. Segnale che il dialogo e i negoziati sono più lontani che mai. La visita di Putin potrebbe portare ulteriori sviluppi, preoccupanti di certo per Washington ma forse in parte anche per Pechino. Menzionato anche il Myanmar, visto che a tre anni dal golpe militare la guerra civile continua a infuriare, mettendo peraltro a repentaglio anche la sicurezza della frontiera cinese.
Ma al centro dei colloqui, sostengono Wall Street Journal e Financial Times, c’è stato anche e forse soprattutto il Mar Rosso. Washington avrebbe intensificato le richieste a Pechino di esercitare la propria influenza sull’Iran per fermare gli attacchi degli Houthi. Ufficialmente, la Cina non si è mossa e ha bilanciato attentamente le sue parole. Da una parte chiedendo di fermare gli attacchi contro le navi civili, dall’altra criticando i raid e l’uso della forza contro gli Houthi sul territorio dello Yemen.
Ma secondo la Reuters, in un recente viaggio in Iran l’alto diplomatico Liu Jianchao avrebbe chiarito che qualora gli interessi cinesi venissero colpiti sul Mar Rosso ci sarebbero conseguenze sui rapporti bilaterali. Nonostante le rassicurazioni degli Houthi sulle navi cinesi e russe, i costi di spedizione dai porti cinesi sono più che raddoppiati nel giro di un mese e mezzo. Allo stesso tempo, la Cina non ha interesse a perdere le posizioni scalate nella regione a livello commerciale e diplomatico, officiando tra l’altro la ripresa delle relazioni tra Iran e Arabia Saudita e ponendosi come sostanziale portavoce del mondo musulmano sulla questione palestinese.
Difficile che tutto questo sia rimasto fuori dai colloqui tra Wang e Sullivan, il binario più strategico dei rapporti tra le due potenze.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Pyongyang preannuncia l’imminente visita di Putin, la prima dopo quella fatta dallo stesso Putin nel 2000. Intanto la situazione nella penisola coreana si fa sempre più tesa tra manovre militari e politiche: ad aprile le elezioni parlamentari in Corea del Sud.
Vladimir Putin è pronto a visitare la Corea del Nord. Lo si era capito già dallo scorso settembre, quando fu Kim Jong-un a recarsi nell’Estremo Oriente russo. Ora però c’è anche la comunicazione ufficiale da parte di Pyongyang, con l’agenzia di stampa statale Kcna che ha confermato che il presidente russo sarà nel Paese “nel prossimo futuro”.
Gli ultimi dettagli del viaggio sarebbero stati messi a punto nei giorni scorsi, durante la visita di tre giorni a Mosca della ministra degli Esteri nordcoreana Choe Son-hui. La diplomatica di Pyongyang ha incontrato sia l’omologo Sergej Lavrov e poi lo stesso Putin, aprendo così un 2024 in cui i rapporti tra Corea del Nord e Russia sembrano destinati a un salto di qualità ulteriore dopo quello già osservato lo scorso anno e in generale a partire dalla guerra in Ucraina.
Si tratterà della prima storica visita di un leader russo a Pyongyang dopo quella compiuta, nel 2000, proprio dallo stesso Putin. Allora il leader supremo era Kim Jong-il, padre di Kim Jong-un. Soprattutto, si era in una fase di ottimi rapporti tra Mosca e Occidente, così come era una fase di parziale distensione tra le due Coree. Tanto che la visita di Putin non fu percepita come una minaccia, così come probabilmente sarà percepita questa volta sia dall’Occidente sia dai Paesi asiatici che temono l’apertura di un nuovo fronte che li coinvolge. A partire, ovviamente, da Corea del Sud e Giappone, i due vicini di Pyongyang che hanno rafforzato in modo notevole l’alleanza militare e strategica con gli Stati Uniti.
Significativo, peraltro, anche il modo in cui è stato definito Putin nell’annuncio della Kcna: “Siamo pronti a ricevere il miglior amico del popolo coreano”, si legge. Un ruolo, quello di “miglior amico”, che in passato era riservato al leader della Cina, l’elefante (o meglio il dragone) nella stanza delle dinamiche in atto tra Russia e Corea del Nord.
La visita di Putin non ha ancora una data, ma potrebbe anche avvenire prima delle elezioni parlamentari del 10 aprile in Corea del Sud, con un possibile impatto sugli equilibri di un’Assemblea nazionale dove il presidente conservatore Yoon Suk-yeol (fautore di una linea ben più dura su Pyongyang rispetto al predecessore Moon Jae-in e al leader dell’opposizione Lee Jae-myung) potrebbe uscire ancora più azzoppato. Il viaggio unirebbe anche formalmente il fronte occidentale a quello orientale, dopo che gli Stati Uniti hanno ufficialmente accusato la Corea del Nord di aver fornito armi e missili balistici alla Russia, che in cambio avrebbe invece secondo Seul fornito assistenza tecnologica per il lancio del primo satellite spia di Pyongyang lo scorso novembre.
Il tutto avviene peraltro mentre le tensioni sulla penisola sono in continua ascesa, sia sul fronte militare sia su quello politico. Prima il record di lanci balistici del 2022, poi l’inasprirsi delle manovre contrapposte con il rafforzamento dell’alleanza con gli Stati Uniti e il Giappone operata da Yoon.
Lo scorso novembre c’è stata la cancellazione dell’accordo militare intercoreano dopo il lancio del primo satellite spia. A inizio 2024 ci sono stati alcuni round di colpi di artiglieria nei pressi della frontiera marittima, che per la prima volta dopo diversi anni hanno portato all’evacuazione delle due isole sudcoreane di Yeongpeyong e Baengnyeong, già teatro di bombardamenti (in quel caso con quattro vittime) nel 2010. Nei giorni scorsi è stato poi testato un sistema d’arma nucleare sottomarino, chiamato Haeil-5-23 e in grado secondo Pyongyang di effettuare attacchi nucleari occulti contro forze navali e porti attraverso dei droni subacquei in grado di creare una sorta di “tsunami radioattivo”.
Dopo aver definito l’obiettivo storico della riunificazione un “errore” nel suo discorso di fine anno davanti alla plenaria del Partito del Lavoro, Kim ha peraltro chiesto di emendare la costituzione nordcoreana per sancire di fatto la separazione e la rivalità col Sud.
La Corea del Sud verrà etichettata come “nemico principale e immutabile”. Verrà inclusa una definizione concreta del territorio del Nord come separato in modo definitivo da quello del Sud. Kim ha anche dichiarato che in caso di conflitto il territorio della Corea del Sud andrebbe “occupato completamente”, con la “sottomissione” totale di Seul. La mossa normativa ha portato immediatamente all’abolizione di tutte le agenzie dedicate alla cooperazione intercoreana. E potrebbe trattarsi di qualcosa di più di una mera azione propagandistica.
Certo, non significa che Kim sia convinto che un conflitto futuro sia inevitabile, ma tra manovre interne e alleanza sempre più esplicita con la Russia di Putin vuole aumentare il suo peso negoziale. Anche nei confronti della Cina, la cui postura in merito alla penisola coreana resta sotto esame. Nelle ultime settimane del 2023 si è svolta una ministeriale degli Esteri a livello trilaterale con Giappone e Corea del Sud, la prima dal 2019. Un summit dei leader con Xi Jinping, Fumio Kishida e Yoon, al di là del contenuto delle discussioni, sarebbe anch’esso un segnale rilevante. E un ulteriore ingrediente in un menù che continua ad arricchirsi, ma anche e soprattutto a rischiare di diventare per qualcuno indigesto.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
“Un lavoratore pragmatico per l’indipendenza di Taiwan”. Così si era definito in passato Lai Ching-te, il vincitore delle elezioni presidenziali taiwanesi di sabato 13 gennaio. Una frase rimasta scolpita nelle menti della Cina continentale, che lo reputa un “secessionista radicale”. Nonostante da allora Lai abbia molto smussato le sue posizioni, ponendosi in perfetta linea con la più moderata presidente uscente Tsai Ing-wen, Lai viene ritenuto come più “imprevedibile” da Pechino, così come forse anche da Washington e da alcuni taiwanesi, convinti comunque dalle sue ripetute garanzie che manterrà lo status quo.
Dunque niente “unificazione” (o “riunificazione” come la chiama Pechino), ma nemmeno una dichiarazione di indipendenza formale che porterebbe Taiwan a superare la cornice della Repubblica di Cina entro la quale è indipendente de facto, pur se riconosciuta da soli 12 Paesi in tutto il mondo dopo la rottura dei rapporti operata da Nauru lunedì 15 gennaio. Appena due giorni dopo la vittoria di Lai, in quella che sembra come una prima reazione cinese alla vittoria del leader del Partito progressista democratico (DPP), che al contrario dell’opposizione dialogante del Kuomintang (KMT) non riconosce il “consenso del 1992”, un controverso accordo tra le due sponde che riconosce l’esistenza di una “unica Cina” pur senza stabilire immediatamente quale.
La base da cui può partire qualsiasi forma di dialogo, secondo Pechino, che pare dunque destinata a non ascoltare le richieste di Lai che si è ripetuto (come già fatto da Tsai) disponibile a un dialogo purché questo sia basato sui principi di “parità” e “dignità”. In sostanza, il DPP richiede che il Partito comunista riconosca che Pechino e Taipei sono al momento due entità separate e non interdipendenti l’una dall’altra. Richiesta irricevibile a cui il PCC replica con il prerequisito del “consenso del 1992” e dunque dell’implicito riconoscimento che Taiwan fa parte della Cina, seppure il KMT specifichi “Cina con diverse interpretazioni”, sottolineando che non accetta il modello “un Paese, due sistemi” di Hong Kong che Xi Jinping vorrebbe imporre anche a Taiwan dopo la “riunificazione”.
65 anni compiuti lo scorso ottobre, proviene da un ambiente molto più modesto rispetto agli ultimi due presidenti, Tsai e Ma Ying-jeou, entrambi appartenenti a famiglie benestanti. Nato nell’attuale Nuova Taipei, Lai è stato allevato dalla madre insieme a cinque fratelli dopo la morte del padre in una miniera di carbone, avvenuta quando lui aveva solo due anni. Lai è cresciuto insieme a cinque fratelli in una casa minuscola.
La sua ascesa è stata però inarrestabile. Prima di quella politica, quella professionale visto che è diventato medico e ha studiato ad Harvard. Una volta che è stata dichiarata la fine della legge marziale, nel 1987, Lai ha abbandonato la professione medica per dedicarsi alla politica. La sua lunga carriera è iniziata come deputato, poi è stato sindaco di Tainan, l’antica capitale prima dell’occupazione giapponese. Poi è stato premier durante il primo mandato di Tsai, ma a fine 2018 succede qualcosa.
Il DPP perde in modo sonoro le elezioni locali e il KMT sembra destinato a vincere le presidenziali in programma a inizio 2020. Lai, alla guida della corrente più radicale del DPP, è protagonista di un duro scontro con l’establishment del partito, tanto che qualcuno reputa non impossibile una scissione. Lo frattura poi si ricompone con il miglioramento della situazione per il DPP, favorito dalla repressione delle proteste di Hong Kong della primavera del 2019 che consentono di spostare la campagna elettorale sul tema identitario e delle relazioni intrastretto, facendo passare il KMT come “filocinese”. Tsai promette a Lai la vicepresidenza, tradizionalmente anticamera della candidatura presidenziale quattro anni dopo.
Così è stato. Lai ha trascorso tutta la campagna elettorale nel provare a convincere gli elettori di essere in piena linea con Tsai sulle relazioni intrastretto, garantendo che manterrà lo status quo. Pechino non si fida ma potrebbe comunque pazientare, in attesa di ascoltare il suo discorso di insediamento il prossimo 20 maggio e di vedere le prime politiche che metterà in atto da presidente in carica. Soprattutto, la Cina può far leva sulla sconfitta del DPP alle elezioni legislative.
Il partito di Lai, infatti, non solo ha perso oltre due milioni e mezzo di voti alle presidenziali rispetto al 2020, ma ha anche perso la maggioranza in parlamento dopo otto anni. Il KMT è il primo partito con 52 seggi, uno in più del DPP ma comunque non abbastanza per avere la maggioranza assoluta. Sarà dunque decisivo il ruolo del terzo incomodo, il Partito popolare di Taiwan (TPP) di Ko Wen-je, ex sindaco di Taipei che si è presentato con una piattaforma che lui definisce “pragmatica e anti ideologica” e basata su temi più concreti, tanto da riscontrare il favore di buona parte dell’elettorato più giovane.
Il sì o il no alle riforme o al budget di difesa potrebbe passare da lui. Pechino potrebbe cercare di far leva sulle frammentazioni interne per guadagnare dei punti politici in vista del cruciale 2027, anno in cui è in programma il XXI Congresso del Partito comunista cinese in cui Xi potrebbe cercare un quarto mandato, proprio nel momento in cui ci sarà la campagna elettorale per le presidenziali taiwanesi del 2028. Una contingenza temporale che potrebbe risultare davvero decisiva, più di quella di questa metà di gennaio.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
La premier Sheikh Hasina ha vinto il suo quinto mandato con il 90% dei voti. Bassa l’affluenza alle urne, il 40%. L’opposizione, messa ai margini, ha organizzato posti di blocco per boicottare il voto, la polizia ha sparato contro gli attivisti.
L’unica cosa certa anche alla vigilia era il risultato: alle elezioni in Bangladesh la premier Sheikh Hasina ha conquistato il suo quinto mandato, il quarto consecutivo dopo il ritorno al potere del 2009. D’altronde era difficile pensare altrimenti, visto che il voto è stato boicottato da un’opposizione messa sempre più ai margini. Tutto il resto, però, conferma che il Paese dell’Asia meridionale, importante hub produttivo, si sta allontanando sempre di più dal poter essere considerato una democrazia.
Il partito Awami League di Hasina si è assicurato 223 dei 299 seggi del parlamento. I candidati indipendenti, molti dei quali selezionati dallo stesso partito di maggioranza e dai gruppi associati, hanno conquistato 62 seggi, mentre il Partito Jatiya ne ha ottenuti 11. Gli ultimi tre seggi sono finiti a tre partiti minori.
Ma il Partito nazionalista del Bangladesh, la principale forza di opposizione, non era presente al voto. Così come non c’era lo Jamaat-e-Islami. Giocando sempre più da solo, il partito della “donna di ferro” Hasina hacontinuato progressivamente a crescere a ogni tornata elettorale: dal 48% del 2008 al 90% di oggi.
Hasina e Awami League puntavano tutto sull’affluenza per dare legittimità al voto. Il test è fallito: la commissione elettorale ha dichiarato che l’affluenza dei circa 120 milioni di elettori è stata intorno al 40%. Una percentuale dimezzata rispetto all’80% delle elezioni del 2018. Tanto che, mentre Hasina e il suo partito esultano per la vittoria, l’opposizione celebra il “boicottaggio riuscito”. Una situazione che presumibilmente rischia di frammentare il Paese anche nei prossimi anni.
Il voto si è svolto d’altronde in un clima di enorme tensione. Da settimane, attivisti e membri dell’opposizione, anche dall’estero, denunciano le elezioni come una “farsa”. Migliaia di esponenti dell’opposizione sono stati arrestati negli ultimi mesi, compreso il segretario generale del Partito nazionalista, Mirza Fakhrul Islam Alamgir. L’ex premier Khaleda Zia è in regime di residenza sorvegliata, mentre il figlio Tarique Rahman si trova in esilio a Londra, da dove attacca a ripetizione il governo. Secondo le accuse, Rahman sarebbe coinvolto in un attacco del 2004 in cui Hasina rimase ferita. Humans Right Watch ha denunciato una “violenta repressione autocratica”, ma la premier non si è fatta impressionare e giustifica la stretta e gli arresti come l’unico metodo a disposizione per difendersi da violenze e rivolte.
D’altronde, proprio durante la giornata del voto di domenica 7 gennaio, Hasina ha etichettato il principale partito dell’opposizione come una “organizzazione terroristica”, presentandosi come l’unica in grado di difendere la democrazia del Bangladesh. Una presa di posizione arrivata dopo che gli attivisti del Partito nazionalista e di altre forze minori hanno indetto uno sciopero generale e organizzato posti di blocco per convincere i cittadini a non recarsi alle urne.
In alcune occasioni, la polizia ha aperto il fuoco contro gli attivisti che stavano evitando il regolare svolgimento del voto, anche se le autorità non segnalano vittime o feriti. È morto invece un sostenitore di Hasina durante alcuni degli scontri che si sono verificati sul territorio. L’episodio più grave è stato il presunto incendio doloso di un treno di pendolari che ha causato 4 morti e 8 feriti. La polizia ha arrestato 8 persone e l’Awami League ha accusato il Partito nazionalista della tragedia. L’opposizione sostiene invece si tratti di “atti di sabotaggio pianificati da parte di funzionari governativi volti a screditare il nostro movimento non violento”.
Mentre gli attivisti provavano a far boicottare il voto, il partito di governo ha cercato di forzare i cittadini a recarsi alle urne. Secondo alcune testimonianze riportate dai media internazionali, alcuni elettori hanno affermato di essere stati minacciati di confisca delle tessere statali necessarie a ricevere l’assistenza welfare se si fossero rifiutati di votare. Sempre durante le operazioni di voto, il Manab Zamin, uno dei principali quotidiani del Bangladesh con una posizione critica nei confronti del governo, avrebbe subito dei blocchi su internet.
Il potere di Hasina, 76 anni, nasce lontano: è la figlia di Sheikh Mujibur Rahman, padre fondatore del Bangladesh. Già premier dal 1996 al 2001, dopo il ritorno al potere del 2009 ha adottato una linea progressivamente più assertiva, tanto che il suo governo è stato più volte accusato di abusi dei diritti umani e di repressione dell’opposizione. Allo stesso tempo, in molti le riconoscono il merito di aver risollevato il Bangladesh dalla povertà rilanciando l’economia del Paese. Partendo dall’immensa industria dell’abbigliamento, ma andando oltre attraendo diversi investimenti e lo spostamento di alcune linee produttive di aziende internazionali.
Di recente, il Fondo monetario internazionale ha dato il via libera alla prima revisione del pacchetto di salvataggio da 4,7 miliardi di dollari, garantendo al Bangladesh accesso immediato a circa 468,3 milioni e mettendo a disposizione 221,5 milioni per il programma di lotta al cambiamento climatico. Contestualmente, però, la popolazione ha spesso protestato negli ultimi mesi per l’inflazione e l’aumento del costo della vita.
Sul piano internazionale, un punto a favore di Hasina è stato senz’altro il vasto piano di accoglienza fornito alla minoranza Rohingya in fuga dal Myanmar. Quasi un milione di rifugiati si trovano attualmente in Bangladesh, che allo stesso tempo starebbe rafforzando i rapporti con la Cina. Gli Stati Uniti e l’Unione Europea restano però i principali acquirenti di capi d’abbigliamento prodotti in Bangladesh, la principale industria di valuta estera del Paese. Anche per questo Hasina spera di evitare che alle accuse di repressione dell’opposizione facciano seguito delle sanzioni. La premier ha bisogno di successi economici per evitare che le turbolenze interne sfocino dal fronte politico a quello sociale.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
A rischio il futuro politico del Primo Ministro Fumio Kishida per uno scandalo legato a fondi neri del Partito liberaldemocratico da lui guidato e che regna da decenni in Giappone. Una vicenda che può avere effetti anche sul sistema di alleanze internazionali.
L’assetto dell’Asia orientale è in costante evoluzione. Processi già in corso sul versante politico-commerciale (come la riorganizzazione delle catene di approvvigionamento) e sul versante strategico (la corsa al riarmo) hanno acquisito una maggiore velocità in seguito alla pandemia di Covid-19 e alla guerra in Ucraina.
Ma il timore diffuso di un crescente allineamento sinorusso e il fastidio cinese per le manovre indopacifiche di Stati Uniti e alleati non sono l’unico fattore di questo processo di riassetto. Al centro ci sono infatti anche dinamiche interne. Non è certo la stessa cosa, in Corea del Sud, avere un presidente democratico come Moon Jae-in o uno conservatore come Yoon Suk-yeol. Così come non è certo la stessa cosa, nelle Filippine, avere un leader filocinese come Rodrigo Duterte e uno rivelatosi come filostatunitense come Ferdinand Marcos Junior.
In Giappone, il consenso sulla posizione in politica estera è più diffuso, anche perché da decenni regna pressoché incontrastato il Partito liberaldemocratico che fu di Shinzo Abe e che è ora guidato dal primo ministro Fumio Kishida. Eppure, non tutti i grandi dirigenti dell’immenso partito sono uguali. E Kishida non è certo il più falco, né la più colomba. Ecco perché è importante osservare quanto sta accadendo nella politica interna giapponese anche da un punto di vista più ampio.
Nel 2024, il Partito liberaldemocratico terrà un’elezione interna per decidere il suo prossimo leader, che automaticamente sarà il candidato premier in vista delle prossime elezioni che si terranno al più tardi nel 2025.
Le possibilità di Kishida si sono improvvisamente ridotte dopo un ampio scandalo in corso nelle ultime settimane e che ha portato a uno stravolgimento nella formazione del governo. Quattro ministri sono stati costretti a dimettersi a causa di uno scandalo relativo alla raccolta di fondi che ha coinvolto la fazione più potente del partito al governo. Si presume che più di 500 milioni di yen (2,8 milioni di sterline; 3,4 milioni di dollari) siano finiti nei fondi neri in un periodo di cinque anni fino al 2022. Anche la procura di Tokyo ha avviato un’indagine per corruzione.
Il capo segretario di gabinetto e portavoce del governo Hirokazu Matsuno, considerato il braccio destro di Kishida e il volto del suo governo, figura tra i quattro ministri costretti a farsi da parte. Un brutto colpo per il premier, che ha dovuto accettare anche le dimissioni del ministro dell’Economia e dell’Industria Yasutoshi Nishimura, del ministro degli Interni Junji Suzuki e del ministro dell’Agricoltura Ichiro Miyashita. Inoltre, si sono dimessi anche cinque viceministri senior e un viceministro parlamentare della stessa fazione, precedentemente guidata dal defunto primo ministro Shinzo Abe.
Conosciuta anche come gruppo politico Seiwa, la fazione aveva fissato delle quote per i suoi membri sulla vendita dei biglietti per gli eventi di raccolta fondi del partito. Quando le loro vendite superavano le quote, i membri ricevevano fondi aggiuntivi. Di per sé, ciò non viola la legge giapponese. Tuttavia, le accuse suggeriscono che le entrate aggiuntive sono state tenute fuori dai libri contabili e sono invece finite nei fondi neri. Lo stesso Matsuno è accusato di non aver dichiarato entrate superiori a 10 milioni di yen.
Anche altre importanti fazioni all’interno del Partito, inclusa quella precedentemente guidata da Kishida, si trovano ad affrontare accuse simili legate alle entrate derivanti dalla raccolta fondi. Il premier ha dichiarato che avrebbe affrontato le accuse “frontalmente”, ma lo scandalo potrebbe costargli caro a livello politico.
Il tasso di sostegno al gabinetto è sceso al 22,3%, nuovo minimo storico, mentre quello per il Partito liberaldemocratico è sceso sotto il 30% per la prima volta da quando è tornato al potere più di dieci anni fa. Il tasso di disapprovazione è invece salito al livello record del 65,4%.
Il sondaggio ha anche mostrato che il 75% degli intervistati ritiene che Kishida manchi di leadership nell’affrontare lo scandalo dei fondi. E la fiducia in un cambio di rotta è bassa, tanto che il 77,2% degli intervistati crede che il Partito non sarà in grado di correggere i propri errori.
Kishida, già nel mirino per l’aumento dell’inflazione e i mancati risultati raggiunti sul piano economico a fronte dell’annuncio in campagna elettorale di un “nuovo capitalismo” più attento alle persone, rischia di vedere in bilico il suo futuro politico.
Una vicenda che potrebbe avere un impatto significativo non solo sul Giappone, ma anche sul sistema di alleanze (compresa quella con la Corea del Sud dopo la fine di una lunga guerra commerciale) che il premier ha rilanciato con forza.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Quando lo scorso 10 settembre Joe Biden ha varcato la soglia del quartier generale del Partito Comunista Vietnamita di Hanoi, il mondo ha raccontato quel momento come “storico”. Non era un’esagerazione, ma era sbagliato pensare che quella visita del presidente degli Stati Uniti avesse improvvisamente arruolato o anche solo sbilanciato il Vietnam nei suoi rapporti internazionali.
La prova di questo arriva martedì 12 e mercoledì 13 dicembre, quando in visita di Stato nel Paese del Sud-Est asiatico ci sarà Xi Jinping. Si tratta del terzo viaggio del presidente cinese in Vietnam, dopo i due precedenti del 2015 e del 2017. Sei anni dopo, è cambiato praticamente tutto.
La guerra in Ucraina ha spinto Hanoi a comprare armi e cercare tutela dagli Usa, per il timore di un crescente allineamento sinorusso e le difficoltà di Mosca a mandare armi come ha sempre fatto.
Ma subito dopo il viaggio di Biden, che con sé aveva portato decine di grandi imprese americane tra cui alcune tra le principali del settore di difesa, Hanoi ha cominciato a mandare segnali di garanzia verso Pechino. Secondo i media di Stato cinesi, il viaggio di Xi sarà concentrato su sei grandi aree: politica, sicurezza, cooperazione pratica, supporto pubblico, questioni multilaterali e problemi marittimi.
L’ultimo tassello di questo elenco è osservato con grande attenzione, vista l’irrisolta disputa territoriale sulle isole Paracelso nel mar Cinese meridionale. Prima dell’avvento di Ferdinand Marcos Junior, che ha portato le Filippine con grande decisione nell’alveo del sistema di alleanze statunitense in Asia-Pacifico, il Vietnam era senz’altro il Paese più deciso a far rispettare le proprie rivendicazioni tra quelli dell’area. E negli ultimi mesi le forze vietnamite hanno accelerato sulla costruzione di infrastrutture e sulla loro presenza nei pressi delle acque contese. Lo stesso ha fatto la Cina, che anzi ha mandato più spesso del solito navi nei tratti di mare più caldi, anche in risposta alla visita della portaerei americana Ronald Reagan al porto di Da Nang, vale a dire la città che sta esattamente di fronte alle isole contese e che ospita anche un museo che reitera le rivendicazioni vietnamite sul tema.
Ciò nonostante, il rapporto commerciale e politico tra Hanoi e Pechino continua a viaggiare spedito. Xi incontrerà, molto significativamente, tutti e 4 i cosiddetti pilastri del sistema politico vietnamita: il segretario generale del Partito comunista Nguyen Phu Trong (che da un anno prima di Xi ha avviato uno storico terzo mandato dopo la rottura del vincolo ufficioso dei due mandati), il presidente Vo Van Thuong, il primo ministro Pham Minh Chinh e il capo dell’assemblea nazionale Vuon Dinh Hue.
In cima all’agenda delle discussioni ci dovrebbe essere il trasporto ferroviario, con l’intenzione reciproca di costruire una linea ferroviaria ad alta velocità lungo il confine, dopo i progetti già conclusi da aziende cinesi in Indonesia e in Laos. Ampio spazio poi alla transizione energetica, col Vietnam a caccia di pannelli solari per sviluppare la sua industria fotovoltaica. La Cina, che domina il settore, può aiutare.
Hanoi e Pechino hanno profondissimi rapporti commerciali. Nonostante il Vietnam stia diventando sempre di più meta privilegiata delle grandi aziende internazionali, colossi digitali in primis, che cercano di diversificare le proprie linee di produzione dalla Cina, è impensabile una strategia di “riduzione del rischio” nei confronti di Pechino come quella promossa dall’Occidente.
Allo stesso tempo, in Vietnam non si è mai cancellato il ricordo dei quasi mille anni di dominazione dell’impero cinese. Pechino è senz’altro il vicino che fa più paura, anche se allo stesso tempo il Vietnam ha subito le guerre col coinvolgimento di Francia e Stati Uniti, diventando il luogo che forse più di tutti ha subito le devastazioni “calde” della prima guerra fredda. Ecco forse perché ora più di tutti il Vietnam vorrebbe evitarne una seconda, avvicinanosi agli Usa ma riaffermando il suo rapporto stretto con la Cina. Legami che sfociano sul fronte ideologico, vista la leadership comunista in entrambi i Paesi.
Le tensioni resteranno celate durante il viaggio di Xi, ma non significa che siano cancellate. Anche perché alla vigilia dell’arrivo del presidente cinese, ci sono state manovre navali vicino alle isole contese, mentre altre navi hanno attraccato per la prima volta in un porto in Cambogia, a poche decine di chilometri dal confine vietnamita. Peraltro non è escluso un trialterale che coinvolga oltre a Xi e i leader vietnamiti anche Hun Manet. Il premier cambogiano, erede di Hun Sen dopo le elezioni dello scorso luglio, si trova infatti in viaggio ad Hanoi lunedì 11 e martedì 12 dicembre.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Un tranquillo weekend di paura, quello appena vissuto dalle Filippine. Tra eventi naturali estremi, attentati terroristici e dispute territoriali, a Manila e dintorni le ultime 48 ore sono state un susseguirsi di emozioni. E soprattutto di problemi.
A partire da sabato mattina, quando un terremoto di magnitudo 7,6 ha colpito la parte orientale di Mindanao, grande isola nella parte meridionale dell’arcipelago filippino. Non una primizia, visto che il Paese si trova sul cosiddetto Anello di fuoco del Pacifico, un’area di grande attività sismica e vulcanica in cui si registrano ogni anno circa settemila terremoti. Ma quello di sabato ha avuto un’entità ben più grave degli eventi sismici consueti, tanto da portare le autorità filippine a emettere un allarme tsunami. A distanza di qualche ora, l’allarme è stato poi revocato, anche se sono arrivate onde oltre un metro al di sopra della marea.
Meno di 24 ore dopo, ancora Mindanao è stata oggetto delle cronache. Questa volta per un attentato terroristico, con un’esplosione durante una messa cattolica che ha ucciso almeno 4 persone ferendone circa 50. L’attacco è avvenuto a Marawi, capitale della provincia di Lanao del Sur. A essere colpita è stata una palestra dell’università di Mindanao, dove si stava svolgendo la messa della prima domenica di avvento. Sulla scena sono stati trovati frammenti di mortaio, mentre le ambulanze hanno continuato a lungo a trasportare i feriti in ospedale. Nessun dubbio che si tratti di un attentato. È subito partita la caccia all’uomo, con la polizia che ha imposto una serie di posti di blocco sulle strade e nei porti dell’isola di Mindanao.
Il presidente filippino Ferdinand Marcos Junior ha incolpato “terroristi stranieri”. Aggiungendo: “Gli estremisti che compiono violenze contro gli innocenti saranno sempre considerati nemici della nostra società. Porgo le mie più sentite condoglianze alle vittime”, ha sottolineato Marcos, assicurando di aver chiesto una maggiore sicurezza nella regione. “Siate certi che consegneremo alla giustizia gli autori di questo atto spietato”.
Anche il ministro degli Esteri Teodoro Locsin Junior ha confermato che “ci sono indizi che l’attacco sia stato condotto da elementi stranieri”, senza entrare nello specifico. Secondo il segretario alla Difesa Gilbert Teodoro, l’attentato ricorda nello stile l’attacco alla cattedrale di Nostra Signora del Monte Carmelo a Jolo, Sulu, nel gennaio 2019, che causò la morte di 23 persone.
Va sottolineato che l’attacco si inserisce in un contesto di alta tensione tra governo centrale e Mindanao, regione con una forte presenza musulmana. Da decenni sul territorio operano gruppi armati con velleità indipendentiste. Proprio nei giorni scorsi un’operazione miltiare ha portato all’uccisione del leader di un gruppo islamista affiliato all’Isis, il Daula Islamiyah. Lo stesso gruppo che nel 2017 si era impadronito di Marawi, cercando di farne un governatorato islamista. All’epoca si era combattuto per cinque mesi con un bilancio finale di oltre mille morti, tra cui anche un centinaio di civili.
A Manila c’è il timore che l’attacco di domenica possa segnare l’inizio di un nuovo periodo di turbolenze interne. L’ultima cosa necessaria a un paese già impegnato a far fronte a una pericolosa disputa territoriale con la Cina nel mar Cinese meridionale.
Una disputa che si sta inasprendo. Sempre domenica 3 dicembre, le autorità delle Filippine hanno dichiarato che oltre 135 navi della Milizia Marittima Cinese hanno “sciamato” nell’area di Julian Felipe Reef, a circa 175 miglia nautiche dalla costa di Bataraza, Palawan. Foto e video diffusi dalla Guardia costiera mostrano diversi gruppi di navi della Milizia Marittima Cinese ormeggiate l’una accanto all’altra. Si tratta di una mossa che gli analisti definiscono “rafting”, ovvero quando le navi si ancorano insieme per creare un avamposto galleggiante temporaneo in mare. È considerata una delle “tattiche della zona grigia”, ovvero delle azioni al di fuori di un conflitto armato che vengono però impiegate per mostrare assertività su una contesa territoriale.
L’arrivo di Ferdinand Marcos Junior ha cambiato tutto nei rapporti tra Filippine e Cina. Manila ha concesso libero accesso alle truppe americane in 4 sue ulteriori basi. Le esercitazioni congiunte di quest’anno sono state le più vaste di sempre, mentre sono state avviate trattative per sviluppare un porto civile nelle remote isole più settentrionali dell’arcipelago, quelle più vicine a Taiwan.
In risposta, Pechino ha aumentato la presenza nei pressi di Second Thomas, una minuscola secca all’interno dell’arcipelago delle Spratly, un centinaio di piccole isole rivendicate dalla Cina. È qui che si trova la Sierra Madre, una nave di fabbricazione statunitense impiegata durante le battaglie contro i giapponesi nel Pacifico durante la Seconda Guerra Mondiale. Rimasta alla deriva, è passata poi di mano alle Filippine.
Nel 1999, Manila ha deciso di arenare il vecchio relitto nei pressi della secca. I resti dell’imbarcazione sono utilizzati dalle Filippine come un avamposto, presidiato da una dozzina di militari, per rafforzare le proprie pretese di sovranità. Da allora, Pechino chiede a Manila di rimuovere il relitto in maniera più o meno diplomatica a seconda dello stato dei rapporti col governo filippino.
Il governo cinese non riconosce la validità del pronunciamento del tribunale dell’Aia, che nel 2016 si è espresso contro la sua rivendicazione di sovranità su circa il 90% del mar Cinese meridionale. E finora non si è mai riusciti a stipulare un agognato codice di condotta regionale su un quadrante fondamentale per il passaggio di enormi quantità di merci ma anche per le sue risorse naturali. Da agosto in avanti si sono succeduti alcuni incidenti, tra cannoni ad acqua e collisioni tra navi, fortunatamente senza gravi conseguenze. Ma una soluzione alla questione ancora non si intravede.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Nel corso del colloquio di Busan i tre ministri degli Esteri hanno concordato di far progredire la cooperazione in sei aree, tra cui la sicurezza, l’economia e la tecnologia, e di preparare il prossimo vertice trilaterale dei leader dei tre giganti dell’Asia orientale
Cina, Giappone e Corea del Sud insieme allo stesso tavolo. Era difficile potesse (ri)succedere viste le tensioni degli ultimi anni, acuite soprattutto dalla guerra in Ucraina. E invece è successo. Domenica 26 novembre a Busan, importante città portuale della Corea del Sud, si è svolta la prima ministeriale degli Esteri tra i tre big dell’Asia orientale a distanza di quattro anni dall’ultima volta.
Un primo incontro di “studio”, che non ha portato svolte o accordi clamorosi, ma che è già di per sé un risultato importante perché riavvia un dialogo trilaterale che sembrava chiuso. Non solo. I ministri di Pechino, Tokyo e Seul si sono accordati per tenere il prima possibile un summit dei tre leader, che non si svolge dal 2019. Quasi un’altra epoca.
Allora, in Giappone c’era ancora il primo ministro Shinzo Abe e in Corea del Sud c’era il presidente democratico Moon Jae-in. Una contingenza favorevole al dialogo, con il leader cinese Xi Jinping che nel 2020 avrebbe dovuto recarsi sia a Tokyo sia a Seul per suggellare una “nuova era” dei rapporti. Viaggi mai avvenuti a causa dell’inizio della pandemia di Covid-19. Nel frattempo è cambiato tutto. Abe è stato assassinato nel luglio 2020 e nel marzo 2022, poche settimane dopo l’invasione russa, in Corea del Sud ha vinto le elezioni il conservatore Yoon Suk-yeol.
Nel corso del colloquio di Busan, durato 100 minuti, i ministri hanno concordato di far progredire la cooperazione in sei aree, tra cui la sicurezza, l’economia e la tecnologia, e di promuovere discussioni concrete per preparare il vertice trilaterale. Wang ha anche invitato i tre Paesi a riavviare al più presto i negoziati per un accordo trilaterale di libero scambio.
Le distanze, ovviamente, restano su diversi temi. A partire dal posizionamento strategico. Il cinese Wang Yi ha detto che i tre Paesi dovrebbero “opporsi alla demarcazione ideologica e resistere a mettere la cooperazione regionale in campi avversi”, un riferimento all’approfondimento dei rapporti di Tokyo e Seul con gli Stati Uniti. Nonostante Xi abbia incontrato il 15 novembre Joe Biden a San Francisco per ridurre le tensioni tra le due potenze, le frizioni restano. E l’architettura di sicurezza messa in piedi da Washington con Tokyo e Seul disturba molto Pechino.
A marzo 2023, Yoon ha riavviato i rapporti col Giappone, operando un allineamento a livello trilaterale degli scambi in materia di sicurezza con il vicino (tradizionalmente odiato) e Washington. Ad aprile, Yoon è stato alla Casa Bianca in visita di Stato, ottenendo l’estensione dell’ombrello nucleare. Ha poi ospitato a Busan un sottomarino americano a propulsione nucleare, ha aumentato esponenzialmente le esercitazioni congiunte e si prepara al pieno dispiegamento del Terminal High Altitude Area Defense (Thaad), il sistema di radar antimissile americano il cui primo acquisto nel 2016 causò una durissima battaglia diplomatica tra Corea del Sud e Cina. Ad agosto è andato in scena il summit di Camp David, che ha riunito proprio Yoon, Biden e il premier giapponese Kishida. Senza contare che Giappone e Corea del Sud sono sempre più integrati nell’orbita di partnership della Nato, tanto che non è da escludere un riavvio dei colloqui sulla possibile apertura di un ufficio di rappresentanza dell’Alleanza Atlantica a Tokyo.
Eppure, il riavvio del dialogo trilaterale con la Cina è considerato fondamentale per provare a ridurre le tensioni in Asia orientale. Il tempismo della ministeriale di Busan è interessante anche perché avviene pochi giorni dopo il lancio del primo satellite spia da parte della Corea del Nord. Era da tempo che Pyongyang provava nell’impresa, mancata per due volte negli scorsi mesi. Tanto da costare il posto al capo di stato maggiore, licenziato ad agosto.
Il terzo tentativo è stato quello buono. La differenza potrebbe averla fatta l’incontro di Vladivostok tra Kim Jong un e Vladimir Putin, avvenuto a settembre. Secondo i servizi segreti di Seul, dopo il vertice tra i due leader la Corea del Nord avrebbe fornito alla Russia progetto e dati dei lanci falliti. Mosca li avrebbe analizzati e fornito i suggerimenti necessari al lancio. In cambio di aiuti militari per la guerra in Ucraina. Secondo i media di regime, il satellite sarebbe già in grado di raccogliere immagini della base militare statunitense di Guam, cruciale epicentro strategico del Pacifico. Gli esperti sudcoreani per ora non confermano e sostengono possa anche trattarsi di un bluff.
La tensione è cresciuta ulteriormente dopo che Seul ha annunciato prima la sospensione parziale dell’accordo militare intercoreano del 2018, poi la cancellazione totale dopo che Pyongyang ha risposto con il lancio (fallito) dell’ennesimo missile balistico. Giovedì 30 novembre anche Seul lancerà il suo satellite spia (mentre il capo dell’intelligence Kim Kyou-hyun si è appena dimesso), già da lunedì 27 sono state avviate esercitazioni congiunte con Usa e Giappone.
La Corea del Nord ha preannunciato il lancio di altri satelliti e ha inviato truppe al suo confine meridionale per ripristinare i posti di guardia che erano stati rimossi dall’accordo del 2018. Pyongyang ha spiegato che il suo esercito non sarà più “vincolato” dall’intesa e riprenderà tutte le attività che erano state interrotte negli ultimi cinque anni.
Tornando a parlare con Pechino, Corea del Sud e Giappone sperano in un maggiore controllo sulle azioni di Kim da parte di Xi Jinping, che in passato ha mostrato più volte di non gradire le sue intemperanze. La giapponese Yoko Kamikawa ha affermato che una maggiore cooperazione trilaterale contribuirebbe alla pace regionale, dato che la situazione della sicurezza internazionale è diventata “più grave e complessa che mai”.
Da capire la prospettiva cinese sull’avvicinamento tra Pyongyang e Mosca. A fine luglio, Xi ha inviato una delegazione di tono minore per le celebrazioni dell’armistizio della guerra di Corea, al contrario della Russia che ha spedito il ministro della Difesa Sergei Shoigu. Delegazione minore anche per le celebrazioni dell’anniversario della fondazione della Repubblica Popolare di Corea e primi contatti per riavviare il meccanismo trilaterale con Giappone e Corea del Sud proprio a cavallo del vertice tra Kim e Putin.
Ma è tutto da vedere che la Cina voglia o possa premere sulla Corea del Nord per abbassare le tensioni, proprio perché in cambio vorrebbe un rallentamento del rafforzamento dell’asse Seul-Tokyo-Washington. Nel summit con Biden, Xi ha chiesto di tenere in considerazione le “legittime preoccupazioni di sicurezza” della Corea del Nord, stessa formula utilizzata tante volte sulla Russia a proposito del conflitto in Ucraina.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Il futuro di Taiwan è appeso all’interpretazione del margine d’errore statistico nei sondaggi d’opinione. Può sembrare strano, ma le prospettive sulle elezioni presidenziali taiwanesi del prossimo 13 gennaio, da cui dipendono anche i rapporti intrastretto fra Taipei e Pechino con importanti riflessi sulle relazioni tra Stati Uniti e Cina, sono legate a qualche punto decimale. Non sui risultati delle urne, ma sui sondaggi d’opinione commissionati dall’opposizione per individuare un candidato unitario.
Le candidature ufficiali vanno depositate entro le 17 di venerdì 24 novembre. Fino a pochi giorni fa, la vittoria del Partito progressista democratico (DPP) appariva quasi scontata. Non fosse altro che il campo “verde”, quello che chiede il riconoscimento di Taiwan come entità non interdipendente rispetto alla Repubblica Popolare Cinese, ha un solo candidato. Si tratta di Lai Ching-te, attuale vicepresidente e leader del DPP che mira a prendere il posto della collega di partito Tsai Ing-wen. Tra i due in passato c’è stata più di una frizione, ricomposta in tempo utile per vincere le elezioni del 2020. Ma ora sembra tutto dimenticato, con Lai che ha smussato le sue posizioni più radicali di un tempo e si propone in perfetta continuità con la postura di Tsai. Pechino non si fida e lo percepisce come il candidato a lei più ostile e lo descrive come una figura più imprevedibile rispetto alla già odiata presidente uscente.
Dopo mesi di indiscrezioni e trattative infruttuose, l’opposizione sembrava aver trovato l’accordo per una candidatura unitaria tra le sue due principali anime, il Kuomintang (KMT) e il Taiwan People’s Party (TPP). Durante un incontro presso la fondazione di Ma Ying-jeou, l’ex presidente più dialogante di sempre con Pechino, i rispettivi candidati Hou Yu-ih e Ko Wen-je avevano firmato un accordo per affidarsi al risultato di alcuni sondaggi d’opinione per individuare i candidati a presidenza e vicepresidenza. Sabato 18 novembre era previsto l’annuncio ufficiale e l’istituzione di un ufficio elettorale unitario.
Ma l’annuncio non è mai arrivato, a causa di una diversa interpretazione dei dati. Secondo il KMT, il risultato finale è di 5 a 1 per il suo candidato Hou. Secondo il TPP, si è trattato di un pareggio per 3 a 3. Ko ha contestato il funzionamento del “margine d’errore”, ma il KMT sottolinea che l’ipotetico alleato non ha rispettato i termini dell’accordo da lui stesso firmato. L’ipotesi più credibile è che Ko, non nuovo a improvvisi ripensamenti, si sia accorto di aver concesso una modalità vantaggiosa a Hou. E abbia dunque deciso di fare un passo indietro. In televisione ha raccontato di essersi sentito preso “alla sprovvista” durante i colloqui di mercoledì e sostanzialmente di aver ripetuto più volte “sì” al KMT perché si sentiva sotto pressione. “La prossima volta andrò a parlare non da solo”, ha aggiunto.
Una giustificazione che ha fatto sorgere profondi dubbi a diversi analisti sulle sue capacità strategiche, nonché sull’opportunità di avere Ko come leader. “Se si è fatto convincere a un accordo svantaggioso perché si sentiva sotto pressione col KMT immaginate che potrebbe fare a dialogare col Partito comunista cinese”, dicono in molti. Ko resta comunque apprezzato soprattutto da una parte dell’elettorato più giovane, in cerca di novità dopo 8 anni di governo del DPP e alcune delusioni sul fronte delle politiche economiche, sociali e legate al mondo del lavoro.
Ko e Hou sono pressoché appaiati nei sondaggi e uniti avrebbero il vantaggio dei pronostici contro il DPP. Per questo il KMT sta continuando a provare ad accordarsi con Ko, il quale però potrebbe alla fine decidere di correre da solo se non fosse indicato lui come candidato unitario. Questo anche perché l’ex sindaco di Taipei si è sempre presentato come un’alternativa alla tradizionale polarizzazione tra DPP e KMT, entrambi aspramente criticati anche durante gli ultimi mesi. L’accordo col KMT potrebbe deludere parte della sua base, ma sarebbe giustificabile con la guida del ticket. Un accordo tenendosi in secondo piano assomiglierebbe di più a un assorbimento e a una normalizzazione della proposta “pragmatica” e “non ideologica” di Ko, che a quel punto vedrebbe tramontare anche l’ipotesi di diventare la vera opposizione al DPP nel 2028.
Da tenere in considerazione anche la variabile di “Terry” Gou Taiming, il patron del colosso dell’elettronica Foxconn, principale fornitore di iPhone per Apple. Un paio di settimane fa la Cina ha annunciato indagini a carico dell’azienda che hanno colpito (volutamente o no) la sua campagna elettorale basata sulla capacità di fare affari sia con la Repubblica Popolare Cinese sia con gli Usa. Gou è molto lontano da tutti gli altri candidati nei sondaggi ma Ko ha dichiarato l’intenzione di coinvolgerlo nei colloqui.
Il tempo a disposizione dell’opposizione per trovare la quadra è assai limitato. La possibilità di una candidatura unitaria non è ancora ufficialmente naufragata, ma Ko dice ora di voler correre per la presidenza “fino alla fine” e il KMT chiede invece al leader del TPP un ritorno su suoi passi e all’accordo sottoscritto il 15 novembre.
Scenario complicato. Come detto, le candidature vanno depositate entro venerdì. Al momento l’unica certezza è la candidatura di Lai per il DPP, con l’ex rappresentante di Taipei negli Usa Hsiao Bi-khim a correre per la vicepresidenza. Una scelta dall’alto tasso simbolico, visto che Hsiao è inserita, al contrario di Lai e Tsai, nella lista nera di quelli che Pechino chiama “secessionisti”. Dall’accordo, o mancato accordo, nell’opposizione dipende molto del possibile risultato alle urne. E del futuro dei rapporti tra le due sponde dello Stretto di Taiwan.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Grande attenzione per il summit della Cooperazione Economica Asia Pacifico. L’edizione 2023, aperta nei giorni scorsi a San Francisco, è uno snodo cruciale della diplomazia globale. Anche, ma non solo, per l’attesissimo incontro tra Joe Biden e Xi Jinping.
I leader delle 21 economie del Pacifico che fanno parte dellìAPEC parteciperanno alle prime riunioni solo giovedì 16 novembre, per poi svolgere la seduta plenaria venerdì 17. Ma si inizia a fare sul serio ben prima. A partire da lunedì 13, quando il presidente indonesiano Joko Widodo sarà ricevuto alla Casa Bianca. Nel corso dell’ultimo anno, Biden ha ospitato un’ampia schiera di leader asiatici. Dal premier giapponese Fumio Kishida al presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol (poi peraltro ospitati entrambi al summit di Camp David dello scorso agosto che ha rilanciato l’alleanza trilaterale), dal presidente filippino Ferdinand Marcos Junior al premier indiano Narendra Modi. Widodo va a completare il quadro, rappresentando la principale economia del Sud-Est asiatico, presidente di turno dell’ASEAN e membro dell’APEC.
I piani per l’incontro a Washington sono stati annunciati per la prima volta a settembre, dopo che Biden aveva deluso l’Indonesia non partecipando al summit dell’ASEAN ospitato da Giacarta, inviando al suo posto la vicepresidente Kamala Harris. Se la Cina è un partner economico fondamentale per l’Indonesia, Giacarta è diventata anche un grande acquirente di armi statunitensi e gli esperti regionali si aspettano che le due parti discutano di rafforzare i legami di sicurezza. Ma a Washington fanno gola anche i minerali critici utilizzati per le batterie dei veicoli elettrici, di cui è ricchissima l’Indonesia. A partire dal nichel, dove però la Cina ha costruito nel tempo un grande vantaggio strategico.
In cambio di qualche accordo in materia, Widodo potrebbe chiedere a Biden di sbloccare i 20 miliardi di dollari promessi dai Paesi occidentali per finanziare la transizione energetica dell’Indonesia, obiettivo cruciale di Giacarta utile a favorire la chiusura delle centrali elettriche a carbone. Un ostacolo al dialogo è però rappresentato dal nuovo conflitto in Medio Oriente. L’Indonesia è il Paese musulmano più popoloso al mondo e ha condannato l’invasione di Gaza da parte di Israele dopo l’attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre, chiedendo un cessate il fuoco immediato. Posizione più vicina a quella di Pechino che a quella di Washington.
Mercoledì 15 novembre, Biden incontrerà invece il presidente cinese Xi. Si tratta senz’altro del momento più atteso della settimana, se non del mese o dell’anno, sul fronte diplomatico. Da alcuni mesi Stati Uniti e Cina hanno tessuto pazientemente la tela che ha consentito il via libera di Pechino al viaggio di Xi a San Francisco. Una serie di visite incrociate tra i membri dell’amministrazione Biden e i fedelissimi del leader cinese hanno portato a replicare l’incontro del 2022 a Bali. Ma stavolta non si tratta di un semplice colloquio “a margine”. La stessa diplomazia cinese ha definito l’incontro un “summit” e nel comunicare la partenza di Xi lo ha citato per primo, davanti al meeting APEC. La speranza è che l’incontro produca qualche risultato concreto, a partire dal riavvio del dialogo in materia militare, interrotto sin dall’agosto 2022 dopo il viaggio a Taiwan dell’allora presidente del Congresso, Nancy Pelosi.
Grande attesa anche per il possibile disgelo tra Cina e Giappone. Da Tokyo non hanno nascosto la speranza che si possa tenere un bilaterale tra Kishida e Xi. Potrebbe essere un modo per abbassare le tensioni tra i due giganti asiatici, acuite dal rafforzamento dei rispettivi legami con Stati Uniti per il Giappone e con la Russia per la Cina, nonché dalla vicenda dello sversamento delle acque della centrale nucleare di Fukushima, a cui Pechino ha risposto con un boicottaggio commerciale. Di certo, Kishida incontrerà il presidente sudcoreano Yoon, suggellando il disgelo dei rapporti avviato all’inizio dell’anno. I ministri della Difesa di Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone hanno peraltro appena annunciato di aver concordato l’attivazione di un’operazione di condivisione dei dati in tempo reale sui lanci missilistici nordcoreani già a dicembre
Ma le tensioni strategiche restano. A partire dalle Filippine. Nei giorni scorsi c’è stato un nuovo incidente tra navi di Manila e di Pechino in acque contese del mar Cinese meridionale. A San Francisco ci sarà anche Marcos Jr. Grande attenzione per capire se si terrà un colloquio con Xi. Complicato, vista l’agenda del presidente filippino protagonista di un grandissimo riavvicinamento agli Usa dopo l’era di Rodrigo Duterte. Il Dipartimento degli Affari Esteri di Manila ha infatti confermato che Marcos si recherà negli Stati Uniti il 14 novembre per partecipare al vertice APEC. In seguito visiterà Los Angeles e le Hawaii, dove il clan Marcos si rifugiò dopo che il padre dittatore fu estromesso dal potere nel 1986. Qui visiterà anche il Comando Indo-Pacifico degli Stati Uniti. Si tratta del più grande comando geografico unificato dell’esercito statunitense. Il suo comandante riferisce direttamente al presidente degli Stati Uniti attraverso il segretario alla Difesa e ha alle sue dipendenze diversi comandi componenti e sub-unificati nella regione, comprese le forze statunitensi in Corea del Sud e Giappone. Le unità del Comando Indo-Pacifico si addestrano solitamente con i soldati filippini durante il Balikatan, la più grande esercitazione congiunta annuale tra le forze statunitensi e filippine. La visita di Marcos ha un valore altamente simbolico, con risvolti però anche operativi.
La Cina, ça va sans dire, non apprezzerà. L’altro fronte di tensione sempre aperto è quello di Taiwan. Anche Taipei fa parte dell’APEC ma non può partecipare coi suoi leader politici. Come accade già da diversi anni, la presidente Tsai Ing-wen ha inviato in sua vece Morris Chang, il fondatore del colosso dei microchip TSMC. Come l’anno scorso a Bangkok, Chang potrebbe parlare con Xi, compiendo così uno scambio di alto livello tra le due sponde dello Stretto a pochi mesi dalle elezioni presidenziali taiwanesi del 13 gennaio prossimo.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Mentre si combatte in Ucraina e a Gaza, c’è un altro conflitto con meno riflettori internazionali che continua da ormai quasi tre anni. Si tratta della guerra civile in Myanmar, dove la situazione è finita fuori controllo in una zona a dir poco nevralgica: il confine con la Cina. Anzi, in realtà, persino oltre quella sensibile frontiera con la principale potenza asiatica.
Sabato 4 novembre, un cittadino cinese è stato ucciso e diversi altri sono rimasti feriti quando un proiettile di artiglieria sparato dall’esercito birmano ha apparentemente mancato il bersaglio previsto ed è atterrato sul lato cinese del confine.
Il colpo aveva preso di mira la città di Laiza, sede del quartier generale dell’Esercito per l’Indipendenza Kachin, una delle più grandi e potenti tra le decine di organizzazioni di resistenza etnica che combattono contro la giunta militare protagonista del golpe del 1° febbraio 2021. Il rischio di ulteriori vittime da parte cinese è stato ridotto dall’evacuazione dei residenti dalla città di confine di Naban. Ma da Laiza, come sottolinea Asia Times, non ci sono molte vie di fuga praticabili.
La Cina osserva con grande preoccupazione l’evolversi della situazione birmana sin dal colpo di Stato che ha deposto Aung San Suu Kyi. Ma l’incidente di Laiza rappresenta un’escalation impossibile da ignorare, anche perché i gruppi armati hanno conquistato un avamposto commerciale chiave lungo la frontiera. Si tratta di Chinshwehaw, importante snodo per l’interscambio annuale di 1,8 miliardi di dollari tra Cina e Myanmar. E infatti il governo di Pechino ha subito esortato il Myanmar a “cooperare” per mantenere stabile il confine condiviso.
Il viceministro degli Esteri Nong Rong ha visitato il Myanmar durante il fine settimana per discutere degli scontri che, secondo le Nazioni Unite, hanno causato lo sfollamento di oltre 23.000 persone. Durante la sua visita, Nong ha incontrato il vice primo ministro e ministro degli Esteri Than Shwe e il vice ministro degli Esteri Lwin Oo. In cima all’agenda, la situazione lungo il confine con la provincia dello Yunnan.
Pechino ha chiesto il “cessate il fuoco immediato”, ma gli ultimi combattimenti sottolineano le difficoltà crescenti che il potere militare deve affrontare per controllare il Paese. Un controllo che è tutt’altro che totale. A settembre, il leader ad interim del governo in esilio del Myanmar, Duwa Lashi La, ha dichiarato che le forze di resistenza controllano circa il 60% del territorio della nazione del Sud-Est asiatico e sono pronte a minacciare la giunta nelle sue roccaforti chiave.
A complicare la situazione, il fatto che da tempo la Cina intrattiene rapporti con il gruppo che governa l’autoproclamato Stato Wa nel nord del Paese, un angolo inaccessibile noto come centro del commercio illegale di stupefacenti. Nel recente passato, questi legami sono stati messi alla prova dalla decisione dei Wa di sospendere l’attività estrattiva, tagliando fuori quasi un terzo delle forniture totali di minerale di stagno della Cina. Le tensioni sono state esacerbate dagli sforzi di Pechino per bloccare le truffe cyber nella regione di confine, attività che finanziano il crimine organizzato e spesso prendono di mira i cittadini cinesi. La stretta di Pechino ha preso di mira gli ufficiali dell’Esercito dello Stato di Wa. L’agenzia di stampa statale Xinhua ha recentemente riferito che più di 2.300 sospetti sono stati catturati in Myanmar nell’ambito di un più ampio giro di vite e scortati oltre il confine.
La Cina non ha certo giocato un ruolo nel golpe del 2021 ma ora vorrebbe presumibilmente vedere un ritorno alla stabilità in Myanmar. Questo nonostante Pechino avesse rapporti probabilmente migliori con la Lega nazionale per la democrazia di Aung San Suu Kyi (che ha un rapporto ottimo con Xi Jinping) che non con il Tatmadaw, con il quale è spesso entrata in rotta di collisione sul presunto sostegno alle milizie etniche.
La Cina ha sempre mantenuto interessi importanti in Birmania. Il China-Myanmar Economic Corridor (CMEC) dovrebbe connettere lo Yunnan al golfo del Bengala (e dunque all’oceano Indiano) attraverso il porto di Kyaukpyu, aggirando lo stretto di Malacca. Ma 29 dei 38 progetti in ambito CMEC sono ancora da approvare.
Inoltre, quasi la metà delle importazioni cinesi di terbio e disprosio (terre rare con alto valore atomico) provengono proprio dal Myanmar. L’avvio della transizione democratica era stata deciso dai militari anche per diversificare i rapporti commerciali e diplomatici e ridurre la dipendenza da Pechino. Lo dimostrano anche gli eccellenti rapporti costruiti nel tempo con Russia (soprattutto in materia militare) e India.
Ora però, la Cina ha bisogno che in Myanmar torni l’ordine. Anche se a poterlo garantire dovessero essere i generali golpisti.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
L’ultima volta era ancora il 2017. Sembra quasi un’altra epoca. Prima del Covid, prima della guerra in Ucraina e di quella tra Israele e Hamas, prima persino della guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti. O ancora: prima della rimozione del vincolo dei due mandati presidenziali nella Repubblica Popolare. Ecco, quella fu l’ultima volta in cui Xi Jinping avviò la Conferenza quinquennale sulle politiche finanziarie. A sei anni di distanza, lunedì 30 e martedì 31 ottobre il leader che nel frattempo ha ottenuto e avviato il suo terzo mandato, riunisce a porte chiuse i principali leader cinesi, i dirigenti statali, le autorità di regolamentazione e i banchieri di alto livello. Obiettivo: dare una direzione precisa allo sviluppo finanziario dei prossimi cinque anni.
Un’altra differenza rispetto al passato è che la conferenza si svolge in un momento in cui la crescita economica della Cina sembra aver rallentato il passo e le turbolenze (esterne e interne) hanno in qualche modo scosso l’ecosistema finanziario del gigante asiatico. La crisi immobiliare e l’aumento del debito sono le due preoccupazioni principali, inserite in un contesto in cui il Partito comunista sta provando a rivedere il proprio modello di sviluppo. Dall’alta esposizione debitoria portata da giganteschi progetti infrastrutturali e dagli investimenti a debito dei colossi immobiliari, si sta provando ad arrivare a una crescita di più alta qualità e soprattutto con meno rischi. Provando dunque a schermarsi sia dalle problematiche esterne (leggasi sanzioni, interruzioni delle catene di approvvigionamento, crisi economiche), sia da quelle interne.
La conferenza si dovrebbe non a caso concentrare principalmente sulla risoluzione del debito. Già nel 2018, il governo centrale ha chiesto alle autorità locali di smettere di accumulare i cosiddetti debiti nascosti, canali informali di prestito spesso attraverso veicoli di finanziamento del governo locale. Obiettivo non del tutto raggiunto, anche perché la stretta e l’avvio della conversione del modello di sviluppo cinese sono coincisi con la pandemia prima e la guerra poi. Le difficoltà per il settore immobiliare (su tutti), che erano state già preventivate quando Xi tracciò le cosiddette “tre linee rosse” per ridurre l’esposizione debitoria, sono state acuite dagli eventi esterni. E le casse locali sono strettamente correlate, così come i fondi fiduciari, proprio ai costruttori immobiliari.
Il governo non ha sin qui predisposto mastodontici piani di salvataggio, ma proprio la scorsa settimana è arrivata una mossa piuttosto rilevante, quando Pechino ha approvato l’emissione di 1.000 miliardi di yuan (137 miliardi di dollari) di obbligazioni sovrane, i cui fondi saranno trasferiti ai governi locali per sostenere la ricostruzione e migliorare le capacità di prevenzione e soccorso in caso di disastri. Metà delle obbligazioni dovranno essere emesse e spese prima della fine del 2023 e l’altra metà entro il 2024. La nuova emissione porterà il rapporto tra deficit di bilancio e prodotto interno lordo a circa il 3,8%, ben oltre l’obiettivo del 3% fissato a marzo durante le cosiddette “due sessioni”.
La parola chiave della conferenza sarà come sempre quella: stabilità.
Nell’ultimo anno Pechino ha chiesto alle maggiori banche cinesi di assumersi una parte della responsabilità, fornendo sostegno creditizio ai costruttori in difficoltà e ai veicoli di finanziamento degli enti locali, che hanno un debito di 9 mila miliardi di dollari. La loro crescente esposizione ha suscitato l’allarme di alcuni analisti. Verrà probabilmente chiesto ai governi locali di rispondere della risoluzione del debito nascosto esistente e della prevenzione di nuove passività illecite. In questo senso potrebbe giocare un ruolo importante il nuovo ministro delle Finanze, Lan Foan, nominato al posto di Liu Kun dal Comitato permanente dell’Assemblea Nazionale del Popolo una settimana fa. Lan è il primo titolare delle Finanze in 40 anni a non essere stato prima viceministro. La rapida ascesa è dovuta alla sua esperienza da governatore provinciale, in un momento in cui la priorità del partito è impedire il contagio della crisi immobiliare sulle casse locali.
Nel corso della riunione a porte chiuse ci si aspetta che venga ribadito il principio secondo cui il settore finanziario deve essere al servizio dell’economia reale. Ciò potrebbe significare una spinta a concedere più prestiti a settori chiave come l’alta tecnologia, le nuove energie e la protezione dell’ambiente, mentre potrebbero essere prese in considerazione anche iniziative per stimolare i consumi e i settori dei servizi.
E poi c’è ovviamente l’aspetto politico. Rispetto all’ultima conferenza quinquennale del 2017, la presa del Partito e dunque di Xi sul settore privato si è molto amplificata. La campagna di rettificazione delle grandi piattaforme digitali è servita come esempio a mostrare che le grandi imprese non possono ammassare eccessivo potere e possibilmente devono contribuire a perseguire i principali obiettivi strategici della politica.
A riprova del mai sopito impulso a “pulizia” e “controllo”, anche i dati diffusi dalla Commissione centrale per la Disciplina e la Supervisione del Partito, secondo cui tra gennaio e settembre del 2023 sono stati puniti per corruzione 405 mila funzionari, di cui 34 con incarichi di alto livello. Tra di loro, l’ex segretario del Partito nella città di Hangzhou (la sede centrale di Alibaba) e l’ex vice governatore della Banca Popolare Cinese. La riforma dell’apparato governativo e statale prevede peraltro una maggiore supervisione centrale e partitica. Xi ha dato un ulteriore messaggio nei giorni scorsi, quando prima della conferenza ha compiuto la sua prima storica visita nei panni di leader alla sede della banca centrale.
La Cina deve continuare a crescere ma deve farlo seguendo un altro dei concetti mantra dell’era di Xi: la sicurezza.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
C’è un’azienda che è il principale fornitore di iPhone per Apple ma che ha i suoi centri di produzione più vasti in Cina. C’è un’azienda il cui fondatore è candidato alle elezioni presidenziali forse più importanti del 2024 insieme a quelle per la Casa Bianca. C’è un’azienda che più di tante altre, forse più di tutte, incarna ciò che rimane del triangolo di cooperazione Repubblica Popolare Cinese-Stati Uniti-Taiwan.
Quell’azienda si chiama Hon Hai, Foxconn a livello internazionale. Il suo storico patron, “Terry” Gou Taiming, ambisce a essere eletto prossimo presidente della Repubblica di Cina (Taiwan) al voto del prossimo 13 gennaio. Al momento si ritrova quarto nei sondaggi, ma per provare una complicata rimonta si presenta come il “grande stabilizzatore”, l’unico in grado di tutelare gli affari commerciali tra le due sponde dello Stretto facendo ripartire il dialogo con Pechino ed evitando azioni militari. Ecco, questa linea sembra improvvisamente e inaspettatamente essere andata in frantumi domenica 22 ottobre, quando i media statali cinesi hanno dato conto dell’avvio di controlli fiscali e indagini in loco sull’uso del terreno da parte della Foxconn e delle sue sussidiarie nelle provincie di Hubei ed Henan, cioè quella che ospita l’immenso stabilimento di Zhengzhou ribattezzato “iPhone City” visto che proprio qui vengono assemblati la maggior parte dei dispositivi poi spediti alla statunitense Apple.
“I dipartimenti competenti che conducono ispezioni fiscali e indagano sulle situazioni di utilizzo dei terreni delle imprese nazionali in Cina sono normali attività di supervisione del mercato, ragionevoli e legali” sostiene il tabloid nazionalista Global Times, ma le tempistiche e la pubblicità data all’indagine fanno sospettare l’esistenza di motivazioni politiche. Il messaggio esplicito in arrivo dai media cinesi alle aziende taiwanesi è il seguente: “Non solo dovrebbero beneficiare delle opportunità di sviluppo e dei dividendi della terraferma, ma anche assumersi le relative responsabilità sociali. Dovrebbero contribuire attivamente alla promozione di relazioni pacifiche tra gli Stretti e svolgere un ruolo positivo nel loro continuo sviluppo”.
Legittimo pensare che si tratti di un messaggio rivolto a Gou in vista delle campagne elettorali. Anche perché secondo fonti citate da Reuters, diverse aziende taiwanesi sarebbero state sottoposte a controlli da parte delle autorità cinesi negli ultimi mesi, senza che fosse annunciato.
L’annuncio esplicito dell’indagine sulla Foxconn ha invece una serie di impatti concreti, al di là che siano stati perseguiti volontariamente e politicamente da parte di Pechino. Partiamo dal fronte aziendale: Foxconn sta di recente insistendo sulla diversificazione e delocalizzazione di alcune linee di produzione dalla Cina continentale ad altri Paesi, in primis India e Vietnam. Indagine e ispezioni sembrano voler dire al colosso taiwanese che deve scegliere da che parte stare: intende mantenere le radici nella Repubblica Popolare (come spera il Partito comunista che anche di recente ha corteggiato l’azienda per nuovi affari) oppure perseguire la strategia di riduzione del rischio promossa dall’Occidente e che secondo la Cina è un “disaccoppiamento mascherato”? La risposta è cruciale, anche perché tradizionalmente la Foxconn è citata da Pechino come un esempio di successo di cooperazione commerciale e tecnologica tra le due sponde dello Stretto.
C’è poi il fronte politico. A Pechino potrebbe non dispiacere un’eventuale presidenza Gou, visto che l’ex presidente della Foxconn ha ottimi agganci anche con gli Stati Uniti. Nel 2019, era stato persino ricevuto alla Casa Bianca da Donald Trump che lo aveva anche etichettato come “vecchio amico”. Allo stesso tempo, il Partito comunista sa che la sua corsa rischia di compromettere le probabilità di successo dell’opposizione dialogante.
A un mese esatto dalla chiusura ufficiale delle candidature, l’attuale partito di maggioranza (DPP, Partito progressista democratico) sembra ancora una volta favorito a vincere le presidenziali con l’attuale vicepresidente Lai Ching-te, meno moderato della leader uscente Tsai Ing-wen e particolarmente inviso a Pechino. Il vantaggio fondamentale di Lai è che il campo rivale è frammentato in tre candidati diversi: Hou Yu-ih del Kuomintang (il principale partito d’opposizione), Ko Wen-je del Taiwan People’s Party (che si presenta come una terza via rispetto ai due grandi partiti tradizionali) e, appunto, Gou.
Il fondatore della Foxconn aveva provato a ottenere la candidatura col KMT, ma come accaduto nel 2019 il partito gli ha preferito un altro nome. Nonostante l’iniziale promessa di supporto a Hou, alla fine Gou ha annunciato la sua candidatura da indipendente a fine agosto. Presentandosi a sua volta come una prospettiva di cambiamento e utilizzando lo slogan “Good Timing”, giocando sulle iniziali del suo nome e mettendo in mostra un nuovo modello di Apple Watch.
Gou fonda(va) la sua campagna sulla capacità di poter parlare sia con la Cina continentale sia con gli Stati Uniti, preservando dunque Taiwan dai rischi geopolitici. L’avvio delle indagini in Cina rischia dunque di far crollare il centro nevralgico della retorica politica di Gou. Una prospettiva citata da qualcuno a Taipei è che in tal modo la Cina vorrebbe ottenere maggiori garanzie o concessioni politiche da Gou qualora avesse un ruolo nella futura amministrazione. Un’altra teoria, la più complottista, è quella che così facendo si dà a Gou la possibilità di smentire la parte di opinione pubblica taiwanese che lo considera troppo vicino alla Cina continentale. Ma l’ipotesi più concreta è che Pechino voglia favorire un compattamento del campo dell’opposizione. Lo stesso DPP ha reagito accusando Pechino di voler fare pressioni su Gou per costringerlo ad abbandonare la candidatura. Così fosse, il campo più “dialogante” avrebbe un disturbo in meno in vista delle urne, con Gou che qualora restasse in corsa ruberebbe voti soprattutto al KMT o a Ko.
Il messaggio potrebbe peraltro essere già stato decrittato dal KMT, che ha innalzato di livello le trattative in corso col TPP per formare un’alleanza. Ko ha infatti incontrato sia Hou sia il presidente del KMT, Eric Chu. Un deciso cambio di passo dopo che fin qui si erano incontrati solo i funzionari dei due partiti, senza riuscire a raggiungere un accordo sul come far funzionare l’eventuale coalizione. Ora, diversi personaggi in vista nella sfera del KMT stanno venendo allo scoperto per dare il via libera alla possibilità di sostenere Ko, al momento testa a testa per il secondo posto con Hou nei sondaggi. Il candidato alle elezioni del 2020 Han Kuo-yu, ancora molto popolare, si è fatto immortalare sui social insieme a Ko. E Jaw Shaw-kong, influente presidente della Broadcasting Corporation of China, ha cambiato posizione dopo aver sempre proposto Hou come candidato presidente: ora sostiene che il KMT debba accettare Ko alla guida del ticket per avere speranze di rovesciare il DPP. In cambio, Ko ha promesso tra le righe un rafforzamento del ruolo del primo ministro a discapito di quello di presidente. Come a dire al KMT che qualora diventasse presidente grazie al suo supporto, gli concederà ampi margini di manovra per l’azione governativa.
La maggiore incognita resta quella sulla volontà di Ko, che ha invece basato la sua proposta politica come una terza via rispetto al tradizionale bipolarismo taiwanese. Accettare l’accordo col KMT significherebbe “normalizzare” il TPP. Andando da solo, Ko sa che molto probabilmente perderà ma se arrivasse secondo diventerebbe il kingmaker del prossimo yuan legislativo (il parlamento taiwanese), dove nessuno dovrebbe avere la maggioranza. Per poi presentarsi come vera alternativa al DPP alle presidenziali del 2028. Viceversa, scegliesse di allearsi con Ko, il voto del 2024 diventerebbe per lui un rischiatutto, dove può diventare presidente o rischiare di finire nel dimenticatoio. Le tempistiche saranno decisive. Un’eventuale alleanza Ko-Hou lascerebbe a Gou il ruolo di vera “novità” rispetto ai partiti tradizionali. Sempre che il fondatore della Foxconn non ceda nel frattempo.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Questa edizione è popolata soprattutto da figure dei Paesi emergenti e in via di sviluppo più che dei Paesi occidentali, tranne rare eccezioni. Una Via della Seta a due velocità: una con sempre più ostacoli in Occidente, l’altra più spedita nel Sud globale.
L’ultima volta era stata l’aprile del 2019. Quattro anni e mezzo fa, un’eternità. Prima della pandemia di Covid-19, prima della guerra in Ucraina, prima della visita di Nancy Pelosi a Taiwan, prima del nuovo conflitto tra Israele e Hamas. Prima di tutto questo, a Pechino si era tenuto il secondo forum sulla Belt and Road Initiative (BRI), nome ufficiale del colossale progetto cinese noto in Italia con la più romanticheggiante alternativa di “Nuova Via della Seta”. Quattro anni e mezzo fa, a Pechino c’era anche l’allora premier italiano Giuseppe Conte. Stavolta, c’è un rappresentante della Farnesina. Già, perché l’Italia si prepara a uscire dalla BRI, seppure abbia rispettato l’etichetta istituzionale attendendo lo svolgimento della terza edizione del forum per non rovinare la festa del presidente Xi Jinping.
Tra martedì 17 e mercoledì 18 ottobre sono attesi all’evento rappresentanti di oltre 130 Paesi. Xi partecipa alla cerimonia di apertura del forum e terrà un discorso programmatico, oltre a organizzare un banchetto di benvenuto ed eventi bilaterali per i vari ospiti. Il bilaterale più atteso è ovviamente quello con Vladimir Putin. Anticipato da un colloquio tra i due ministri degli Esteri, Wang Yi e Sergej Lavrov, i due leader si ritrovano a Pechino venti mesi dopo l’ormai celebre incontro del 4 febbraio 2022 a margine dei Giochi Olimpici Invernali.
In quell’occasione fu forgiata quella “partnership senza limiti” che la Cina ha poi rapidamente disconosciuto con la guerra in Ucraina. Quantomeno a livello lessicale, facendola depennare da tutti i successivi incontri e dal documento congiunto dello scorso marzo durante la visita di Xi a Mosca. Gli analisti si attendono novità più concrete sul fronte energetico. Secondo i dati doganali cinesi, a settembre il valore degli scambi bilaterali è salito a 21,18 miliardi di dollari, il valore più alto dal febbraio 2022. Il mese scorso, il ministro del Commercio cinese Wang Wentao ha dichiarato che la cooperazione economica e commerciale tra Cina e Russia si è approfondita ed è diventata più “solida” sotto la “guida strategica” dei due leader.
Mosca esporta circa 2 milioni di barili di petrolio al giorno in Cina, pari a più di un terzo delle sue esportazioni totali di greggio. Circa il 40% delle forniture passa attraverso l’oleodotto East Siberia Pacific Ocean (ESPO), lungo 4.070 km e finanziato con prestiti cinesi per un valore stimato di 50 miliardi di dollari. Le forniture attraverso il gasdotto Power of Siberia, invece, sono iniziate alla fine del 2019 e dovrebbero salire a 38 miliardi di metri cubi all’anno entro il 2025. Sono attese novità più precise sul secondo gasdotto verso la Cina, il Power of Siberia 2, che dovrebbe avere una capacità di 50 miliardi di metri cubi all’anno e passare per la Mongolia. Xi e Putin hanno menzionato più volte il progetto nei loro recenti incontri, ma non sono ancora chiari contorni e tempistiche del progetto.
I titoli dei media internazionali saranno senz’altro dominati dall’incontro Xi-Putin, ma a Pechino ci sono diversi altri attori. Più di una dozzina di leader provenienti da Africa, Asia e Medio Oriente sono già arrivati a Pechino, tra cui il presidente cileno Gabriel Boric, il primo ministro ungherese Viktor Orbán, il primo ministro etiope Abiy Ahmed, il presidente dello Sri Lanka Ranil Wickremesinghe, il presidente della Repubblica del Congo Denis Sassou Nguesso, il primo ministro della Papua Nuova Guinea James Marape e il primo ministro cambogiano Hun Manet.
Presente anche il presidente indonesiano Joko Widodo. Proprio lui, a inizio ottobre ha inaugurato il treno Giacarta-Bandung, la linea ferroviaria ad alta velocità del Sud-Est asiatico. Un progetto che rientra sotto l’ombrello della BRI, lanciata esattamente dieci anni fa da Xi appena asceso al potere. Lo sviluppo della rete ferroviaria del Sud-Est asiatico è da sempre uno dei primi obiettivi della Belt and Road. Nel 2021 è entrato in funzione il collegamento tra Kunming, capoluogo della provincia cinese dello Yunnan, e Vientiane, capitale del Laos. Il primo passo di un tracciato che in futuro dovrebbe arrivare fino a Singapore passando per Thailandia e Malesia.
Presenti anche emissari del governo dei talebani in Afghanistan. Alla Cina interessano i giacimenti non sfruttati di rame e litio, mentre i talebani vorrebbero entrare a far parte del Corridoio economico Cina-Pakistan.
Negli ultimi anni i progetti targati BRI hanno perso un po’ di slancio. Non solo per la pandemia, ma anche per il rallentamento della crescita cinese e le tensioni geopolitiche che hanno provocato ritardi, rallentamenti e sospensioni di diversi progetti. Fino al 2019 sono stati investiti circa 100 miliardi di dollari all’anno, da allora la cifra si aggira tra i 60 e i 70 miliardi. E alcuni Paesi sono in difficoltà o del tutto impossibilitati a ripagare i debiti accumulati nei confronti della Cina. Questo non significa che il progetto è destinato ad arenarsi. Anzi, l’idea è quella di passare dai mastodontici progetti portatori (anche) di debito a obiettivi più specifici e di alta qualità.
Qualche tempo fa, Wang Yi aveva auspicato “progetti piccoli e belli” in ambito BRI. Non a caso il nome ufficiale del terzo forum richiama questo concetto: “High-quality Belt and Road Cooperation: Insieme per lo sviluppo e la prosperità comuni”. Il richiamo è in realtà anche ad altri due concetti chiave della retorica della “nuova era” di Xi: prosperità comune e destino condiviso. Il primo tradizionalmente all’interno, il secondo all’esterno. Citato per la prima volta proprio nel discorso con cui da Giacarta lanciò la Via della Seta marittima il 2 ottobre 2013, nelle scorse settimane Pechino ha rilasciato un documento che sistematizza la teoria della “comunità globale con destino condiviso”, che mira a presentare la Cina come un attore responsabile e garante di stabilità. Una retorica adottata su diverse crisi di questi anni, spesso in contrapposizione agli Stati Uniti, presentati invece dalla narrazione cinese come portatori di instabilità e di una “mentalità da guerra fredda” che rischia di dare forma a una nuova “logica di confronto tra blocchi”. Si tratta di una narrazione che trova consensi soprattutto nel cosiddetto Sud globale. E non è un caso che il terzo forum sia pensato e popolato soprattutto da figure dei Paesi emergenti e in via di sviluppo più che da figure dei Paesi occidentali, tranne rare eccezioni.
In futuro, si può prevedere una Via della Seta a due velocità: una con sempre più ostacoli in Occidente, soprattutto nei settori strategici come infrastrutture e telecomunicazioni, l’altra più spedita nel Sud globale.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Un nuovo fronte dopo quello della guerra in Ucraina. Seppure ci si trovi non così lontano dalle porte dell’Europa, il conflitto in Israele viene osservato con attenzione anche in Asia orientale. A partire dalla Cina, che proprio sulla questione israelo palestinese aveva iniziato a investire un forte capitale diplomatico e retorico. La prima reazione di Pechino agli attacchi di Hamas è stata come sempre all’insegna della pretesa di neutralità e imparzialità. “La Cina è profondamente preoccupata per l’attuale escalation di tensioni e violenze tra Palestina e Israele. Chiediamo alle parti interessate di mantenere la calma, di esercitare la moderazione e di porre immediatamente fine alle ostilità per proteggere i civili ed evitare un ulteriore deterioramento della situazione”, si legge nel comunicato del ministero degli Esteri di domenica 8 ottobre. Per poi passare alla fase propositiva: “La via d’uscita fondamentale dal conflitto è l’attuazione della soluzione dei due Stati e la creazione di uno Stato palestinese indipendente. La comunità internazionale deve agire con maggiore urgenza, intensificare il contributo alla questione palestinese, facilitare la rapida ripresa dei colloqui di pace tra Palestina e Israele e trovare un modo per realizzare una pace duratura”.
Nessuna condanna diretta degli attacchi, dunque, tanto da suscitare la reazione delusa di Israele, la cui ambasciata a Pechino ha postato sul proprio account X una critica non proprio velata, dicendo che sperava in una dimostrazione di solidarietà e sostegno da parte di Pechino, aspettandosi una “forte condanna” di Hamas. Lunedì, il governo cinese ha parzialmente aggiustato il tiro. “La Cina si oppone e condanna le azioni che danneggiano i civili”, ha dichiarato Mao Ning, portavoce del Ministero degli Esteri, durante la conferenza stampa quotidiana. Ma, ancora una volta, non è stata menzionata esplicitamente Hamas. “L’unica soluzione è il dialogo e tutelare le legittime preoccupazioni di entrambe le parti”, ha aggiunto Mao. Parole che a molti hanno ricordato quelle utilizzate regolarmente dal governo cinese sulla guerra in Ucraina. Pechino ha d’altronde rapporti profondi sia con la Palestina, di cui ha sempre appoggiato l’indipendenza, sia con Israele, di cui è il secondo partner commerciale dopo gli Stati Uniti. E la Cina, dopo aver favorito il riavvio delle relazioni tra Arabia Saudita e Iran, si era detta pronta a svolgere un ruolo di mediazione tra le parti. A giugno, il Presidente Xi Jinping ha ricevuto a Pechino il leader palestinese Mahmoud Abbas. A luglio, l’ambasciatore cinese in Israele ha regalato al premier israeliano una copia autografata dell’ultimo libro di Xi e ha trasmesso l’invito a Netanyahu a visitare Pechino.
Come sottolineato da Wen Ti-sung dell’Australian National University, proprio a causa delle difficoltà diplomatiche sulla guerra in Ucraina a causa dell’impossibilità nel condannare la Russia, la Cina ha puntato molto sulla sua diplomazia in Medio Oriente per promuovere la propria immagine da “grande stabilizzatore”. Ora, però, col conflitto in Israele vacilla anche il percorso di dialogo tra Arabia Saudita e Iran, il cui ruolo sull’azione di Hamas è peraltro da chiarire. Tutto ciò rischia di creare delle nuove frizioni con gli Stati Uniti, proprio mentre Pechino e Washington stanno cercando di arrivare a una stabilizzazione delle relazioni. Sempre lunedì, Xi ha peraltro ricevuto a Pechino la prima delegazione congressuale statunitense dal 2019. Chuck Schumer, leader della maggioranza democratica al Senato e guida della missione, si è detto deluso dalla reazione del governo cinese sulla situazione israeliana. Sui media di stato cinesi, invece, iniziano già ad affiorare delle allusioni più o meno esplicite alla posizione giudicata “non imparziale” degli Stati Uniti e in particolare sull’intenzione espressa dalla Casa Bianca di inviare nuove armi a Israele. Dinamiche che ricordano quelle sull’Ucraina, con la Cina che prova ancora una volta a presentarsi come osservatrice giusta, non parte coinvolta direttamente nel conflitto o sostenitrice di una delle due parti. E dunque, un potenziale mediatore. O meglio, ispiratore. Ruolo a cui ha dimostrato di voler assurgere col celeberrimo documento di posizione sull’Ucraina, che non è un piano di pace per stessa ammissione cinese, e con tutti i documenti sulla visione cinese del mondo pubblicati di recente. L’ultimo, quello sulla “comunità globale dal destino condiviso” che sistematizza il concetto espresso da Xi per la prima volta esattamente dieci anni fa col lancio della Nuova Via della Seta marittima col discorso di fronte al parlamento indonesiano del 2 ottobre 2013.
A Taiwan si osserva invece con qualche preoccupazione quanto accade in Israele. Non tanto perché si ritenga che l’ennesima crisi possa dare il via libera a Pechino per tentare un’avventura militare sullo Stretto, quanto per il potenziale impatto sugli aiuti e spedizioni militari. Gli Stati Uniti hanno già mostrato di non avere risorse infinite per sostenere le difese dell’Ucraina e la promessa di mandare nuove armi in Israele potrebbe produrre nuovi rallentamenti nella consegna dei pacchetti previsti per Taipei. Il governo, intanto, ha preso con convinzione le parti di Israele. Lo stesso ha fatto l’India, che è stata fin qui invece molto più ambigua su Russia e Ucraina. “Profondamente scioccato dalla notizia degli attacchi terroristici in Israele”, ha scritto il primo ministro indiano Narendra Modi su X. “I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con le vittime innocenti e le loro famiglie. Siamo solidali con Israele in questo momento difficile”. Anche Singapore è sulla stessa linea. “Condanniamo fermamente gli attacchi missilistici e terroristici da Gaza contro Israele, che hanno causato la morte e il ferimento di molti civili innocenti. Chiediamo la fine immediata delle violenze e sollecitiamo tutte le parti a fare il possibile per proteggere la sicurezza dei civili”, si legge in un comunicato del Ministero degli Esteri della città-Stato.
Anche Giappone e Corea del Sud hanno espresso solidarietà a Israele. A Seul però c’è chi teme che la situazione possa aumentare ancora di più le pressioni di Usa e Nato per inviare direttamente armi all’Ucraina. Cosa sin qui evitata visto che le norme sudcoreane impedirebbero un’assistenza militare diretta a Paesi coinvolti in conflitti. Senza contare le ripercussioni sulla sicurezza nazionale e i rapporti con Russia, Corea del Nord e Cina. Particolarmente colpita dalla nuova crisi anche la Thailandia, che ha avuto almeno 12 suoi cittadini tra le vittime degli attacchi.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
“Se vincerò le elezioni, amplierò i legami tra i nostri due Paesi”. Era il 2022, quando Mohamed Muizzu ha fatto questa promessa alla Cina durante un incontro virtuale con rappresentanti del Partito comunista cinese. Allora era il sindaco di Male, la capitale delle Maldive, da oggi invece è il Presidente eletto dell’arcipelago dell’oceano Indiano. Muizzu (Partito Progressista delle Maldive) ha infatti vinto il ballottaggio delle elezioni presidenziali che si è svolto sabato 30 settembre. Un voto osservato con grande attenzione dalla Cina e dall’India, visto che le due potenze regionali si contendono da tempo l’influenza sulle Maldive tra prestiti, accordi, infrastrutture, investimenti e partnership legate alla sicurezza.
Con quasi tutti i voti scrutinati, la Commissione elettorale delle Maldive ha dichiarato sul proprio sito web che Muizzu ha ricevuto il 54% delle preferenze alle urne, contro il 46% del Presidente uscente Ibrahim Solih del Partito Democratico Maldiviano. Circa l’85% dei 282.000 elettori aventi diritto si è presentato ai seggi elettorali allestiti nelle 187 isole dell’arcipelago.
Nuova Delhi tifava con convinzione per la conferma di Solih, che durante la sua presidenza ha sostenuto una politica di rafforzamento dei legami col grande vicino, denominata “India First“. Solih rimarrà presidente fino all’insediamento di Muizzu, previsto per il 17 novembre. “Oggi il popolo ha preso una forte decisione per riconquistare l’indipendenza delle Maldive”, ha dichiarato Muizzu ai giornalisti nella capitale Male. “Tutti noi, lavorando insieme con unità, Insha Allah, avremo successo”.
Dietro Muizzu si staglia l’ombra di Abdulla Yameen, ex presidente filocinese finito in carcere per scontare una condanna a 11 anni per corruzione e riciclaggio di denaro. Il Presidente eletto sostiene che le accuse contro Yameen sono motivate politicamente e, appena vinte le elezioni, ha chiesto a Solih di rilasciarlo. Già dal primo turno delle presidenziali Muizzu era uscito in vantaggio, nonostante i favori del pronostico fossero dalla parte di Solih, infine però frenato da alcune divisioni all’interno del suo partito. Il leader uscente aveva puntato sul mettere in evidenza l’efficace gestione della pandemia di Covid-19, ma alla fine hanno prevalso le critiche dell’opposizione sulla crescita dell’indebitamento a causa degli ingenti prestiti dei Paesi stranieri per finanziare gli investimenti infrastrutturali di cui l’arcipelago ha estremo bisogno. Tra questi Paesi stranieri in prima fila proprio Nuova Delhi, finita però al centro della campagna di protesta chiamata “India out”, motivata dalla volontà di rimuovere la (seppur piccola) presenza militare indiana alle Maldive, composta da circa 70 unità e aerei di sorveglianza.
Ingegnere civile di formazione britannica, Muizzu è stato in passato il ministro dell’Edilizia dell’amministrazione Yameen. In quel ruolo ha supervisionato diversi progetti infrastrutturali finanziati dalla Cina, tra cui spicca un ponte di 200 milioni di dollari che collega la capitale con il principale aeroporto dell’arcipelago. Anche qui, a costo di forti debiti accumulati verso Pechino e in scadenza nel 2025. Muizzu è riuscito a convincere gli elettori che con lui alla guida è concreta la possibilità di raggiungere nuovi accordi in materia con la Cina, visto che a suo dire la politica estera di Solih era troppo sbilanciata a favore dell’India, pregiudicando così i rapporti con Pechino.
Sia Cina sia India si sono affrettate a complimentarsi con Muizzu. “La Cina è disposta a collaborare con le Maldive per consolidare la tradizionale amicizia, approfondire la cooperazione reciprocamente vantaggiosa e spingere verso nuovi e continui progressi nel partenariato amichevole e globale orientato al futuro tra i due Paesi”, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri di Pechino. Per l’India è sceso in campo direttamente il premier Narendra Modi, che sul suo account X ha scritto: “L’India rimane impegnata a rafforzare le relazioni bilaterali India-Maldive, ormai consolidate nel tempo, e a migliorare la nostra cooperazione generale nella regione dell’Oceano Indiano”. Osservano con attenzione anche gli Stati Uniti, che puntano tantissimo sul ruolo di Nuova Delhi per contenere l’ampliamento dell’influenza cinese in tutta la regione che chiamano Indo-Pacifico. Maldive comprese. Ma ora l’arcipelago famoso in tutto il mondo delle vacanze da sogno sembra in procinto di guardare proprio verso Pechino.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Un pesce mitologico che può trasformarsi in un uccello. 海鯤 (Hǎi kūn) è il nome scelto dalla marina taiwanese per il suo primo sottomarino di produzione autoctona. Il riferimento è a una leggenda della dinastia Ming, il cui lealista Koxinga riparò a Taiwan cacciando gli olandesi, prima che i suoi eredi fossero costretti a sottomettersi ai Qing. Storie che rimandano ancora una volta a un’epica antica, come spesso accade nelle liturgie dell’esercito taiwanese che più di altri comparti sociali si riconosce ancora pienamente all’interno della cornice della Repubblica di Cina, il nome con cui Taiwan è indipendente de facto.
Al di là dei nomi, il lancio del primo sottomarino di produzione autoctona è una notizia rilevante per la difesa di Taiwan, che sta provando ad aumentare le proprie capacità di combattimento asimmetriche. Costato 49,36 miliardi di dollari, Hǎi kūn utilizzerà un sistema di combattimento della Lockheed Martin Corp e trasporterà siluri pesanti MK-48 di produzione statunitense.
Il varo del sottomarino è previsto per giovedì 28 settembre presso lo stabilimento della Taiwan Shipbuilding Corporation di Kaohsiung, il principale porto taiwanese. Dopo il varo, verrà effettuato il test di ancoraggio portuale, così come i test di navigazione e varie azioni tattiche come immersioni e mirate. Dopo di che il sottomarino verrà consegnato alla marina che valuterà la sua prontezza al combattimento. Tutto il processo dovrebbe completarsi entro la fine del 2024.
Non resterà l’unico. Entro il 2027 Taipei punta ad avere in funzione almeno due sottomarini di produzione autoctona, possibilmente dotando i modelli successivi di missili. Taiwan ha fatto del programma di sottomarini indigeni una parte fondamentale di un ambizioso progetto di modernizzazione delle proprie forze armate, anche perché l’area grigia entro la quale si svolgono le manovre militari di Pechino continua ad allargarsi. L’ammiraglio Huang Shu-kuang, Consigliere per la sicurezza della Presidente Tsai Ing-wen, guida il programma relativo ai sottomarini. E ha dichiarato che una flotta di 10 sottomarini, che ne include però alcuni piuttosto datati e due di fabbricazione olandese commissionati negli anni ’80, renderebbe più difficile un’azione militare di Pechino. Taipei è infatti convinta che una buona flotta di sottomarini possa rappresentare un “deterrente strategico” per le navi da guerra cinesi che attraversano lo Stretto di Miyako, vicino al Giappone sudoccidentale, o il Canale di Bashi, che separa Taiwan dalle Filippine. Proprio da qui, nelle scorse settimane, è transitata la portaerei Shandong che ha dato vita a imponenti esercitazioni sul Pacifico occidentale. Nella strategia taiwanese, i sottomarini potrebbero aiutare a mantenere aperto un canale di collegamento invece verso Pacifico orientale e meridionale, rompendo un ipotetico blocco al largo della costa orientale di Taiwan. Uno scenario che l’Esercito popolare di liberazione ha avvicinato durante le esercitazioni dello scorso aprile, in risposta all’incontro tra Tsai e lo speaker del Congresso Usa, Kevin McCarthy, in California. La Shandong si è infatti posizionata al largo della costa orientale col suo gruppo di combattimento. Il messaggio è stato in quel caso chiaro: provare a trasformare lo Stretto di Taiwan in una sorta di mare interno bloccando l’unica via d’accesso all’isola. “I sottomarini terranno le loro navi lontane dalle nostre coste orientali”, ha detto ottimisticamente Huang alla stampa.
Secondo la Reuters, Taiwan ha ottenuto tecnologia, componenti e talenti da almeno sette Paesi per sostenere il suo programma di costruzione di sottomarini. Il caso più noto sarebbe quello del Regno Unito, che lo scorso anno ha aumentato drasticamente la quantità di esportazioni di parti di sottomarini e di tecnologia approvate per Taipei. Le spese militari sono in costante aumento, col governo taiwanese che ha da poco proposto un budget da 19,1 miliardi di dollari per il 2024: un aumento del 7,7% rispetto all’anno in corso. Senza contare bilanci speciali aggiuntivi e altri fondi che potrebbero essere assegnati al Ministero della Difesa.
Negli ultimi anni le manovre militari di Pechino nella regione intorno a Taiwan sono nettamente aumentate. Lunedì 18 settembre si è registrato il record di jet avvistati nello spazio di 24 ore: 103. Domenica 24 settembre invece la difesa taiwanese ha dichiarato di aver individuato, sin dalle prime ore del mattino, un ciclo di esercitazioni in una baia della provincia costiera del Fujian, cioè quella che si affaccia su Taiwan. In particolare, i test sarebbero stati condotti nella baia di Dacheng col probabile scopo di testare la capacità delle forze armate di utilizzare navi civili per supportare le operazioni di sbarco congiunte.
Il mare è l’elemento decisivo della partita del Pacifico, a partire da Taiwan. Governare quello che accade sopra è fondamentale per assicurarsi un vantaggio strategico. Così come governare quello che accade sotto.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Dopo gli Stati Uniti, tocca alla Russia. Giornate intense per la diplomazia cinese, in particolare per il ministro degli Esteri Wang Yi che, dopo aver tenuto due giornate di incontri a Malta col consigliere per la Sicurezza Nazionale statunitense Jake Sullivan, oggi si sposta a Mosca per una visita di 4 giorni. La seconda da quando è a capo della diplomazia del Partito comunista cinese dopo quella di febbraio scorso, al termine di un tour europeo, alla vigilia del primo anniversario dell’invasione dell’Ucraina, la prima da quando è tornato ministro al posto di Qin Gang, rimosso per ragioni mai chiarite a fine luglio dal suo ruolo.
Wang parteciperà al 18esimo round di consultazioni sulla sicurezza strategica Cina-Russia su invito del Segretario del Consiglio di Sicurezza di Mosca, Nikolai Patrushev.
I colloqui del diplomatico cinese con l’omologo Sergei Lavrov riguarderanno “un’ampia gamma di questioni”, compresi “i contatti ai livelli più alti”, ha dichiarato la scorsa settimana il Ministero degli Esteri russo. Come sempre, Pechino è meno prodiga di dettagli e dipinge la visita all’interno di una cornice abitudinaria, probabilmente anche per allontanare potenziali paralleli con il viaggio appena concluso di Kim Jong-un nell’Estremo Oriente russo. La visita di Wang è un “evento di routine” nell’ambito delle consultazioni sulla sicurezza strategica tra Cina e Russia, ha dichiarato in conferenza stampa Mao Ning, portavoce del Ministero. E ha l’obiettivo di “attuare l’importante consenso raggiunto dai due capi di Stato, promuovere lo sviluppo delle relazioni bilaterali e condurre una comunicazione approfondita su importanti questioni che coinvolgono gli interessi strategici di sicurezza dei due Paesi”.
Probabile che Wang aggiorni Lavrov sui colloqui tenuti con Sullivan, ma anche sulla visita in Cina del cardinale Zuppi della scorsa settimana. Già ad agosto, dopo la partecipazione dell’inviato speciale cinese Li Hui al summit per la pace di Gedda in Arabia Saudita, Wang aveva parlato con Lavrov al telefono. Anche per rassicurarlo del fatto che la posizione di Pechino non era cambiata. Una posizione che il governo cinese continua a descrivere come in linea con l’impegno “a promuovere la pace e i colloqui” e con la volontà a“svolgere un ruolo costruttivo nel promuovere l’allentamento e il raffreddamento della situazione”. La cooperazione tra Cina e Russia non si è mai fermata dopo la guerra. Ultimo esempio? Al forum di Vladivostok dei giorni scorsi, mentre tutti i riflettori erano sull’incontro tra Kim e Putin, Cina e Russia hanno invece firmato un accordo sul grano. Uno dei nodi della discordia tra Mosca e Occidente. Il New Land Grain Corridor, un consorzio di aziende che gestisce lo sviluppo della produzione di cereali e delle infrastrutture tra Urali e Siberia, collaborerà con l’azienda statale China Chengtong International Investment, per creare un hub logistico nei pressi del confine tra i due paesi. Investimento di 159 milioni di dollari, con la realizzazione di 22 mila container per il trasporto di 600 mila tonnellate di cereali, con capacità massima di stoccaggio di 8 milioni di tonnellate all’anno.
Allo stesso tempo, Pechino ha evitato di sostenere a livello militare la Russia, mostrando il desiderio di mantenere aperti e fluidi i rapporti con l’Occidente. Anche per questo, secondo molti analisti, Putin si sarebbe rivolto a Kim per ottenere armi. Una dinamica che crea forse qualche preoccupazione alla Cina, che teme il ritorno della Corea del Nord in cima all’agenda degli Usa, e dunque in grado di giustificare una presenza ulteriormente rafforzata dei mezzi militari statunitensi e un ampliamento delle partnership militari coi vicini asiatici come Giappone e Corea del Sud.
Ma l’agenda di Wang dovrebbe gettare le basi per la visita di Putin nella capitale cinese per il terzo Belt and Road Forum, dopo l’invito del presidente Xi Jinping durante una visita di alto profilo a Mosca a marzo. Putin ha partecipato ai primi due Belt and Road Forum cinesi nel 2017 e nel 2019 ed è ampiamente atteso come il “grande ospite” anche del terzo forum che si svolgerà a ottobre. Sarebbe il primo viaggio ufficiale all’estero del Presidente russo dopo che la Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto nei suoi confronti per l’accusa di aver deportato illegalmente centinaia di bambini dall’Ucraina. Il mandato, emesso pochi giorni prima della visita di Xi in Russia, obbliga i 123 Stati membri della Corte ad arrestare Putin e a trasferirlo all’Aia per il processo se entra nel loro territorio. Ma la Cina non è parte dello Statuto di Roma che ha portato all’istituzione della Corte penale internazionale nel 2002. E così, dopo aver saltato il summit dei Brics in Sudafrica, Putin dovrebbe recarsi a Pechino.
Interessante sottolineare anche la coincidenza di tempi con i colloqui tra Wang e Sullivan, così come l’incontro tra il Segretario di Stato Antony Blinken e il vicepresidente Han Zheng all’Assemblea delle Nazioni Unite a New York. I colloqui Wang-Sullivan per la parte cinese sono stati “strategici, sinceri, sostanziali e costruttivi, incentrati sulla stabilizzazione e sul miglioramento delle relazioni”. Significativo che vengano utilizzate due parole: “costruttivi” e “miglioramento”. Ovviamente i problemi e le tensioni restano, dai microchip su cui presto potrebbero arrivare nuove restrizioni della Casa Bianca fino soprattutto a Taiwan (nella cui regione Pechino ha inviato tra domenica e lunedì un numero record di jet militari), ma la sensazione è che l’incontro Wang-Sullivan faccia registrare un importante passo avanti in vista di una possibile visita di Xi Jinping negli Usa, dove Joe Biden spera di incontrarlo a margine del summit dell’Apec (Asia-Pacific Economic Cooperation) di novembre. Sarebbe la prima volta che i leader delle due potenze si parlano di persona dopo il G20 del 2022 a Bali.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Ogni tanto, i vecchi nemici possono anche diventare amici. Non alleati, termine abusato nella descrizione delle dinamiche di un mondo in cui gli interessi sono compenetrati e compenetrabili. Ma succede che Stati Uniti e Vietnam, a meno di 50 anni dalla fine di una sanguinosa e drammatica guerra, elevino i loro rapporti a partnership strategica globale. Una mossa che porta gli Usa al livello di Russia e Cina nella gerarchia delle relazioni diplomatiche di Hanoi. Tutt’altro che banale, visto che il salto è doppio dalla condizione precedente e rende Washington pari a due storici partner del Vietnam. Con Mosca, Hanoi ha profondi rapporti sul fronte militare e della difesa. Con Pechino, invece, su quello commerciale e ideologico. Ma anche dispute territoriali aperte sulle isole Paracelso nel conteso mar Cinese meridionale.
Ha fatto sensazione agli osservatori, seppur fosse atteso, il primo storico ingresso di un presidente degli Stati Uniti nel quartier generale del Partito comunista vietnamita. A ricevere Biden c’era Nguyen Phu Trong, il Segretario generale e vero leader politico del Paese del Sud-Est asiatico, seppure il sistema politico locale si basi sui cosiddetti ” 4 pilastri” che comprendono anche presidente, premier e capo del parlamento. Nguyen, al suo terzo mandato, ha in realtà accentrato progressivamente il potere. Tendenza ancora più chiara dopo le dimissioni probabilmente pilotate di qualche mese fa da parte del Presidente Nguyen Xuan Phuc, che alla vigilia dell’ultimo congresso del partito nel 2021 era considerato il più papabile successore allo scranno di segretario generale.
L’accentramento di potere e la non certo idilliaca situazione sui diritti degli oppositori non ha impedito a Biden di effettuare l’agognato viaggio in Vietnam, anticipato lo scorso aprile dalla visita del segretario di Stato Antony Blinken.
Lo stesso Biden ha definito “storico” il suo viaggio e ha definito il Vietnam un “partner cruciale”. Nell’ottica statunitense, l’elevazione dei rapporti con Hanoi si inserisce nella più vasta strategia di rilancio della presenza americana in Asia-Pacifico. E si aggiunge agli altri accordi sottoscritti da Biden da quando è alla Casa Bianca: il piano AUKUS con Australia e Regno Unito, l’allineamento trilaterale con Giappone e Corea del Sud suggellato dal summit di Camp David del 18 agosto, nonché i nuovi accordi militari con le Filippine di Ferdinand Marcos Junior.
“Gli Stati Uniti sono una nazione del Pacifico. E non ce ne andremo da nessuna parte”, ha detto Biden. La Cina la vede come una minaccia, anche se lui prova a rassicurare. “Non stiamo provando a ferire la Cina. Voglio vederla avere successo, ma deve seguire le regole”, avvisa Biden. Prima di aggiungere di sperare di vedere presto Xi Jinping. Sul piatto della visita di Biden anche numerosi accordi commerciali. Vietnam Airlines ha concluso l’acquisto di 50 jet 737 Max dal costruttore statunitense Boeing: un affare dal valore di 7,8 miliardi di dollari. È stato inoltre tenuto un colloquio business di alto livello, con Biden e il premier vietnamita Pham Minh Chinh. Presenti i dirigenti delle principali aziende statunitensi e vietnamite in vari settori, con particolare attenzione a semiconduttori, mobilità e terre rare. Tra gli altri, c’erano alti dirigenti di Google, Intel, Amkor, Marvell, GlobalFoundries. Per il Vietnam erano presenti i dirigenti di una mezza dozzina di aziende, tra cui VinFast, produttore di auto elettriche quotato al Nasdaq, la compagnia di bandiera Vietnam Airlines, l’azienda tecnologica FPT che si è da poco lanciata sui chip, MoMo, il più grande portafoglio elettronico del Paese per numero di utenti, e l’azienda internet VNG, che in agosto ha presentato domanda di quotazione a Wall Street.
Durante l’incontro, Biden ha ribadito che i due Paesi stanno approfondendo la cooperazione nei settori del cloud computing, dei semiconduttori e dell’intelligenza artificiale e ha sottolineato che il Vietnam è fondamentale per le forniture di minerali critici. Il Paese del Sud-Est asiatico possiede un grande deposito al mondo di terre rare, utilizzate nei veicoli elettrici e nelle turbine eoliche. Tra gli accordi svelati dalla Casa Bianca vi è il progetto di Microsoft di realizzare una “soluzione basata sull’intelligenza artificiale generativa su misura per il Vietnam e i mercati emergenti. Chiusa una collaborazione tra Nvidia, FPT, Viettel e Vingroup, società madre di VinFast, sempre sul fronte dell’intelligenza artificiale. E poi, come detto, i microchip. Capitolo strategico della contesa Usa-Cina e in cui Washington vorrebbe ridurre la dipendenza da Taiwan. Marvell e Synopsys investiranno in Vietnam per la costruzione di centri di progettazione di chip. La nuova fabbrica di Amkor nei pressi di Hanoi, del valore di 1,6 miliardi di dollari, che si occuperà dell’assemblaggio, del confezionamento e del collaudo dei chip, dovrebbe entrare in funzione a ottobre.
Tutto questo non significa, però, che il Vietnam voglia allinearsi del tutto agli Usa. Anzi, nel suo discorso Nguyen ha ricordato il principio di non interferenza negli affari interni degli altri Paesi (caro anche alla Cina), ha parlato di rispetto necessario per i diversi modelli politici e di sviluppo. Così come ha richiamato al multilateralismo e all’autonomia della politica estera vietnamita. Senza mai menzionare la Cina, né in conferenza stampa né nei documenti congiunti che pure richiamano alla stabilità e al rifiuto di azioni unilaterali sul mar Cinese meridionale. La guerra in Ucraina e il timore dell’allineamento tra Russia e Cina spingono il Vietnam a rafforzare i rapporti con Washington. Ma allo stesso tempo Hanoi starebbe negoziando nuovi acquisti di armi da Mosca, e non è escluso che ospiti presto anche Xi Jinping. D’altronde, già durante il summit Asean della scorsa settimana il premier vietnamita aveva incontrato l’omologo cinese Li Qiang per dargli qualche garanzia che Hanoi non si schiererà né con, né contro nessuno.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Quando si parla di possibili flashpoint in Asia, si citano sempre Taiwan e Mar Cinese meridionale. Eppure, l’unico confine conteso dove ci sono stati dei veri scontri negli ultimi anni è quello tra Cina e India. Nella tarda primavera del 2020 ci sono state anche diverse vittime dall’una e dall’altra parte dopo un lungo periodo di calma apparente. Lo scorso dicembre si sono verificate nuove schermaglie. Da allora, ci sono stati diversi incontri tra gli esponenti delle forze armate e dei Ministeri della Difesa dei due giganti asiatici, ma la situazione non è mai stata del tutto risolta. Al massimo congelata. Il governo di Nuova Delhi ha recentemente descritto la situazione come “fragile e pericolosa”, quello di Pechino tende più a minimizzare. Ma secondo diversi osservatori è lungo questa immensa frontiera che si decide molto del futuro del continente.
Qui, d’altronde, si deciderà molto del bilanciamento regionale. Dopo che la guerra in Ucraina ha spinto Giappone, Corea del Sud e Filippine sempre più tra le braccia degli Stati Uniti, il posizionamento indiano è cruciale. Non a caso Joe Biden ha invitato Narendra Modi alla Casa Bianca a giugno, rafforzando la cooperazione in materia tecnologica e militare. Già lo scorso dicembre, per la prima volta, l’esercito indiano ha utilizzato le informazioni satellitari condivise dagli Stati Uniti per acquisire vantaggi strategici nella contesa con l’esercito cinese. E ha anche acquistato dei droni militari americani, che Pechino teme possano essere dispiegati proprio su questo quadrante.
Qui, sui territori impervi e montuosi a cavallo dell’Himalaya, c’è in gioco moltissimo. Con diversi aspetti che contribuiscono a ritenere che nel prossimo futuro, se i colloqui tra le due parti non garantiranno stabilità, la tensione possa persino aumentare. Dalle risorse idriche alla questione strategica, dall’aspetto storico a quello religioso. Quella tra Cina e India è una contesa territoriale che ha più di un secolo, sin dalla linea McMahon tracciata nel 1914 e non riconosciuta da Pechino perché frutto di un accordo tra il Tibet autonomo e l’India britannica, con cessioni di una parte importante di territorio da quella che sarebbe poi diventata una regione autonoma della Repubblica Popolare. Una contesa che riguarda diverse aree. In primis l’Aksai Chin, regione montuosa del Kashmir in mano alla Repubblica Popolare dalla guerra sino-indiana del 1962, nella quale sono morti circa duemila soldati. Si tratta di un’area montuosa che funge da strategico collegamento tra Tibet e Xinjiang e che Nuova Delhi continua a rivendicare come parte del Ladakh, una delle divisioni dello stato di Jammu e Kashmir. Non solo. L’Aksai Chin ha un’altra porzione di territorio ceduta nel 1963 alla Cina dal Pakistan e che funge da cuscinetto tra Xinjiang e l’entità autonoma del Gilgit-Baltistan, controllata da Islamabad.
La coda allungata dell’Aksai Chin tocca anche la zona strategica del lago himalayano Pangong Tso, che dal territorio indiano arriva a toccare il principale snodo stradale del Tibet. Il tutto dopo essere passata anche a toccare altri due stati indiani, l’Himachal Pradesh (dove col benestare di Nuova Delhi risiede, nella città di Dharamsala, il Dalai Lama, fuggito dal Tibet dopo l’arrivo di Mao nel 1950) e l’Uttaranchal. Scendendo a sud est, invece, si trovano altre due aree dove la tensione è alta. La prima è quella del Sikkim, incastonato tra Nepal e Bhutan ed entrato a far parte dell’India nel 1975 con un referendum. La seconda, andando ancora più verso oriente dopo il Bhutan, è quella dell’Arunachal Pradesh, stato controllato dall’India ma rivendicato da Pechino. Le due parti si accusano reciprocamente di aumentare le tensioni costruendo nuove strutture o strade nei pressi del confine. Pechino ha anche dato nuove denominazioni ad alcune località che si trovano in territorio conteso, in una mossa utile a operare una simbolica reiterazione di sovranità.
La vicenda della successione del Dalai Lama gioca un ruolo non trascurabile sugli scenari futuri. Il leader religioso è stato peraltro “schierato” la scorsa estate sul Ladakh, nei pressi dei territori contesi. La spinosa questione della successione porterà ad avere probabilmente due figure nominate a capo del buddhismo tibetano. La prima sostenuta dal governo tibetano in esilio (e con ogni probabilità dall’India e dagli Stati Uniti), la seconda nominata dalla Cina. Un doppio Dalai Lama, con Pechino pronta a mettere nel mirino chiunque ospiti quello che nella sua prospettiva sarà un “impostore”. Una questione che rischia di alimentare le tensioni tra Cina e India. Un antipasto si è avuto negli scorsi mesi, quando Tenzin Gyatso ha nominato il decimo Khalkha Jetsun Dhampa, terza carica del buddhismo tibetano. Si tratta di un bambino di otto anni, nato negli Stati Uniti ma originario della Mongolia. Vero che il Tibet è ormai completamente integrato nella vita della Repubblica Popolare, ma non si può escludere che il delicato passaggio della più che probabile doppia nomina (scenario peraltro ammesso anche dal Presidente del governo tibetano in esilio, Penpa Tsering) porti a nuove tensioni anche nella regione autonoma. O che quantomeno Pechino intensifichi la presenza del suo apparato statale per presidiare quella fase. È prevedibile che i paesi buddhisti subiranno una forte pressione per scegliere quale leader seguire. Soprattutto quelli che finora hanno provato a mantenere una posizione equilibrata in politica estera, come la Mongolia.
La partita sul quadrante himalayano comprende anche altri due attori: Nepal e Bhutan. Il primo con questioni territoriali aperte con l’India, il secondo con la Cina. A Kathmandu, dalla fine del 2022 c’è un governo guidato da Pushpa Kamal Dahal, meglio noto col nome da combattente Prachanda. Ex guerrigliere maoista, tempo fa ha definito l’India una forza “espansionistica”, accusandola di aver orchestrato la sua estromissione dal ruolo di premier nel 2008 e insinuando persino l’esistenza di un piano per ucciderlo. Il tutto dopo che l’anno scorso il governo precedente aveva rifiutato lo State Partnership Program, un accordo proposto da Washington che a Kathmandu si temeva potesse portare difficoltà nei rapporti con la Cina. Col suo ritorno da premier, però, Prachanda sta provando ad adottare una linea più equidistante. A dimostrarlo, una recente visita a Nuova Delhi, durante la quale ha incontrato Modi. Prachanda ha affermato che la sua visita ha ripristinato la fiducia smarrita con la leadership indiana. Ma il principale partito di opposizione nepalese, il CPN-UML, si è fortemente opposto alla proposta del Primo Ministro per risolvere la disputa sui confini nella regione di Kalapani, definendola contraria all’interesse nazionale. Insomma, tutt’altro che scontato che i tentativi di distensione funzionino o portino a risultati concreti.
Anche il sovrano del Bhutan, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, è stato di recente in India. Si è parlato, lontano dai microfoni, anche della disputa territoriale con Pechino. Una necessità per il Bhutan, che non ha relazioni diplomatiche ufficiali con la Repubblica Popolare e ha invece rapporti profondi con Nuova Delhi e il buddhismo tibetano, per ragioni storiche e religiose. Nell’ottobre 2021, il Bhutan e la Cina hanno firmato un memorandum d’intesa per una “tabella di marcia in tre fasi” per accelerare i colloqui sulla risoluzione dei confini. I colloqui si concentrano su due valli a nord del Bhutan e sull’area di Doklam, a ovest del Bhutan, vicino alla tripartizione con l’India, che è stata teatro di uno stallo tra le forze indiane e cinesi nel 2017. L’India è stata particolarmente attenta a qualsiasi possibilità di un “accordo di scambio” tra i due Paesi che potrebbe influire sulla sua sicurezza. Il confine conteso si snoda su una lunghezza di circa 470 chilometri. È da quasi 40 anni che i due governi conducono colloqui per arrivare a una soluzione, senza successo. Negli ultimi anni, il Bhutan sostiene che la Cina abbia adottato una postura più assertiva alla frontiera. Secondo Thimphu, la Cina avrebbe costruito circa 200 strutture, tra cui edifici a due piani, in sei diverse località a cavallo della labile frontiera. Recenti colloqui a Kunming sembravano aver sbloccato la situazione, ma qualsiasi accordo tra il Regno e Pechino pare debba passare anche per Nuova Delhi, che secondo la parte cinese starebbe cercando di rallentare il dialogo.
La sfida incrociata si intreccia anche con l’ambizione di Cina e India di ergersi a guida del cosiddetto Sud globale. Una partita che comincia dalle cime dell’Himalaya.
Questo articolo è pubblicato anche sul numero di Luglio/Settembre di eastwest
Puoi acquistare la rivista sul sito o abbonarti
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Bergoglio ha elogiato il Paese che ricerca con tenacia il bene del singolo e della comunità e ha salutato la Cina, chiedendo ai cattolici cinesi di essere “buoni cristiani e buoni cittadini”
Si è chiusa la storica visita di Papa Francesco in Mongolia. Un viaggio che ha riservato anche numerosi spunti di interesse sulla Cina, l’immenso vicino convitato di pietra del pellegrinaggio di Bergoglio. Tanto che più di una bandiera della Repubblica Popolare Cinese è apparsa durante gli appuntamenti pubblici a cui ha presenziato il pontefice.
Dopo i vari incontri istituzionali con le massime cariche politiche e religiose del Paese, il fulcro del viaggio del Papa è stato l’incontro ecumenico e interreligioso di Ulan Bator. Qui ha dichiarato che l’Asia ha moltissimo da offrire e che la Mongolia “custodisce un grande patrimonio di sapienza, che le religioni qui diffuse hanno contribuito a creare e che vorrei invitare tutti a scoprire e valorizzare”. Da sempre considerata periferia, nella visione del Papa “venuto dalla fine del mondo” la Mongolia è il cuore dell’Asia, cioè del continente a sua volta cuore del terzo millennio. Bergoglio ha anche elencato i 10 elementi che la Mongolia può offrire al mondo come esempio: “Il buon rapporto con la tradizione, nonostante le tentazioni del consumismo; il rispetto per gli anziani e gli antenati – quanto bisogno abbiamo oggi di un’alleanza generazionale tra loro e i più giovani! Dialogo tra nonni e nipoti –. E poi, la cura per l’ambiente, nostra casa comune, altra necessità tremendamente attuale. Siamo in pericolo… E ancora: il valore del silenzio e della vita interiore, antidoto spirituale a tanti malanni del mondo odierno. Quindi, un sano senso di frugalità; il valore dell’accoglienza; la capacità di resistere all’attaccamento alle cose; la solidarietà, che nasce dalla cultura dei legami tra le persone; l’apprezzamento per la semplicità. E, infine, un certo pragmatismo esistenziale, che tende a ricercare con tenacia il bene del singolo e della comunità”.
Alla Steppe Arena della capitale mongola, Bergoglio ha poi tenuto la messa di fronte a circa 2500 fedeli. Molti mongoli vivono ancora una tradizione nomade per far pascolare i loro animali e, nella sua omelia, il Papa ha usato l’immagine per far capire il suo punto di vista. “Tutti noi siamo nomadi di Dio, pellegrini in cerca di felicità, viandanti assetati d’amore”, ha detto. Diversi monaci buddisti hanno partecipato alla cerimonia, insieme ad altri rappresentanti religiosi. Evenienza criticata da alcuni cattolici conservatori, che hanno parlato di “supermercato delle religioni”. Ma il Papa ha ribadito di dare grande importanza al “dialogo ecumenico, interreligioso e culturale” e ha condannato “la ristrettezza, l’imposizione unilaterale, il fondamentalismo e la costrizione ideologica”, dicendo che distruggono la fraternità, alimentano le tensioni e compromettono la pace.
Presenti, come detto, anche alcuni fedeli cinesi. Appena atterrato in Mongolia, peraltro, Papa Francesco ha fatto recapitare un messaggio a Xi Jinping in cui ha augurato il benessere alla nazione cinese. Poi Bergoglio ha inviato anche altri due segnali. Il primo quando ha detto di voler sfatare un mito sulla Chiesa cattolica, affermando che il suo obiettivo non è quello di convertire i popoli. Il secondo, forse più significativo, quando ha detto che la Chiesa non è un’entità politica. “Le istituzioni secolari e i governi non hanno nulla da temere dall’opera di evangelizzazione della Chiesa”, ha dichiarato. Due tentativi di rassicurazioni, con sullo sfondo il sogno mai sopito di un viaggio a Pechino sulle tracce di Matteo Ricci.
C’è anche un passaggio esplicito, quando al termine della messa il Papa ha inviato un saluto alla Cina, definendo i suoi cittadini un popolo “nobile” e chiedendo ai cattolici in Cina di essere “buoni cristiani e buoni cittadini”. Un’aggiunta, la seconda, che non dispiacerà a Pechino che da anni è impegnata a sinizzare la religione cattolica e in generale ad adattare le diverse fedi alle “caratteristiche cinesi”. Domenica il Santo Padre ha voluto al suo fianco il cardinale John Tong Hon, vescovo emerito di Hong Kong, e il cardinale designato, nonché attuale vescovo, Stephen Chow. Pronta la risposta. “La Cina ha assunto un atteggiamento positivo nel migliorare le relazioni con il Vaticano”, ha dichiarato Mao Ning, portavoce del Ministero degli Esteri, durante la conferenza stampa quotidiana.
Santa Sede e Pechino hanno rinnovato già due volte l’accordo biennale del 2018 sulla nomina dei vescovi, ma il Vaticano ha denunciato più volte di non essere stato consultato durante le procedure di scelta operate dal Partito comunista. Col viaggio in Mongolia, Bergoglio spera di aver fatto un passo in più in direzione di Pechino.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Se in Asia c’è un esempio brillante di democrazia, questo è probabilmente Taiwan. Dal 1996, anno delle elezioni che hanno portato Lee Teng-hui a diventare il primo presidente democraticamente eletto, Taipei ha fatto passi da gigante. Ci sono stati tre passaggi di potere del tutto pacifici, con gli sconfitti che hanno accettato l’esito delle urne, nonostante la forte polarizzazione che contraddistingue un sistema politico basato sulla contrapposizione tra il Partito progressista democratico (DPP) e il Kuomintang (KMT). L’avanzamento dei diritti è stato costante e ha portato Taiwan a diventare nel 2019 il primo luogo in Asia a riconoscere i matrimoni tra persone dello stesso sesso. Negli scorsi mesi è arrivato anche il via libera alle adozioni per le coppie gay. Il governo, anche grazie all’attività della ministra degli Affari digitali Audrey Tang, promuove un sistema di governance partecipativa che utilizza consultazioni pubbliche per recepire indicazioni e suggerimenti sulle politiche da attuare.
Detta così, sembra una favola. Anche perché nella narrazione mediatica occidentale prevale spesso un racconto “esterno” di Taiwan, legato più che altro al triangolo con Stati Uniti e Repubblica Popolare Cinese e alle questioni legate alla sicurezza o esercitazioni militari. Sul fronte interno, si resta piuttosto in superficie. Eppure, com’è normale che sia per qualsiasi democrazia al mondo, anche a Taiwan tra le tante luci non mancano certo le zone d’ombra.
Il primo esempio è quello che riguarda il mercato del lavoro. Nel 2022 poco più del 23% della forza lavoro di Taiwan ha guadagnato meno di 30mila dollari taiwanesi al mese, meno di 900 euro. Il salario medio dell’intera forza lavoro è stato lo scorso anno di poco inferiore a 41mila dollari taiwanesi al mese, circa 1200 euro. I numeri variano molto a seconda dell’area di riferimento. Se a Taipei o Hsinchu (sede del colosso dei semiconduttori TSMC e di altri giganti dei microchip e dell’elettronica) gli stipendi sono più alti, in alcune zone più rurali si scende parecchio. Il problema, come spesso accade, si acuisce soprattutto tra le nuove generazioni. Il 70% dei giovani taiwanesi guadagna tra i 27mila e i 29mila dollari taiwanesi al mese. Il Ministero del Lavoro ha dichiarato che i bassi salari sono dovuti alla mancanza di laureati con competenze in “settori chiave”. Il governo ha fatto sapere di voler aumentare il numero di giovani che si laureano con competenze nei settori della produzione di semiconduttori, dell’intelligenza artificiale e delle comunicazioni intelligenti. Tre cardini della strategia di crescita non solo economica ma anche strategica di Taiwan. Il tasso di partecipazione al lavoro dei giovani taiwanesi è inoltre inferiore del 10% rispetto alla media OCSE, a causa del numero relativamente elevato di anni di istruzione frequentati dagli studenti taiwanesi, un divario che il Ministero spera di colmare.
Non solo. Taiwan ha alcune delle tasse universitarie molto alte, se si tiene conto della parità di potere d’acquisto. Bassi salari, alte tasse universitarie, alti prezzi degli alloggi, soprattutto a Taipei. I giovani taiwanesi sono spesso in difficoltà e comprare una casa diventa spesso un’utopia. Tutti aspetti che peraltro influiscono sulla bassa natalità che affligge Taiwan. Bassi stipendi e alte spese significa far fatica a costruire una famiglia. E dunque a fare figli. Non a caso il calo demografico è una delle maggiori preoccupazioni di Taipei, che secondo alcuni report potrebbe perdere circa un quarto della sua popolazione da 24 milioni entro il 2050. Un problema che si ripercuote peraltro anche sull’indebolimento della forza lavoro, che sta provocando tra le altre cose una carenza di infermieri. Secondo le normative, il rapporto medio infermiere-paziente dovrebbe essere di 1 a 8 negli ospedali di grandi dimensioni, 1 a 10 negli ospedali regionali e 1 a 15 negli ospedali locali. Tuttavia, accade spesso che un’infermiera che lavora in un turno diurno debba occuparsi di più di 15 pazienti. Il sovraccarico di lavoro porta spesso infermieri a licenziarsi, innescando un circolo vizioso difficile da interrompere senza interventi decisi.
I problemi vissuti dal mercato del lavoro sono simboleggiati anche dalle proteste che si sono svolte negli ultimi tempi. In occasione della festa del Primo Maggio, migliaia di persone hanno marciato per le strade di Taipei per contestare le politiche del governo in materia di salari e diritti del lavoro. La Confederazione dei Sindacati di Taiwan (TCTU) sostiene che il DPP, nonostante abbia avuto la maggioranza parlamentare negli ultimi sette anni, non ha mantenuto la promessa di emanare una legge sul salario minimo. Si tratta di un tema che ha contraddistinto la campagna elettorale con cui la Presidente Tsai Ing-wen ha vinto il voto del 2016. Sebbene il salario minimo sia aumentato del 28,36% da quando Tsai è entrata in carica, i salari reali sono stati pesantemente erosi dall’inflazione, problema notevolmente acuito dalle conseguenze della guerra in Ucraina che hanno fatto schizzare in alto i prezzi delle case e di un’infinita lista di categorie merceologiche, a partire dal settore alimentare. I sindacati vogliono un quadro normativo chiaro e stabile: la richiesta a Tsai è quella di aumentare il salario minimo mensile di 3600 dollari taiwanesi, portandolo a 30mila dollari. E poi di introdurre una legge, prima della fine del suo secondo mandato nel maggio del prossimo anno, che istituisca un meccanismo di adeguamento del salario minimo.
Un altro classico tema di dibattito è quello della scarsità del numero di giorni festivi e di ferie concessi ai lavoratori dipendenti. Viene poi espressa la necessità di aumentare i contributi minimi per il conto pensionistico dei lavoratori da parte dei datori di lavoro rispetto all’attuale 6% del salario individuale. A lamentarsi sono anche i fattorini e i lavoratori della cosiddetta gig economy, figure atipiche non ancora coperte dalla legge che fissa gli standard lavorativi.
Tra le altre questioni non ancora del tutto risolte c’è quella che riguarda le minoranze. Oggi il 98% della popolazione di Taiwan è di etnia han, quella maggioritaria anche in Cina continentale. Frutto di ondate migratorie avvenute in diversi momenti storici. Il 2% circa della popolazione proviene da diversi gruppi indigeni, che secondo diversi studi ed evidenze archeologiche hanno dato origine alle popolazioni austronesiane. Le comunità indigene di Taiwan hanno affrontato una lunga e travagliata storia di trattamento negativo e discriminazione. Sia durante la colonizzazione giapponese, sia dopo l’arrivo del KMT di Chiang Kai-shek dopo la sconfitta nella guerra civile del 1949, le politiche di modernizzazione del governo centrale hanno spesso ignorato i diritti delle comunità indigene e i loro bisogni. La confisca delle loro terre ha privato le comunità indigene del loro modo tradizionale di sostenersi, creando dipendenza da lavori precari e impoverimento. La perdita di identità culturale e la pressione per assimilarsi alla cultura dominante hanno causato un senso di alienazione e discriminazione all’interno della società taiwanese più ampia. L’accesso limitato all’istruzione di qualità e alle opportunità economiche ha anche contribuito a un ciclo di svantaggio sociale per le comunità indigene. Negli ultimi decenni, ci sono state significative iniziative messe in atto dal governo per proteggere i diritti delle minoranze, compreso il riconoscimento delle loro terre tradizionali e la promozione della cultura indigena nelle scuole. L’opinione pubblica taiwanese si è sensibilizzata sulla questione, anche attraverso una promozione culturale che passa da alcuni musei e serie televisive che raccontano la loro storia, proponendo una visione in cui le minoranze e l’eterogeneità identitaria arricchiscono Taiwan.
Ma molte sfide permangono e ogni tanto si verificano ancora episodi che danno vita a delle tensioni. A maggio, un gruppo di studenti indigeni della National Taiwan University di Taipei ha inscenato una protesta nel campus contro quella che, a loro dire, è una discriminazione di fondo nei loro confronti. Il motivo del contendere era uno striscione apparso nel campus con lo slogan “sfogo del mio spleen a 4,5 zhang“, un gioco di parole sull’idioma cinese “sfogo del proprio spleen a tre zhang“, che descrive lo stato di rabbia con “zhang“, antica unità di misura cinese della lunghezza. Lo slogan, secondo un'”alleanza contro la discriminazione” formata da studenti indigeni della NTU, sarebbe una sottile frecciatina alla politica del Ministero dell’Istruzione per “garantire agli studenti indigeni un accesso adeguato” alle università. Nelle chat degli studenti era circolata una frase anticipatoria dello striscione: “I privilegi concessi alle popolazioni indigene sono una tirannia per gli abitanti delle città”. Il riferimento era al sistema di ponderazione più favorevole introdotto per le minoranze indigene.
A proposito di minoranze, nonostante le parole di sostegno (politico e non) arrivate negli scorsi anni dopo le proteste e la repressione che ne è seguita, gli abitanti di Hong Kong non stanno trovando a Taiwan quel porto sicuro che pensavano di avere. Anzi, per gli attivisti e gli esuli politici di Hong Kong potrebbe presto diventare più difficile rimanere a lungo a Taiwan. Secondo i piani di modifica dei requisiti di residenza in fase di approvazione, ai cittadini di Hong Kong potrebbe essere richiesto di aver vissuto più a lungo nella Repubblica di Cina (nome ufficiale di Taiwan) per ottenere la residenza permanente. Secondo le regole attuali, alcuni immigrati di Hong Kong e Macao possono ottenere la residenza permanente più facilmente di altri cittadini stranieri, per i quali sono richiesti cinque anni di residenza. Ciò potrebbe presto cambiare. La ragione della modifica sarebbe quella di evitare che le regole possano essere sfruttate da “spie” della Cina continentale. Ma se approvate, le modifiche rappresenterebbero un altro colpo all’immagine di Taiwan come rifugio per i dissidenti e i critici di Pechino. L’amministrazione Tsai ha aperto un ufficio dedicato ai servizi di scambio tra Taiwan e Hong Kong per assistere gli arrivi dall’ex colonia britannica il giorno dopo l’introduzione della famosa legge sulla sicurezza nazionale. Ma negli anni successivi, alcuni esuli di Hong Kong hanno trovato la vita a Taiwan più difficile del previsto, affrontando problemi che vanno dai salari più bassi all’eccessiva burocrazia, dalle barriere linguistiche alla difficoltà di ottenere i documenti per restare in modo permanente. Tra gennaio 2020 e marzo 2023, 32.364 hongkonghesi hanno ottenuto il permesso di residenza a Taiwan. Ma l’anno scorso il numero di nuovi residenti da Hong Kong è sceso a 8.945. Le domande sono diventate più difficili da quando Taiwan ha chiuso il suo consolato non ufficiale nel 2021, ma ora molti taiwanesi vedono sempre meno distinzioni tra Hong Kong e la Cina continentale.
A Taiwan, d’altronde, manca ancora una legge sul diritto d’asilo, nonostante le numerose discussioni al riguardo durante la campagna elettorale di Tsai e le pressioni di coloro che ricordano che durante la legge marziale erano stati i taiwanesi a trovare rifugio a Hong Kong. Le richieste, infatti, sono ancora esaminate caso per caso.
Anche sul fronte della politica estera, spesso viene da chiedersi che cosa c’entrino Paesi come Haiti, Guatemala o eSwatini con la retorica dei “like-minded partners” utilizzata da Taipei per raccontare i suoi rapporti con gli alleati diplomatici o i paesi “amici” con i quali non si intrattengono relazioni ufficiali come Stati Uniti e Giappone. Taiwan ha a lungo staccato corposi assegni tutti gli anni per il regime sandinista di Ortega in Nicaragua, prima che il Paese centroamericano decidesse a fine 2021 di avviare rapporti diplomatici con la Repubblica Popolare Cinese. Insomma, Taiwan ha tante storie positive da raccontare, ma com’è normale che sia esistono anche storie meno edificanti.
Questo articolo è pubblicato anche sul numero di Luglio/Settembre di eastwest
Puoi acquistare la rivista sul sito o abbonarti
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Papa Francesco è pronto a diventare il primo pontefice della storia a recarsi in visita in Mongolia. Prevista per giovedì sera la partenza dall’aeroporto di Fiumicino, con arrivo all’aeroporto Chinggis Khaan di Ulan Bator per la mattinata di venerdì 1° settembre. Un viaggio che conferma la proiezione asiatica del papato di Bergoglio, che si avvicina come mai fatto prima alla Cina, cioè la meta che lui stesso ha definito a più riprese come una sorta di “sogno”. Lui, gesuita come Matteo Ricci, in territorio cinese. Un passaggio che avrebbe davvero un significato storico, che per ora si ferma però nella limitrofa Mongolia, il Paese asiatico stretto tra Cina e Russia e futura via di passaggio del gasdotto Power of Siberia 2.
“Si tratta di una visita tanto desiderata”, ha confessato Bergoglio al termine dell’Angelus di domenica 27 agosto. “Sarà l’occasione per abbracciare una Chiesa piccola nei numeri ma vivace nella fede e grande nella carità. E anche per incontrare da vicino un popolo nobile, saggio, con una grande tradizione religiosa che avrò l’onore di conoscere specialmente nel contesto di un evento interreligioso”. Al centro del viaggio i rapporti con la religione buddista, maggioritaria in Mongolia. Giusto negli ultimi mesi, un bambino di 8 anni di cittadinanza mongola è stato scelto dal Dalai Lama come nuovo Khalka Jetsun Dhampa, terza carica del buddismo tibetano. Una nomina che in Mongolia crea in realtà anche qualche preoccupazione, vista la disputa aperta tra il Dalai Lama e la Repubblica Popolare Cinese, che rivendica il diritto di nomina delle cariche religiose tibetane.
Il pellegrinaggio di Bergoglio ha anche un alto valore simbolico. Da sempre il Papa “venuto dalla fine del mondo” insiste sulla necessità di ampliare gli sforzi e il ruolo della Chiesa nelle cosiddette periferie globali. E la Mongolia è senz’altro una di queste, visto che conta solo poche centinaia di fedeli cattolici. Per l’esattezza, i battezzati sono poco meno di 1500, circa il 2% dei 3,5 milioni di abitanti di cui il 30% si professa non religioso.
Altro tema centrale sarà l’ambiente, visto che proprio la Mongolia nel 2026 ospiterà la Cop17 della Convenzione delle Nazioni Unite per combattere la desertificazione. Un fenomeno che, secondo gli ultimi studi, colpisce circa il 76% del territorio mongolo. E che mette a rischio la produzione agricola, cruciale per l’economia del Paese asiatico, nonché l’antica tradizione pastorale e nomade. A incidere anche le attività estrattive. Mongolia e Mongolia interna, quest’ultima una delle province del territorio cinese, hanno attive ancora molte miniere e centrali elettriche a carbone, anche perché molto ricche di risorse minerali o terre rare considerate strategiche per la competizione tecnologica e la transizione energetica. Il governo locale si trova di fronte alla difficile sfida di trovare un equilibrio tra esigenze climatiche e necessità economiche, visto che altri settori, a partire dal turismo, sono stati pesantemente colpiti prima dalla pandemia di Covid-19 e poi dalla guerra in Ucraina che ha bloccato il consueto flusso dalla Russia.
Bergoglio si fermerà in Mongolia fino a lunedì 4 settembre. In programma incontri col Presidente Ukhnaagiin Khurelsukh e il capo del Grande Hural di Stato (il parlamento unicamerale mongolo) Gombojavyn Oyun-Erdene. Ma anche ovviamente con vescovi, sacerdoti e missionari presenti in Mongolia. Domenica 3 settembre in agenda l’incontro ecumenico e interreligioso con esponenti del buddismo tibetano, mentre nel pomeriggio il Papa celebrerà la messa nella Steppe Arena.
Un programma fitto che conferma il recente grande attivismo diplomatico della Mongolia, che sta cercando di rafforzare la diversificazione dei suoi rapporti internazionali. Solo poche settimane fa, il premier Luvsannamsrain Oyun-Erdene si è recato negli Stati Uniti dove ha incontrato la vicepresidente Kamala Harris. A luglio, invece, era stato a Ulan Bator il Presidente francese Emmanuel Macron.
Ma la visita rafforza anche la presenza asiatica della Chiesa cattolica. A fine luglio, durante la visita a Roma del Presidente Vo Van Thuong, la Santa Sede ha raggiunto uno storico accordo col Vietnam per la nomina di un rappresentante stabile del Vaticano ad Hanoi. Uno sviluppo rilevante che potrebbe servire da apripista, quantomeno nei programmi vaticani, a un simile accordo con la Cina. Per ora, con Pechino è in vigore un accordo sulla nomina dei vescovi di durata biennale, istituito nel 2018 e rinnovato già due volte nel 2020 e nel 2022. In attesa di un viaggio in terra cinese, un Pontefice arriva per la prima volta davvero alle sue porte.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
A Johannesburg, grande assente Vladimir Putin, e grande presente Xi Jinping. Gli interessi cinesi nel summit e nella spinta all’allargamento, richiesto da una ventina di Paesi del cosiddetto Sud globale, desiderosi di entrare nel blocco dei Brics.
A Johannesburg è tutto pronto per il summit annuale dei leader del gruppo BRICS, di cui fanno parte Brasile, Russia, India, Cina e appunto Sudafrica. Unico assente, Vladimir Putin. Il mandato d’arresto della Corte Penale Internazionale, riconosciuta dal Paese africano, avrebbe rischiato di costringere le autorità locali a procedere all’arresto. E dunque il capo del Cremlino ha deciso di mandare il fidato ministro degli Esteri Sergej Lavrov al suo posto.
La sua assenza aumenterà ulteriormente la già ampia risonanza della presenza di Xi Jinping. Non era scontato che il presidente cinese decidesse di recarsi a Johannesburg di persona. D’altronde, già a luglio, il summit dei leader della Sco (l’Organizzazione della cooperazione di Shanghai) di Nuova Delhi è stato ridotto a un formato virtuale per evitare imbarazzi al padrone di casa, un’India impegnata in un complicato esercizio di equilibrismo tra Quad, Sco e appunto Brics.
Invece Xi ha deciso di esserci. Una mossa importante, che arriva in un momento peraltro parecchio delicato. Venerdì scorso, Joe Biden ha ospitato il premier giapponese Fumio Kishida e il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol, per il primo trilaterale di questo tipo di sempre. Pechino l’ha interpretata come un’azione ostile nei suoi confronti e un tentativo di creare una sorta di “mini Nato asiatica”.
Non sorprende dunque che il viaggio di Xi in Sudafrica venga presentato anche mettendo in evidenza le pretese differenze di azione diplomatica tra le due potenze: la cooperazione win-win con attenzione ai Paesi in via di sviluppo del cosiddetto “Sud globale” da parte di Pechino, contro invece la “mentalità da guerra fredda” e la logica del “confronto tra blocchi” che sarebbero promosse dagli Usa.
Un racconto che si poggia sul ruolo dei Brics e sulla volontà di tanti altri governi di aderire al gruppo. L’espansione è in cima all’agenda dopo essere stata messa in secondo piano ai vertici precedenti. Ci sarebbero circa una ventina di Paesi desiderosi di entrare. Tra questi Argentina, Indonesia, Arabia Saudita ed Egitto.
La spinta della Cina verso l’allargamento è stata tradizionalmente rallentata dall’India, ma anche dal Brasile. Il timore è quello di trasformare il gruppo in una piattaforma filocinese o quantomeno utilizzata da Pechino come strumento di confronto con gli Stati Uniti e l’Occidente. Cosa che il premier indiano Narendra Modi e il presidente brasiliano Lula vogliono evitare. Ma è aumentata la pressione di chi chiede che vengano concordate regole e criteri di ammissione, aprendo dunque la porta all’adesione di nuovi membri.
Ovviamente si parlerà anche di economia. Il blocco proverà a ravvivare l’idea di ridurre il predominio del dollaro statunitense nei pagamenti. Un dibattito che ha ripreso grande vigore dopo che gli aumenti dei tassi di interesse americani e l’invasione dell’Ucraina hanno fatto impennare la valuta statunitense. Senza contare il desiderio di schermarsi di fronte a eventuali sanzioni future di alcuni dei componenti del gruppo. Il tentativo sarà quello di incentivare l’utilizzo delle valute nazionali dei vari Paesi membri negli scambi commerciali e transazioni transfrontaliere, ma l’idea di sviluppare una moneta comune appare ancora molto lontana.
Un articolo di Chen Xiaodong, ambasciatore della Cina in Sudafrica, riassume bene la prospettiva cinese sui BRICS: “Il meccanismo di cooperazione BRICS è un’importante piattaforma per la collaborazione tra i Paesi dei mercati emergenti e le nazioni in via di sviluppo. È diventata una forza chiave nel promuovere la crescita economica globale, guidare le riforme nel sistema di governance globale e mantenere la pace e la stabilità internazionali”. Sviluppo e stabilità, in linea con l’iniziativa di sicurezza globale lanciata da Xi lo scorso anno e che ha avuto i primi riverberi nelle iniziative diplomatiche sul Medio Oriente e sull’Ucraina, pur con esiti molto alterni.
Ma per Xi sono cruciali altri due passaggi. Il primo è un forum di dialogo che presiederà insieme al presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, a cui parteciperà la maggior parte dei leader africani. Un modo per riaffermare il legame tra la Cina e un continente cruciale per gli interessi di Pechino, che da decenni ormai investe ingenti somme sulle sue infrastrutture ottenendo in cambio un accesso privilegiato alle sue risorse naturali e minerarie.
Il secondo appuntamento molto atteso è il possibile bilaterale con Modi. I due non si parlano da maggio 2020, poche settimane prima dei violenti scontri esplosi lungo l’enorme confine conteso che hanno causato diversi morti tra i militari di entrambe le parti. Scontri che si sono poi ripetuti anche lo scorso dicembre, stavolta senza vittime. Un incontro tra funzionari della difesa, avvenuto nei giorni scorsi, non è bastato per un totale disgelo. Ma avrebbe quantomeno posto le basi affinché Xi e Modi possano tornare a parlarsi. Sarebbe uno sviluppo rilevante.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Nuovo stress test sullo Stretto di Taiwan. Il vicepresidente taiwanese, Lai Ching-te, sta effettuando un viaggio tra Stati Uniti e Paraguay che rischia di riaccendere le tensioni tra Taipei e Pechino. Il tutto un anno dopo la visita di Nancy Pelosi a Taiwan, che diede il via alle più vaste esercitazioni di sempre intorno all’isola. Da allora, le manovre di jet e navi dell’Esercito popolare di liberazione oltre la linea mediana, il confine sullo Stretto non riconosciuto ma ampiamente rispettato sino ad agosto 2022, si sono moltiplicate e si svolgono su base pressoché quotidiana.
Il viaggio non è una novità assoluta ed era anzi atteso da tempo. Si tratta infatti dell’undicesima volta che un vicepresidente taiwanese effettua un transito negli Stati Uniti, la seconda per Lai che era passato da queste parti nel gennaio del 2022 sulla strada dell’Honduras, dove aveva assistito alla cerimonia d’insediamento di Xiomara Castro. La presidente honduregna ha poi deciso nei mesi scorsi di rompere le relazioni diplomatiche con Taipei, per stabilire quelle con Pechino.
I paesi rimasti ad avere rapporti ufficiali con la Repubblica di Cina, il nome con cui Taiwan è indipendente de facto, sono rimasti 13. Tra questi il Paraguay, dove Lai si reca lunedì 14 al termine del primo transito a New York. Martedì 15 è in programma la cerimonia di insediamento del neo presidente Santiago Peña, che vincendo le elezioni dei mesi scorsi ha allontanato le possibilità che anche Asuncion possa abbandonare Taiwan, come chiedeva invece uno degli altri candidati.
Il profilo del viaggio di Lai appare però più basso rispetto a quello del 2022. C’è un dettaglio, infatti, che rende più delicato che mai il suo transito dagli Stati Uniti: Lai non è solo il vicepresidente, ma anche il candidato alle presidenziali del 2024 per l’attuale forza di maggioranza, il Partito progressista democratico della presidente Tsai Ing-wen. Non è certo strano che un candidato taiwanese si presenti negli Stati Uniti. Anzi, è una sorta di tradizione.
Gli stessi rivali di Lai al voto di gennaio prossimo lo hanno fatto o lo faranno. Ko wen-je, sindaco di Taipei e attualmente secondo nei sondaggi con il suo Taiwan People’s Party, è stato a Washington nei mesi scorsi. Hou Yu-ih, il candidato del Kuomintang (il partito nazionalista cinese, dialogante con Pechino), dovrebbe andarci a settembre.
Ma per Pechino, con Lai è un’altra storia. Intanto perché è già la seconda carica della politica taiwanese. E poi perché viene ritenuto un “secessionista”. Questo soprattutto per alcune sue dichiarazioni passate, in cui si era raffigurato come un “lavoratore per l’indipendenza di Taiwan”. Cosa ben diversa dal riconoscere e dire di voler tutelare la sovranità de facto di Taiwan come Repubblica di Cina, la posizione ufficiale di Tsai e dello stesso Lai, che ha molto smussato la sua retorica e le sue esternazioni sulle relazioni intrastretto da quando è vicepresidente. Ma a Pechino ricordano che nel 2019, il detestato partito di maggioranza (per il suo mancato riconoscimento del cosiddetto “consenso del 1992”, che riconosceva l’esistenza di una unica Cina pur, dice il Kuomintang, senza stabilire quale) fu sull’orlo della scissione per i contrasti tra l’ala radicale di Lai e quella più moderata di Tsai.
Proprio per questo, Lai sta cercando di veicolare un’immagine di continuità sia sul piano interno sia durante il suo viaggio. “Se Taiwan è sicura, il mondo è sicuro. Se sullo Stretto di Taiwan c’è pace, nel mondo c’è pace”, ha detto durante il discorso alla comunità taiwanese di New York, a cui ha presenziato Ingrid Larson, direttrice generale dell’Ufficio di Washington dell’American Institute in Taiwan (di cui incontrerà la presidente Laura Rosenberger nel secondo transito di San Francisco).
Le direttrici del suo discorso sono state in linea con Tsai: disponibilità al dialogo con il Partito comunista, ma tutela della sovranità de facto di Taiwan come entità non subordinata alla Repubblica Popolare, entro la cornice della Repubblica di Cina e senza indipendenza formale. Presente anche il capo dello staff di Tsai, Lin Chia-lung per ribadire la pretesa di continuità con l’ex rivale all’interno del partito. Una necessità, dopo alcune esternazioni delle scorse settimane che avevano destato qualche timore sulla riedizione di un periodo Chen Shui-bian, il primo presidente eletto col Dpp nel 2000 e non apprezzato dagli Usa per la sua imprevedibilità. Caratteristica che ora renderebbe tutto più pericoloso, visto che la Repubblica Popolare Cinese non è certo quella di 20 anni fa.
Lai vuole presentarsi come garante dello status quo, che nonostante le attuali tensioni a diverse componenti degli Usa (con l’amministrazione Biden che si professa comunque neutrale sul voto taiwanese) sembrerebbe più appetibile rispetto a un ritorno del Kuomintang, che invece veniva quasi apertamente sostenuto dall’amministrazione Obama fino al 2012.
Il profilo del viaggio di Lai è stato finora piuttosto basso. A New York non sono stati annunciati incontri con nessun componente dell’amministrazione Biden o del Parlamento. In Paraguay non potrà imbattersi nella vicepresidente Kamala Harris, com’era invece accaduto in Honduras nel gennaio 2022. Tra i repubblicani statunitensi c’era chi aveva chiesto che la vicepresidente incontrasse Lai, una possibilità di cui si è parlato molto anche a Taipei. Ma alla fine Biden ha mandato ad Asuncion (dove un incontro con Lai sarebbe stato meno sensibile che durante i due transiti negli Usa) la segretaria degli Interni, Deb Haaland. Mercoledì 16 agosto previsto il transito a San Francisco, proprio la città dove dovrebbe recarsi a novembre Xi Jinping per il summit dell’Asia Pacifico. Non è ancora chiaro chi vedrà in questo caso Lai, che si fermerà solo per mezza giornata prima del rientro a Taipei.
Pressoché certa la reazione di Pechino. Domenica 13 il ministero degli Esteri cinese ha definito Lai un “piantagrane”, ha detto di “monitorare attentamente” i suoi transiti negli Stati Uniti e che verranno prese “misure forti e risolute a tutela della sovranità nazionale e integrità territoriale”. Ampiamente attese nuove esercitazioni militari intorno a Taiwan. Non certo quelle di routine lanciate sabato 12 nel mar Cinese orientale, al largo della provincia dello Zhejiang e a più di 500 chilometri a nord di Taiwan. No, è probabile che ci sia una finestra temporale per svolgere esercitazioni più o meno ampie dopo il transito di Lai a San Francisco e prima della partenza di Xi per il Sudafrica, dove sarà il 22 agosto per il summit dei Brics.
I funzionari taiwanesi si aspettano possibili manovre aeree e/o navali nei pressi delle 24 miglia nautiche dalle coste, che segnano l’ingresso nelle acque contigue. Quello delle 24 miglia è il limite che è stato lambito dai mezzi di Pechino già ad agosto 2022 e nei mesi scorsi, ma oltre cui non si è mai andati. Attenzione anche alla possibile estensione delle ispezioni a bordo delle navi in passaggio sullo Stretto annunciata in alcune zone dal Fujian lo scorso aprile, e poi non messe in atto in modo stringente.
La sensazione è però che la reazione militare possa essere in qualche modo contenuta. Soprattutto se, come pare, Lai terrà un basso profilo durante il doppio passaggio negli Usa. Un po’ come accaduto ad aprile, quando Tsai incontrò lo speaker del Congresso Kevin McCarthy in California. In quell’occasione Taipei messe in atto una sorta di “male minore” per Pechino: incontro con McCarthy sì, ma negli Usa invece che a Taiwan. Invito al compromesso che fu colto per effettuare manovre sì vaste ma non tanto quelle dell’agosto 2022 dove la visita di Pelosi non aveva contenuto nessun segnale di compromesso, nemmeno nei suoi più piccoli dettagli.
In vista delle elezioni di gennaio 2024, manovre troppo forti potrebbero rivelarsi un boomerang per il Partito comunista, che senz’altro utilizzerà comunque la vicenda e il suo malcontento che non mancherà di dimostrare più volte anche a parole come leva negoziale (in senso ampio e non su Taiwan dove un negoziato è impossibile) nei dialoghi in corso con Washington per organizzare il viaggio di Xi a San Francisco.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Firmati accordi su voli Open Skies e sull’estrazione di minerali critici. La Mongolia possiede ampi depositi di rame e terre rare, importanti nella competizione tecnologica tra Washington e Pechino.
Non solo Giappone, Corea del Sud e Filippine. Gli Stati Uniti allargano lo spettro della loro azione diplomatica in Asia orientale, con uno sguardo anche a quei paesi che a prima vista sembrerebbero ormai inseriti negli ingranaggi della Cina. Tra questi anche la Mongolia, snodo chiave incastonato tra Repubblica Popolare e Russia.
Da qui passerà in futuro il Power of Siberia 2, il nuovo gasdotto frutto di un accordo tra Pechino e Mosca che aumenterà in maniera rilevante le forniture energetiche russe alla Cina. Proprio un anno fa, il premier Luvsannamsrain Oyun-Erdene ha annunciato l’inizio dei lavori per la sua costruzione in territorio mongolo. Oggi, lo stesso premier è reduce da una visita negli Stati Uniti, la prima per un pari grado dal 2018. Un passo rilevante e che mostra l’interesse di Ulan Bator a diversificare le proprie relazioni diplomatiche. Il sottotesto è significativo anche per Cina e Russia, “avvisate” indirettamente che la Mongolia ha intenzione di preservare i suoi rapporti commerciali e politici con l’Occidente.
“Gli Stati Uniti non sono solo il nostro vicino commerciale, ma anche la stella polare dell’economia di mercato e dei valori democratici della Mongolia”, ha dichiarato Oyun-Erdene in un’intervista rilasciata all’ambasciata mongola a Washington. Parole che sembrano andare al di là della circostanza e convenienza commerciale. Alla domanda sui rapporti con i vicini della Mongolia il premier ha risposto: “Abbiamo le nostre tensioni geopolitiche… ma sono fiducioso che i nostri due vicini continueranno a rispettare le nostre scelte e le partnership che stiamo sviluppando”.
Queste scelte includono la firma dell’accordo Open Skies e un altro sulle terre rare, annunciati a margine dell’incontro con la vicepresidente statunitense Kamala Harris. Washington ha stipulato accordi di aviazione civile Open Skies con oltre 130 paesi. Si tratta di una piattaforma che consente alle compagnie aeree di entrambi il diritto di operare nei rispettivi Paesi, imponendo standard di sicurezza e protezione.
La compagnia di bandiera della Mongolia, MIAT Mongolian Airlines, vola in Europa e in Asia, ma non negli Stati Uniti. L’accordo Open Skies cambierà la situazione e offrirà anche opzioni più facili per i voli cargo. Il nuovo accordo si affianca a nuove iniziative di scambio culturale e di formazione in lingua inglese in Mongolia, dopo la recente legislazione che ha reso l’inglese la prima lingua straniera nell’istruzione secondaria del paese asiatico.
Più strategico sul fronte tecnologico e politico il dialogo sulle risorse minerali. La Mongolia possiede ampi depositi di minerali, di terre rare e di rame, materiali critici a cui anela l’amministrazione Biden per elettrificare il mercato automobilistico nazionale. La Casa Bianca vede la Mongolia come un candidato per il Partenariato per la sicurezza dei minerali, un’iniziativa con 14 paesi per lo più occidentali per promuovere investimenti sostenibili nell’estrazione, nella lavorazione e nel riciclaggio di minerali critici.
Secondo il Dipartimento di Stato americano, i funzionari dei due paesi hanno discusso “modi creativi” per garantire che Ulan Bator possa ovviare al mancato sbocco sul mare e immettere minerali critici sul mercato mondiale. Oyun-Erdene ha dichiarato che la Mongolia intende approfondire la cooperazione con gli Stati Uniti per l’estrazione di terre rare e altri minerali con applicazioni high-tech. Un tema particolarmente delicato, vista l’importanza delle terre rare nella competizione tecnologica Washington e Pechino.
Il premier mongolo ha incontrato anche giganti del settore privato. Tra questi, spiccano i colloqui con l’amministratore delegato di Tesla Elon Musk su possibili investimenti e collaborazioni nel settore dei veicoli elettrici. La SpaceX di Musk è stata anche autorizzata a operare come fornitore di servizi Internet in Mongolia.
Il principale interesse di Ulan Bator è quello di ridurre la dipendenza dai suoi vicini. Nello specifico, la Cina acquista più del 90% delle esportazioni della Mongolia e Ulan Bator si affida al porto di Tianjin per spedire gran parte di ciò che vende al resto del mondo. La Mongolia spera che la tecnologia possa ridurre questa dipendenza. “In futuro, le merci potrebbero essere trasportate da droni”, ha dichiarato Oyun-Erdene dopo l’incontro con Harris.
Ambizione legittima, ma che non cela certo l’obiettivo di scaricare o prendere le distanze da Pechino o Mosca. La Mongolia sa che i suoi “eterni vicini” sono destinati a restare. L’importante è provare a non restarne schiacciati.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Il passato è definitivamente alle spalle. L’Occidente ha messo da parte le perplessità sul conto di Ferdinand Marcos Junior. Non tanto perché non piacesse lui in sé, quanto ovviamente per l’ingombrante retaggio che si porta dietro a causa del padre, dittatore delle Filippine fino al 1986 e alla rivoluzione di febbraio. E a causa della mamma Imelda, ancora viva e per molti vera mente dell’ascesa politica del figlio, che delle Filippine è diventato Presidente dopo le elezioni del maggio 2022.
In molti si aspettavano un’estremizzazione della politica filocinese promossa da Rodrigo Duterte, anche perché la vicepresidente è Sara, figlia del suo predecessore. E invece no, Marcos Jr. ha subito riportato l’arcipelago del Sud-Est asiatico nell’alveo del sistema di alleanze degli Stati Uniti nel Pacifico. Tanto da raggiungere un accordo con l’ex colonizzatore, aprendo quattro nuove basi militari su territorio filippino alle forze armate di Washington. In posizione ritenuta a dir poco cruciale in caso di contingenza militare su Taiwan. O sul mar Cinese meridionale, dove le tensioni con la Cina sono in crescita. Proprio anche in seguito a questa ridefinizione della postura strategica di Manila. Marcos ha ricevuto il definitivo lasciapassare in ambito euroatlantico lo scorso 1° maggio, quando è stato ricevuto alla Casa Bianca da Joe Biden. Rapporti completamente rilanciati nonostante sulle sue spalle pesasse un’antica class action per la sostanziosa somma di denaro che la sua famiglia avrebbe sottratto dalle casse pubbliche filippine durante il regno del padre.
Dopo il placet americano, lunedì 31 luglio è arrivato un altro capitolo importante della diplomazia filippina. Ursula von der Leyen è infatti diventata la prima leader europea a recarsi in visita ufficiale a Manila da quando c’è Marcos Jr. La presidente della Commissione europea ha incontrato il leader filippino nel palazzo presidenziale di Malacañang, quello dove si narra che mamma Imelda aveva una collezione sterminata di oltre tremila paia di scarpe. Qui von der Leyen ha manifestato l’intenzione di dare “un nuovo slancio alle relazioni bilaterali tra Unione europea e Filippine”. In cima all’agenda: commercio, transizione ecologica, innovazione digitale e sicurezza.
Sul primo punto i due leader hanno annunciato l’intenzione di perseguire il rilancio dei negoziati per un accordo di libero scambio “ambizioso, moderno ed equilibrato, incentrato sulla sostenibilità”. Piano ambizioso, che segue gli accordi di libero scambio conclusi dall’Unione europea con Singapore e Vietnam negli scorsi anni. A testimonianza del fatto che Bruxelles punta molto sul Sud-Est asiatico, area in grande ascesa che consente anche una diversificazione dei rapporti commerciali e diplomatici nella regione asiatica rispetto alla Cina. “Le Filippine sono per noi un partner fondamentale nella regione indo-pacifica e con l’avvio di questo processo di valutazione stiamo aprendo la strada per portare il nostro partenariato al livello successivo”, ha detto von der Leyen. “Insieme, realizzeremo il pieno potenziale della nostra relazione, creando nuove opportunità per le nostre aziende e i consumatori, sostenendo anche la transizione verde e promuovendo un’economia giusta”.
Per la presidente della Commissione europea, il futuro accordo di libero scambio comprenderà impegni ambiziosi in materia di accesso al mercato, procedure sanitarie e fitosanitarie rapide ed efficaci, nonché la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche”. Al centro però anche il tema della sostenibilità, dossier su cui è già arrivato un annuncio durante la visita. Von der Leyen e Marcos hanno infatti lanciato l’iniziativa Team Europe sulla green economy, che prevede un contributo Ue di 466 milioni di euro per la gestione “verde” dei rifiuti. Il tutto nell’ambito del programma Global Gateway lanciato dalla Commissione europea. Previsto anche il trasferimento di competenze, formazione e tecnologie volte a costruire un modello alternativo di gestione dei rifiuti di plastica.
Sul fronte della sicurezza, non sono mancati riferimenti di von der Leyen alla questione del mar Cinese meridionale, con critiche alle manovre di Pechino in merito alle dispute territoriali aperte con Manila. “La Cina deve ancora assumersi pienamente la responsabilità ai sensi della Carta delle Nazioni Unite di sostenere la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina”, ha dichiarato la Presidente della Commissione Ue. “Ciò sta accadendo sullo sfondo della sua posizione più assertiva nella vostra regione. L’Europa ha costantemente invitato la Cina a rispettare i diritti sovrani degli Stati all’interno delle loro zone economiche esclusive. La dimostrazione di forza militare della Cina nel Mar Cinese Meridionale e Orientale e nello Stretto di Taiwan colpisce direttamente le Filippine e gli altri nostri partner nella regione”.
Von der Leyen ha anche collegato il fronte occidentale con quello orientale, quando ha detto che “qualsiasi indebolimento della stabilità regionale in Asia, la regione in più rapida crescita al mondo, influisce sulla sicurezza globale, sul libero flusso degli scambi e sui nostri interessi nella regione. Quindi, sia che si parli dell’Ucraina o del Mar Cinese Meridionale, la nostra sicurezza è collegata. Ecco perché l’Ue ha rafforzato il suo impegno nell’Indo-Pacifico“. Con riferimenti alle manovre di sicurezza marittima e informatica condotte dai singoli Paesi Ue nella regione. Non esattamente musica per le orecchie di Pechino. Proprio in queste settimane, per esempio, si sono svolte o sono in fase di svolgimento esercitazioni aeree congiunte di Francia e Italia con il Giappone. E le Filippine sembrano sempre più coinvolte in un’architettura di difesa che vede un crescente interesse europeo.
“Le Filippine e l’Ue sono partner affini grazie ai nostri valori condivisi di democrazia, prosperità sostenibile e inclusiva, Stato di diritto, pace e stabilità e diritti umani”, ha detto invece Marcos. “I continui scambi tra me e la Presidente von der Leyen, iniziati a Bruxelles l’anno scorso, testimoniano il nostro comune desiderio di portare le nostre relazioni bilaterali a livelli più alti”, ha aggiunto. Il passato è ormai lontano. E anche i leader europei possono mettere piede senza imbarazzi al palazzo di Malacañang.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Sono passati più di due mesi dalle elezioni in Thailandia, terminate con un successo fragoroso di Move Forward, il partito anti sistema guidato da Pita Limjaroenrat. Ma ancora il Paese del Sud-Est asiatico non ha un nuovo primo ministro. E, anzi, le speranze del grande vincitore emerso dalle urne sembrano vacillare. Giovedì 13 luglio il Parlamento ha respinto la sua prima nomina, arrivata di concerto con la coalizione che Pita è riuscito a mettere in piedi insieme al Pheu Thai della dinastia Shinawatra e ad altre forze minori.
Servivano 376 voti per ottenere il via libera, ne sono arrivati “solo” 325. Un numero che potrebbe sembrare sufficiente, visto che la camera bassa del parlamento è composta da 500 membri. Ma in realtà sulla nomina di premier e formazione del governo votano anche i 250 senatori. Espressione del potere costituito di esercito e monarchia, cioè quelle istituzioni che non vedono bene (per usare un eufemismo) l’ascesa al potere di un giovane leader che ha costruito la sua campagna elettorale promettendo una revisione del reato di lesa maestà, architrave della perpetuazione del potere della corona thailandese.
Mercoledì 19 luglio si svolge la seconda votazione. E tutti gli scenari sono aperti. Pita ha dichiarato di volerci riprovare, chiedendo dunque l’appoggio alla coalizione per i prossimi due voti. Ma ha anche aggiunto che si farà da parte a favore del partner di coalizione Pheu Thai se non riuscirà a diventare primo ministro in una delle due votazioni previste per i prossimi giorni. “La Thailandia non può continuare a lungo senza un governo popolare come questo. Ci restano poche possibilità”, ha dichiarato in un video rapidamente diventato virale sui social.
Pita ha rifiutato di ritirare la posizione di Move Forward sulla riforma reale, nonostante le pressioni dei senatori e dei partner della coalizione. Nei giorni scorsi si è iniziato a intravedere qualche scricchiolio: il leader del Partito liberale thailandese, che fa parte della coalizione, ha dichiarato che la posizione di Move Forward sulla modifica della Costituzione è “futile” ed “egoista”. E ha poi esortato Move Forward a farsi da parte per Pheu Thai, per evitare che quest’ultimo si unisca ai partiti conservatori.
Ma invece che cercare compromessi, Move Forward sembra deciso ad andare nella direzione opposta. Venerdì scorso è stata infatti presentata in Parlamento una mozione per limitare il potere del Senato. Il Segretario generale del partito, Chaithawat Tulathon, ha affermato: “Ci sono forze del vecchio potere che fanno pressione sul Senato”. La richiesta è quella di revocare l’articolo della Costituzione che consente ai senatori di votare per la nomina del primo ministro. Un tentativo che appare però velleitario, visto che ci vorrà almeno un mese per arrivare a una decisione sulla mozione.
Nel frattempo, si continueranno però a mettere in agenda votazioni. Pita ha ottenuto una seconda nomina, ma è tutt’altro che scontato che possa arrivarne una terza e soprattutto una quarta. Anche perché la pressione opposta pare destinata a salire. “Non possiamo nominare lo stesso nome due volte”, ha dichiarato il senatore Seri Suwannapanont, citando un regolamento del Parlamento che, secondo lui, impedisce che una mozione che non passa una volta venga riproposta nella stessa sessione. L’opinione è condivisa da alcuni dei suoi colleghi del Senato di nomina militare, anche se come sottolinea il Bangkok Post nella costituzione thailandese non sono previsti limiti al numero di volte in cui un candidato può essere nominato premier, né viene specificata una scadenza per la scelta del leader.
Su Pita incombono però anche due vicende dalle sfumature legali. La Corte Costituzionale ha dichiarato di aver accettato una denuncia presentata da un avvocato contro Pita e il suo partito Move Forward, secondo cui il suo piano di riforma di una legge che vieta gli insulti reali equivale a un tentativo di “rovesciare il regime democratico di governo con il re come capo di Stato”. La commissione elettorale ha invece raccomandato allo stesso tribunale di squalificare Pita come deputato, affermando di aver trovato fondamento in un reclamo in cui si affermava che non era qualificato a candidarsi alle elezioni generali del 14 maggio, a causa del suo possesso di azioni in una società di media in violazione delle regole elettorali.
Gli scenari più estremi sono quelli di un’estromissione di Pita o persino dello scioglimento di Move Forward, com’era successo in passato col partito Future Forward. Appare ottimistico, per chi ha votato i partiti riformisti, già immaginare un governo con un premier di Pheu Thai, sostenuto da Move Forward: Shinawatra Jr. oppure Srettha Thavisin. Mentre c’è chi non esclude che alla fine la forza populista di Paetongtarn Shinawatra, figlia dell’ex premier Thaksin, raggiunga un accordo con le forze pro establishment. Il premier uscente Prayuth Chan-o-cha ha già preannunciato il ritiro della politica, ma intanto continua a conservare il suo posto conquistato nel 2014 con un golpe militare. Uno spettro sempre presente nella vita politica della Thailandia.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Shavkat Mirziyoyev ha vinto le elezioni presidenziali in Uzbekistan. L’ufficialità è arrivata lunedì 10 luglio, quando la commissione elettorale ha annunciato i risultati preliminari del voto del giorno precedente. Ma in realtà questa frase poteva essere scritta nello stesso momento in cui sono state indette le elezioni, cioè dopo un referendum costituzionale che spiana la strada a due nuovi mandati presidenziali per Mirziyoyev, al potere dal 2016.
Il leader ha vinto le elezioni del 9 luglio con l’87,1% dei voti. Dei circa 20 milioni di elettori, si è presentato alle urne più o meno il 70%. Proprio l’affluenza era ritenuta un indicatore importante per dare legittimità a un voto in cui Mirziyoyev non aveva veri oppositori. Lungo tutta la campagna elettorale, gli altri tre candidati sono rimasti per lo più in silenzio. Un po’ per l’oscuramento da parte dei media, molto perché di fatto sono stati considerati da diversi osservatori internazionali come candidati di facciata. Xidirnazar Allaqulov, un ex rettore di università, era ritenuto un possibile avversario serio. Ma il suo tentativo di candidarsi è stato ostacolato e le autorità hanno bloccato gli sforzi di Allaqulov di fondare un suo partito.
Mirziyoyev è a capo della Repubblica ex sovietica dell’Asia centrale dalla morte del suo storico leader Islam Karimov. Ascesa effettuata dopo aver occupato il ruolo di premier dal 2003. Nel suo primo mandato presidenziale, ha operato diverse riforme, attirando l’attenzione mondiale di chi ha intravisto nel suo Uzbekistan un possibile esempio di apertura nella regione dell’Asia centrale. A Mirziyoyev va il merito di aver eliminato il lavoro forzato nei campi di cotone, di aver aperto il Paese al turismo e agli investimenti e di aver concesso una libertà, seppur limitata, ai media.
Ma quello che non è mai cambiato è l’ecosistema politico dell’Uzbekistan. E il secondo mandato del Presidente ha visto sprazzi di ritorno al recente passato autoritario, forse anche a causa degli effetti collaterali della guerra in Ucraina. I critici hanno sottolineato, tra le altre cose, la repressione dei disordini delle minoranze nella regione autonoma del Karakalpakstan nel luglio 2022.
Nei mesi scorsi il passaggio più critico, con la riforma costituzionale che prevedeva un’estensione dei mandati presidenziali da 5 a 7 anni e l’azzeramento delle presidenze passate. Un referendum ha approvato la riforma col 90% dei voti. Ciò consente a Mirziyoyev di aggirare il vincolo dei due mandati. Dopo l’approvazione del referendum, sono state indette elezioni anticipate, visto che il secondo mandato del leader avrebbe dovuto concludersi solo nel 2026. Il nuovo mandato di Mirziyoyev scadrà così nel 2030, con la possibilità di un suo prolungamento fino al 2037. Questo significa che ora il Presidente ha la strada spianata e soprattutto un lunghissimo periodo di tempo a disposizione per costruire quello che ha già definito “nuovo Uzbekistan“, che i critici sostengono, però, rischi di assomigliare molto a quello vecchio.
La base della legittimità sarà ricercata ancora una volta su due direttrici: crescita economica e sicurezza. Nel 2022, il Pil uzbeko è cresciuto del 5,7%, col Paese che ha attirato circa 10 miliardi di dollari di investimenti. Oltre tre volte quelli di cinque anni prima. Come tanti altri leader dell’area, Mirziyoyev si presenta poi come l’uomo in grado di garantire stabilità in una regione ancora esposta a diverse turbolenze. Basti pensare alle frequenti ribellioni in Kirghizistan o alla rivolta del gennaio 2022 in Kazakistan.
La speranza degli attivisti è che quantomeno, avendo messo in sicurezza la sua presa politica, Mirziyoyev possa operare alcune delle aperture promesse sul fronte dei diritti. In particolare la revisione del codice penale, che continua a ritenere un crimine il sesso consensuale tra due persone dello stesso sesso. Richiesta a gran voce anche una facilitazione delle regole di registrazione per le organizzazioni non governative, così come per la libertà di protesta.
Ma la sensazione è che il sistema politico uzbeko sia destinato a restare simile a quello di Karimov ancora per diverso tempo. Il tutto in un’Asia centrale che continua a mostrare tendenze autoritarie. Il Turkmenistan, per esempio, ha appena inaugurato una nuova e futuristica città “intelligente” dedicata all’ex presidente Kurbanguly Berdymukhamedov. La città si chiama Arkadag, o protettore, un titolo non ufficiale con cui i media turkmeni si riferiscono da tempo a Berdymukhamedov, che ha festeggiato il suo 66° compleanno recandosi alla città santa musulmana della Mecca. La costruzione della nuova città per 73.000 residenti è costata 3,3 miliardi di dollari e si prevede di spendere altrettanto nei prossimi anni. A tagliare il nastro è stato il nuovo Presidente e successore del “protettore”: Serdar Berdymukhamedov, suo figlio.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Come controllare i contenuti che appaiono su internet senza imporre una Grande Muraglia digitale come fatto dalla Cina? Il Vietnam sta provando a capirlo da diverso tempo. E, pare, con diversi successi. Il governo di Hanoi ha chiesto alle piattaforme social transfrontaliere di utilizzare modelli di intelligenza artificiale in grado di rilevare e rimuovere automaticamente i contenuti “tossici”. Ciò significa, nella visione del Partito comunista vietnamita, “contenuti offensivi, falsi e contro lo Stato”. La richiesta è arrivata durante la revisione di metà anno del Ministero dell’Informazione.
Si tratta dell’ennesimo segnale della volontà delle autorità vietnamite di restringere la portata delle piattaforme di social media per bloccare sul nascere qualsiasi potenziale manifestazione di dissenso organizzato.
Le grandi piattaforme internazionali ricevono pressioni già da tempo. Secondo i dati forniti dalle autorità locali, nella prima metà di quest’anno, in conformità con le richieste del governo, Facebook ha rimosso 2.549 post. YouTube ha rimosso 6.101 video, mentre TikTok ha eliminato 415 link. Negli ultimi anni il Vietnam ha emanato diverse normative che prendono di mira le piattaforme di social media straniere nel tentativo di combattere la disinformazione e soprattutto i contenuti ritenuti contrari agli interessi statali e governativi. Allo stesso tempo, il governo prova a costringere le aziende tecnologiche straniere a stabilire uffici di rappresentanza in Vietnam e a conservare i dati nel Paese.
Nel 2018 ha approvato una legge sulla cybersicurezza che obbliga Facebook e Google a togliere i post ritenuti minacce alla sicurezza nazionale entro 24 ore dalla ricezione di una richiesta governativa. Per dimostrare che faceva sul serio, a un certo punto il governo ha persino minacciato di bloccare l’accesso a Facebook se l’azienda non avesse soddisfatto le sue richieste.
Nel mirino non ci sono solo i colossi occidentali. A maggio, il Vietnam ha intrapreso un’ispezione completa sulle operazioni locali della piattaforma di video brevi TikTok e i risultati preliminari hanno mostrato “varie” violazioni da parte dell’applicazione. Mentre nelle stesse settimane il gigante dello streaming statunitense Netflix ha presentato i documenti necessari per aprire un ufficio locale in Vietnam. Una mossa arrivata dopo la visita di una maxi delegazione di aziende e giganti tecnologici e digitali degli Stati Uniti ad Hanoi.
È difficile non ottemperare alle richieste del governo vietnamita, anche perché il Paese ha un’età media bassa con una classe media in continua espansione. Sempre più vietnamiti hanno accesso a internet e nessuno vuole perdere le opportunità fornite da questa tendenza. Già nel 2020, su richiesta del governo, Facebook (che ha superato i 60 milioni di utenti locali) ha cancellato il 95% dei post ritenuti sovversivi, YouTube circa il 90%. Il tutto alla vigilia del 13esimo Congresso del Partito comunista che ha visto iniziare il terzo mandato del segretario generale Nguyen Phu Trong.
La maggior parte dei contenuti viene rimossa, secondo le parole di Facebook, per “presunta violazione delle leggi locali sulla fornitura di informazioni che distorcono, calunniano o insultano la reputazione di un’organizzazione o l’onore e la dignità di un individuo”. Amnesty International ha affermato che Facebook e YouTube sono responsabili di “censura e repressione su scala industriale” in Vietnam.
La manovra vietnamita arriva mentre i Paesi del Sud-Est asiatico stanno elaborando linee guida sulla governance e sull’etica dell’intelligenza artificiale che imporranno limiti precisi alla tecnologia. Nella vicina Cambogia, il leader “eterno” Hun Sen ha dichiarato di voler vietare Facebook, perché si dice “stufo degli abusi” che riceve dai suoi nemici politici all’estero. In realtà rivali e dissidenti bannati dalla possibilità di svolgere il loro ruolo di opposizione in vista delle elezioni del 23 luglio.
Hun Sen è sempre stato molto presente su Facebook, tra post, foto e i suoi diversi discorsi in livestreaming, anche per diverse ore. Nei giorni scorsi, Hun Sen ha dichiarato che non caricherà più su Facebook e utilizzerà invece Telegram. Proprio la Cambogia lavora da anni a un sistema di controllo dei contenuti online sotto la diretta supervisione del governo, anche se l’introduzione del suo nuovo National Internet Gateway (NIG) è stata finora rimandata. Quando l’annunciata riforma entrerà in vigore, tutte le reti dovranno collegarsi a un gateway al quale dovranno fornire moduli compilati con identità e generalità degli utenti. L’operatore del gateway dovrà aggiornare le autorità sul traffico con report regolari. Il mancato allacciamento al gateway, che dovrà avvenire entro un anno, potrebbe comportare la sospensione delle licenze operative ai fornitori di servizi e persino il blocco dei conti bancari.
L’intenzione annunciata è quella di “prevenire e disconnettere tutte le connessioni di rete che minacciano sicurezza, ordine sociale, moralità, tradizioni e costumi” cambogiani.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Slogan e accuse contro gli Stati Uniti a Pyongyang in occasione del 73esimo anniversario della guerra di Corea. Mentre Seul si avvicina a Washington, la Corea del Nord accusa gli Usa di volere una guerra nucleare
“Gli Stati Uniti stanno compiendo sforzi disperati per scatenare una guerra nucleare”. A lanciare l’accusa, forte e sopra i consueti toni anche per il suo mittente, è la Corea del Nord. È un momento particolarmente delicato a Pyongyang, denso di significati politici e retorici. Domenica 25 giugno si è infatti celebrato il 73esimo anniversario dell’avvio della guerra di Corea, che fu combattuta per poco più di tre anni fino al 27 luglio 1953 e che non produsse mai una vera pace, ma un semplice armistizio. Tecnicamente, Corea del Nord e Corea del Sud sono ancora in conflitto. Anche se fortunatamente congelato. Per la ricorrenza, Pyongyang ha organizzato grandi manifestazioni di massa. Ai raduni organizzati dal Partito dei Lavoratori e dal regime di Kim Jong-un hanno partecipato circa 120 mila persone, molti studenti. Tra gli slogan più quotati la promessa di una “guerra di vendetta” per distruggere gli Stati Uniti.
Le foto diffuse dai media statali hanno mostrato uno stadio affollato di persone che reggevano cartelli con la scritta: “L’intera terraferma statunitense è nel nostro raggio di tiro”. O ancora: “Gli Stati Uniti imperialisti sono i distruttori della pace”. A metà tra esaltazione del proprio arsenale nucleare e denuncia delle azioni di Washington che metterebbero a rischio la stabilità della penisola coreana.
L’agenzia di stampa statale della Corea del Nord ha rincarato l’avvertimento, sostenendo che il paese ha ora a disposizione “la più forte arma assoluta per punire gli imperialisti statunitensi” e i “vendicatori su questa terra ardono con l’indomabile volontà di vendicare il nemico”.
A margine degli eventi, il ministero degli Esteri ha rilasciato un report dove accusa appunto gli Stati Uniti di volere una guerra nucleare. “Le azioni belligeranti degli Stati Uniti hanno spinto le tensioni militari nella penisola coreana e nel nord-est asiatico, che sono già precipitate in una situazione estremamente instabile vicino all’orlo della guerra nucleare”. Nello stesso report, si sostiene che le tensioni militari nell’area sono paragonabili a quelle della vigilia dell’inizio della guerra del 1950-53. Stati Uniti e Corea del Sud sono accusati di “delirante confronto militare anticomunista” e “minacce retoriche”. E l’eventuale conflitto, sostiene Pyongyang, “si intensificherà rapidamente in una guerra mondiale e termonucleare, senza precedenti per il mondo” e porterà alle “conseguenze più catastrofiche e irreversibili” per la pace e la stabilità nella regione e per tutti gli altri.
Frasi altamente retoriche che vanno però appunto anche contestualizzate in una giornata di ricorrenza storica fondamentale per la narrativa del regime.
Ma è innegabile che le tensioni nella penisola coreana e nell’Asia orientale siano molto cresciute negli ultimi tempi, in particolare dopo l’inizio della guerra in Ucraina. Il timore di un crescente allineamento tra Cina e Russia ha portato diversi paesi dell’area a rafforzare la partnership militare con gli Stati Uniti. In particolare la Corea del Sud, dopo la vittoria alle elezioni dello scorso anno del conservatore Yoon Suk-yeol. Il presidente di Seul ha riavviato i rapporti col Giappone, operando un allineamento a livello trilaterale degli scambi in materia di sicurezza con il vicino (tradizionalmente odiato) e Washington. Ad aprile, Yoon è stato alla Casa Bianca in visita di Stato, ottenendo l’estensione dell’ombrello nucleare. Non solo. Nelle scorse settimane ha ospitato a Busan un sottomarino americano a propulsione nucleare, ha aumentato esponenzialmente le esercitazioni congiunte e si prepara al pieno dispiegamento del Terminal High Altitude Area Defense (Thaad), il sistema di radar antimissile americano il cui primo acquisto nel 2016 causò una durissima battaglia diplomatica tra Corea del Sud e Cina.
Da parte sua, nel corso del 2022 Pyongyang ha effettuato più lanci balistici dei cinque anni precedenti messi insieme. E ha testato anche il suo più grande missile balistico intercontinentale, che ha sorvolato anche una porzione di territorio giapponese causando l’entrata in funzione dei sistemi di allarme. Dopo la prima prova fallita, si ritiene che presto Kim possa anche provare a effettuare un altro lancio del suo primo satellite spia militare per aumentare il monitoraggio delle attività militari statunitensi. La tensione cresce anche perché, mentre Seul si avvicina a Washington, Pyongyang si è avvicinata a Mosca. Dopo la ribellione del Gruppo Wagner, la Corea del Nord ha ribadito il proprio “forte sostegno” al Cremlino. Negli scorsi mesi, più volte si è detto che il regime ha inviato munizioni a Mosca. Mentre dall’altra parte vacilla la storica posizione di Seul di non inviare direttamente armi a un paese in guerra, visto che Nato e Usa sono in pressing su Yoon per aiutare anche militarmente l’Ucraina.
Le tensioni regionali si allargano anche al Vietnam. Domenica è arrivata a Da Nang la portaerei a propulsione nucleare americana Ronald Reagan. Si fermerà fino al 30 giugno. Non è certo usuale che questo avvenga, ma negli ultimi mesi anche Hanoi ha compiuto qualche passo in direzione degli Usa. Le ragioni? Primo: la difficoltà della Russia di continuare a mandare armi al Vietnam come ha sempre fatto in passato, col paese del Sud-Est asiatico che ha dunque bisogno di alternative. Secondo: il timore dell’appiattimento di Mosca sulle posizioni di Pechino, con cui Hanoi ha floridi rapporti commerciali e politici, ma anche dispute territoriali aperte e irrisolte. Non è un caso che la portaerei americana abbia attraccato in una città che si trova esattamente di fronte alle isole Paracelso, contese tra Vietnam e Cina. E intorno alle quali negli ultimi mesi Pechino ha alzato i giri delle manovre, proprio mentre Hanoi pensa all’acquisto di armi americane e il segretario generale del Partito comunista Trong potrebbe viaggiare per la prima volta a Washington.
Il fronte di guerra è tra Ucraina e Russia, ma in Asia orientale la situazione è in costante evoluzione.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Più i rapporti si fanno tesi e più il dialogo diventa importante. Stati Uniti e Cina hanno mostrato di saperlo, nell’importante visita di Antony Blinken a Pechino. Due giorni che non hanno prodotto accordi o intese particolari, non avrebbero potuto farlo e nessuna delle due parti se lo aspettava. L’obiettivo massimo era quello di rilanciare le comunicazioni bilaterali e provare a intensificare gli scambi per evitare che il confronto si trasformi in conflitto. Un obiettivo raggiunto, con alcune zone d’ombra. Non bisogna pensare che il viaggio del segretario di Stato americano possa produrre il “rapido disgelo” che aveva previsto Joe Biden a margine del G7 di Hiroshima lo scorso mese, ma neppure che la grande distanza che permane su diversi fronti sia stata acuita dalle posizioni contrapposte ed espresse in modo anche assertivo.
È utile seguire la cronologia di quanto avvenuto a Pechino. In molti hanno notato che per Blinken non è stato riservato nessun tappeto rosso e che in aeroporto non c’erano alti diplomatici ad accoglierlo. Si tratta in realtà di una dinamica in piena linea con le visite passate di pari grado. Il paragone con Emmanuel Macron ovviamente non regge, essendo quest’ultimo un capo di Stato a differenza di Blinken. Il primo a riceverlo è stato poi Qin Gang, il ministro degli Esteri e fresco ex ambasciatore cinese a Washington. Questo è stato il confronto più lungo e approfondito, visto che i due sono omologhi. Qin ha adottato una linea più rassicurante rispetto alle sue recenti uscite, tra le “due sessioni” dello scorso marzo e da ultimo la telefonata della scorsa settimana con lo stesso Blinken. Qin ha sottolineato che i rapporti bilaterali sono “al punto più basso di sempre”, ma ha anche garantito che la Cina vuole costruire relazioni “stabili, costruttive e prevedibili”. Nei rispettivi comunicati sui colloqui, durati 5 ore e mezza prima di una cena di lavoro di ulteriori 2 ore e mezza, viene ripetuta diverse volte la parola “cooperazione”.
Lunedì è toccato invece ai due incontri formalmente più rilevanti. Dapprima quello con Wang Yi, il capo della diplomazia del Partito comunista cinese. Nel sistema politico di Pechino, si tratta di una figura al di sopra del ministro degli Esteri perché incarna dall’interno la politica estera del Partito. Qui i toni si sono fatti più assertivi. Wang ha ribadito che su Taiwan, definito come il nodo più “rischioso” dei rapporti bilaterali, “non c’è alcun margine di compromesso o concessioni. Gli Stati Uniti devono aderire veramente al principio dell’Unica Cina confermato nei tre comunicati congiunti Usa-Cina, rispettare la sovranità e l’integrità territoriale della Cina e opporsi chiaramente all’indipendenza di Taiwan”.
Nella sua risposta in conferenza stampa, Blinken ha dato una garanzia: “Gli Stati Uniti ribadiscono di non sostenere l’indipendenza di Taiwan e di non volere una nuova Guerra Fredda con la Cina”. Una passaggio tradizionale, ma che era stato omesso di recente sia da Lloyd Austin allo Shangri-La Dialogue di Singapore, sia da Joe Biden al G7 di Hiroshima. Ma allo stesso tempo, Blinken ha citato le “azioni provocatorie” di Pechino sullo Stretto e ha rivendicato il diritto/dovere di “accertarsi che Taiwan sia in grado di difendersi”, in ottemperanza al Taiwan Relations Act e le Sei Assicurazioni di Ronald Reagan, che la Cina vede come atti unilaterali e in contrasto coi tre comunicati congiunti che avviarono le relazioni diplomatiche ufficiali tra i due paesi.
Le distanze su Taiwan restano dunque incolmabili, come prevedibile. Più convinta la rassicurazione sul fronte economico, con Blinken che ha assicurato che gli Stati Uniti non vogliono il decoupling, bensì il de-risking, riconoscendo anche la maternità della formula alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. “Un completo disaccoppiamento sarebbe un disastro”, ha detto Blinken, il quale ha sottolineato che l’ascesa economica cinese porta benefici anche agli Usa. Parole e prospettive che aprono alle imminenti visite in Cina di Janet Yellen e Gina Raimondo, a capo rispettivamente di Tesoro e Commercio.
Ma il momento clou della visita di Blinken è stato senz’altro l’incontro con Xi Jinping. Non era scontato che questo avvenisse, visto che nel 2018, durante l’ultimo viaggio di un segretario di stato americano in Cina, il leader cinese non aveva aperto le porte della Grande Sala del Popolo. A creare suspence è stato anche il mancato annuncio da parte di Pechino, che si è voluta cautelare dopo quanto accaduto lo scorso febbraio, quando la visita di Blinken fu cancellata all’ultimo momento dopo la vicenda del presunto pallone-spia. E soprattutto dopo che era stato già annunciato nei giorni precedenti l’incontro con Xi. Lo stesso ricevimento di Bill Gates aveva fatto temere che Xi potesse non incontrare Blinken, amplificando la prospettiva cinese secondo cui i rapporti tra “popoli” sono positivi e che i problemi vengono creati dalla postura “errata” della politica americana, intenta a “sopprimere” l’ascesa cinese. Nell’incontro con Blinken, Xi ha assunto una posizione centrale, con il segretario di Stato americano e Wang Yi seduti ai suoi lati. E ha ammonito gli Usa: “Nessuna delle due parti può modellare l’altra secondo i propri desideri, tanto meno privare l’altra del suo legittimo diritto allo sviluppo”. La Cina, ha aggiunto, “spera sempre che le relazioni Cina-Usa siano sane e stabili e che i due Paesi possano superare tutte le difficoltà e trovare il modo giusto per per andare d’accordo tra loro, caratterizzato da rispetto reciproco, coesistenza pacifica e cooperazione vantaggiosa per tutti. Si spera che gli Stati Uniti adottino un atteggiamento razionale e pragmatico”, ha concluso il presidente cinese, “vengano incontro alla Cina e mettano in atto azioni per stabilizzare le relazioni e migliorare la situazione dei rapporti sino-americani”.
Non è stato dichiarato ufficialmente, ma è certo che le due parti abbiano anche parlato del probabile bilaterale tra Xi e Biden a margine del summit Apec di San Francisco, il prossimo novembre. Visita e incontro avrebbero un significato molto rilevante, vista la presenza di una grande diaspora cinese nella città californiana. Prima di allora, Qin andrà a Washington per un altro incontro con Blinken e, a questo punto, con ogni probabilità anche Biden. Senza nuovi palloni o collisioni sfiorate, novembre potrebbe segnare uno snodo fondamentale per stabilizzare i rapporti. Che non significa andare d’accordo, o annullare una contesa che andrà avanti per lungo tempo.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
La Cina alza il tiro della sua ambizione diplomatica globale. Dopo aver favorito il riavvio dei rapporti tra Arabia Saudita e Iran, nonché essersi resa protagonista di un’iniziativa per provare a immaginare una soluzione politica per la guerra in Ucraina, tocca ora al fronte apparentemente più insolubile della scena mondiale: i rapporti tra Israele e Palestina. Il tutto in un momento nel quale la proiezione cinese in Medio Oriente si fa sempre più convinta.
Martedì 13 giugno arriva infatti a Pechino Abu Mazen, il nome con cui è conosciuto a livello internazionale il presidente palestinese Mahmoud Abbas. Il viaggio dura fino a venerdì 16 giugno e prevede diversi incontri ad alto livello, su tutti quello col presidente Xi Jinping. “Abbas è un vecchio e buon amico del popolo cinese ed è il primo capo di stato arabo a essere ospitato in Cina quest’anno. Questo la dice lunga sulle relazioni amichevoli tra Cina e Palestina”, ha dichiarato in conferenza stampa il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin. La Repubblica Popolare Cinese è stata d’altronde uno dei primi paesi al mondo a riconoscere l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp). Per 10 anni consecutivi, Xi ha inviato messaggi di congratulazioni allo speciale incontro commemorativo in occasione della Giornata internazionale di solidarietà con il popolo palestinese. Più di una volta ha avanzato le proposte della Cina per risolvere la questione palestinese, sottolineando la necessità di portare avanti con determinazione una soluzione politica basata sulla soluzione dei due Stati.
La spinta cinese sull’argomento ha preso nuovo impulso in questi mesi, in concomitanza del lancio della Global Security Initiative, il piano pensato da Xi per promuovere sotto un ombrello programmatico le concezioni in politica estera del Partito comunista cinese. Sui media di Stato cinesi, emerge l’ambizione di Pechino di svolgere un ruolo speciale nel promuovere la de-escalation del conflitto tra Palestina e Israele, “in quanto è stata un partner affidabile della Palestina e ha anche mantenuto una stretta e pragmatica cooperazione con Israele”, scrive per esempio il Quotidiano del Popolo. “Comunicando con ciascuna delle parti attraverso colloqui bilaterali, la Cina potrebbe esplorare i modi per allentare le tensioni tra Palestina e Israele come primo passo”.
Gli ultimi colloqui di pace diretti tra funzionari israeliani e palestinesi, mediati da Washington, si sono tenuti nel 2014. Da allora, la massiccia crescita degli insediamenti israeliani nella Cisgiordania occupata ha reso quasi impossibile una soluzione a due Stati. La Cina si sta proiettando con forza in Medio Oriente, in concomitanza di una parziale ritirata dell’influenza degli Usa, e sente che è giunto il momento di provare a dare la sensazione di potersi sostituire a Washington come “potenza responsabile” e “garante di stabilità”.
La visita di Abu Mazen dà nuovo impulso a questa ambizione. E non è un caso che l’invito arrivi in un momento nel quale Abu Mazen non è stato ancora invitato a incontrare Joe Biden. Ma resta a dir poco complicato immaginare sviluppi concreti. Anzi, come accaduto col recente viaggio tra Mosca, Kiev ed Europa dell’inviato speciale Li Hui, la sensazione di molti osservatori è che la visita del leader palestinese possa soprattutto servire a rafforzare le credenziali di Pechino sulla scena mondiale, piuttosto che un vero tentativo di rilanciare il processo di pace israelo-palestinese. Anche perché i rapporti tra Cina e Israele si sono fatti di recente meno caldi. Israele è diffidente nei confronti dei legami economici della Cina con l’Iran e i funzionari israeliani hanno detto apertamente a Pechino che il paese è strettamente allineato agli Stati Uniti in politica estera. Negli ultimi anni, la Cina ha ripetutamente criticato l’occupazione israeliana dei territori palestinesi e, in particolare, le operazioni militari nella Striscia di Gaza.
Il ricevimento di Abu Mazen potrà non portare a sviluppi concreti sulla risoluzione della questione israelo-palestinese, ma dà senz’altro un messaggio di disponibilità ai paesi arabi. Solo nei giorni scorsi sono stati firmati accordi per ben 10 miliardi di dollari nel corso della decima edizione della conferenza imprenditoriale Cina-Arabia Saudita, organizzata a Riad. Secondo il quotidiano saudita Saudi Gazette, gli accordi riguardano il settore tecnologico, immobiliare, turistico, sanitario, delle energie rinnovabili, dell’agricoltura, dei minerali e delle catene di approvvigionamento. Spicca la firma tra il gruppo saudita Ask e la China National Geological & Mining Corporation per lo sviluppo, il finanziamento, la costruzione e la gestione di un progetto di estrazione di rame nell’Arabian Shield. Lo scorso dicembre, Xi è stato a Riad per il Consiglio di Cooperazione del Golfo, portando a casa diversi accordi commerciali e diplomatici. E ha poi ricevuto a Pechino il presidente iraniano Ebrahim Raisi.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Chi sperava in segnali di disgelo dallo Shangri-La Dialogue di Singapore è rimasto deluso. Una rapida e cordiale stretta di mano prima della cena di apertura è stato l’unico contatto noto tra Lloyd Austin, segretario alla Difesa degli Stati Uniti, e Li Shangfu, ministro della Difesa cinese. Nessun bilaterale, tante critiche e nessuna concessione in vista, con anzi i due impegnati a indicare il rivale come fonte di instabilità. Per tre giorni, oltre 600 delegati da 49 paesi presenti al massimo summit di sicurezza dell’Asia-Pacifico, hanno assistito alle manovre contrapposte delle due grandi potenze, Stati Uniti e Cina. È la loro relazione ad aver dominato la scena, dopo che lo scorso anno si era parlato molto di più di Ucraina.
D’altronde, come ha detto l’alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la sicurezza Josep Borrell durante una delle sessioni plenarie, “in Europa abbiamo una guerra. Ma il centro della competizione globale è qui, nell’Indo-Pacifico”. Da Singapore si esce non coi segnali di disgelo previsti da Joe Biden al termine del G7, ma semmai con la solidificazione di due linee contrastanti. E per i padroni di casa di Singapore “in larga parte inconciliabili”, come affermato dal primo ministro in pectore della città-stato, Lawrence Wong. La sensazione è che, preso atto della divaricazione di prospettive, si lavori non tanto alla ricerca dell’armonia ma alla stabilizzazione della disarmonia. Non un caso che sia nel discorso di apertura di John Chipman (direttore dell’IISS, l’istituto che organizza da 20 anni il vertice) e di Ng Eng Hen (ministro della Difesa di Singapore) si siano richiamati ai “lati positivi” della guerra fredda, come lo stop alla corsa nucleare e i paletti stabiliti per evitare che il confronto si trasformasse in conflitto.
Praticamente tutte le conversazioni pubbliche e private negli ampi e lussuosi locali dello Shangri-La, l’hotel simbolo della diplomazia di Singapore, erano concentrate su questo: le relazioni tra Washington e Pechino. Il discorso di Austin, intitolato “la leadership americana nell’Indo-Pacifico”, è teso a rivendicare la posizione di guida degli Stati Uniti nella regione. Il capo del Pentagono ha elencato tutte le attività di sicurezza nell’area, compresi i nuovi accordi e sviluppi facilitati in qualche modo dalla guerra in Ucraina: rafforzamento dei rapporti militari col Giappone, estensione dell’ombrello nucleare con la Corea del Sud, AUKUS con i sottomarini a propulsione nucleare (e “non con armi nucleari”, ha tenuto a sottolineare rispondendo alle accuse cinesi), accesso a nuove basi militari delle Filippine, vaste esercitazioni congiunte con tutti gli alleati e accordo di sicurezza con Papua Nuova Guinea. Poi ha sottolineato anche il riavvio dei rapporti tra Tokyo e Seul, esaltando il valore della cooperazione trilaterale dei due vicini della Cina. Promettendo una maggiore disponibilità nel trasferimento tecnologico militare e una maggiore interoperabilità delle rispettive forze armate. Poi è passato all’attacco sui “tentativi di cambiare lo status quo” nel mar Cinese meridionale e nel mar Cinese orientale, citando le manovre nei pressi dei vari paesi del Sud-Est asiatico e del Giappone. Con riferimenti a “manovre non professionali”, in riferimento al recente incontro ravvicinato tra jet sul mar Cinese meridionale.
Ma il principale nodo della discordia sulle due potenze, come noto, è Taiwan. “Un conflitto sullo Stretto di Taiwan sarebbe devastante, l’economia mondiale dipende dallo status quo”, ha avvisato Austin, internazionalizzando sempre di più una questione che la Cina considera interna. Austin ha garantito che gli Usa “mantengono la stessa linea, in linea con la politica dell’unica Cina e il Taiwan Relations Act. Siamo impegnati a preservare lo status quo e ci opponiamo a cambi unilaterali da entrambe le parti”. Cioè, si implica: un’azione militare cinese e una dichiarazione di indipendenza formale di Taiwan. Ma la delegazione cinese lamenta la mancata esplicitazione di questo secondo punto, che nel 2022 c’era stata ed è mancata anche nel documento finale del G7 di poche settimane fa a Hiroshima: “Non supportiamo l’indipendenza di Taiwan”. Ma Austin in realtà non cita nemmeno le esercitazioni di Pechino intorno a Taiwan dopo la visita di Pelosi e quelle più recenti. Nel 2022 aveva invece citato le manovre aeree e navali di Pechino, mettendo in dubbio la volontà cinese di mantenere lo status quo e collegando direttamente il fronte ucraino a quello taiwanese. Non sfugge questo elemento ad alcuni osservatori cinesi presenti a Singapore, che descrivono l’intervento come “meno duro” del precedente, “segnale che vogliono provare a parlare”.
Quando ha tenuto il suo discorso, Austin ancora non sapeva della collisione sfiorata tra una nave da guerra cinese e un cacciatorpediniere americano nello Stretto, un segnale che Pechino intende reiterare con maggiore forza la sua pretesa di sovranità. Cercando di trasformare sempre più lo Stretto in una sorta di “mare interno”, come già si evinceva dalle recenti esercitazioni militari svolte dopo l’incontro in California tra la presidente taiwanese Tsai Ing-wen e lo speaker del Congresso americano Kevin McCarthy. Ma il capo del Pentagono sostiene di essere convinto che un conflitto “non è imminente, né inevitabile”. Ma lancia un appello al dialogo: “Il momento giusto per parlare è qualsiasi momento, il momento giusto per parlare è ogni momento, il momento giusto parlare è adesso”. E ancora: “Più parliamo e più possiamo evitare incidenti che rischiano di portarci a un conflitto”.
Il giorno dopo il discorso di Austin, è stata la volta della risposta di Li Shangfu, al suo primo discorso da ministro di fronte a una platea internazionale. Come ampiamente previsto, Li comincia illustrando i principi della Global Security Initiative, il programma lanciato da Xi Jinping lo scorso anno: “mutuo rispetto” e “opposizione all’egemonismo”, equità contro la “legge della giungla”, richiamo ai principi della carta delle Nazioni Unite e no alla “mentalità da guerra fredda”. Tutti punti già noti della posizione cinese, che trovano da qualche mese una sistematizzazione sotto l’ombrello della GSI. Molte domande retoriche dirette a presentare gli Usa come agente di instabilità: “Chi sta minando la stabilità? Quali sono le radici di caos e instabilità?”. Li respinge l’ipotesi di una Nato asiatica e di un confronto tra blocchi. “Le strategie sul cosiddetto Indo-Pacifico non dovrebbero contenere elementi ideologici e alleanze militari contro minacce immaginarie o si rischia di arrivare a una profezia che si autoavvera”. Li esalta poi il ruolo di stabilità economica garantito dalla Cina alla regione. Molto breve il passaggio sull’Ucraina, in cui si limita a ribadire che Pechino lavora per costruire un ampio dialogo tra le parti. Citate le iniziative diplomatiche su Afghanistan e Asia occidentale. Sul mar Cinese meridionale sostiene che la libertà di navigazione continua a essere garantita e che i paesi asiatici “possono risolvere le differenze tra loro”. Li ripete l’impegno a uno sviluppo pacifico, ma ribadisce che la Cina “non esiterà a difendere i legittimi interessi”. E al centro di questi viene citata Taiwan. Anche qui, discorso in linea col 2022: reiterazione di sovranità, opposizione a “interferenze esterne”, critiche esplicite al DPP (il partito di maggioranza) sulla “negazione del consenso del 1992” e sforzi per “cancellare l’identità cinese di Taiwan”. La “riunificazione” è un “processo storico che non può essere fermato” e per raggiungerla, come sempre, non viene escluso l’utilizzo della forza. “Se qualcuno prova a separare Taiwan dalla Cina, il nostro esercito non esiterà un secondo a intervenire”. Tutte cose già dette dal predecessore Wei Fenghe nel 2022, ma anche qui l’intervento è un po’ più breve. Manca per esempio questo passaggio in riferimento al DPP: “In quanto elemento dei gruppi stranieri anti-cinesi, essi saranno solo usati e poi abbandonati dai loro padroni”. Il passaggio più preoccupante è però quello sull’incidente sfiorato sullo Stretto, di cui si è avuta notizia poche ore prima del discorso di Li. “Non si tratta di passaggi innocenti, alcuni paesi usano la libertà di navigazione come pretesto per esercitare egemonia di navigazione”, ha detto il ministro della Difesa in risposta a delle domande dei delegati. Come evitare incidenti? “Non si navighi troppo vicino ai territori altrui”. Questo commento lascia presagire che si possano ripetere i rischi di incidenti durante i passaggi sullo Stretto. A Singapore, dai delegati di diversi paesi emerge preoccupazione su questa possibilità, altri collegano la situazione alla mancanza di dialogo, implicando che una ripresa delle comunicazioni Usa-Cina porterebbe a una gestione diversa da parte di Pechino di questi passaggi.
Sui rapporti con gli Usa, Li riconosce che le relazioni sono al “minimo” da decenni. L’unico punto su cui Li e Austin sono sembrati d’accordo è nel definire un possibile conflitto “devastante”. Li definisce comunque la Cina pronta al dialogo ma chiede a Washington di “agire con sincerità”. Pechino ha rifiutato il bilaterale a Singapore lamentando l’assenza di un clima adeguato. Il riferimento di diversi delegati cinesi allo Shangri-La Dialogue è alla mancata rimozione delle sanzioni in vigore dal 2018 per l’acquisto di componenti militari dalla Russia. Allora, Li era un generale dell’esercito. La sua nomina a ministro è arrivata solo a marzo di quest’anno, una mossa voluta da Pechino per segnalare a Washington che non vuole più scendere a compromessi per riavviare il dialogo. Il significato simbolico è chiaro: “Se davvero volete parlare con noi, dovete accettare gli ufficiali scelti da noi, dunque il nostro modello di sviluppo”. Non a caso un punto sul quale Li ha insistito molto nel suo discorso è quello del “mutuo rispetto”. Al termine del G7, Biden aveva paventato la rimozione delle sanzioni, ma il Dipartimento di Stato lo ha subito smentito. Sinora dunque niente riavvio del dialogo di difesa, interrotto sin dall’agosto 2022 dopo la visita di Pelosi a Taipei.
Chi sta parlando sono i servizi di intelligence. Durante il summit, il Financial Times ha dato la notizia che il direttore della Cia William Burns è stato in missione in Cina il mese scorso. E proprio durante lo Shangri-La, a Singapore si sono inusualmente riuniti, in quello che Reuters ha definito “conclave segreto”, anche i rappresentanti dell’intelligence di vari paesi, compresi quelli di Usa e Cina. Al summit era d’altronde presente tra gli speaker anche Avril Haines della National Intelligence. L’incontro non è per forza un segnale positivo, ma la dimostrazione più concreta che i canali di comunicazione consueti sono seriamente otturati.
Lo scorso anno, lo Shangri-La Dialogue era stato la sede della tetra previsione del premier giapponese Fumio Kishida, che nel discorso di apertura aveva indicato come l’Asia avrebbe potuto diventare la “prossima Ucraina”. Questa volta, il primo a parlare è stato Anthony Albanese. Il premier australiano ha provato ad allontanare il fatalismo: “Passare dall’immaginare la guerra come impossibile a descriverla come inevitabile danneggia in egual modo i nostri interessi. La pace va conquistata ma il futuro dell’Indo-Pacifico è scritto da tutti noi”, ha dichiarato il premier australiano. In generale, la regione si sente comunque a rischio di diventare un’arena di confronto. Un’esperienza già vissuta in maniera catastrofica, come ricorda il ministro di Singapore Ng Eng Hen: “Dobbiamo evitare l’incubo di due guerre contemporanee tra Europa e Asia. Credo tutti siano d’accordo ma purtroppo la traiettoria geopolitica rischia di andare in quella direzione se non si riprende il dialogo”. Il ministro cita poi l’aumento esponenziale delle spese militari a livello regionale. “Non è fonte di instabilità in sé, ma in assenza di dialogo e reciproco contenimento rischia di trasformarsi in una corsa al riarmo che può portarci verso la catastrofe”. Nota di colore: proprio su queste parole rimbomba dall’esterno un tuono fortissimo e prolungato che dà l’avvio a un temporale. Risate e dark humour in sala stampa e sul palco, dove il ministro si ferma per qualche secondo.
Molti paesi hanno mostrato la ricerca di un complicato equilibrio. Giappone, Corea del Sud e Stati Uniti hanno ufficializzato il preannunciato accordo per la condivisione di un sistema radar anti missilistico. Ma sia Tokyo sia Seul hanno mantenuto una linea più cauta di quanto qualcuno si aspettava sulla Cina. Il ministro della Difesa giapponese Hamada Yasukazu ha criticato implicitamente Pechino per gli ingressi nelle acque territoriali altrui e ha sollevato il problema dei cavi sottomarini, dopo che nelle isole Matsu controllate da Taipei negli scorsi mesi si era verificata una recisione. Uno scenario che molti analisti militari considerano possibile in caso di potenziali azioni militari, soprattutto verso isole e stati insulari. Ma Hamada non ha citato Taiwan nel suo discorso, nonostante sia risaputo che per Tokyo la sua stabilità rappresenta una priorità della nuova strategia di difesa nazionale.
Il ministro sudcoreano Lee Jong-sup ha invece parlato esclusivamente di Corea del Nord, lanciando solo una velata critica a Pechino sulla mancata approvazione delle risoluzioni alle Nazioni Unite di condanna dei lanci missilistici di Pyongyang. Lee ha però rivendicato la scelta dell’amministrazione di Yoon Suk-yeol di rafforzare i rapporti di sicurezza con Usa e Giappone, motivandoli con l’esigenza di aumentare la deterrenza e coi fallimenti dei precedenti tentativi di dialogo nell’era Moon Jae-in.
Molto attive le Filippine, che con Ferdinand Marcos Jr. si sono avvicinate molto agli Usa. Lo speaker di Manila ha parlato nella stessa sessione di Regno Unito e Canada, mentre la domanda più accesa nei confronti del cinese Li è arrivata proprio da un delegato filippino, che ricorda le manovre nelle acque dell’arcipelago e sostiene che le parole e le azioni della Cina siano “discordanti”. Più defilato il Vietnam, che sta comunicando molto con Washington di recente ed è anch’esso oggetto di manovre navali cinesi. Nessuno speaker per Hanoi. Se la Cambogia promette trasparenza sull’utilizzo delle sue strutture militari, nel tentativo di fugare i dubbi sulla base navale di Ream dove gravitano mezzi cinesi, c’è anche chi si schiera abbastanza apertamente al fianco di Pechino. È il caso di Timor Est. Il presidente José Ramos-Horta giustifica l’avvicinamento di diversi paesi della regione e del cosiddetto Sud globale alla Cina: “In tanti erano stati lasciati soli, con Pechino non lo sono più”. Ancora Ramos-Horta: “La Cina è ora una potenza globale e i suoi interessi sono intrecciati col resto del mondo. Non credo che abbia interesse a uccidere la mucca che le dà il latte”. Sostegno a Pechino anche su Taiwan: “Vanno evitate azioni provocatorie di attori esterni”.
A confermare che le visioni del Sud globale spesso non collimano con quelle dei paesi occidentali, c’è stata anche e soprattutto la proposta di pace dell’Indonesia sull’Ucraina. Sentimento che porta a prospettive diverse da quelle occidentali, anche sulla guerra. Il simbolo di un solco che sembra essersi allargato è la proposta di pace dell’Indonesia. Il ministro della Difesa Prabowo Subianto si richiama alla “saggezza dei leader” di Stati Uniti e Cina per evitare il conflitto in Asia. Poi si lancia a sorpresa sull’Ucraina: “Propongo di firmare un documento congiunto per chiedere la fine delle ostilità”. E articola un’idea di pace alla coreana: “Primo: cessate il fuoco. Secondo: istituzione di una zona demilitarizzata di 15 chilometri da entrambi i lati. Terzo: invio di forze di pace delle Nazioni unite. Quarto: referendum nei territori contesi per far decidere a loro da che parte stare”. Alle critiche, Subianto replica: “Non equiparo aggressore e aggredito, in passato l’Indonesia e altri paesi asiatici sono stati aggrediti in maniera anche più sanguinosa. Ci sono anche altre guerre nel mondo. Ho fatto una proposta di pace, a che cosa serve l’Onu se non a risolvere i conflitti? La storia insegna che ci vuole un compromesso”. Una visione condivisa da altri, in Asia, magari con sfumature diverse rispetto alla proposta “sui generis” di Subianto.
L’idea indonesiana è stata subito respinta da Ue e Ucraina. Prima, implicitamente, dall’alto rappresentante per gli esteri Josep Borrell: “Se vogliamo che la guerra finisca subito basterebbe smettere di mandare le armi all’Ucraina. Ma non vogliamo la pace del più forte, non vogliamo che l’Ucraina diventi una nuova Bielorussia. L’Europa vuole una pace giusta”. Ancora più netto il rifiuto di Oleksii Reznikov, ministro della Difesa di Kiev. “L’Indonesia non ha parlato con noi e il suo piano sembra un piano della Russia. Non abbiamo bisogno di questa strana proposta”.
Dai paesi occidentali non sono emerse nuove idee, almeno ufficialmente, e si continua a garantire il sostegno all’Ucraina in attesa della controffensiva. Da parte cinese, più eloquente di Li è stato Cui Tiankai, ex viceministro degli Esteri: “Non abbiamo una proposta di pace con una soluzione concreta, ma ci stiamo sforzando per facilitare un dialogo”. Cui afferma che la Cina è aperta “a qualsiasi buona idea per arrivare a una fine della guerra immediata, ma finora vediamo arrivare solo armi”. Intrigante quando Cui ricorda il periodo trascorso in URSS in Manciuria, in un pezzo di territorio sottratto dagli zar ai Qing: “Ma quando l’URSS è caduta non ne abbiamo approfittato per vendicarci, abbiamo fatto prevalere la voglia di stabilità”. Poi un altrettanto interessante e irrituale colloquio diretto con Reznikov, che chiede a Cui: “So che Mao e Stalin firmarono un accordo in cui si diceva che l’Urss era il fratello maggiore e la Cina il fratello minore. Ora mi pare che Xi e Putin abbiano un accordo ribaltato. Potete convincere il fratello minore a ritirarsi?” Cui non si fa trovare impreparato: “All’epoca rompemmo i rapporti con l’Urss proprio perché non ci piaceva quel tipo di rapporto, oggi non vogliamo ripeterlo noi ai loro danni”. Il diplomatico cinese prova a rassicurare: “Non arrivate a conclusioni affrettate: se in passato le potenze in ascesa hanno usato la forza non significa che la userà anche la Cina”. E ancora: “Vogliamo fare più sforzi per far capire le nostre politiche, ma anche altri paesi devono sforzarsi per capire noi”. Stati Uniti e Cina, però, al momento sembrano capirsi poco.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
È la mattina del 27 febbraio 2002. Il Sabarmati Express si ferma nei pressi della stazione ferroviaria di Godhra, nello Stato del Gujarat, India occidentale. A bordo centinaia e centinaia di pellegrini indù di ritorno da Ayodhya, una delle sette città sacre per la religione dominante in India. Scoppia una discussione tra i passeggeri e i venditori sul binario della stazione. In circostanze mai del tutto chiarite, quattro carrozze del treno prendono fuoco. Scatta la fuga, ma decine di persone restano intrappolate a bordo. Le vittime sono 59: nove uomini, 25 donne e 25 bambini. Tutti morti tra le fiamme.
Bisogna andare indietro a quella tragica giornata di 21 anni fa per capire qualcosa in più del presente dell’India, sia sotto il profilo politico che sotto quello sociale e dei diritti. Oggi la cosiddetta “più grande democrazia del mondo” ha diversi punti oscuri. La minoranza musulmana lamenta leggi discriminatorie, mentre la situazione della libertà di stampa e quella digitale sono in costante peggioramento. E Rahul Gandhi, il principale leader di un’opposizione che sembrava stare cercando di ricomporre la frammentazione che l’ha caratterizzata negli ultimi anni è stato condannato a due anni di carcere. Rischiando di non potersi candidare alle elezioni del 2024.
Su questi 21 anni si staglia la figura di Narendra Modi, il potente Primo Ministro ultranazionalista che domina da tempo la politica indiana. Sin dall’inizio, è lui il protagonista di questa storia. In quel 2002 è lui il governatore del Gujarat, Stato in cui è nato. È lui a osservare quanto accade dopo la tragedia del Sabarmati Express. La colpa ricade sulla minoranza musulmana della regione. Parte una violentissima rappresaglia da parte della maggioranza indù, che nel corso di alcune settimane provoca la morte di mille persone. Almeno secondo i dati ufficiali, perché le stime degli attivisti e delle organizzazioni governative parlano invece di 2500 vittime.
Modi viene accusato di non aver fatto abbastanza per provare a evitare la strage. Ma dopo anni di indagini, la Corte Suprema dell’India sostiene che la sua squadra investigativa non ha trovato prove sufficienti per avviare un procedimento giudiziario contro di lui. Qualche ombra è però sempre restata, ed è tornata ad addensarsi negli scorsi mesi, quando è uscito il documentario della Bbc India: The Modi Question. Il film contiene documenti del governo britannico secondo cui le violenze del Gujarat hanno “tutte le caratteristiche di una pulizia etnica”. Jack Straw, all’epoca Ministro degli Esteri del Regno Unito, viene ritratto mentre afferma che vi erano “serie affermazioni” secondo cui Modi stava attivamente limitando le attività della polizia e “incoraggiando tacitamente gli estremisti indù”.
Il documentario è stato censurato in tutta l’India, col governo che lo ha definito “spazzatura” e “propaganda anti indiana”. L’esecutivo ha ordinato di non condividerne nemmeno link o spezzoni a tutti i social media, che hanno eseguito pedissequamente. Una vicenda emblematica che, al di là della veridicità delle accuse nei confronti del premier, dimostra un sostanzioso sfilacciamento del tessuto democratico indiano. A partire dal discorso pubblico. Dopo la polemica sul documentario, la sede locale della Bbc a Nuova Delhi è stata perquisita due volte nell’ambito di un’indagine fiscale. Con computer, agende e telefoni di diversi giornalisti che sono stati sequestrati. Non è un caso che l’anno scorso, l’India è scivolata di otto posizioni nell’indice della libertà di stampa, scendendo a 150 su 180 paesi: la peggiore posizione di sempre per il gigante asiatico. D’altronde, l’ambiente dei media indiani è ormai sempre più vicino al governo Modi e le voci critiche sono sempre meno. Ndtv, broadcaster che aveva mantenuto una linea scettica nei confronti di Modi, è stata di recente acquistata dal suo amico multimiliardario Gautam Adani al termine di una scalata ostile. Proprio quell’Adani a capo di uno dei principali conglomerati industriali indiani, finito in crisi per un report del fondo ribassista Hindenburg Research, che ha evidenziato presunte manipolazioni del mercato e irregolarità contabili attraverso “sfacciate alterazioni dei prezzi delle azioni” e “decenni di falsificazione dei bilanci”.
Adani ha definito le accuse del fondo statunitense “subdolamente malevole”, descrivendole come come un tentativo di un’entità straniera di sabotare l’ascesa indiana. La stessa linea mantenuta dal governo Modi sul documentario della Bbc. D’altronde, i due sono vicinissimi e si conoscono proprio dall’era del Gujarat, da dove è iniziata anche la fortuna di Adani. Proprio il rapporto con alcuni multimiliardari come lui e la spinta del mondo del business hanno rafforzato l’immagine internazionale di Modi come di un leader pronto ad aprire un mercato in immensa crescita agli investimenti internazionali.
Così l’Occidente si è infatuato di Modi, diventato premier per la prima volta nel 2014. Se a livello esterno ha sfruttato questa immagine di grande modernizzatore, all’interno Modi ha cavalcato i toni del nazionalismo indù per favorire la sua ascesa politica. Una volta salito al potere i toni sono saliti ancora di più e hanno sforato nel modello di governance, con leggi considerate da più parti come lesive della minoranza musulmana. Nel 2019, poco dopo aver ottenuto il secondo mandato da primo ministro, Modi ha revocato improvvisamente l’autonomia del Kashmir. L’unico Stato dove i musulmani sono la maggioranza è stato diviso in due parti: Ladakh e Jammu & Kashmir. Il primo non ha nemmeno più un parlamento statale. Non solo. Il governo centrale ha anche approvato una nuova legge sulla cittadinanza che stabilisce che per richiedere il passaporto indiano, uno straniero debba aver vissuto nel Paese o lavorato per il governo federale per almeno 11 anni. Sono previste eccezioni per i membri di sei minoranze religiose provenienti dai paesi limitrofi, in grado di chiedere la cittadinanza dopo sei anni. Ma sono esclusi gli ahmadi provenienti dal Pakistan e i rohingya provenienti dal Myanmar, entrambi musulmani.
Ma la stretta dei diritti riguarda un po’ tutta la società indiana. Nel 2022, i tribunali indiani hanno comminato 165 nuove condanne a morte. Il numero più alto in un solo anno per il paese dal 2000. I detenuti indiani nel braccio della morte sono dunque diventati 539, anche questo il dato più pesante a partire dal 2004. Da decenni l’India si oppone a qualunque tentativo di risoluzione delle Nazioni Unite per sospendere o vietare la pena di morte, e nel 2019 il governo targato Bharatiya Janata Party (BJP) ha ampliato lo spettro di reati punibili con la sentenza capitale.
Le proteste anti governative esplose negli scorsi anni sono state represse in modo anche violento. Come accaduto nel 2020, quando immense folle di contadini si sono concentrate nella capitale per protestare contro la riforma agraria. La repressione delle forze di sicurezza ha causato anche dei morti.
Un altro modo con cui il governo “oscura” il dissenso è il controllo della rete. Secondo il report annuale di Access Now, gruppo di difesa dei diritti digitali con sede a New York, nel 2022 sono state imposte in tutto 187 chiusure della rete internet. Di queste, ben 84 sono state ordinate in India. In oltre la metà dei casi (49) è coinvolto il Kashmir. Il poco invidiabile record nei blocchi alla rete non è frutto del caso ma nasce da lontano, visto che l’India occupa la prima posizione della graduatoria redatta da Access Now per il quinto anno consecutivo.
Anche le grandi piattaforme digitali internazionali subiscono forti pressioni dal governo per bloccare contenuti antigovernativi o ritenuti una minaccia per la sicurezza nazionale. Twitter, per esempio, ha seguito le indicazioni delle autorità sia in occasione delle proteste del 2020 e 2021, sia sul documentario della Bbc. Così come YouTube. Non sempre è bastato. In diverse parti del Paese, gli studenti hanno organizzato delle proiezioni di gruppo. Andando spesso incontro a interventi della polizia o degli atenei. In alcuni casi, si sono verificate anche delle violenze. Alla Jawaharlal Nehru University di Delhi un gruppo di studenti nazionalisti indù ha lanciato mattoni contro quelli che si erano radunati per guardare il documentario sui propri telefonini, visto che l’università aveva staccato la corrente per evitare l’utilizzo del proiettore.
In tutto ciò, l’opposizione è stata a lungo ridotta ai minimi termini. Ma negli ultimi mesi si è raccolta intorno a Rahul Gandhi, capo del Partito del Congresso, protagonista di una lunga marcia di 3500 chilometri attraverso il Paese durata cinque mesi fino allo scorso gennaio. L’esponente della più celebre dinastia politica indiana è stato condannato il 23 marzo dal tribunale della città di Surat, ancora una volta nel Gujarat. La pena è di due anni di carcere per diffamazione. Il motivo è quanto ha detto in un discorso prima del voto del 2019, in cui denunciava la corruzione dilagante e in cui aveva fatto riferimento al Primo Ministro e a due uomini d’affari latitanti, tutti col cognome Modi. Ai sensi della legge che regola il processo elettorale indiano, Gandhi rischia seriamente di non potersi candidare alle elezioni del 2024, a meno che la condanna non venga sospesa o cancellata. Se i due anni di carcere fossero confermati, non potrà invece candidarsi per 6 anni dopo la fine della pena.
In tutto ciò, l’Occidente ha spesso guardato dall’altra parte. E questo per due motivi. Il primo è commerciale: i paesi europei, e non solo, sono a caccia di opportunità di diversificazione della propria economia, nell’ambito delle grandi tensioni con la Russia e soprattutto con la Cina. L’India non ha solo un prodotto interno lordo in crescita, ma è anche al centro di una storica ascesa demografica che nel 2023 dovrebbe renderla la nazione più popolosa del mondo al posto della Cina, che ha invece appena iniziato un trend di calo demografico. Un fenomeno che amplierà ancora di più la base del mercato del lavoro indiano, così come quella dei consumatori. Due caratteristiche che fanno sì che Nuova Delhi stia attirando sempre più grandi aziende internazionali. Uno dei principali esempi è quello della Foxconn, principale fornitore di Apple per i suoi iPhone. Il colosso taiwanese è intenzionato a espandere la produzione di smartphone nel suo impianto esistente vicino a Chennai, nello stato indiano meridionale del Tamil Nadu. L’obiettivo è quello di aumentare la produzione fino a circa 20 milioni di unità all’anno entro il 2024. Ma Foxconn intende anche costruire un nuovo impianto di componenti per iPhone in un sito di 300 acri vicino all’aeroporto internazionale Kempegowda a Bangalore.
C’è poi la dimensione geopolitica e strategica. Gli Stati Uniti stanno lanciando una serie di ambiziose iniziative tecnologiche, spaziali e di difesa con l’India, nel tentativo di contrastare la Cina in Asia-Pacifico e di liberare Nuova Delhi dalla dipendenza dalla Russia per gli armamenti. A inizio febbraio, il consigliere per la sicurezza nazionale americano Jake Sullivan e il suo omologo indiano Ajit Doval si sono incontrati a Washington e hanno sottoscritto un accordo di cooperazione in diversi settori, tra cui l’informatica quantistica, l’intelligenza artificiale, le reti wireless 5G e i semiconduttori. Stati Uniti e India hanno inoltre creato un meccanismo per facilitare la produzione congiunta di armi. Mosca sta d’altronde facendo sempre più fatica a onorare le consegne a causa della guerra in Ucraina e a dicembre, per la prima storica volta, l’esercito indiano ha usato informazioni satellitari condivise in tempo reale dagli Stati Uniti per avvantaggiarsi negli scontri coi militari cinesi lungo il confine conteso. È dagli scontri mortali, i primi da decenni, del giugno 2020 che Nuova Delhi non ha del tutto riallacciato i rapporti diplomatici con la Repubblica Popolare Cinese. In ogni caso, l’India continua ad avere una politica estera indipendente, come dimostra la sua contemporanea partecipazione a Quad, Brics e Sco (Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, insieme tra gli altri a Cina e Russia). Ma per Washington il rafforzamento dei rapporti strategici con Nuova Delhi è considerata la vera priorità diplomatica e sul fronte della sicurezza per fronteggiare il suo principale rivale: Pechino.
Una priorità che, nell’ottica statunitense e non solo, val bene un occhio chiuso sullo stato dei diritti all’interno di quella che continua a essere definita la “più grande democrazia del mondo”.
Questo articolo è pubblicato anche sul numero di aprile/giugno di eastwest
Puoi acquistare la rivista sul sito o abbonarti
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Si chiama Gui Haichao ed è il primo astronauta civile cinese a essere inviato nello spazio. 36 anni, specialista di carico utile dell’Università di Aeronautica e Astronautica di Pechino, fa parte dell’equipaggio che martedì 30 maggio si imbarca nella navicella Shenzhou 16, diretta verso la stazione spaziale Tiangong.
Si tratta solo dell’ultimo episodio rivelatorio delle sempre crescenti ambizioni della Cina nello spazio. Il professor Gui sarà responsabile della gestione e della manutenzione del carico utile, del funzionamento delle apparecchiature e delle condizioni di controllo degli esperimenti, nonché della raccolta, dell’organizzazione e dell’analisi dei dati. Lo specialista ha alle spalle un dottorato in ingegneria aerospaziale conseguito presso la Beihang University nel 2014.
Si tratta di un arruolamento storico, visto che prima di questa missione tutti gli astronauti cinesi selezionati per i voli spaziali erano membri delle forze armate di Pechino. Non un caso che arrivi in un momento nel quale Xi Jinping sta spingendo tantissimo sul fronte dell’ingegneria aerospaziale. Al XX Congresso del Partito comunista dello scorso ottobre, sono stati moltissimi i promossi al Comitato centrale e al Politburo con competenze del settore. Gui diventa così uno degli esponenti di spicco di quella classe di tecnocrati che sta rapidamente guadagnando spazio all’interno delle istituzioni partitiche e statali cinesi.
L’equipaggio di cui fa parte Gui rimarrà a bordo della stazione spaziale fino a novembre, quando gli astronauti saranno sostituiti da un nuovo equipaggio nella missione Shenzhou 17, mentre la Tiangong prosegue il suo lavoro di ricerca spaziale da ormai diverso tempo.
Da quando la stazione spaziale è stata completata in ottobre, la Cina è stata avara di dettagli sulle attività dei suoi astronauti. Quando il 30 marzo due di loro hanno fatto una passeggiata spaziale, è stato annunciato dopo che il fatto era già accaduto. Non sono stati forniti dettagli. La Stazione Spaziale Internazionale, invece, segnala in anticipo tutte le passeggiate spaziali e le trasmette in diretta streaming.
D’altronde, la Cina sta insistendo da tempo sulle ambizioni spaziali come specchio della propria pretesa di potenza. Anche nel cinema e nella letteratura, il sostegno alle opere in grado di costruire una retorica spaziale e fantascientifica con caratteristiche cinesi viene molto apprezzata dal Partito. Visto il prestigio in gioco, i funzionari potrebbero essere inclini a nascondere i fallimenti. Qualche silenzio o comunque cautela nella comunicazione potrebbe derivare dalla volontà di evitare di comunicare eventuali insuccessi. È accaduto così, per esempio, sulla vicenda del rover Zhurong. Atterrato su Marte nel 2021, nel maggio dello scorso anno è entrato in un’ibernazione programmata per l’inverno marziano. Zhurong avrebbe dovuto svegliarsi a dicembre, ma ad aprile gli scienziati hanno spiegato che un accumulo di polvere aveva impedito ai raggi solari di riavviare il rover.
Ci sono però diversi altri episodi di grande successo, che dimostrano come il programma spaziale cinese stia procedendo rapidamente. A fine aprile, la Cina ha rilasciato le prime immagini globali di Marte ottenute dalla sua prima missione di esplorazione, fornendo una mappa di base di migliore qualità per le attività scientifiche e di esplorazione del Pianeta Rosso. Le immagini a colori comprendono proiezioni ortografiche, Robinson, Mercatore e azimutali degli emisferi orientale e occidentale di Marte con una risoluzione spaziale di 76 metri. Le immagini forniranno una mappa di base di migliore qualità per i progetti di esplorazione di Marte e per la ricerca scientifica.
La roadmap degli obiettivi di Pechino è ambiziosa. La Cina ha presentato il suo piano di costruzione della Stazione Lunare Internazionale (ILRS) con i suoi partner internazionali, un progetto a lungo termine in tre fasi da qui al 2050. Una “versione di base” della stazione di ricerca dovrebbe essere completata entro il 2028 nel corso di sette lanci, ovvero le missioni cinesi Chang’e 4, 6, 7 e 8 e tre lanci internazionali. Queste missioni si concentreranno sull’esplorazione dell’ambiente lunare e delle sue risorse, oltre che sulla sperimentazione di applicazioni tecnologiche. Altre sei missioni, tra cui ILRS 1-5, saranno realizzate tra il 2030 e il 2040 per costruire una “versione completa” della stazione. Entro il 2050, l’ILRS dovrebbe diventare una base di ricerca lunare a grandezza naturale e multifunzionale, con la speranza di poter eventualmente supportare missioni con equipaggio su Marte. Già nel 2030, invece, la Cina mira a portare i suoi astronauti sulla Luna.
Non è tutto. La Cina prevede di lanciare la sonda Tianwen-2 intorno al 2025 tramite il vettore Long March-3B; la missione eseguirà un fly-by e la restituzione di un campione con un asteroide vicino alla Terra denominato 2016HO3 e poi, intorno al 2034, un altro fly-by con una cometa della fascia principale denominata 311P. Zhang Rongqiao, capo progettista del progetto interplanetario cinese, ha dichiarato ai media che il lancio di Tianwen-2 è previsto intorno al maggio 2025, con la fase di ricerca del prototipo quasi completata.
La Cina sta inoltre pianificando una ricerca oltre il sistema solare per trovare pianeti abitabili, e la prima ricerca sarà effettuata nel 2030 dopo il completamento di un tipo di telescopio di base, hanno rivelato i ricercatori cinesi durante l’evento China Space Day. Il piano, chiamato programma Miyin, mira a individuare “un’altra Terra” tra i vicini del sistema solare attraverso il lancio di un array di telescopi. Il programma prevede anche l’esecuzione di immagini ad alta risoluzione e osservazioni spettroscopiche di vari tipi di oggetti per mappare la composizione dell’acqua del sistema solare, aprendo una nuova era di osservazioni astronomiche ad alta risoluzione. La realtà come la finzione, visto che la ricerca di un altro pianeta per salvare l’umanità era il centro de Il problema dei tre corpi, celebre romanzo di fantascienza di Liu Cixin, tradotto poi nel più grande blockbuster della storia del cinema cinese, The Wandering Earth.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
“No ai test Covid, sì al cibo. No all’isolamento, sì alla libertà. No alle bugie, sì alla dignità. No alla rivoluzione culturale, sì alla riforma. No al grande leader, sì al voto. Non essere schiavo, sii cittadino”. È il 13 ottobre 2022. Sul Sitong Bridge, un cavalcavia nel distretto di Haidian a Pechino, compare uno striscione di protesta con questa frase. Viene rapidamente rimosso e sul web cinese vengono censurate le parole chiave in esso contenute. Pochi giorni dopo, Xi Jinping viene nominato per la terza volta segretario generale al termine del XX Congresso del Partito comunista cinese. Nelle settimane seguenti, slogan simili appaiono anche in altre città cinesi. Soprattutto nei bagni pubblici, uno dei pochi spazi privi delle telecamere di sicurezza. A fine novembre, poi, esplodono diverse proteste contro le restrizioni imposte dalla strategia zero Covid allora in vigore. All’inizio c’è persino chi parla di “rivoluzione degli A4”, prendendo spunto dai fogli bianchi tenuti in mano da diversi manifestanti che così sperano di evitare problemi con le autorità per l’assenza di slogan critici nei confronti del governo. Il tutto poi viene riassorbito in fretta, con Xi che dosa concessioni e repressione, arrivando velocemente alla riapertura della Cina e allo stesso tempo presidiando in maniera diffusa i centri nevralgici delle città del Paese per evitare la prosecuzione delle proteste.
È forse questa contingenza di poco più di un mese e mezzo l’esempio internazionalmente più celebre di protesta in Cina. Quantomeno da quanto accaduto in piazza Tiananmen nel 1989. Come se nei 33 anni seguenti i cinesi non abbiano mai rivendicato diritti, nella visione spesso stereotipata che se ne ha in Occidente. Ovviamente, non è così. Anche se le forme di protesta raramente mettono nel mirino direttamente i leader o il governo centrale, ma semmai autorità locali, privati o politiche specifiche. Un po’ per convinzione, un po’ per convenienza. Dopo Tiananmen, il Partito ha giurato di non lasciar mai più ripetere una protesta di massa in grado di mettere in discussione la sua governabilità. Per questo nelle proteste di fine novembre si cantava spesso l’Internazionale o l’inno cinese, come ad allontanare preventivamente l’accusa di mancato patriottismo o mancata fedeltà al Paese.
Nonostante i riflettori internazionali siano spesso rimasti spenti o semi spenti, anche a causa della censura interna, in questi 30 anni ci sono state molte altre proteste. Per restare sul tema sanitario, già nel 2003 in diverse città ci furono proteste contro la gestione dell’epidemia di SARS. Una delle principali critiche era la mancanza di trasparenza e la presunta lentezza della risposta del governo, che inizialmente aveva negato l’esistenza della malattia, silenziando medici e giornalisti che mandavano segnali d’allarme. Le proteste e le critiche portarono le autorità a riconoscere la gravità della malattia e ad adottare misure per contenerla, tra cui l’attuazione di misure di quarantena e l’aumento delle risorse per le cure mediche. Una vicenda con diversi paralleli con quella del 2019.
Al di là del fronte sanitario, ci sono stati altri episodi in cui la gestione centrale è finita nel mirino. In particolare, nel 2011, quando un treno ad alta velocità a Wenzhou si scontrò con un altro treno, uccidendo 40 persone e ferendone quasi 200. Anche in quel caso ci fu la percezione di mancanza di trasparenza e molti furono insoddisfatti della gestione dei soccorsi e del trattamento delle vittime. Una delle prime ondate di indignazione popolare a essere veicolata attraverso i social, alla quale il governo e in particolare Xi (che di lì a poco avrebbe assunto il potere) risposero rafforzando l’affidabilità della rete ferroviaria e la sua modernizzazione tecnologica.
In altri casi, invece, il governo non si è adeguato alle richieste di chi protestava. Per esempio sul caso della Diga delle Tre Gole, oggetto di insoddisfazione sin dagli anni Novanta, quando milioni di persone sono state sfollate dai pressi del fiume Yangtze per la costruzione dell’immensa opera idroelettrica. Tra i motivi delle proteste, anche il timore dell’impatto ambientale del progetto, visto il florido habitat faunistico dell’area e l’alterazione del flusso del fiume e seguenti problematiche per le comunità a valle. Il governo ha comunque continuato a sostenere la diga, sottolineandone i benefici in termini di produzione di energia elettrica, argomento divenuto cruciale dopo la crisi energetica dell’autunno del 2021.
Molto più spesso, invece, le proteste sono dirette contro aziende private o funzionari locali. Un esempio celebre è quello di Wukan, un piccolo villaggio di pescatori nella provincia di Guangdong che nel 2011 hanno protestato contro il sequestro dei loro terreni da parte dei funzionari locali a fini di sviluppo. Le proteste sono degenerate e gli abitanti hanno eretto barricate e si sono scontrati con la polizia. Alla fine si è arrivati a negoziati tra gli abitanti del villaggio e il governo, che hanno portato all’elezione di un nuovo comitato di villaggio.
Negli ultimi anni, a differenza di quanto accadeva una volta, è diventato peraltro più complicato contenere la diffusione di questi episodi in rete. Vero che il web cinese viene definito da molti esperti una sorta di gigantesco intranet, ma allo stesso tempo tra le maglie della rete qualcosa riesce a passare. Una questione da tenere presente per Xi, che ha appena iniziato il suo terzo mandato. Le rivendicazioni dei cinesi della “nuova era” riguardano diversi argomenti. Uno di questi è il lavoro. Tra gli esempi più recenti e significativi, quello di Zhengzhou, dove il mega impianto della Foxconn è stato teatro di fughe di massa e scontri tra operai e polizia. Motivo del contendere, presunti bonus non pagati ai lavoratori che avevano scelto di restare chiusi nella bolla della fabbrica per continuare a produrre durante il Covid. Una vicenda che ha avuto un impatto rilevante sul principale fornitore di iPhone per Apple. Già nel 2019, negli stabilimenti Foxconn c’erano state proteste di dipendenti che chiedevano salari più alti e il diritto di formare un sindacato. Medesimi ingredienti della rivolta agli impianti cinesi della Honda, nello stesso anno.
Il governo è spesso riuscito a presentarsi come tutore dei diritti dei lavoratori, in particolare nel caso della cosiddetta gig economy. Già prima del Covid, i riders di servizi di consegna come Deliveroo e la cinese Meituan hanno iniziato a inscenare scioperi e proteste per le paghe troppo basse e l’assenza quasi totale di tutele. Il Partito è intervenuto per regolare maggiormente il settore, colpendo anche i colossi digitali e le loro posizioni di monopolio. Arrivando anche a mettere in discussione la famosa “cultura del 996”, cioè la tradizione di lavorare dalle nove del mattino alle nove di sera per sei giorni alla settimana, imposta dai giganti del settore tecnologico.
Un altro tema che sta a cuore dei cinesi è quello ambientale. Già nel primo decennio del nuovo millennio c’erano state diverse proteste contro l’inquinamento, causato dalla rapida industrializzazione della Cina. Anche in questo caso, il governo ha recepito e agito con forza per ridurre lo smog. Soprattutto nelle grandi città come Pechino, molto meno altrove in province meno centrali. Nel 2019, in diverse città cinesi si sono verificate proteste contro i piani di costruzione di inceneritori di rifiuti. I cittadini erano preoccupati per i rischi sanitari e ambientali degli inceneritori e le proteste hanno portato alla cancellazione di diversi progetti. Anche nel 2016, la rivolta contro un impianto chimico a Chengdu, motivata dal timore di esalazioni tossiche, ha portato all’accantonamento del progetto. Ancora prima, nel 2011, stessa sorte per un impianto di produzione di paraxilene a Xiamen, sulla costa del Fujian. Più recente il caso della centrale a carbone proposta nella provincia dello Zhejiang. Nel 2021, residenti e attivisti sono riusciti a bloccare l’idea, col governo che ha contestualmente annunciato di voler aumentare gli investimenti nelle fonti di energia rinnovabili.
Certo, non finisce sempre così bene. Anzi, nell’ultimo anno e mezzo sono state costruite moltissime nuove centrali a carbone. E su altri argomenti ritenuti più sensibili il governo non opera concessioni. Per esempio sulle politiche identitarie. Nel 2020, in Mongolia interna si sono verificate diverse proteste per la decisione di aumentare l’insegnamento della lingua mandarina nelle scuole della regione autonoma. Questa politica è stata vista da molti mongoli come un tentativo di erodere la loro identità culturale e di minare l’uso della lingua mongola. Le proteste hanno incluso grandi dimostrazioni e boicottaggi delle scuole, con i genitori che hanno tenuto a casa i figli per dimostrare dissenso. Ma in questo caso il governo ha risposto arrestando e detenendo diversi manifestanti e attuando misure severe per reprimere il dissenso. Come prima in Tibet o nello Xinjiang, su temi del genere Pechino non prevede nessuna possibilità di arretrare.
Più pronta ad accogliere le insoddisfazioni dei cittadini, invece, in merito alla questione immobiliare. Soprattutto se le lamentele sono in direzione di aziende private. Gli esecutivi locali e quello centrale sono intervenuti più volte per imporre o sostenere la consegna degli appartamenti da parte dei grandi sviluppatori immobiliari, caduti in una grossa crisi tra il 2021 e il 2022. In diverse occasioni, i clienti di colossi come Evergrande si sono presentati sotto le sedi delle aziende per contestare la mancata fine dei lavori di case già pagate. Le autorità sono spesso intervenute sostenendo piani di ristrutturazione aziendale che prevedono anche l’intervento diretto dello stato. Con la priorità di garantire la consegna degli appartamenti ai cittadini cinesi per evitare che la questione potesse turbare ulteriormente l’ordine sociale o diventare argomento di rivendicazione contro il sistema politico. I prezzi delle case sono stati oggetto di manifestazioni in questi anni anche a Pechino e Shenzhen, mentre a Suzhou e Chongqing si sono contestati piani di demolizione. In questi due ultimi casi si sono verificati anche degli scontri tra i residenti e le forze di polizia.
Negli ultimi anni ci sono state anche alcune proteste scaturite da abusi e violenze di genere, ma un vero e proprio movimento #MeToo non si è mai riuscito a formare. Non tanto per misoginia del Partito, quanto per la sua avversione verso qualsiasi forma di associazionismo in grado di avanzare istanze non direttamente gestibili dalle autorità.
Dopo la riapertura post Covid, le autorità locali devono invece far fronte a un altro problema: la mancanza di liquidità nelle proprie casse. A febbraio si sono verificate diverse proteste a Wuhan, Guangzhou e altre città. Coinvolti soprattutto i pensionati, arrabbiati per i tagli alle detrazioni delle spese mediche. Le autorità sanitarie locali sono d’altronde costrette a rivedere le spese, dopo che negli scorsi tre anni hanno disperso enormi risorse per lockdown e tamponi di massa, all’interno della mastodontica macchina anti Covid imposta dalla strategia di tolleranza zero voluta da Xi.
La rapida e improvvisa riapertura dei mesi scorsi non ha cancellato tutti i problemi o i motivi di rivendicazione.
Le proteste non sono l’inizio di una rivoluzione, ma dimostrano che i cinesi sono pronti a scendere in strada per chiedere la tutela dei propri diritti. Anche con più vigore di un tempo. Un elemento di cui il governo dovrà tenere conto, visto anche che la crescita imponente degli ultimi decenni ha cominciato a rallentare. Col calo demografico e una probabile quanto necessaria riforma delle pensioni che incombono all’orizzonte, Pechino sarà chiamata a dosare con ancora maggiore attenzione concessioni e repressione. Anche perché il Partito sa bene che alla base delle proteste di fine novembre, rimaste un fuoco fatuo ma comunque molto significative per la loro diffusione contemporanea in diverse città, non c’era solo la stanchezza per le politiche anti Covid. Nel mix c’erano anche la disoccupazione giovanile e l’incertezza verso il futuro, sentimento inedito quantomeno sul fronte economico per le ultime generazioni di cinesi che erano state abituate a stare sempre meglio di quelle precedenti.
Oltre ai tempestosi mari del Pacifico, il nuovo timoniere Xi dovrà essere in grado di navigare anche le acque interne, per evitare che eventuali improvvise correnti finiscano per provocare qualche burrasca.
Questo articolo è pubblicato anche sul numero di aprile/giugno di eastwest
Puoi acquistare la rivista sul sito o abbonarti
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Non solo Ucraina, non solo Russia. In un summit del G7 dominato dalla presenza di Volodymyr Zelensky e dal via libera di Washington all’invio di F-16 da paesi terzi, c’è stata anche tantissima Asia. A partire dalla sede del vertice, ovviamente, Hiroshima. Un messaggio potente, quello arrivato dal Giappone, con la scelta della città simbolo del disastro atomico. “Accogliere Zelensky a Hiroshima è stata un’opportunità per inviare un messaggio urgente: la minaccia delle armi nucleari e il loro uso non devono essere permessi”, ha dichiarato in conclusione del summit il padrone di casa Fumio Kishida, che sembra destinato a utilizzare il successo dell’evento come volano per chiedere elezioni anticipate e cementare il consenso. D’altronde, il Giappone può sostenere di essere riuscito a portare a parlare col blocco occidentale anche esponenti del cosiddetto “sud globale”.
Particolare attenzione all’Asia, con la presenza di diversi paesi tra gli invitati. Si è parlato soprattutto di India e Corea del Sud. Il premier Narendra Modi ha avuto il suo primo incontro con Zelensky dall’inizio della guerra. Colloquio da cui è derivato l’impegno a sforzarsi di arrivare a una soluzione del conflitto, ma senza dettagli o passi avanti significativi. C’è chi spera in una mediazione dell’India, magari in concomitanza del summit del G20 di Nuova Delhi di settembre, visto che il blocco G7 riconosce molto di più (anche per calcoli strategici) la neutralità indiana rispetto a quella cinese. L’India teme l’allineamento tra Cina e Russia, per questo sembra in parte disposta a dare quantomeno segnali formali di maggiore disponibilità agli Usa. Da Hiroshima, Modi ha peraltro annunciato che il prossimo summit del Quad si terrà proprio in India nel 2024, dopo che quello di Sydney è stato cancellato per l’assenza di Joe Biden.
La presenza del presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol è invece stata funzionale a suggellare il riavvio dei rapporti tra Tokyo e Seul. Significativo in tal senso che Biden abbia invitato sia Yoon che Kishida alla Casa Bianca per un trilaterale, dopo che i due leader negli scorsi mesi hanno già visitato Washington siglando importanti accordi.
Se n’è parlato meno, ma è molto rilevante anche la presenza di Indonesia e soprattutto Vietnam. Hanoi è uno degli anelli chiave dell’ecosistema strategico dell’Asia-Pacifico. Il Giappone sta puntando molto sul rafforzamento dei rapporti col paese del Sud-Est asiatico, così come gli Stati Uniti. Il premier Pham Minh Chinh ha incontrato i vari leader del G7 e lo stesso Zelensky, mentre si parla con insistenza di un possibile viaggio a Washington del segretario del Partito comunista vietnamita Nguyen Phu Trong.
Ciò ovviamente non vuol dire che i vari paesi presenti al G7 siano improvvisamente disponibili a una sorta di arruolamento anti russo o anti cinese. Ma proprio il rafforzamento di questa architettura asiatica di rapporti regionali può essere uno dei motivi (impliciti) di insoddisfazione della Cina, il vero elefante (o meglio dragone) nella stanza di Hiroshima. Il comunicato congiunto dei leader del G7 critica implicitamente Pechino sulla coercizione economica ed esplicitamente sui dossier politici. Il governo cinese ha denunciato “diffamazioni” sulle varie questioni Tibet, Xinjiang e mar Cinese meridionale. Fastidio anche per il passaggio su Taiwan, in cui il G7 sottolinea che la pace e la stabilità sullo Stretto sono “indispensabili per sicurezza e prosperità della comunità globale”. L’internazionalizzazione della questione è quanto più dà fastidio a Xi Jinping, che il G7 prova comunque a rassicurare sottolineando che “non ci sono cambi di posizione dei paesi membri sulla politica della unica Cina”. Pechino lamenta però la mancata opposizione esplicita all’indipendenza di Taiwan. Lunedì 22 maggio è stato convocato l’ambasciatore giapponese per esprimere proteste.
A margine e a conclusione dei lavori i toni sono stati più concilianti. Sia Europa che Stati Uniti hanno ribadito che l’obiettivo non è contenere l’ascesa cinese, né il disaccoppiamento economico. Francia e Germania sottolineano che Washington condivide la formula di “riduzione del rischio” coniata dall’Unione europea. Aumenteranno dunque controlli e restrizioni, ma solo su tecnologia e i settori più sensibili. Sul resto, si intende mantenere o rafforzare i rapporti. Lo stesso Biden, prima di lasciare il Giappone, ha auspicato un prossimo disgelo tra le due potenze.
Ma i media di stato cinesi denunciano il passaggio da “disaccoppiamento” e “riduzione del rischio” come una sorta di “decoupling mascherato”. Mentre la portavoce del ministro degli Esteri Mao Ning ha messo in dubbio la credibilità degli Usa di voler riavviare i rapporti, visto il perdurare delle sanzioni economiche e commerciali nei confronti di varie entità cinesi. Sulla coercizione economica, la Cina ha peraltro replicato con un lungo documento in cui gira le accuse proprio in direzione degli Stati Uniti, citando i numerosi casi di embargo verso paesi terzi dal Dopoguerra a oggi, nonché le più restrizioni alle esportazioni. Il tutto mentre la stessa Cina ha vietato agli operatori di infrastrutture chiave l’uso di prodotti di Micron, il colosso americano dei microchip.
Sul fronte diplomatico, la Cina sostiene che le proposte del G7 sulla guerra in Ucraina non siano credibili. Nella retorica di Pechino, Usa e occidente non tengono in considerazione le “legittime preoccupazioni di sicurezza di tutti i paesi”, in questo caso della Russia. Il che renderebbe, sempre secondo la Cina, non affidabile qualsiasi proposta di pace in arrivo dalla Casa Bianca o dai suoi alleati più stretti.
Insomma, se davvero sarà disgelo il lavoro da fare per ottenerlo è parecchio.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Non è stata un’onda, ma uno tsunami, quello che si è abbattuto sul mondo politico thailandese. Le elezioni generali di domenica 14 maggio hanno registrato un risultato davvero storico. Non solo ha vinto l’opposizione, ma ha stravinto. Ed è clamoroso che per la prima volta dopo diverse tornate elettorali ad affermarsi alle urne non sia stato il Pheu Thai della celeberrima dinastia politica dei Shinawatra, ma Move Forward, un partito nato sull’onda delle proteste giovanili degli ultimi anni ma che ha saputo catalizzare evidentemente le preferenze della maggior parte di coloro che vogliono il cambiamento. E i thailandesi hanno dimostrato di volerlo eccome, quel cambiamento.
Secondo i risultati preliminari diffusi dalla commissione elettorale, il Move Forward è in vantaggio in 113 dei 400 seggi in cui vengono eletti direttamente i membri del Parlamento, rispetto ai 112 seggi del Pheu Thai, che dal 2001 ha vinto cinque elezioni generali consecutive, ma ogni volta è stato costretto a lasciare il potere. O con le norme, o con i golpe militari del 2006 e del 2014 che hanno colpito gli ex premier Thaksin Shinawatra prima e la sorella Yingluck poi. Stavolta sembrava destinata a primeggiare la figlia e nipote dei due, Paetongtarn, che aveva ricevuto un’ulteriore spinta nei sondaggi dopo essere diventata mamma una decina di giorni prima del voto.
E invece a vincere, contro tutte le attese, è stato il Move Forward del candidato premier Pita Limjaroenrat. Il risultato deriva in parte da un’ondata di entusiasmo tra i giovani per il suo programma liberale e le promesse di cambiamenti audaci, tra cui la rottura dei monopoli e la riforma della legge sulla lesa maestà. La legge punisce gli insulti percepiti con una pena fino a 15 anni di carcere e centinaia di persone sono accusate, alcune delle quali sono in detenzione preventiva. Ma a premiare Move Forward anche presso le generazioni più adulte è stata una linea chiara e priva di compromessi, critica sia dei militari sia della monarchia. A dir poco significativo, un segnale che i thailandesi hanno veramente voglia di un’aria nuova. Così il partito è riuscito a catalizzare consensi che tradizionalmente sarebbero andati al Pheu Thai, considerato più ambiguo su alcuni punti. Alla domanda se avrebbe appoggiato la proposta di riforma del reato di lesa maestà, per esempio, il partito ha risposto che se ne sarebbe potuto discutere in parlamento. Il risultato è stato incredibile. A partire dalla capitale Bangkok, dove sono stati conquistati tutti e 33 i seggi a disposizione. A dimostrazione della connessione stabilita tra il partito e la dinamicità culturale della metropoli.
Totale insuccesso per i principali partiti della coalizione di governo uscente, che hanno ottenuto complessivamente 151 seggi elettorali. Solo 23 per il nuovo partito United Thai Nation del Primo ministro Prayuth Chan-ocha, che ha sfidato la costituzione costruendo una forza politica tutta sua e disperdendo il voto pro establishment. Leggermente meglio Palang Pracharath, guidato dal vice Primo ministro Prawit Wongsuwan, che ha ottenuto 39 seggi. Al terzo posto con 67 seggi il Bhumjaithai, che ha basato buona parte della sua campagna elettorale promettendo la depenalizzazione dell’utilizzo di cannabis. I Democratici hanno invece totalizzato 22 seggi.
L’indicazione è quella di una coalizione tra Move Forward e Pheu Thai. Limjaroenrat ha già proposto un’alleanza di sei partiti che dovrebbe ottenere 309 seggi. Ne mancano però ancora diversi per raggiungere i 376 necessari per neutralizzare il ruolo del Senato nell’individuazione del premier. Anche il Pheu Thai ha dato garanzie sull’alleanza. Shinawatra e l’altro leader del partito, Chonlanan Srikaew, hanno garantito che il partito “non ha intenzione di formare un altro governo” che non sia quello col Move Forward.
Ma la strada è tutt’altro che spianata. Oltre ai 500 membri della Camera, la costituzione prevede che 250 senatori di nomina militare siano inclusi nel voto per il primo ministro. Di conseguenza, qualsiasi blocco di coalizione avrebbe appunto bisogno di almeno 376 seggi alla Camera bassa per nominare un primo ministro senza che il Senato influisca sul risultato. E la storia insegna che non è scontato che la Camera alta del Parlamento thailandese ascolti le indicazioni arrivate dalle urne. Basti pensare al 2019, quando il Senato ha votato all’unanimità per Prayuth, nonostante il suo partito abbia ottenuto molti meno seggi rispetto al Pheu Thai. Il Primo ministro è poi riuscito a mettere insieme una coalizione di 19 partiti diversi che lo ha mantenuto in carica per quattro anni.
La sensazione è che l’establishment non escluda un compromesso col Pheu Thai. Le insistenti voci sul possibile rientro dall’esilio di Thaksin Shinawatra nei prossimi mesi lasciano intuire che le due parti starebbero in qualche modo dialogando. La piattaforma populista promessa dalla figlia dell’ex leader, incardinata sulla promessa di raddoppiare il salario minimo nel giro di qualche anno, non contiene gli elementi anti sistema della linea di Move Forward.
Proprio l’assenza di compromessi nelle proposte del partito arrivato al primo posto potrebbe rappresentare il principale ostacolo alla formazione di un’alleanza vasta e in grado di arrivare ai 376 seggi, vista la ritrosia della maggior parte dei partiti di oltrepassare la linea rossa che rischia di proiettare nella schiera degli “anti monarchici”. Ancora un sostanziale tabù, soprattutto per le forze politiche di governo.
Da non trascurare, tra l’altro, possibili azioni normative o legali. La Commissione elettorale ha ora 60 giorni di tempo per approvare o respingere i risultati delle elezioni, il 95% dei quali deve essere certificato per l’insediamento del Parlamento. L’assegnazione dei seggi alle liste di partito richiederà più tempo. Nel frattempo, i partiti probabilmente si scambieranno denunce di violazioni elettorali. In base alle elezioni del 2019, alcuni candidati potrebbero essere squalificati e i partiti potrebbero essere sciolti. Così era accaduto a Future Forward. Proprio lo scioglimento di quella forza politica aveva costituito uno degli ingredienti principali delle grandi proteste del 2020 e 2021 da cui ha preso origine Move Forward. In molti immaginano una possibile replica. La differenza, rispetto ad allora, è che il partito in questione è arrivato primo. Sommando il tradizionale forte consenso per il Pheu Thai, la popolazione ha parlato chiaro, molto più di tante altre volte. Il che mette in una posizione particolarmente scomoda i militari, costretti al compromesso per evitare il muro contro muro che porterebbe con ogni probabilità a nuove grandi proteste e tensioni.
Le elezioni in Thailandia sono appena finite e il popolo ha indicato con decisione la strada del cambiamento. Ora inizia un lungo e tortuoso periodo di incertezza. Non è scontato che la voce dei thailandesi venga ascoltata, ma di certo si è levata molto forte.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
“La Cina ha già vinto la battaglia sull’intelligenza artificiale. Non abbiamo alcuna possibilità di combattere contro la Cina tra 15 o 20 anni. In questo momento, è già un affare fatto; a mio parere, è già finita”. Ottobre 2021. A pronunciare queste parole al Financial Times è Nicolas Chaillan, il primo responsabile del software del Pentagono che si era dimesso pochi giorni prima per protestare contro la lentezza della trasformazione tecnologica delle forze armate statunitensi. Una presa di posizione illuminante su quanto venga ritenuto strategico il ruolo dell’intelligenza artificiale nella competizione tra Stati Uniti e Cina. E stando alle previsioni di Chaillan ma anche di diversi servizi di intelligence occidentali, Pechino è destinata a dominare molte delle principali tecnologie emergenti, in particolare l’intelligenza artificiale, la biologia sintetica e la genetica, entro un decennio o poco più. Anche per questo Washington sta reagendo con vigore, per provare a stoppare o rallentare questa ascesa.
La Cina è già il primo paese al mondo per numero di brevetti di intelligenza artificiale: tra il 2011 e il 2020 sono state depositate quasi 390 mila domande, pari al 74,7% del totale. Non si tratta di una leadership solo quantitativa ma anche qualitativa. Nel 2020, per la prima volta, gli articoli accademici cinesi sono stati più citati di quelli americani nelle pubblicazioni scientifiche mondiali di settore. Si stima che l’industria cinese dell’AI abbia un valore di oltre 150 miliardi di dollari e il governo si è impegnato a investire più di 150 miliardi di dollari in industrie legate all’AI entro il 2030.
Alla base di questa tendenza ci sono diversi punti di forza. Il primo è quello che riguarda la sua grande popolazione e le sue vaste risorse di dati. Con oltre 1,4 miliardi di persone, la Cina dispone di un enorme mercato per i prodotti e i servizi di AI, che può essere sfruttato per promuovere l’innovazione e la crescita. Inoltre, le vaste risorse di dati della Cina, combinate con le norme sulla privacy relativamente rilassate, offrono alle aziende cinesi un vantaggio significativo nello sviluppo di modelli e applicazioni. Non solo. Come accade in altri settori, l’industria AI cinese è caratterizzata da un alto grado di integrazione tra governo, industria e università, che ha permesso un progresso più rapido.
I piani di sviluppo messi in campo dal Partito comunista cinese sono notevoli. Dopo aver lanciato il piano Made in China 2025, che conteneva in nuce le ambizioni di autosufficienza tecnologica che sono ora invece state rese esplicite, nel 2017 il governo cinese ha pubblicato il piano nazionale di sviluppo dell’AI. Obiettivo dichiarato: diventare un leader mondiale dell’AI entro il 2030. Nel 2019, il Ministero della Scienza e della Tecnologia ha annunciato un piano per investire 1,4 miliardi di dollari nella ricerca di base sull’AI fino al 2024. Secondo un rapporto previsionale della società di consulenza IDC dello scorso anno, gli investimenti cinesi nell’AI dovrebbero raggiungere 26,69 miliardi di dollari nel 2026, pari a circa l’8,9% degli investimenti globali, diventando così la seconda destinazione di investimento al mondo.
Le applicazioni sono entrate in maniera vasta in diversi settori chiave individuati dai documenti governativi: sanità, trasporti e finanza, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza, la produttività e l’innovazione. Pechino persegue quella che gli esperti chiamano strategia di “intelligentizzazione”, che prevede l’integrazione delle tecnologie dell’AI in tutti gli aspetti della società, compresi governo, industria e vita quotidiana. Basti vedere l’avanzamento dei progetti su veicoli a guida autonoma e smart cities, sulle quali Pechino ha negli anni scorsi già fissato un punto di riferimento.
Ma c’è ovviamente anche un imponente versante di applicazione in campo militare. La Cina ha investito molto nello sviluppo di veicoli senza pilota gestibili attraverso tecnologie AI, come droni e veicoli terrestri senza pilota. Questi sistemi d’arma autonomi sono progettati per svolgere una serie di compiti militari, dalla ricognizione e sorveglianza alle operazioni di combattimento. Un’altra area in cui la Cina sta applicando l’AI alle forze armate è lo sviluppo di capacità di guerra informatica. È considerato molto importante lo sviluppo di strumenti basati sull’intelligenza artificiale per lo spionaggio, l’hacking e il sabotaggio informatico. Oltre a questi settori, la Cina sta applicando l’AI anche alla logistica militare e ai processi decisionali. Le forze armate cinesi utilizzano già le tecnologie AI per ottimizzare le catene di approvvigionamento, tracciare le attrezzature e pianificare le operazioni. Ma anche per analizzare i dati provenienti da diverse fonti, tra cui immagini satellitari, social media e altre fonti di intelligence aperte, e per supportare i processi decisionali.
Dall’altra parte, gli Stati Uniti provano ad arrestare il processo e a mantenere una leadership che già nel corso del 2023 appare condivisa. Anzi, è probabile che già ora la Cina sia in vantaggio nell’implementazione delle tecnologie in prodotti e servizi. Come ha spiegato recentemente l’esperto Kaifu Lee, gli Stati Uniti rimarranno all’avanguardia nella ricerca sull’AI. Ma la Cina guiderà l’implementazione di queste tecnologie.
Si stima che il settore dell’intelligenza artificiale negli Stati Uniti abbia un valore di oltre 300 miliardi di dollari, con aziende come Google, Microsoft e Amazon in testa. La reazione “anti cinese” di Washington è sia propositiva che in qualche modo confrontazionale. Seguendo la prima logica, sono aumentati gli investimenti. Nel 2020, la National Science Foundation (NSF) statunitense ha annunciato un finanziamento di 140 milioni di dollari per gli istituti di ricerca sull’AI. Nel 2019, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha annunciato un investimento di 2 miliardi di dollari nell’AI, con l’obiettivo di mantenere la superiorità militare. Investimenti ai quali ne sono seguiti altri negli anni successivi. Seguendo invece una logica di confronto, gli Stati Uniti hanno imposto restrizioni all’esportazione di tecnologie di intelligenza artificiale in Cina, aumentando sul fronte interno il controllo delle aziende tecnologiche cinesi che operano negli Stati Uniti, esprimendo timori sulla privacy dei dati e sulla sicurezza nazionale. Prima del caso di attualità legato a TikTok, era già capitato a diverse altre aziende cinesi finite nella lista nera delle “entità” che rappresenterebbero un pericolo alla sicurezza nazionale statunitense.
Come accade anche sul fronte dei semiconduttori, oltre alle restrizioni sulle singole aziende il governo statunitense ha attuato anche politiche più ampie volte a limitare l’esportazione di tecnologie di AI in Cina. Nel mirino, soprattutto quelle riguardanti il riconoscimento facciale e la sorveglianza. In base alle regole, le aziende statunitensi devono ora ottenere una licenza per esportare determinati tipi di software di AI in Cina. Allo stesso tempo, in un altro parallelo con quanto accade sui microchip, la Casa Bianca ha inoltre esortato altri paesi a limitare le esportazioni di tecnologie AI verso la Cina. Nel 2019, il governo statunitense ha rilasciato una dichiarazione congiunta con diversi altri paesi, tra cui Giappone e Australia, chiedendo reti 5G “sicure e resilienti”. Il pressing sulle infrastrutture di rete di Huawei si è fatto incessante a ogni latitudine, Italia compresa. Ora questa manovra continua su semiconduttori e, appunto, intelligenza artificiale.
Non è certo un caso che la Cina stia accelerando sulla strada del perseguimento dell’autosufficienza tecnologica. I segnali in tal senso sono stati moltissimi, sia dal XX Congresso del Partito comunista dello scorso ottobre sia dalle “due sessioni” legislative di marzo. Il forte senso di urgenza della missione arriva anche dalle nomine: sia in ambito partitico che statale sono stati promossi tantissimi tecnocrati. Funzionari con esperienza in settori a cui Xi Jinping assegna grande rilevanza per lo sviluppo tecnologico e strategico della Cina. Ci sono tanti componenti di quel “cosmos club” che ha vissuto un’ascesa esponenziale durante l’era di Xi. Provenienti dai programmi di difesa e dai programmi spaziali, si tratta di figure in sintonia con l’ambizione di Xi di trasformare la Cina in una superpotenza tecnologica. La presenza di un numero sempre maggiore di tecnocrati negli organi decisionali del Partito può cambiare i connotati dell’élite politica cinese e rafforzare ulteriormente la già forte fusione delle industrie civili e militari.
Ci sono poi, ovviamente, gli investimenti. Nell’annunciare il budget per il 2023, l’aumento più deciso dei capitoli di spesa è, in proporzione, quello sui finanziamenti speciali a sostegno dello sviluppo dei semiconduttori e di altre industrie strategiche: una crescita quasi del 50%. Secondo Reuters, è previsto un ulteriore maxi pacchetto da 143 miliardi di dollari per microchip e intelligenza artificiale. La necessità di perseguire una complicata (e forse utopistica) autosufficienza tecnologica ha permeato tutti i discorsi più recenti di Xi. In tale direzione va anche la ristrutturazione del Ministero di Scienza e Tecnologia. Come si prevedeva sin dalla conclusione del secondo Plenum del XX Comitato centrale del Partito, è stata approntata una riforma profonda che investe soprattutto i settori scientifico e tecnologico con l’obiettivo di razionalizzare la gestione delle risorse e snellire la struttura normativa. E, ovviamente, consente al governo di accentrare e velocizzare il processo decisionale su tutti i settori ritenuti prioritari. A partire da quello che investe la contesa tecnologica su intelligenza artificiale e non solo.
C’è ancora un elemento sul quale la Cina è però in ritardo rispetto agli Usa: la ricerca di base. L’insegnamento e la ricerca in Cina non possono ancora competere con gli stipendi del settore privato, né le università possono attrarre talenti accademici di alto livello dall’estero. Anche per questo, negli obiettivi del terzo mandato di Xi c’è quello non solo di spendere e lanciare nuovi progetti, ma anche costruire una rete efficace e capillare di formazione e ricerca dei talenti. Il governo non deve solo aumentare gli investimenti, ma anche dirigere come un’orchestra le altre componenti della società civile come gli istituti di ricerca, le università e le imprese private: tutti chiamati a collaborare in maniera stretta e sotto la guida della sfera politica.
Proprio nelle scorse settimane, è arrivata l’ennesima accelerazione con il lancio di un nuovo piano chiamato “Intelligenza artificiale per la scienza”. Il progetto si concentrerà sui principali problemi delle discipline di base e sulle esigenze di ricerca nei settori chiave della scienza e della tecnologia, come lo sviluppo di farmaci, la ricerca genetica e l’allevamento biologico, allo scopo di favorire l’apertura e la convergenza delle risorse e potenziare le capacità di innovazione.
Mentre infuria la contesa tra le due potenze, sullo sfondo emerge un altro attore sempre più in grado di competere con gli innovatori cinesi e statunitensi. Si tratta della Corea del Sud, che a sua volta si è posta l’obiettivo di diventare un leader mondiale nell’AI entro il 2030. Uno dei principali punti di forza di Seul è l’avanzata infrastruttura di telecomunicazioni e gli alti livelli di penetrazione di Internet. Una solida base per lo sviluppo e la diffusione di tecnologie basate sull’AI, come l’Internet delle cose e i veicoli autonomi. Il governo ha investito oltre 2 miliardi di dollari nella ricerca e nello sviluppo dell’AI negli ultimi 4 anni. Sono stati poi istituiti il Korea AI Research Institute e il Korea Institute for Artificial Intelligence per coordinare e promuovere la ricerca e lo sviluppo. Anche il settore privato è stato coinvolto attivamente: colossi come Samsung, LG e Naver, che hanno investito molto nella ricerca e nello sviluppo dell’AI. Queste aziende si stanno concentrando sullo sviluppo di applicazioni e servizi basati sull’AI in settori quali la sanità, la finanza e la vendita al dettaglio. Oltre a queste grandi aziende, c’è anche una galassia in espansione di startup attive nel settore. La Corea del Sud è una potenza anche nello sviluppo della robotica alimentata dall’intelligenza artificiale, in particolare nel campo dei robot di servizio, che si prevede svolgeranno un ruolo importante nell’invecchiamento della popolazione.
Finora, la relazione tra Seul e Pechino è stata non solo di competizione ma anche di partnership. I due paesi asiatici hanno collaborato a una serie di iniziative sull’AI. Ad esempio, il Korea Advanced Institute of Science and Technology e la cinese Tsinghua University sono legate da un memorandum d’intesa per collaborare nella ricerca e nello sviluppo dell’AI, con particolare attenzione ad aree quali l’elaborazione del linguaggio naturale, la computer vision e la robotica. Inoltre, diverse aziende coreane, come Samsung e SK Telecom, hanno aperto centri di ricerca e sviluppo nella Repubblica Popolare, avviando diverse collaborazioni con aziende e ricercatori cinesi.
Visti però gli ultimi sviluppi politici, geopolitici e strategici, è altamente probabile che la relazione assuma tratti di maggiore rivalità. Con l’arrivo del Presidente conservatore Yoon Suk-yeol, ma soprattutto dopo la recente escalation di tensioni con la Corea del Nord e gli effetti collaterali della guerra in Ucraina, Seul ha molto rafforzato i rapporti con gli Usa. Sia sul fronte militare sia su quello tecnologico, che ormai sono ritenuti entrambi cruciali e sempre più intrecciati. Nonostante le perplessità, la Corea del Sud è entrata nella cosiddetta Chip 4, un’alleanza sulla produzione di semiconduttori che include anche Giappone e Taiwan, con l’obiettivo di ridurre l’accesso cinese alle tecnologie più avanzate. Lo stesso sta accadendo anche sul fronte dell’intelligenza artificiale. D’altronde, la tecnologia non è solo tecnologia.
Questo articolo è pubblicato anche sul numero di aprile/giugno di eastwest
Puoi acquistare la rivista sul sito o abbonarti
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Fino a due mesi fa ci avrebbero creduti in pochi. Un presidente sudcoreano a Tokyo. E un premier giapponese a Seul. Il tutto nel giro di meno di due mesi. E invece è successo, in un cerchio che si è completato con la visita di Fumio Kishida in Corea del Sud tra domenica e lunedì, dopo il precedente viaggio di Yoon Suk-yeol in Giappone a metà marzo. Una doppia visita che serve a rilanciare i rapporti tra i due ex litiganti asiatici, per la gioia degli Stati Uniti che vedono riallinearsi i due principali alleati regionali.
L’iniziativa, accelerata dalle conseguenze della guerra in Ucraina, nasce dal passo di Yoon di abbandonare la pretesa di risarcimenti per le vittime di abusi e lavori forzati durante l’era della dominazione coloniale nipponica. Una ferita sempre aperta che ha compromesso negli scorsi anni le relazioni bilaterali. “Il mio cuore sanguina per le sofferenze dei sudcoreani”, ha detto Kishida durante la conferenza stampa che ha fatto seguito al vertice con Yoon a Seul. Ma non sono arrivate scuse esplicite. “La nostra posizione è quella di mantenere tutte le nostre precedenti posizioni sul passato coloniale, compresa la dichiarazione del 1998”, ha detto Kishida, riferendosi a quella che viene accettata come una guida per legami più amichevoli che discute la “genuina riflessione del Giappone sul suo passato coloniale e le sue scuse sincere”.
Il presidente Yoon ha ribadito che Seul non “pretenderà unilateralmente” che Tokyo si scusi per le violazioni dei diritti, riferendosi alla decisione presa il 6 marzo scorso che prevede il risarcimento delle vittime coreane senza coinvolgere le aziende giapponesi ritenute responsabili di tali danni da una sentenza del tribunale coreano del 2018. Alle rispettive opposizioni interne non basta. Il Partito democratico sudcoreano protesta per quella che ritiene una “umiliante sottomissione” di Yoon di fronte al Giappone. Mentre le vittime annunciano nuovi ricorsi legali. Ai conservatori giapponesi invece non piace la parziale concessione di Kishida. Da una parte e dall’altra esistono dunque ancora delle resistenze al rilancio totale dei rapporti. Ma entrambi i leader hanno chiarito che “la situazione internazionale rende indispensabile la cooperazione tra Giappone e Corea del Sud”.
Nel vertice di domenica sono stati ribaditi gli accordi che erano già stati raggiungi a marzo a Tokyo. Tokyo ha revocato le restrizioni alle esportazioni utili alla produzione di microchip, settore cruciale dell’economia sudcoreana. Seul ha ritirato il reclamo del 2019 all’Organizzazione mondiale del commercio. Parola fine, dunque, su quasi 4 anni di guerra commerciale. Riavviato l’accordo per la condivisione delle informazioni di intelligence, mentre aumenteranno le esercitazioni militari congiunte. Kishida ha anche accettato di permettere a una delegazione di esperti nucleari sudcoreani di visitare l’impianto di Fukushima prima del rilascio delle acque considerate radioattive.
Due i punti particolarmente sensibili tra quelli toccati dai due leader. Il primo è il rafforzamento della catena di approvvigionamento dei semiconduttori, settore ritenuto cruciale nell’ambito della contesa tecnologica tra Stati Uniti e Cina. Il Giappone si è già allineato alle restrizioni e ai controlli alle esportazioni imposti da Washington, la Corea del Sud è stata invece sinora più scettica. Il secondo punto è quello della cooperazione militare. Yoon ha aperto al coinvolgimento del Giappone nell’accordo di cooperazione sul nucleare sottoscritto con Biden durante la recente visita di Stato alla Casa Bianca.
Proprio quella visita e i suoi riferimenti alla Cina e allo Stretto di Taiwan continuano a creare problemi nelle relazioni tra Seul e Pechino. Il Global Times, tabloid nazionalista cinese, si è scagliato contro l’ambasciata sudcoreana che ha inviato una lettera al quotidiano criticando la sua copertura della visita del presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol negli Stati Uniti. In un editoriale di lunedì, intitolato “Questo giornale ha qualcosa da dire sulla ‘protesta’ dell’ambasciata della Corea del Sud”, il Global Times si è definito indignato. La Cina ha anche avvisato Washington e Seul di non “provocare un confronto” con Kim Jong-un. Avvisaglia di nuove tensioni, visto che Pechino ha già fatto capire che come con la Russia in Ucraina ritiene che gli Usa stiano “gettando benzina sul fuoco” pregiudicando le “legittime preoccupazioni di sicurezza” di Pyongyang.
Il rafforzamento dei legami trilaterali Usa-Giappone-Corea del Sud rischia di provocare reazioni da parte della Corea del Nord, che da ormai un mese non risponde alle due telefonate quotidiane di collegamento, prassi in vigore sin dall’armistizio. E potrebbero presto arrivare altri passi sull’asse Washington-Tokyo-Seul. Kishida ha invitato Yoon a Hiroshima per un trilaterale con Biden a margine del summit del G7 ospitato dal Giappone tra il 19 e il 21 maggio.
Manovre che infastidiscono anche Mosca, soprattutto dopo che qualche settimana fa Yoon ha aperto all’invio diretto di aiuti militari all’Ucraina. Il ruolo della Corea del sud come esportatore nel settore della difesa è aumentato in modo esponenziale negli ultimi anni. Nel 2022 ha superato i 10 miliardi di dollari, più del triplo della cifra raccolta solo due anni prima.
Al di là dell’invio di armi o meno, ciò che è certo è che la guerra e il crescente allineamento (quantomeno a livello di percezione) tra Russia e Cina ha portato i due ex litiganti Giappone e Corea del Sud a mettere da parte (almeno per ora) le questioni storiche per rilanciare i rapporti. Kishida e Yoon vogliono persino dare un’immagine da amici. Domenica dopo il summit, hanno cenato insieme, con tanto di bevuta del “bomb shot” sudcoreano. Il Poktanju, un mix tra birra e soju, è stato reso celebre anche a livello globale dal successo dei K-Drama. Chissà se basterà a lenire in modo definitivo le antiche ferite. Senza aprirne di nuove.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Cruciale per l’economia, visto che attrae sempre più investimenti e linee produttive anche di grandi colossi tecnologici che tentano di diversificare l’esposizione alla Cina. Fondamentale anche a livello diplomatico, vista la sua centralità all’interno dell’ASEAN (l’Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico) e il ruolo che può giocare tra India, Giappone e soprattutto Cina, con cui ha ottimi rapporti commerciali e politici ma anche una disputa territoriale mai risolta sul mar Cinese meridionale.
Il Vietnam è sempre più al centro delle attenzioni degli Stati Uniti, che stanno cercando di migliorare i rapporti con un attore importante sullo scenario a cui tengono di più, quello dell’Asia-Pacifico.
Non a caso nei giorni scorsi si è svolta un’importante visita di Antony Blinken ad Hanoi. Un viaggio durato quasi 48 ore prima che il segretario di Stato americano si trasferisse a Nagano per la riunione dei ministri degli Esteri del G7, arrivato in un contesto nel quale Washington sta moltiplicando le manovre di avvicinamento.
Nelle scorse settimane una nave statunitense è transitata per le isole Paracelso, contese tra Vietnam e Cina, proprio mentre Lockheed Martin e Boeing si trovavano con altre aziende americane nel paese del Sud-Est asiatico per negoziare la vendita di droni ed elicotteri. Non solo. Il 29 marzo, Joe Biden ha avuto un colloquio telefonico col segretario del Partito comunista Nguyen Phu Trong. Mossa non così usuale, visto che di solito il Presidente americano parla con l’omologo vietnamita. Interessante anche il tempismo, visto che il colloquio è avvenuto in concomitanza del summit per la democrazia organizzato dalla Casa Bianca. I più maligni hanno sottolineato che un sistema politico non certo democratico possa alla fine andare bene a Biden qualora questo rientri in una sua strategia o calcolo. Come già accade peraltro con l’India.
La visita di Blinken è servita a porre le basi per l’elevazione dei rapporti, che dovrebbe avvenire a luglio. Dopo essere arrivato ad Hanoi venerdì, Blinken ha incontrato sabato il Segretario Generale del Partito Comunista Nguyen Phu Trong, il Primo Ministro Pham Minh Chinh e il Ministro degli Esteri Bui Thanh Son. Ha inoltre partecipato alla cerimonia di posa della prima pietra della nuova ambasciata statunitense. La sede diplomatica a stelle e strisce avrà otto piani, testimoniando anche plasticamente l’importanza accresciuta che il Vietnam ricopre per gli Usa. Il nuovo edificio sarà una delle ambasciate più costose degli Stati Uniti nel mondo.
“Dal nostro punto di vista, pensiamo che questo sia un momento propizio per elevare la nostra partnership esistente”, ha detto Blinken. “Abbiamo incaricato le agenzie competenti di coordinarsi con gli Stati Uniti per considerare, dire e fare, nello spirito di elevare il partenariato tra i due Paesi a nuovi livelli”, ha risposto Chin.
Dalla firma del partenariato globale Usa-Vietnam nel 2013, i due paesi hanno ampiamente aumentato i legami politici, economici e di difesa. Blinken ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno ultimando il trasferimento di un terzo cutter della guardia costiera al Vietnam, che andrà ad aggiungersi alle 24 motovedette statunitensi fornite dal 2016.
Ma ora si vuole fare un passo in più. L’idea degli Stati Uniti è quella di elevare i rapporti fino a un partenariato di sicurezza, aumentando i rapporti in materia di difesa. Una possibilità che sembra diventata concreta negli ultimi tempi, vista la difficoltà del Vietnam a reperire importazioni di dispositivi di difesa e componenti militari dalla Russia, il tradizionale fornitore di Hanoi coinvolto nella guerra in Ucraina. Secondo gli esperti, la dipendenza del Vietnam dagli armamenti russi obsoleti sta erodendo la preparazione militare del Paese. E così gli Stati Uniti, in qualità di maggiore esportatore di armi al mondo, vorrebbero conquistare una quota maggiore del mercato della difesa vietnamita e rafforzare così i legami con un attore chiave dello scenario indo-pacifico, estendendo l’influenza che nel Sud-Est asiatico è stata di recente riaffermata con le Filippine tra l’accordo di accesso a 4 nuove basi militari di Manila e le vaste esercitazioni congiunte in svolgimento sino al 28 aprile.
Se l’elevazione dei rapporti diplomatici è vista favorevolmente e rappresenta soprattutto una mossa simbolica, quella sul fronte della sicurezza incontra maggiori resistenze ad Hanoi.
Il Vietnam sa che la Cina interpreterebbe la decisione come una mossa a lei ostile. E così Hanoi sta provando a capire come ottenere quello che vuole anche sul fronte della difesa senza però legarsi ad accordi o iniziative che possano far sembrare che si stia posizionando all’interno di una contesa della quale non vuole fare parte.
La presenza americana è già sempre più evidente a livello commerciale. Molte grandi imprese statunitensi stanno espandendo la loro presenza in Vietnam, a partire dalla Apple che qui fabbricherà almeno in parte i suoi MacBook. Un segnale fondamentale, che chiarisce come a spostarsi non sono solo industrie manifatturiere di medio basso valore, ma anche colossi dell’alta tecnologia.
Il passaggio simbolicamente più significativo dei prossimi mesi potrebbe però essere la visita a Washington di Trong. Blinken ha ribadito l’invito già fatto al telefono da Biden e la diplomazia vietnamita è al lavoro per trovare l’incastro giusto. Ospitare Trong, che nel 2021 ha iniziato uno storico terzo mandato in anticipo di quasi due anni su Xi Jinping, sarebbe un segnale indiretto anche alla Cina: gli Usa possono accettare anche sistemi politici molto diversi dal loro, qualora l’interlocutore non sia un contendente per la leadership globale.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Alla fine è successo. La Cina ha lanciato nuove esercitazioni militari intorno a Taiwan. Quasi 48 ore di silenzio, dopo l’incontro in California fra la presidente taiwanese Tsai Ing-wen e lo speaker del Congresso degli Stati Uniti, Kevin McCarthy. Poi, appena ripartito da Pechino il Presidente francese Emmanuel Macron, i motori di jet e navi da guerra dell’Esercito popolare di liberazione sono tornati a rombare. Eppure non è stato tutto come lo scorso agosto, dopo la visita a Taipei di Nancy Pelosi. Né il prima, né il durante. Il livello di retorica ultranazionalista sui media di Stato e social cinesi è stata molto meno aggressiva rispetto ad agosto 2022. Soprattutto, stavolta si è concentrata soprattutto sulla figura di Tsai o comunque del Partito progressista democratico (DPP). Contestualmente, è stato invece più volte citato il Kuomintang (KMT) come entità politica dialogante. A contribuire alla divisione, la storica visita in Cina continentale dell’ex Presidente Ma Ying-jeou.
Anche sul fronte militare sono numerose le differenze da quanto accaduto post Pelosi. Primo: la durata. Allora le esercitazioni erano durate 7 giorni, anche se inizialmente dovevano durare 4. Questa volta è stato invece mantenuto il termine annunciato di 3 giorni. Secondo: l’impatto concreto. A differenza della scorsa estate, nessuna conseguenza rilevante segnalata per le navigazioni commerciali e i voli di linea. Terzo: l’estensione delle operazioni, che stavolta è apparsa minore. Nell’ultimo giorno di test si è segnalato il numero più alto di incursioni di jet oltre la “linea mediana”, confine non ufficiale e non riconosciuto ma ampiamente rispettato sino all’anno scorso: 56 jet. Ad agosto, nel solo secondo giorno si erano registrati 68 aerei e anche 13 navi da guerra oltre la linea mediana. Comunque mai, almeno finora, entro le 12 miglia nautiche delle acque territoriali. Una ventina di imbarcazioni delle due marine si sono confrontate in concomitanza delle 24 miglia nautiche che segnano l’ingresso nelle acque contigue, ma senza atti provocatori.
A Taipei la vita è proseguita come sempre, con ancora maggiore tranquillità rispetto allo scorso agosto. Questo anche per il mancato lancio di missili. Lo scorso agosto c’erano state diverse polemiche sul governo per l’assenza di allarme in concomitanza del loro passaggio sullo Stretto. L’avviso era infatti arrivato dalle autorità giapponesi e non da quelle taiwanesi.
Fatto salvo tutto questo, c’è però da segnalare come vera novità l’impiego nei test della portaerei Shandong, che nei giorni scorsi è stata per la prima volta dislocata nel Pacifico orientale. Da qui è servita come trampolino per i test che hanno simulato attacchi contro “obiettivi chiave” sull’isola, nonché un parziale blocco navale sulla costa orientale. Un avviso anche o forse soprattutto agli Stati Uniti, visto che proprio quella sarebbe l’unica strada possibile per fornire aiuti a Taiwan dall’esterno.
Altra novità: la mobilitazione di aerei da combattimento da parte del Giappone in risposta alle manovre di Pechino, giunte in un’area compresa tra 230 e 430 chilometri a sud dell’isola giapponese di Miyako, a sud ovest Okinawa e a poca distanza dall’isola principale di Taiwan.
Insomma, la reazione di Xi Jinping è stata sì muscolare ma più circoscritta e meno imponente di quella dello scorso agosto. Hanno influito una serie di componenti. La prima, intrastretto: a gennaio 2024 ci sono le elezioni presidenziali taiwanesi e il leader cinese sa che mostrando troppo i muscoli rischia di aiutare il DPP, che si presenterà peraltro al voto con William Lai, attuale vicepresidente e figura più radicale di Tsai. La seconda, contingente: l’incontro fra Tsai e McCarthy è stato un parziale compromesso di Taipei e Washington, perché un incontro sull’isola sarebbe stato percepito come maggiormente provocatorio. Rispondere con un’ulteriore escalation avrebbe dato il messaggio che non serve a nulla provare a tenere un profilo più basso. La terza, globale: Xi sta proiettando un’immagine di grande stabilizzatore negli ultimi tempi. Dal rilancio dei rapporti tra Iran e Arabia Saudita favorito da Pechino alla manovra sulla guerra in Ucraina, il leader cinese non vuole compromettere la sua ampia manovra diplomatica e il riavvicinamento con l’Europa. I primi risultati li ha ottenuti con Macron, che dopo essere tornato a Parigi ha chiesto all’Europa di non diventare un “vassallo” degli Stati Uniti. Musica per le orecchie di Xi.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
“Alcune restrizioni sui semiconduttori imposte dagli Stati Uniti sono inaccettabili”. Oppure: “I divieti americani sono un favore per i produttori di chip cinesi e uno svantaggio per noi”. E ancora: “Sappiamo dall’inizio che le manovre degli Stati Uniti sui semiconduttori non sono giuste o buone per noi. Ma è difficile riuscire a dirlo esplicitamente”. Negli ultimi giorni è diventato esplicito qualcosa che era rimasto implicito per lungo tempo, anche se ben noto a chi ha contatti col settore: ai colossi taiwanesi dei microchip non piacciono per niente le iniziative della Casa Bianca sui semiconduttori.
Le tre dichiarazioni riportate all’inizio sono state rese tutte nel corso dell’ultima settimana, nell’ordine da: Mark Liu, amministratore delegato della Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), Tsai Ming-kai (presidente di Mediatek) e infine Frank Huang, fondatore e capo di Powerchip (PSMC). Tutti e tre hanno parlato proprio mentre la presidente taiwanese Tsai Ing-wen si trova in viaggio in America centrale, con un doppio scalo negli Stati Uniti tra New York e la California.
La presa di posizione potenzialmente più rilevante è quella di Liu, visto che TSMC pesa da sola oltre il 50% dello share globale del comparto di fabbricazione e assemblaggio. Non solo, il colosso di Hsinchu sta anche costruendo due stabilimenti in Arizona. Secondo quanto detto dal braccio destro del fondatore Morris Chang durante l’assemblea dei membri della Taiwan Semiconductor Industry Association, alcune restrizioni e regolamenti supplementari previsti dal CHIPS and Science Act degli Stati Uniti sono “inaccettabili” e potrebbero dissuadere potenziali partner dal richiedere la sovvenzione. Per ricevere i fondi del CHIPS Act, le aziende produttrici di chip devono accettare di non espandere la capacità produttiva in “paesi stranieri di interesse”: in primis la Repubblica Popolare Cinese. Ciò significa che per un decennio le aziende coinvolte nel programma non possono impegnarsi in attività di ricerca congiunte o di licenza che coinvolgano tecnologie sensibili. Non un grande favore ad aziende taiwanesi e sudcoreane, da tempo attive in Cina continentale. Proprio per questo, Taipei e Seul sembrano meno convinte del Giappone a seguire le restrizioni anticinesi volute da Washington. Liu ha spiegato che dovranno essere condotti ulteriori negoziati con gli Stati Uniti affinché le attività delle aziende taiwanesi come TSMC non subiscano ripercussioni negative.
Ancora più negativo Tsai di Mediatek, altro colosso taiwanese del comparto. “I controlli sulle esportazioni degli Stati Uniti contro il settore dei chip avanzati della Cina nell’ottobre dello scorso anno hanno spinto i fondi del governo cinese a confluire nel settore della tecnologia dei chip maturi, e crediamo che le piccole e medie aziende di progettazione di chip di Taiwan saranno probabilmente le prime ad essere colpite”, ha dichiarato Tsai allo stesso evento in cui ha parlato Liu. “In questo momento, l’industria taiwanese della progettazione di circuiti integrati si trova ad affrontare preoccupazioni nascoste, come la rapida ascesa degli operatori cinesi, la grave carenza di talenti nazionali e i pochi operatori che investono in tecnologie/prodotti avanzati, ed è urgente intraprendere azioni attive per consolidare l’attuale vantaggio competitivo e la posizione di mercato”, ha aggiunto Tsai.
Del mancato gradimento per le politiche statunitensi ha parlato anche Huang di Powerchip. “Il rapporto con gli Usa è vitale, ma la Cina è il nostro mercato principale. Spediamo più chip lì che in qualsiasi altro posto. Gli Usa vogliono disperatamente controllare l’industria e la nostra tecnologia. Ma Taiwan è Taiwan, non fa parte degli Stati Uniti”, ha detto Huang in un’intervista a La Stampa. Vogliamo mantenere la nostra democrazia, ma non siamo nemici della Cina e vogliamo continuare a farci affari”.
Gli scricchiolii nell’alleanza sui chip a guida americana sono molto significativi, anche perché arrivano dallo snodo cruciale per la fabbricazione e assemblaggio. Le aziende taiwanesi controllano oltre il 65% dello share globale del comparto di fabbricazione e assemblaggio dei semiconduttori. Il dominio è ancora più esteso dal punto di vista qualitativo: i produttori taiwanesi detengono il 92% della manifattura di chip sotto i dieci nanometri. Praticamente la totalità di questi se si aggiungono quelli sudcoreani. Anche gli operatori di Seul, tra cui Samsung e SK, non sono per niente entusiasti delle restrizioni statunitensi, anche perché non si accompagnano a un sostegno concreto nei loro confronti. Anzi, la sensazione diffusa anche se per ora rimane più sottotraccia, è che dalle parti di Washington si punti a entrare in possesso di informazioni sensibili su linee produttive e clienti, perseguendo un’autosufficienza tecnologica che nel settore dei chip rischia di essere, Morris Chang docet, un “esercizio futile”. Ma compiendolo, si rischia intanto di far traballare la globalizzazione e scalfire il cosiddetto “scudo di silicio” di Taiwan.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Una scelta tra guerra e pace. All’alba della lunga campagna elettorale. Ma Ying-jeou ha descritto così le presidenziali taiwanesi del gennaio 2024. L’ex presidente, in carica dal 2008 al 2016, è ancora una voce molto influente all’interno del Kuomintang (KMT), il principale partito di opposizione. E a breve diventerà il primo leader o ex leader della Repubblica di Cina (Taiwan) a visitare la Cina continentale dopo il 1949 e la fine della guerra civile. L’annuncio, arrivato domenica sera, ha colto di sorpresa fino a un certo punto. Ma è stato anche l’unico presidente taiwanese in carica a incontrare un omologo della Repubblica Popolare Cinese, nello storico incontro con Xi Jinping andato in scena a Singapore nel 2015. Stavolta non dovrebbe incontrare Xi, ma il tempismo del suo viaggio è molto rilevante, visto che avverrà in perfetta concomitanza con il doppio scalo dell’attuale presidente Tsai Ing-wen negli Stati Uniti.
L’ufficio della fondazione guidata da Ma ha dichiarato che l’ex presidente visiterà 5 città della Repubblica Popolare: Nanchino, Wuhan, Changsha, Chongqing e Shanghai. Niente Pechino dunque, con Ma che dovrebbe restare nella zona centrale del territorio cinese. Secondo il programma ufficiale, incontrerà degli studenti e visiterà i siti legati alla Seconda Guerra Mondiale e al conflitto della Cina con il Giappone. Dovrebbe visitare anche luoghi significativi della rivoluzione del 1911 che ha rovesciato l’ultimo imperatore Pu Yi e ha inaugurato la Repubblica di Cina, ancora oggi il nome ufficiale con cui Taiwan è indipendente de facto. C’è anche un forte risvolto privato, visto che Ma dovrebbe rendere omaggio alle tombe dei suoi antenati, in concomitanza della festività dei morti che tra Cina e Taiwan cade proprio a inizio aprile.
L’ufficio di Ma non ha comunque escluso incontri con funzionari di Pechino, a seconda degli inviti “dell’ospitante”. Secondo quanto risulta a Eastwest, è tutt’altro che escluso che Ma possa incontrare ufficiali di alto livello di Pechino. Non nella capitale, ma durante il suo tour e in particolare a Shanghai. Si fa il nome di Wang Huning, numero tre della gerarchia del Partito e appena nominato presidente della Conferenza politica consultiva del popolo durante le “due sessioni”. Non solo. Wang, considerato l’ideologo del “sogno cinese”, ha le deleghe sul dossier taiwanese e secondo Nikkei sarebbe stato persino incaricato di trovare un nuova cornice retorica per l’ipotetica “riunificazione” (o “unificazione” come la chiamano a Taipei). Possibile anche un incontro con Song Tao, da poco direttore dell’Ufficio per gli Affari di Taiwan di Pechino.
Ma il tempismo della visita è molto particolare. L’ex presidente sarà dall’altra parte dello Stretto tra il 27 marzo e il 7 aprile, coprendo entrambi i passaggi negli Usa di Tsai, attesa il 30 marzo a New York e qualche giorno dopo in California per un incontro con lo speaker Kevin McCarthy. L’Ufficio presidenziale di Taiwan ha dichiarato di essere stato informato e di “rispettare” i piani di Ma, notando che il viaggio coincide con un “momento delicato” e auspicando che Ma “dimostri i valori di democrazia e libertà di Taiwan” durante il suo viaggio. I ranghi inferiori del Partito progressista democratico (DPP) al potere criticano più esplicitamente: “L’ex presidente Ma ignora totalmente il fatto che il Partito comunista ha continuato ad aumentare la pressione contro di noi, intensificando le minacce militari e isolandoci a livello internazionale”, ha dichiarato il portavoce del partito Chang Chih-hao. Il DPP teme che Ma possa sottrarre attenzione al doppio scalo di Tsai, ma soprattutto utilizzerà la visita come la presunta dimostrazione che il KMT voglia chiudere accordi politici con Pechino qualora torni al potere. Così come è stato fatto il mese scorso quando l’attuale vicepresidente del principale partito di opposizione aveva guidato un’altra delegazione in Cina continentale.
La prospettiva di Ma, che durante i suoi otto anni di presidenza operò una storica distensione dei rapporti con l’altra sponda firmando diversi accordi commerciali, è diversa: “Ritiene che negli ultimi anni le due parti siano entrate in uno stato di gelo. Se i giovani riusciranno a comunicare e a dialogare, le tensioni attuali si ridurranno”, ha spiegato Hsiao Hsu-tsen, direttore esecutivo della Fondazione Ma Ying-jeou, annunciando la visita. “Invece di acquistare altre armi, sarebbe meglio aumentare gli scambi tra i giovani delle due sponde dello Stretto di Taiwan”, ha aggiunto.
I due partiti principali di Taiwan sono d’altronde avviati verso la campagna elettorale vera e propria. Dopo la batosta subita dal DPP alle elezioni locali dello scorso novembre, Tsai si avvia verso l’ultimo anno in carica. Non potendosi candidare per un terzo mandato, lascerà spazio con ogni probabilità al vicepresidente William Lai, che ha posizioni tradizionalmente ben più radicali di quella della moderata Tsai. Quest’ultima ha sempre sostenuto la cosiddetta “teoria dei due Stati”, che diniega il consenso del 1992 e dunque l’appartenenza di entrambe le entità a una “unica Cina”, ma non si è mai espressa a favore di un’indipendenza formale di Taipei come Repubblica di Taiwan. Al contrario di Lai, che ora ha smussato le sue posizioni ma resta particolarmente inviso a Pechino. Il KMT riconosce invece ancora il consenso del 1992, che ritiene sancire l’esistenza di una “unica Cina ma con diverse interpretazioni”, visto che non veniva stabilito quale fosse quella legittima. Artificio semantico che ha tenuto in piedi lo status quo e rende il KMT l’opzione favorita da Pechino.
Il KMT ha però difficoltà nell’individuazione del suo candidato. La scelta preferita sarebbe quella del sindaco di Nuova Taipei Hou You-ih, ex poliziotto molto popolare ma senza esperienza e statura internazionale. Ma il presidente del partito Eric Chu, già sconfitto da Tsai alle elezioni del 2016, sembra volerci provare. Pechino, dal canto suo, sa che prima delle elezioni le converrebbe tenere un basso profilo. La postura muscolare del 2019 (prima del voto del gennaio 2020), combinata al caos di Hong Kong, spostò il focus del voto taiwanese sulla questione identitaria e dei rapporti intrastretto. Terreno su cui il DPP ha un più ampio consenso, soprattutto tra le generazioni più giovani che sono meno inclini al dialogo con Pechino. Anche in tal senso può essere letto il viaggio di Ma, come un assist a Xi Jinping per non avere una reazione troppo aggressiva al doppio scalo di Tsai negli Usa. La prima storica visita di un ex presidente taiwanese può infatti essere utilizzata dal Partito comunista per mostrare ipotetici passi avanti sulla strada della “riunificazione”.
Certo, un’ipotetica seconda visita di Tsai specifica negli Usa tra agosto e novembre metterebbe Pechino spalle al muro, costringendola a una reazione muscolare che potrebbe favorire il DPP alle urne. Comunque vadano le elezioni, dopo il voto la Repubblica Popolare potrebbe aumentare il pressing. Militare in caso di vittoria del DPP. Politico in caso di vittoria del KMT.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
L’ultimo giorno dell’appuntamento più importante del quinquennio, con le plenarie dell’Assemblea nazionale del popolo e della Conferenza politica consultiva del popolo, ha avuto come momento clou il discorso di Xi, bissato poi dalla prima conferenza stampa in veste di premier del suo fedelissimo Li Qiang.
In linea con la più classica delle strategie “poliziotto buono e poliziotto cattivo”, Xi e Li si sono divisi i compiti tra assertività e rassicurazioni. Normale che sia così, viste anche le diverse modalità dei due interventi e gli opposti momenti della loro espressione di potere. Al culmine, quella del segretario generale del Partito comunista appena confermato per un terzo storico mandato da Presidente della Repubblica popolare. Ai suoi primi bagliori invece, quella del nuovo Primo ministro, chiamato dunque a “farsi conoscere” a livello globale e soprattutto dal mondo imprenditoriale, visti i tradizionali compiti nelle politiche economiche richiesti dal suo ruolo.
Le prime due parole chiave del discorso finale di Xi sono sicurezza e stabilità. “La sicurezza è il fondamento dello sviluppo, mentre la stabilità è un prerequisito per la prosperità”, ha detto Xi ripetendo due dei mantra che hanno caratterizzato già il suo secondo mandato. Il presidente ha sottolineato la necessità di perseguire un approccio olistico alla sicurezza nazionale, ampio ombrello sotto il quale Pechino fa ricadere non solo il settore della difesa, ma anche la sicurezza sanitaria, alimentare e sociale.
L’apparato governativo di sicurezza è stato confermato in toto, con la permanenza del fidato Chen Yixin come ministro della Sicurezza di Stato. Un alleato chiave di Xi, in particolare per le campagne anticorruzione degli ultimi anni.
Per quanto riguarda la “stabilità”, è un termine che è tornato moltissimo anche nell’ultimo discorso di governo del premier uscente Li Keqiang, che non a caso ha presentato un obiettivo di crescita del prodotto interno lordo più basso del previsto per il 2023: +5%. La Cina ha scelto la cautela, conscia delle difficoltà e turbolenze globali che rendono difficile il mantenimento di una crescita stabile.
Un’altra delle priorità individuate dal leader è quella dell’autosufficienza tecnologica. Un tema molto caro a Xi, sin dai tempi del Made in China 2025 e ancora di più ora che gli Stati Uniti stanno accelerando la corsa alle restrizioni per impedire le esportazioni di tecnologia avanzata verso Pechino, soprattutto quella relativa al settore strategico dei semiconduttori. Non è un caso che i fondi speciali a sostegno dello sviluppo dei microchip e di altre industrie strategiche siano stati aumentati di quasi il 50%.
Xi ha invitato ad “attuare pienamente la strategia per rinvigorire la Cina attraverso la scienza e l’istruzione, la strategia per lo sviluppo della forza lavoro e la strategia per lo sviluppo guidato dall’innovazione. La Cina dovrebbe lavorare per raggiungere una maggiore autosufficienza e forza nella scienza e nella tecnologia, promuovere la trasformazione e l’aggiornamento industriale, far progredire lo sviluppo urbano-rurale e regionale coordinato e promuovere uno sviluppo economico e sociale verde e a basse emissioni di carbonio”, ha affermato Xi.
In direzione di una gestione più diretta delle politiche sul settore tecnologico va la riforma dell’apparato statale approvata durante le “due sessioni”. Verrà infatti istituita anche una Commissione centrale per la scienza e la tecnologia “per rafforzare la leadership centralizzata e unificata del Comitato Centrale del Partito”. Il nuovo organo sarà responsabile del coordinamento delle politiche atte a perseguire l’autosufficienza tecnologica, una delle priorità assolute. Il Partito, che dallo scorso ottobre ha tra le sue figure apicali sempre più tecnocrati, punta a guidare in modo più deciso l’attività delle entità statali e private per colmare il ritardo sui semiconduttori e puntellare il vantaggio raggranellato in altri settori come l’intelligenza artificiale.
Obiettivo che si intreccia con quello dell’ammodernamento delle forze armate.
Sul fronte militare, la necessità è “rafforzare gli aspetti scientifici e tecnologici della difesa per un esercito forte e per vincere guerre”, ha detto Xi durante il suo discorso di lunedì 6 marzo di fronte all’organo consultivo.
Affermazioni che vanno lette insieme a quelle di lunedì 13 marzo in cui si invita l’Esercito popolare di liberazione a diventare una “Grande muraglia d’acciaio” (formula già utilizzata durante il suo discorso del 1° luglio 2021 in occasione del centenario del Partito) in gradio di “salvaguardare con efficacia la sovranità nazionale, la sicurezza e gli interessi di sviluppo”. Obiettivo sul quale si punta con decisione in vista del centenario della fondazione delle forze armate della Repubblica popolare, in agenda proprio nel 2027 in concomitanza col XXI Congresso che potrebbe consegnare a Xi un quarto mandato.
Negli anni che ci separano da quella data, Xi ha confermato che un’altra delle priorità sarà compiere passi avanti verso la “riunificazione” con Taiwan. Nessuna novità normativa su Taipei, né elementi di discontinuità nei discorsi di Xi e Li. Eppure, con l’emendamento che prevede l’approvazione lampo di leggi in “tempi d’emergenza” e alcune nomine, a partire da quella del generale He Weidong (con grande esperienza sul campo nello Stretto) a vicepresidente della Commissione militare centrale, si lascia intendere che il dossier sarà studiato con attenzione.
Anche perché la visione sui rapporti bilaterali con gli Stati Uniti è sempre più negativa, come dimostrato ampiamente dalla prima conferenza stampa del neo ministro degli Esteri Qin Gang, fresco ex ambasciatore cinese a Washington. A complicare il dialogo nel settore della Difesa, peraltro, potrebbe esserci anche la nomina di Li Shangfu come nuovo ministro della Difesa. Generale dell’esercito, Li è dal 2018 sotto sanzioni degli Stati Uniti per il suo ruolo nell’acquisto di aerei da combattimento SU-35 e di sistemi missilistici antiaerei S-400 dalla Russia.
In tal senso, a Li Qiang è stato destinato il ruolo di pontiere. “Cina e Usa devono cooperare e non separare le loro economie”, ha detto il premier. “Negli ultimi anni, alcune persone negli Stati Uniti vogliono il decoupling. Ma chi se ne avvantaggerà? Pechino e Washington devono collaborare”, ha ribadito. “Il contenimento e la repressione non giovano a nessuno”.
Una lettura che alimenta la prospettiva di Pechino, già espressa diverse volte, secondo cui a Washington ci sarebbe chi vuole sabotare il riavvio del dialogo sul quale avevano invece trovato un “consenso” Xi e Joe Biden. Prospettiva utilizzata per spiegare la visita di Nancy Pelosi a Taipei dello scorso agosto, così come la reazione giudicata “eccessiva” alla vicenda del presunto pallone-spia che ha portato alla cancellazione della visita del Segretario di Stato Antony Blinken a Pechino.
Dopo di che, Li ha provato a rassicurare investitori e privati garantendo che la Cina continuerà sulla strada delle riforme e dell’apertura internazionale. Non è detto che basti, considerando anche il potenziale ulteriore accentramento della gestione delle politiche economiche con la prossima annunciata istituzione di una Amministrazione nazionale di regolamentazione finanziaria, che sarà responsabile di tutti i tipi di politiche e attività finanziarie con esclusione del settore dei titoli. Tra le varie priorità della Cina di Xi ce n’è infatti anche un’altra: decidere in fretta.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Se i semiconduttori sono il petrolio del futuro, questo petrolio scorre soprattutto in Asia orientale. In particolare tra Taiwan e Corea del Sud. Entrambe al centro di tensioni diplomatiche e geopolitiche, entrambe destinatarie di pressioni politiche. Sia Taipei sia Seul hanno rinviato il più in là possibile il momento in cui sarebbero state costrette a operare una scelta di campo. Ma quel momento sembra essere ormai arrivato, con gli Stati Uniti che col passaggio da Donald Trump a Joe Biden non hanno solo mantenuto, bensì intensificato, le manovre per provare a isolare la Repubblica Popolare Cinese nel mercato strategico dei microchip. Il divieto alle esportazioni verso Huawei imposto nel 2020 alla Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, comunemente nota come TSMC, erano solo l’inizio di un processo che si è inasprito negli scorsi mesi e ha acquisito velocità dopo la guerra in Ucraina. I semiconduttori non servono solo a far funzionare computer e smartphone, ma anche armi e mezzi militari. La carenza di chip riscontrata durante le prime fasi della pandemia di Covid-19 e l’invasione russa hanno accelerato la presa di coscienza globale, in primis delle grandi potenze, di quanto sia cruciale il controllo del settore. Ed ecco che i colossi taiwanesi e sudcoreani sono entrati sempre di più nei radar strategici della Casa Bianca e non solo.
D’altronde la dipendenza globale da Taipei e Seul è enorme, pur in un settore composto da molteplici step che hanno origine negli Stati Uniti con il design e passano immancabilmente dai Paesi Bassi per la litografia ultravioletta della ASML. Le aziende taiwanesi controllano oltre il 65% dello share globale del comparto di fabbricazione e assemblaggio dei semiconduttori. La TSMC da sola pesa oltre il 50%. Il primo competitor è la sudcoreana Samsung col 16% del mercato. Il dominio è ancora più esteso dal punto di vista qualitativo: i produttori taiwanesi detengono il 92% della manifattura di chip sotto i dieci nanometri. Praticamente la totalità di questi se si aggiungono quelli sudcoreani.
Si tratta di un settore fondamentale sia per Taipei sia per Seul e sotto molteplici punti di vista. Innanzitutto economico. I semiconduttori rappresentano da soli il 15% del Pil taiwanese e sono il prodotto che più contribuisce alle esportazioni della Corea del Sud. E Pechino gioca un ruolo fondamentale in entrambi i casi. La Cina rappresenta d’altronde oltre un quarto della domanda annuale globale di apparecchiature per semiconduttori. Secondo le stime di Tony Phoo della banca Standard Chartered, circa il 60% dei chip prodotti da Taiwan viene venduto proprio sull’altra sponda dello Stretto. Circa il 45% della domanda di chip di memoria della Cina continentale è coperto da semiconduttori sudcoreani. Ma, per quanto importanti, non si tratta solo di numeri. Mantenere aperto il flusso di microchip verso la Repubblica Popolare consente di non chiudere il flusso diplomatico, nel caso di Seul, e non cancellare una possibile leva nei rapporti bilaterali, nel caso di Taipei.
Sia la TSMC sia Samsung sono state coinvolte in investimenti faraonici negli Stati Uniti. A inizio dicembre, il Presidente americano Joe Biden ha visitato lo stabilimento del colosso taiwanese in costruzione in Arizona. La TSMC ha peraltro annunciato che triplicherà gli investimenti negli Usa portandoli a sfiorare i 40 miliardi di dollari, con l’avvio dei lavori per un secondo stabilimento “gemello” che fabbricherà semiconduttori a 3 nanometri, la tecnologia più alta a disposizione in questo momento. L’impianto dovrebbe entrare in funzione nel 2024. La Samsung sta invece costruendo una fonderia in Texas. Durante la visita della scorsa primavera a Seul, il primo luogo in cui si è recato Biden è proprio il mega impianto dell’azienda sudcoreana dove si è tenuto un primo simbolico incontro con l’allora neo presidente Yoon Suk-yeol. L’altra sudcoreana SK Siltron è invece attiva nel Michigan. Nei mesi scorsi Chey Tae-won, presidente della casa madre SK Hynix, ha avuto un incontro virtuale con Biden per annunciare investimenti per 22 miliardi di dollari in semiconduttori, batterie per veicoli elettrici e tecnologie verdi negli Stati Uniti, tra cui un nuovo impianto di semiconduttori.
Sia Taiwan sia la Corea del Sud sono coinvolte nel programma Chip 4 lanciato dalla Casa Bianca e che coinvolge anche il Giappone. Il piano è stato citato più volte da Nancy Pelosi durante la sua contestata visita a Taipei, come esempio di cooperazione win-win tra Washington e Taiwan. Eppure, nella Repubblica di Cina (nome col quale Taiwan è indipendente de facto) sono in molti a storcere il naso di fronte al tentativo americano di portarsi in casa la produzione più avanzata di semiconduttori. Il timore è quello di perdere quel cosiddetto “scudo di silicio” che si ritiene possa fungere da potenziale (e molto parziale, c’è da dire) deterrente nei confronti di una possibile azione militare di Pechino. Non è un caso che la TSMC mantenga in attività una fonderia a Nanchino e ha interrotto le spedizioni di chip alla Tianjin Phytium Information Technology, una delle entità cinesi che stanno sviluppando i cosiddetti “supercomputer” con possibili applicazioni anche in campo militare, solo dopo che le è stato intimato dall’amministrazione Biden.
La funzione di quello “scudo di silicio” va vista anche al contrario: per molti taiwanesi rappresenta anche una parziale garanzia della volontà di Washington di difenderli, allo scopo di impedire che le fonderie della TSMC finiscano sotto il controllo del Partito Comunista Cinese. I produttori locali hanno sottolineato più volte che pensare di raggiungere l’autosufficienza sull’intero ciclo di produzione di semiconduttori è un “esercizio futile”. Taiwan ha costruito nel corso dei decenni un sistema integrato di ricerca, sviluppo e produzione che non può semplicemente essere trasferito altrove. Anche qualora ci fosse la volontà di farlo. Cosa che di certo non hanno le aziende. “Il confronto geopolitico sta distorcendo l’intero mercato”, ha lamentato di recente CC. Wei, amministratore delegato della TSMC. “La situazione ha distrutto tutta la produttività e l’efficienza portate dalla globalizzazione”, ha aggiunto Wei. “Queste barriere compromettono seriamente i benefici di un’economia libera. È una situazione davvero negativa”. Ma qualunque manager delle aziende di semiconduttori taiwanesi ripete: “Non vogliamo interrompere il rapporto commerciale con la Cina continentale”.
La stessa cosa succede in Corea del Sud. “Samsung e SK non vorrebbero mai il disaccoppiamento tecnologico con la Cina”, dice Hwang Jihwan, professore di relazioni internazionali alla University of Seoul. Eppure, entrambe le aziende hanno iniziato ad approntare piani di emergenza qualora fossero costrette a recidere quel cordone tecnologico e a chiudere gli stabilimenti che hanno attivi sul territorio cinese.
“La Corea del Sud ha avuto grandi benefici dall’ascesa economica cinese e non vorrebbe mai il disaccoppiamento economico. Ma se sarà costretta a scegliere, non potrà che scegliere di seguire Washington per i legami fondamentali anche e soprattutto in materia difensiva”, spiega Hwang. Un panorama ancora più concreto a Taiwan, dove l’amministrazione della Presidente Tsai Ing-wen non ha dialogo politico da oltre sei anni con Pechino e che, dopo le esercitazioni militari della scorsa estate, vede la tutela difensiva americana come ancora più fondamentale. La leva americana non è solo difensiva, ma anche tecnologica. Nessuno può produrre in massa chip all’avanguardia senza le attrezzature e la tecnologia statunitensi.
Eppure, la stessa Taipei preferirebbe non recidere quel legame. Anche perché in assenza di dialogo politico i colossi tecnologici svolgono il ruolo di ambasciatori. Qualche esempio? Nella primavera del 2021, quando una brillante eradicazione iniziale del Covid-19 aveva portato a un posticipo della campagna vaccinale taiwanese, furono proprio la TSMC e la Foxconn (uno dei principali fornitori di Apple e attiva con impianti giganteschi nella Repubblica Popolare) a sbloccare una pericolosa impasse (prima delle spedizioni di AstraZeneca soprattutto dal Giappone) acquistando su indicazione del governo dieci milioni di dosi di vaccini Pfizer da Fosun Pharma, azienda con sede a Shanghai che deteneva l’esclusiva per la distribuzione del siero anche su Taiwan. Sempre in rappresentanza del governo di Taipei, lo scorso novembre Morris Chang (fondatore della TSMC) ha partecipato al summit dell’APEC a Bangkok. Evento nel quale colui che viene considerato “l’imperatore dei chip” ha anche avuto un breve colloquio bilaterale col Presidente cinese Xi Jinping. L’incontro più rilevante tra rappresentanti delle due sponde dello Stretto dal 2015, quando andò in scena il primo e finora unico summit tra leader col vertice tra Xi e l’allora Presidente taiwanese Ma Ying-jeou a Singapore.
“Un decoupling completo è irrealistico”, ha ammesso a ottobre il vice ministro dell’Economia Chen Chern-chyi. I partiti di opposizione hanno espresso riserve sui piani americani della TSMC. La maggioranza ha provato a tranquillizzare minimizzando il numero degli ingegneri TSMC che andranno a lavorare negli Stati Uniti e in Giappone, dove è in costruzione un altro impianto del colosso. La ministra dell’Economia Wang Mei-hua ha affermato che la TSMC ha più di 50.000 ingegneri sull’isola e che quelli inviati all’estero fanno parte dei piani di espansione globale dell’azienda e non hanno nulla a che fare con la fuga dei cervelli. Il ministro degli Esteri Joseph Wu ha dovuto invece garantire che non ci sono “accordi segreti” con Washington che mettono a repentaglio la leadership taiwanese nel comparto dei semiconduttori. Non a caso è stato poi annunciato che a breve inizieranno i lavori di costruzione di un impianto di produzione di chip a 1 nanometro a Hsinchu, per ribadire che le tecnologie più avanzate resteranno a Taiwan.
Anche la Corea del Sud pesa con attenzione le sue mosse. Fino a qualche tempo fa aveva sempre cercato di mantenersi in equilibrio tra Washington e Pechino, complice anche la presidenza di Moon Jae-in che, cercando con insistenza il riavvio del dialogo con la Corea del Nord, aveva bisogno della mediazione cinese. Il passaggio di consegne al conservatore Yoon, fautore di una linea meno conciliante, ma soprattutto la rottura operata già a fine 2019 da Kim Jong-un e gli effetti collaterali della guerra in Ucraina hanno portato Seul a compiere passi importanti e forse decisivi in direzione degli Usa. Pechino non ha per ora alzato il tiro sulla Corea del Sud come ha invece fatto col Giappone, già da tempo ormai completamente allineato a Washington e in aperta fase di riarmo e superamento della costituzione pacifista impostagli dall’attuale alleato dopo la Seconda guerra mondiale. Ma la “giapponesizzazione” della postura sudcoreana può portare a un inasprimento delle frizioni con la Cina. Cosa che senz’altro succederebbe nel caso in cui da Seul non arrivassero più microchip. Pechino sta provando a evitarlo e negli scorsi mesi ha anche annunciato un fondo e condizioni agevolate per la cooperazione in materia di semiconduttori aperto anche alle aziende sudcoreane.
Persino in Giappone, che sembra essere l’elemento più convinto a seguire la strategia a stelle strisce, c’è qualche perplessità sulle misure della Casa Bianca in materia di semiconduttori e sulle loro conseguenze sull’economia nazionale: le apparecchiature per la produzione di chip sono la seconda fonte di esportazione di Tokyo, e un terzo di esse è destinato proprio alla Cina. Gli Usa sembrano però aver ormai optato per il confronto totale, quantomeno sul fronte dei semiconduttori. E ai partner asiatici, se e quando arriverà il momento di una scelta definitiva, non resterà che seguire. “La globalizzazione e il libero commercio sono quasi morti”, ha amaramente dichiarato Morris Chang, proprio dall’Arizona dopo aver incontrato Biden. Il dado, pardon, il chip sembra proprio tratto.
Questo articolo è pubblicato anche sul numero di gennaio/marzo di eastwest
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Definirlo astro nascente in questo caso non è un’esagerazione. Vo Van Thuong ha “solo” 52 anni ed è il membro più giovane del Politburo del Partito comunista del Vietnam, anche se ha cominciato la sua carriera giovanissimo nelle organizzazioni giovanili. Non solo. Da qualche giorno è anche il Presidente del Paese del Sud-Est asiatico.
In una sessione straordinaria, l’Assemblea nazionale vietnamita ha eletto Thuong alla presidenza. Un finale scontato dopo l’indicazione in tal senso arrivata dal Partito comunista, ma che di fatto cambia i connotati della politica vietnamita nel giro di qualche settimana. Tutto nasce infatti dalle dimissioni “guidate” di Nguyen Xuan Phuc, l’ex Presidente lambito da un’inchiesta anticorruzione nell’ambito del nuovo impulso alla campagna della “fornace ardente” lanciata da Nguyen Phu Trong, il segretario generale del Partito. Un regolamento di conti, con Trong che ha portato all’autoesclusione di uno di quelli che era considerato un suo potenziale erede. L’anziano leader, che è nel corso del suo terzo mandato dopo la non osservazione della prassi dei due mandati inaugurata negli anni Ottanta da Le Duan (un po’ come fatto da Xi Jinping in Cina), ha invece in Thuong il suo pupillo.
Il ruolo di presidente è in gran parte cerimoniale ma è comunque uno dei cosiddetti “quattro pilastri” del sistema politico vietnamita insieme a segretario generale del Partito, premier e presidente dell’Assemblea nazionale. Con la nomina del 52enne, ora Trong ha alleati fidati in tutte le posizioni apicali. Nel suo primo discorso al parlamento in qualità di nuovo Presidente, Thuong ha dichiarato che continuerà “risolutamente” la lotta alla corruzione.
Diplomatici e uomini d’affari hanno espresso preoccupazione per la campagna anticorruzione che ha paralizzato molte transazioni di routine in Vietnam, poiché i funzionari temono di essere coinvolti nella repressione. Ma la nomina di Thuong, al di là delle dinamiche interne al Partito e alla concentrazione di potere nelle mani del segretario generale, non dispiace agli investitori: questo perché pone fine a una parentesi di incertezza che aveva fatto seguito alle dimissioni di Phuc, col timore che si sarebbe potuta scatenare una lotta di potere tra diverse fazioni del Partito.
Thuong significa invece continuità, visto che come Trong il neo presidente si pone su una linea ideologica piuttosto ortodossa, ammantata di una forte retorica anticorruzione ma anche di una spinta verso gli affari. Una scelta come quella del ministro della Pubblica sicurezza To Lam sarebbe stata più delicata. Sia sul fronte interno, per i possibili timori di un’ulteriore ascesa dell’influenza del potente apparato di pubblica sicurezza che esprime già il premier Pham Minh Chinh, sia su quello esterno per le perplessità dei paesi europei nel relazionarsi coi protagonisti di figure coinvolte in campagne più o meno opache legate alla gestione del potere politico.
Ci sono anche altri aspetti da tenere in considerazione sulla scelta di Thuong. Nato nella provincia meridionale di Vinh Long, interrompe una parentesi nella quale tutti e 4 i pilastri venivano espressi dalle province settentrionali. La sua nomina riporta dunque una sorta di bilanciamento regionale che aveva sempre caratterizzato la politica vietnamita. C’è anche chi vede la nomina di un politico in età ancora relativamente giovane come il primo segnale di una futura successione a Trong. Nel 2021, nonostante le chiacchierate condizioni di salute, il segretario generale aveva mantenuto il potere per un terzo mandato anche proprio per l’assenza di un accordo su un potenziale erede. L’investitura di Thuong segnala invece che il Partito potrebbe puntare su di lui nel prossimo futuro, magari al prossimo Congresso del 2026.
Nel frattempo, Hanoi cercherà di continuare ad attrarre investimenti stranieri. Diversi colossi internazionali, a partire da quelli dell’elettronica, stanno scegliendo il Vietnam per posizionarsi in Asia o diversificare le proprie catene di produzione rispetto alla Cina. Fenomeno incentivato dagli accordi di libero scambio sottoscritti da Hanoi con Unione Europea e Regno Unito. Ma anche dagli effetti collaterali delle tensioni tra Cina e Stati Uniti, potenze tra le quali il Vietnam cerca di restare in equilibrio.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Toni duri e accuse esplicite tra il capo della diplomazia americana e quello cinese durante la Conferenza sulla Sicurezza in Germania: gli Usa allontanano la pace, attacca Wang, la Cina sostiene la Russia anche militarmente, contrattacca Blinken. L’Europa assiste al match…
Chi sperava che la Conferenza sulla Sicurezza di Monaco di Baviera potesse rappresentare un’occasione di distensione tra Stati Uniti e Cina si sbagliava di grosso. Non solo il breve bilaterale “informale” (come ha tenuto a sottolineare Pechino) si è svolto con toni duri, ma ha generato nuove polemiche e accuse incrociate. In particolare sul fronte della guerra in Ucraina. Entrambi i litiganti sembrano intenzionati a non lasciare al rivale il ruolo di potenza responsabile. Se Pechino continua ad accusare Washington di gettare benzina sul fuoco del conflitto, Washington dichiara in modo esplicito che Pechino potrebbe sostenere, anche a livello militare, lo sforzo della Russia. In palio, i cuori e le teste dei Paesi europei che vorrebbero vedere passi concreti in direzione della pace e ripongono qualche speranza proprio nella Cina, come dimostrato dai bilaterali tra Wang Yi e gli omologhi e leader europei incontrati nei giorni scorsi.
Sia Francia, sia Italia hanno detto di voler mantenere la cooperazione con la Repubblica Popolare, anzi intensificarla sul fronte commerciale, auspicando poi un ruolo attivo del governo cinese nel cercare di interrompere il conflitto. Un desiderio al quale il direttore dell’Ufficio della Commissione centrale degli Affari esteri del Partito comunista cinese ha provato in qualche modo a rispondere, preannunciando la presentazione di un documento che dovrebbe rappresentare una proposta di pace. Tanto che in Europa c’è chi ha visto l’ultima tappa del tour all’estero di Wang in Russia come un possibile segnale che la Cina potesse farsi portavoce di un messaggio da parte europea. In realtà, Wang è incaricato soprattutto di preparare la visita di Xi Jinping al Cremlino, prevista in primavera.
Gli Stati Uniti hanno osservato l’offensiva diplomatica cinese e hanno deciso di rispondere. Anche perché durante il forum in terra tedesca, Wang ha ribadito la convinzione di Pechino secondo cui sarebbe proprio Washington a non volere anzi ad allontanare la pace evitando l’avvio del processo negoziale. Col tentativo di creare qualche frattura tra Europa e Stati Uniti, con la Cina intenta, come sempre, a ricordare agli europei che i loro interessi non sono necessariamente gli stessi di quelli degli americani. Forse per questo, Antony Blinken è passato al (duro) contrattacco. A margine del bilaterale con Wang, ha affermato che gli Usa temono che la Cina prenda in considerazione l’ipotesi di inviare armi a sostegno della Russia. Ipotesi rilanciata dal Wall Street Journal, che sostiene che droni cinesi continuino a essere utilizzati sul campo dalle forze armate di Mosca, nonostante le sanzioni. Per adesso si tratta di speculazioni, che sono però bastate a far alzare un coro di avvertimenti da parte dei vari governi europei. L’alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, Josep Borrell, ha definito una “linea rossa” l’eventuale spedizione di armamenti a Mosca, mentre il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato dei rischi di una eventuale “guerra mondiale” in caso di sostegno cinese alla Russia.
Anche l’ultima tappa del viaggio di Wang a Mosca assume improvvisamente un altro significato per chi teme che possa servire non per esercitare pressioni ma semmai per saldare ulteriormente il rapporto tra Cina e Russia. Proprio il messaggio che la parte cinese non voleva veicolare, quantomeno in direzione del Vecchio Continente, e che potrebbe invece essere rafforzato dalla contemporanea e inattesa visita a Kiev del Presidente statunitense Joe Biden. Viaggio che rende politicamente più complicato per Pechino mostrarsi neutrale e imparziale sulla situazione.
La Cina ovviamente nega tutto e definisce “false” le affermazioni americane sul possibile rifornimento di armi a Mosca. Il portavoce del Ministero degli Esteri Wang Wenbin ha anzi ricordato che sono gli Usa che “non smettono di fornire armi al campo di battaglia” e non la Cina. Aggiungendo: “Gli Stati Uniti non sono qualificati per dare ordini alla Cina e non accetteremo che gli Stati Uniti dettino o impongano come dovrebbero essere le relazioni sino-russe”. Una replica che però potrebbe compromettere i tentativi cinesi di riannodare il filo dei rapporti con l’Europa. Mentre quelli con Washington sono sempre più burrascosi: un botta e risposta politico e simbolico nel quale non si intravede la ripresa di un dialogo che fino a qualche settimana fa sembravano volere entrambe le parti.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Sarà Wang Yi, massimo esponente della diplomazia cinese, a ricalibrare il delicato rapporto con l’Unione europea in un viaggio che toccherà Francia, Italia, Germania e Ungheria. Ultima tappa Mosca.
Giuntura cruciale per la diplomazia cinese. Mentre il presidente iraniano Ebrahim Raisi arriva per la prima volta a Pechino per incontrare l’omologo Xi Jinping, il direttore della Commissione centrale per gli Affari esteri cinese Wang Yi si reca in Europa. Il ricevimento di Raisi serve per far ripartire i rapporti con Teheran dopo i malumori creati dalla firma apposta da Xi al comunicato finale del Consiglio del Golfo (in cui si dava ragione agli Emirati Arabi Uniti su una disputa territoriale aperta con l’Iran) durante la sua visita di dicembre in Arabia Saudita. Il viaggio di Wang ha invece l’obiettivo di tenere aperta la porta della diplomazia con l’Unione europea, riaffermando poi il sostegno politico alla Russia di Vladimir Putin, visto che l’ultima tappa dell’ex ministro degli Esteri cinese (promosso all’interno del Politburo del Partito comunista al Congresso dello scorso ottobre) sarà proprio a Mosca.
Prima, però, i passaggi in Francia e in Italia. Si tratta di due tappe chiave per la diplomazia cinese, che prova a non recidere il legame con l’Occidente nonostante le crescenti tensioni con gli Stati Uniti, anche a seguito della vicenda dei presunti palloni-spia che continua a inquinare i canali di dialogo tra le due potenze. Dopo la visita del cancelliere tedesco Olaf Scholz a inizio novembre, la Cina vorrebbe veder apparire a Pechino anche Emmanuel Macron e Giorgia Meloni. Il presidente francese aveva più volte manifestato l’intenzione di recarsi in Cina ed è un grande sostenitore della prospettiva di chi vorrebbe mantenere stretti i rapporti con Pechino per impedire che quest’ultima si avvicini sempre più alla Russia. Il viaggio di Wang servirà probabilmente a preparare il terreno per la possibile visita di Macron, così come per quella di Meloni. La premier italiana è stata invitata in Cina da Xi durante il bilaterale a margine del summit del G20 di Bali dello scorso novembre. Da allora, Meloni ha parzialmente corretto la postura sulla Cina visto il successo imprevisto del dialogo col presidente cinese. Quantomeno a livello pubblico e ufficiale, nessuna dichiarazione ostile né di aperta critica, in controtendenza con quanto accaduto durante la campagna elettorale, quando la leader di Fratelli d’Italia si era espressa più volte su dossier delicati come Taiwan e Tibet, prefigurando l’uscita dell’Italia dalla Belt and Road Initiative. Durante l’incontro con Xi si è invece parlato molto di aumento delle esportazioni italiane sul mercato cinese. Da qui una posizione un po’ più attendista, a partire dall’argomento Taiwan, con la premier che potrebbe volare a Pechino in primavera per un incontro che fino a qualche tempo fa era tutt’altro che scontato.
Dopo di che Wang sarà a Monaco di Baviera per partecipare alla Conferenza sulla sicurezza, in programma dal 17 al 19 febbraio. Secondo il comunicato del Ministero degli Esteri cinese, ora guidato dall’ex ambasciatore a Washington Qin Gang, Wang terrà un discorso sul concetto di sicurezza “comune, globale, cooperativa e sostenibile” promosso da Xi, sottolineando che la Cina “aderirà sempre alla via dello sviluppo pacifico”.
C’è dunque da aspettarsi l’ennesima rimodulazione del messaggio cinese sulla guerra in Ucraina. Rimodulazione più in alcuni dettagli formali che non negli elementi sostanziali, rimasti sempre invariati sin dall’inizio del conflitto. Anzi, sui media di Stato cinesi, in questi giorni si sottolinea che le responsabilità di un’eventuale nuova escalation saranno da ascrivere soprattutto agli Stati Uniti e alla loro scelta di “ignorare” le richieste di Mosca e le sue “legittime preoccupazioni” sulla sicurezza. In terra tedesca potrebbero arrivare interessanti agganci diplomatici. Secondo l’agenzia di stampa giapponese Kyodo, Wang incontrerà in un bilaterale il Ministro degli Esteri di Tokyo, Hayashi Yoshimasa. Incontro particolarmente atteso, dopo le rinnovate tensioni tra i due paesi asiatici in seguito all’elevazione della partnership militare tra Usa e Giappone, nonché l’approvazione di una nuova strategia di difesa da parte dell’amministrazione del premier Kishida Fumio. Ma c’è anche chi immagina un possibile colloquio con la vicepresidente americana Kamala Harris, magari per provare a riannodare il filo che si è slegato dopo la cancellazione della visita del segretario di Stato Antony Blinken a Pechino.
Ma la coda del tour di Wang prevede due tappe meno “allineate” all’Europa atlantista. Previsto infatti uno stop in Ungheria, che mantiene una posizione ambigua sull’invasione russa visti anche i rapporti privilegiati tra Viktor Orban e Vladimir Putin. Chiusura poi proprio a Mosca, prima del rientro in Cina il 22 febbraio. Wang sarà ricevuto dal Ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov e potrebbe parlare anche direttamente con Putin, a poche ore dal primo anniversario dell’invasione. Nel frattempo, da venerdì 17 si terranno delle esercitazioni navali congiunte tra le marine di Cina e Russia al largo del Sudafrica. A testimonianza del fatto che, al di là del tentativo di mantenere fluidi i rapporti con i Paesi Ue, Pechino non ha intenzione di allontanarsi da Mosca.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Se c’è un imprenditore che rappresenta il simbolo dell’India di Narendra Modi e delle sue ambizioni di ascesa regionale e globale, questo è Gautam Adani. Fino a poche settimane fa uomo più ricco d’Asia e terzo uomo più ricco al mondo, ha visto andare in fumo una quantità immensa di patrimonio dopo un report durissimo del fondo ribassista statunitense Hindenburg sulla sua creatura, il conglomerato Adani Group. Una vicenda che non è una “semplice” possibile caduta di un impero economico, ma anche una storia che intreccia aspetti politici e geopolitici di ampia portata.
Adani e Modi sono legati a doppio filo da molto tempo. Entrambi provengono dal Gujarat, lo Stato dell’India occidentale. Qui è dove Modi ha iniziato a sperimentare le sue doti di leadership. Mentre era a capo del governo locale, si verificò il famoso massacro del 2002. Un treno di pellegrini indù venne attaccato e la responsabilità ricadde sulla minoranza musulmana, presa di mira dalla maggioranza. Gli scontri che ne seguirono causarono ufficialmente 1500 morti, la maggior parte nella comunità musulmana. Modi fu anche indagato dalla giustizia indiana per presunte responsabilità nel non aver agito per impedire le violenze contro la minoranza. Dopo diversi anni fu assolto, ma la sua politica ha sempre avuto tinte ultranazionaliste indù. Negli ultimi anni, diverse leggi dell’amministrazione Modi hanno considerevolmente ridotto i diritti della minoranza musulmana, a partire dalla revoca dell’autonomia del Kashmir e dalla revisione della legge sulla cittadinanza.
Ad aiutare la sua ascesa ai tempi del Gujarat partecipò anche Adani, che ha iniziato a costruire le sue fortune con la gestione di un porto commerciale. Dopo le violenze che avevano creato grande instabilità, l’imprenditore creò un’organizzazione per ridurre le associazioni di categoria a livello locale e, in collaborazione con il governo statale di Modi, ha contribuito a creare una conferenza annuale per gli investitori dal nome “Vibrant Gujarat”. Sotto la mano ferma di Modi, la crescita economica dello Stato ha subito un’accelerazione sostanziale. Una volta salito al potere, il premier si è giovato della sua fama costruita sul fronte economico, seducendo molte cancellerie internazionali con promesse di apertura al mercato indiano e facilitazione di investimenti esteri.
L’ascesa di Modi è stata accompagnata da quella di Adani, la cui creatura si è espansa progressivamente a immobili, energia e cemento. Controlla il porto più grande dell’India ed è uno dei suoi maggiori operatori aeroportuali. Di recente ha promesso di sostenere la transizione energetica dell’India dopo aver investito a più riprese sul carbone. Si tratta di una figura controversa già da prima della vicenda Hindenburg. Ampie porzioni di foreste abitate dalle comunità tribali dell’India centrale sono state abbattute per fare spazio alle sue inquinanti operazioni di estrazione.
Ecco perché il report Hindenburg colpisce in toto il “sistema indiano”. Il fondo ribassista americano ha pubblicato i risultati di due anni di indagini sull’immenso conglomerato indiano, denunciando manipolazioni del mercato e irregolarità contabili attraverso “sfacciate alterazioni dei prezzi delle azioni” e “decenni di falsificazione dei bilanci”. Le azioni delle società del miliardario sono in caduta libera dal 24 gennaio, con perdite di mercato cumulate del gruppo che ora superano i 110 miliardi di dollari, scatenando timori di un più ampio contagio finanziario.
La crisi rischia ora di allargarsi anche a Modi e al sistema politico, visto che l’opposizione indiana ha sempre accusato il governo di riservare un trattamento di favore ai grandi miliardari. In primis Adani, che tra le altre cose lo scorso anno ha lanciato e completato un’acquisizione ostile dell’emittente NDTV, uno dei pochi media che aveva mantenuto una linea indipendente e critica nei confronti di Modi, resosi protagonista in questi anni di una forte stretta sulla libertà di stampa. I partiti dell’opposizione hanno chiesto l’istituzione di una commissione parlamentare per indagare sulla vicenda e hanno interrotto i lavori, attaccando di nuovo sulla vicinanza tra Adani e Modi. Nei giorni scorsi, diversi manifestanti guidati dall’opposizione hanno anche espresso rabbia per gli investimenti effettuati da Life Insurance Corporation e State Bank of India, sostenute dallo Stato, nel Gruppo Adani.
Sia Modi sia Adani provano a difendersi inserendo l’elemento geopolitico. Il miliardario ha definito la vicenda “un attacco calcolato all’India” e “all’indipendenza, all’integrità e alla qualità delle istituzioni indiane”. La portata dello scandalo rischia di essere notevole, visto che arriva in un momento molto delicato per Modi, già alle prese con le proteste per la decisione di censurare il documentario prodotto dalla BBC su di lui. Il film getta ombre inquietanti sul ruolo di Modi nel massacro del Gujarat ma anche sull’erosione dei diritti delle minoranze e dei cittadini indiani da quando il premier è al governo. La sua stretta censura ha causato proteste di studenti. Questa vicenda, unita a quella di Adani, potrebbe compattare la tradizionalmente frammentata opposizione indiana in vista delle elezioni del 2024.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
L’opinione, espressa in una nota a uso interno, è circolata sui social media generando una serie di articoli e analisi, nonché la presa di distanze ufficiale da parte del Pentagono. Il Dipartimento di Difesa ha infatti chiarito che si tratta di commenti “non rappresentativi del punto di vista” generale sulla Cina.
Negli anni e mesi scorsi, altri militari o esponenti politici statunitensi hanno fatto previsioni diverse sulla data di una possibile azione militare di Pechino sullo Stretto: 2027, 2032, persino 2024. Tutte con basi più o meno logiche. Va però ricordato innanzitutto che si tratta di opinioni. E che c’è chi, sempre dalle parti di Washington, ritiene che né un’azione militare su Taiwan e né tantomeno una guerra tra le due superpotenze sia prossima o inevitabile.
Detto questo, il 2023 taiwanese potrebbe essere persino più “interessante” del 2022. L’anno appena trascorso ha visto una parziale erosione dello status quo. Da una parte, Pechino ha criticato l’escalation diplomatica statunitense con la visita di Nancy Pelosi a Taipei, la prima di uno speaker della Camera dei Rappresentanti dal 1997. Dall’altra parte, Washington ha criticato l’escalation militare cinese con esercitazioni militari senza precedenti intorno a Taiwan e le incursioni aeree e navali ormai quotidiane oltre la cosiddetta “linea mediana”, confine non ufficiale ma ampiamente rispettato sullo Stretto sino allo scorso agosto.
Nel mezzo, a Taiwan è stata annunciata l’estensione della leva militare da 4 a 12 mesi e l’opposizione del Kuomintang (KMT, più dialogante nei confronti di Pechino) ha stravinto le elezioni locali.
L’anno appena iniziato può essere decisivo per capire i futuri equilibri sullo Stretto. A partire proprio dalla postura di Taipei, che ha una rilevanza ancora notevole nel gioco delle parti rispetto invece a quanto accade nella penisola coreana dove ormai il regime di Kim Jong-un non ritiene più Seul un interlocutore significativo, a prescindere da chi la governi. E in questo senso ci sono novità cruciali.
Proprio lunedì 30 gennaio, a Taiwan è stato annunciato un ampio rimpasto di governo, dopo le dimissioni di massa che hanno fatto seguito alle elezioni locali del 26 novembre scorso. L’ex vicepresidente Chen Chien-jen ha sostituito Su Tseng-chang nel ruolo di premier. Chen, 71 anni, è stato vicepresidente durante il primo mandato di Tsai, dal 2016 al 2020, durante il quale si è distinto per aver coordinato gli sforzi per riformare il sistema pensionistico del governo e per aver approvato una legge speciale per legalizzare il matrimonio tra persone dello stesso sesso.
Il vice ministro degli Esteri Tsai Ming-yen è stato messo a capo dell’Ufficio di Sicurezza Nazionale (NSB). Tsai, studioso di relazioni internazionali ed ex diplomatico, è stato scelto per sostituire Chen Ming-tong, che si è dimesso dopo essere stato coinvolto in uno scandalo di plagio che ha coinvolto il suo ex studente, l’ex sindaco di Hsinchu Lin Chih-chien. Tra i ministri, fanno il loro ingresso una serie di accademici di alto profilo, ma restano al loro posto sia Joseph Wu, agli Esteri, sia Chiu Kuo-cheng, alla Difesa: segnale che la presidente Tsai Ing-wen vuole dare continuità alla sua politica intrastretto.
Eppure, all’orizzonte si stagliano elementi di discontinuità. Dallo scorso 18 gennaio, infatti, alla guida del Partito Progressista Democratico (DPP) non c’è più Tsai ma il vicepresidente William Lai. Si tratta di una figura ben più radicale di quella di Tsai. L’attuale presidente non riconosce il consenso del 1992 e il principio della unica Cina, ma non ha mai voluto l’indipendenza formale come Repubblica di Taiwan, limitandosi a difendere quella de facto come Repubblica di Cina. Lai si è invece espresso in passato a favore dell’indipendenza formale, salvo poi smussare la sua retorica una volta diventato vicepresidente per ricomporre una frattura interna che nel 2019 aveva portato il DPP sull’orlo della scissione tra l’ala più moderata guidata da Tsai e quella più radicale guidata da Lai.
Proprio quest’ultimo sarà con forte probabilità il candidato del DPP alle presidenziali del prossimo gennaio. Un nome inviso a Pechino e sul quale Washington deve ancora convincersi del tutto. Una parte degli stessi elettori taiwanesi, pur se di inclinazione pro DPP, sono scettici su quella che viene percepita come un’opzione più rischiosa di quanto non fosse stata Tsai nel 2016 e 2020.
Ma da qui alle urne di gennaio 2024 possono succedere varie cose anche sul fronte esterno. Le rispettive manovre di Washington e Pechino sembrano infatti continuare. Ad aprile potrebbe arrivare la visita di Kevin McCarthy a Taipei. Si tratterebbe del bis del viaggio di Pelosi a distanza di meno di un anno, dopo 25 anni di assenza di visite di così alto profilo. Difficile che Pechino non lo percepisca, o quantomeno non lo racconti, come un segnale preciso di incoraggiamento a quelle che definisce “forze secessioniste”.
Nonostante McCarthy, repubblicano, sia del partito opposto al presidente Joe Biden a differenza di Pelosi, la reazione di Xi Jinping non potrà probabilmente essere meno intensa di quella dello scorso agosto. Contestualmente, a marzo, durante le annuali “due sessioni” legislative, potrebbero arrivare le prime novità dal punto di vista normativo sul dossier taiwanese da parte del Partito comunista. Una revisione della legge anti secessione del 2005 o persino una nuova legge per la riunificazione sono opzioni sul tavolo.
Così come all’ideologo Wang Huning, numero 3 della gerarchia del Comitato permanente, Xi avrebbe chiesto una nuova formulazione teorica che superi il tradizionale modello “un paese, due sistemi”, reso inaccettabile dai taiwanesi dopo quanto accaduto a Hong Kong.
La volontà potrebbe essere quella di proporre un nuovo modello a un possibile e auspicato (da Pechino) governo taiwanese targato KMT, che però difficilmente potrà accettare le condizioni poste dal Partito comunista. Quelle sul 2025 sono solo opinioni, così come quelle sul 2027 o altre date, ma di certo le lancette dell’orologio sullo Stretto scorrono più rapide di un tempo.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Se la visita sarà confermata, la Cina si potrebbe dimostrare meno disponibile nel ridiscutere la ristrutturazione del debito che lo Sri Lanka ha nei suoi confronti
“Servitù della gleba feudale”. La diplomazia cinese ha definito così il sistema a cui è a capo il Dalai Lama, in un nuovo capitolo di scontro sull’autorità religiosa buddhista che è destinato ad accendersi ulteriormente nel prossimo futuro e che già ora causa forti tensioni. In questo caso tra Cina e Sri Lanka, ma come sempre con l’India sullo sfondo. L’origine della polemica è la possibile visita del Dalai Lama nel Paese sull’oceano Indiano. Sarebbe la prima ed è stata definita “subdola” come quella di Nancy Pelosi a Taiwan lo scorso agosto. Ormai una prassi anche a livello lessicale per delegittimare viaggi diplomatici o religiosi di autorità non gradite. Come il viaggio dell’ex speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti era stata descritta come un tentativo di fomentare le cosiddette “forze indipendentiste di Taiwan”, in questo caso l’obiettivo del Dalai Lama sarebbe quello di “promuovere l’indipendenza tibetana”.
Appresa la notizia, l’incaricato d’affari dell’ambasciata cinese a Colombo, Hu Wei, ha visitato il venerabile Thibbatuwawe Sri Siddhartha Sumangala Thero, capo prelato del capitolo di Malwathu, dicendogli che la Cina si oppone fermamente all’intenzione di Tenzin Gyatso di recarsi nello Sri Lanka. E lo ha fatto con parole dure, definendo il 14° Dalai Lama come qualcosa di più di un “semplice monaco come si autoproclama”, descrivendolo come “il capo della servitù della gleba feudale e della teocrazia in Tibet prima del 1951, un esule politico travestito da figura religiosa che da tempo è impegnato in attività separatiste anticinesi e tenta di dividere il Tibet dalla Cina”.
Un’entrata decisa accompagnata alla sottolineatura del peso che ha il rapporto con Pechino per il governo srilankese. Hu ha infatti sottolineato l’aiuto fornito dal governo cinese per il contrasto alla pandemia, nonché alla crisi che ha mandato in bancarotta lo Sri Lanka. Proprio il legame economico è quello che è balzato più volte all’attenzione internazionale sulle dinamiche bilaterali, con descrizioni più o meno veritiere della cosiddetta “trappola del debito” nella quale Colombo sarebbe rimasta invischiando, cedendo pezzi di sovranità a partire dalla gestione del porto di Hambantota. L’autorità religiosa dello Sri Lanka avrebbe recepito il messaggio, quantomeno stando al comunicato in merito dell’ambasciata cinese: “Il Gran Prelato ha sottolineato che la Cina è l’amico più stretto dello Sri Lanka. Le nostre relazioni con la Cina non devono essere danneggiate. È meglio che anche il governo comprenda l’importanza del contributo fornito dalla Cina per il miglioramento dell’economia dello Sri Lanka”. Per poi ricordare che i due Paesi si sono impegnati a dare sostegno reciproco sui propri interessi fondamentali, nei quali rientra anche il mancato spazio concesso a un’autorità religiosa che viene vista anche come politica e ostile alla Repubblica Popolare.
Non è difficile immaginare che nel caso la visita si compia, la Cina si dimostrerà meno disponibile nel ridiscutere la ristrutturazione del debito che lo Sri Lanka ha nei suoi confronti. Attitudine che potrebbe invece essere molto diversa nel caso non vengano aperte le porte al Dalai Lama. Scelta non semplice per Colombo, che ha bisogno disperato di investimenti e sostegno economico e che si ritrova però in mezzo anche alle opposte manovre di Cina e India, big dell’area che sta serrando le fila dopo le accresciute tensioni con Pechino lungo il confine conteso.
Le tensioni sulla figura del Dalai Lama sono peraltro destinate ad aumentare nel prossimo futuro, visto che già ora si inizia a polemizzare sulla questione della sua successione. Il governo tibetano in esilio, non riconosciuto da Pechino ma ospitato e in qualche modo sostenuto da Nuova Delhi, sostiene che il Partito comunista cinese voglia “interferire” sulla successione. “Si stanno preparando per questo da 15 anni”, ha dichiarato nei giorni scorsi Penpa Tsering, il leader del governo tibetano in esilio. Da Pechino replicano che la nomina andrà approvata dal governo centrale cinese, “come sempre avvenuto in precedenza”. Ma appare impossibile qualsiasi tipo di accordo, visto che il Dalai Lama accusa la Cina di “voler distruggere il buddhismo”, mentre Pechino definisce il Dalai Lama un “traditore” e lo accusa col governo tibetano in esilio di voler “influenzare e fomentare il separatismo” nella regione che viene sempre più spesso chiamata Xizang (il nome in mandarino di Tibet) anche nei documenti in lingua inglese.
Lo Sri Lanka è il primo test di un tema che tornerà più volte nei prossimi anni e che costituisce uno dei tanti ingredienti delle tensioni tra Cina e India.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Il successo grazie all’accordo di libero scambio che ha favorito gli investimenti occidentali. Artefice il Presidente Phuc che rischia di perdere presa a livello politico
Da una parte, numeri roboanti. Dall’altra, manovre di potere. Il Vietnam si pone sotto la luce dei riflettori per i suoi ottimi dati economici, ma intanto qualcosa si muove ai vertici della sua rigida gerarchia decisionale. Rischiando potenzialmente di cambiare regole e prassi su cui la vita politica del Paese del Sud-Est asiatico si è sempre basata.
Partiamo dalla luce. L’economia vietnamita è cresciuta dell’8,02% nel 2022, il ritmo annuale più veloce dal 1997. Si tratta di un dato superiore anche all’ambizioso +6,%-6,5% che era stato fissato dal governo. Non che negli anni precedenti si andasse male: nel 2020, primo anno di pandemia, il Vietnam è stato il Paese asiatico a crescere di più (2,9%), persino più della Cina che allora sembrava aver voltato pagina per prima rispetto all’Occidente. Parziale rallentamento col +2,58% del 2021, quando la prima vera ondata di Covid-19 aveva costretto a diverse restrizioni e chiusure le autorità dell’esecutivo, portando a un serio impatto sull’attività delle fabbriche.
Ma ora il rimbalzo è fortissimo, spinto soprattutto dalle esportazioni ma anche dalle vendite al dettaglio. Segno che l’economia vietnamita si sta rafforzando su due fronti. Il primo: l’industria manifatturiera. Il secondo: i consumi, cresciuti nell’anno appena trascorso del 19,8%. Segnale estremamente positivo, quest’ultimo, che lascia intravedere la crescita del mercato interno grazie allo storico processo di rafforzamento della classe media. Un fenomeno in pieno divenire e che nei piani del Partito comunista vietnamita dovrebbe consentire ad Hanoi di entrare nella top 20 delle più grandi economie mondiali dei prossimi anni.
Sul fronte manifatturiero, il Vietnam si sta giovando degli effetti collaterali della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. Basti citare l’aumento del 13,5% degli investimenti diretti esteri, che hanno superato i 22,4 miliardi di dollari. Non è un caso, visto che sempre più grandi aziende internazionali spostano parte della loro produzione in Vietnam. A partire dai giganti dell’elettronica, che hanno l’obiettivo di diversificare il loro business asiatico e portano segmenti produttivi all’esterno della Cina. L’esempio più celebre è quello di Apple, che entro la prima metà del 2023 inizierà a produrre in Vietnam alcuni dei suoi MacBook, per la prima volta fuori dal territorio cinese. Un segnale fondamentale, che chiarisce come a spostarsi non sono solo industrie manifatturiere in posizione medio bassa nella catena di valore, magari a causa dell’accresciuta concorrenza o dell’aumento del costo del lavoro in Cina. No, ora arrivano anche grandi produttori hi-tech. Ma la lista è lunga: Samsung, Hp, Dell, nonché i fornitori come Foxconn e Pegatron, stanno mettendo radici sempre più profonde nel Paese, in grado anche di attrarre sempre più spesso nuovi progetti, come per esempio quello di Lego. Il gigante danese dei giocattoli aprirà in Vietnam la sua prima fabbrica a emissioni zero, un progetto da un miliardo di dollari.
Gli investimenti occidentali e in particolare europei sono favoriti anche dall’accordo di libero scambio sottoscritto nel 2019 ed entrato in vigore nel 2020. Ma l’uomo copertina che ha favorito quell’accordo rischia ora di perdere presa a livello politico. Si tratta del presidente Nguyen Xuan Phuc, ex premier confinato a inizio 2021 nel ruolo di presidente, figura più cerimoniale e con meno incisività politica di quella di primo ministro e soprattutto di segretario generale del Partito che sembrava destinato a ricoprire.
Il leader è rimasto invece Nguyen Phu Trong, che al XIII Congresso di due anni fa ha ottenuto uno storico e inaspettato terzo mandato. Il vincolo dei due mandati era stato rispettato sin dai tempi di Le Duan, così come in Cina era stato rispettato dai tempi di Deng Xiaoping. Trong, in modo simile a Xi Jinping, ha costruito la sua reputazione su una ostentata inflessibilità in materia di sicurezza e di anticorruzione, promossa attraverso la spietata campagna della “fornace ardente” che gli ha consentito di sbarazzarsi dei rivali politici sconfitti al XII congresso del 2016. Il mancato accordo sul nome del suo successore, con il delfino Tran Quoc Vong rimasto fuori persino dal politburo, ha fatto sì che Trong restasse al suo posto.
Trong ha ulteriormente cementato il suo potere dopo una mossa a sorpresa del Comitato centrale del Partito, che ha rimosso gli incarichi a due vicepremier. Si tratta di Pham Binh Minh, incaricato della diplomazia generale, e Vu Duc Dam, incaricato della sanità pubblica. Il reato di Minh sarebbe la mancanza di supervisione su uno scandalo nel quale circa 40 persone sono state arrestate per aver presumibilmente intascato tangenti dai passeggeri a cui era stata data priorità d’imbarco per rimpatriare in Vietnam durante le fasi più espansive della pandemia. Dam è invece finito nel mirino per la sua supervisione del modo in cui il governo ha condotto le gare d’appalto per i kit di analisi del coronavirus. Il processo è stato poi rivelato come viziato da brogli, dando vita a uno scandalo che ha portato all’espulsione e all’arresto di un ex ministro della Sanità e di un ex sindaco di Hanoi.
Ma la sensazione è che dietro ci sia un disegno più ampio di natura politica. C’è chi ritiene che possa essere anche il preludio di qualche mossa più clamorosa che possa anche toccare uno dei cosiddetti “quattro pilastri” della politica vietnamita, che oltre a segretario generale, presidente e premier includono anche il presidente dell’Assemblea nazionale.
Finché si cresce così tanto a livello economico, è più semplice nascondere rivali politici sotto il tappeto.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Il tour arriva in un momento in cui la posizione del Giappone sulla scena internazionale è in grande trasformazione: Tokyo ha consolidato il proprio asse con Washington e rafforzato il partenariato con la Nato proponendosi come pilastro per il contenimento della Cina nell’Indo-Pacifico
Sempre più allineato, sempre più nel mirino. Il viaggio in Occidente del premier Kishida Fumio certifica in modo probabilmente definitivo la strategia difensiva e la postura in politica estera di Tokyo. Il Giappone continua a radicarsi all’interno del sistema di alleanze degli Stati Uniti e a rafforzare il suo sistema di difesa, cambiandone la concezione strategica. Washington applaude, Mosca e soprattutto Pechino (che Tokyo considera ormai apertamente una “minaccia” alla sua sicurezza nazionale) molto meno.
È in questo contesto che nasce il tour del primo ministro nipponico, cominciato in Francia e pronto a snodarsi tra Italia, Regno Unito, Canada e Stati Uniti. Cinque giorni fitti di incontri, inaugurati da quello col presidente francese Emmanuel Macron, che hanno come obiettivo annunciato quello di preparare la strada al vertice del G7 che lo stesso Giappone ospiterà a Hiroshima il prossimo maggio. Un ruolo che pone Tokyo ancora più sotto i riflettori. E non sarà l’unico di questo 2023, visto che al Giappone spetta anche uno dei seggi non permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Dopo aver fermamente condannato la Russia schierandosi sin dal primo giorno dell’invasione dell’Ucraina dalla parte di Washington, il governo giapponese si è fatto portavoce dei timori di chi in Asia orientale vede la possibilità di un secondo fronte e osserva con crescente disappunto le manovre cinesi sullo Stretto di Taiwan e l’escalation sulla penisola coreana.
Il tour di Kishida servirà dunque anche e soprattutto a serrare le fila delle partnership coi paesi del G7 e a sottoscrivere importanti accordi. In particolare, a Londra attesa la firma con l’omologo britannico Rishi Sunak del testo che garantirà l’accesso reciproco per gli ufficiali militari. La mossa arriva poche settimane dopo che è stato annunciato un progetto trilaterale che coinvolge anche l’Italia per lo sviluppo di jet da combattimento Tempest di nuova generazione, la prima grande collaborazione industriale del Giappone nel settore della difesa che non vede il coinvolgimento al di fuori degli Stati Uniti sin dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Tema che verrà affrontato anche nella colazione di lavoro con Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, dopo che il bilaterale in programma a margine del summit del G20 di Bali lo scorso novembre era saltato all’ultimo momento. Significativo anche il passaggio in Canada, visto che ormai il Giappone viene ritenuto quasi un “sesto occhio” dei Five Eyes, l’alleanza dei servizi di intelligence dei paesi anglofoni. Il piatto forte sarà poi il faccia a faccia con Joe Biden, previsto per venerdì 13 alla Casa Bianca.
Il tour di Kishida arriva dopo una serie di mosse che stanno tirando fuori il Giappone dal “grigiore strategico” che lo aveva caratterizzato negli ultimi decenni e che, probabilmente, porteranno a un superamento quantomeno parziale della costituzione pacifista che gli è stata imposta dagli Stati Uniti alla fine del conflitto. Il passo più evidente in tal senso è stato la revisione della strategia di difesa nazionale. Il governo Kishida ha deciso di incrementare in modo sostanziale la spesa per la difesa e, per la prima volta, di acquisire capacità di colpire le basi nemiche per dissuadere gli attacchi da parte di forze esterne. Si tratta di una vera e propria svolta, che dà impulso al processo di riarmo e transizione militare del Giappone, nominalmente finora dotato solo di forze di autodifesa e non di un vero e proprio esercito.
Le spese per la difesa saranno di 314 miliardi di dollari tra il 2023 e il 2027, portando Tokyo a raggiungere lo standard Nato del 2% del Pil. Nella legge di bilancio del 2023, sono stati stanziati 211,3 miliardi di yen (1,58 miliardi di dollari) per l’acquisto di missili da crociera Tomahawk a lungo raggio prodotti negli Stati Uniti. Entro il 2030, il ministero della Difesa giapponese doterà il paese di missili a lungo raggio con una gittata fino a circa 3.000 chilometri. La partnership con gli Usa, nel frattempo, arriva anche nello spazio. Secondo Nikkei Asia, gli Stati Uniti stanno ultimando i piani per estendere il loro ombrello di sicurezza per il Giappone a protezione dei satelliti utilizzati per la sorveglianza e le operazioni militari. Tutte mosse che hanno causato l’esplicita condanna del governo cinese. D’altronde le frizioni tra Pechino e Tokyo sono in costante aumento. Le diverse posture sulla guerra in Ucraina sono solo una delle ragioni. La Repubblica Popolare Cinese non apprezza il sempre più forte coinvolgimento del Giappone nella sua partnership con la Nato e in ambito Quad, di cui ha ospitato il summit lo scorso maggio. Nel corso del 2022 sono state diverse le manovre di jet e navi sinorusse al largo dell’arcipelago giapponese o sui suoi stretti strategici. Lo scorso agosto, durante le esercitazioni militari sullo Stretto, alcuni missili cinesi sono ricaduti nelle acque della zona economica speciale di Tokyo (non riconosciuta da Pechino). Segnale che un’eventuale azione su Taiwan rischia di coinvolgere in maniera diretta il Giappone, che negli scorsi mesi ha mandato diverse delegazioni a Taipei e ha invitato il vicepresidente taiwanese William Lai (figura radicale e probabile candidato alle elezioni presidenziali del 2024) ai funerali privati di Abe Shinzo. Non a caso, secondo il nuovo Defense Buildup Program, le forze terrestri giapponesi potranno schierare tutte le unità a protezione delle isole Nansei sud-occidentali. Cioè quelle della Prefettura di Okinawa, la più vicina a Taiwan.
La 15esima brigata di Okinawa, che fa parte della catena Nansei, sarà aggiornata a divisione e guadagnerà una seconda unità di fanteria. A dimostrazione che Tokyo considera la stabilità sullo Stretto una questione vitale per la sua sicurezza nazionale.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Trentasette anni. Tanto è durato il regno di Hun Sen in Cambogia. Finora. Perché della successione promessa da qualche anno non si vede ancora traccia. Nel luglio del 2023 sono fissate le nuove elezioni generali, dalle quali usciranno i membri della nuova Assemblea nazionale. La vittoria del Partito popolare cambogiano è scontata e il Primo Ministro dovrebbe essere ancora una volta lui. Per altri cinque anni. Negli scorsi anni sono iniziate le voci sul cambio della guardia, ma il 43esimo Congresso del partito ha stabilito che il candidato per il 2023 sarà ancora Hun Sen. Ma non è ancora chiaro se e quando comincerà la transizione di potere. Anche perché si prevede che la poltrona da Primo Ministro verrà ceduta nientemeno che a suo figlio Hun Manet. Segnale che il leader non mollerà del tutto la presa nemmeno quando lascerà la guida del Governo.
Hun Sen governa il Paese dal 1985. La maggior parte dei cambogiani è nata quando lui era già al potere, che ha conosciuto diverse fasi ma che negli anni sembra essersi consolidato sempre di più. Nato come Hun Bunal, si è cambiato il nome nel 1972 dopo che due anni prima aveva lasciato la scuola monastica a Phnom Penh per arruolarsi tra i khmer rossi. Durante l’insorgenza contro il governo filoamericano di Lon Nol restò ferito durante l’assedio della capitale, diventando cieco da un occhio. Impaurito dalle purghe di Pol Pot scappò in Vietnam, dove diventò uno dei leader della ribellione anti khmer sponsorizzata da Hanoi. Dopo la fine del regime di Pol Pot, Hun Sen cominciò la sua rapida ascesa diventando premier dopo la morte di Chan Sy. Da allora governa col pugno di ferro. Nel 1993, quando l’opposizione di Norodom Ranariddh vinse le elezioni, Hun Sen minacciò la secessione di sette province con il supporto dell’esercito e dell’apparato statale. Il vincitore fu costretto a condividere il potere con lui dandogli il ruolo di secondo premier. Ma nel 1997 Hun Sen lanciò un colpo di stato rimpiazzando Ranarridh col fidato Ung Huot. Da lì in poi ha concesso sempre meno spazio di manovra ai rivali.
L’opposizione cambogiana se la passa male. Alle proteste di massa del 2014 la polizia ha risposto aprendo il fuoco uccidendo quattro persone e ferendone oltre 20. Nel 2017 la Corte Suprema ha sciolto il Partito della salvezza nazionale, principale forza d’opposizione, due mesi dopo l’arresto di Kem Sokha per il suo ruolo in un presunto piano per rovesciare Hun Sen con l’aiuto del Governo statunitense: accuse che lui nega. L’ex Presidente del partito rischia fino a 30 anni di carcere. Sembra essersi creata qualche frattura con l’altro leader dell’opposizione, Sam Rainsy del Candlelight Party. Lo scorso marzo Rainsy, che si trova in esilio dal 2016, è stato condannato a 10 anni di carcere insieme ad altre sette leader dell’opposizione. Le accuse sono legate al tentato ritorno di Rainsy in Cambogia, previsto per il 2019 e bloccato dal governo. Hun Sen aveva esplicitamente chiesto all’esercito di attaccare lui e Mu Sochua in caso fossero atterrati a Phnom Penh.
La stretta è anche sulla società civile. Negli ultimi anni centinaia di oppositori e critici sono stati arrestati e accusati di tradimento per aver preso parte ad attività politiche non violente contro il governo. La Cambogia sembra essere diventata de facto un Paese con un partito unico. Nel 2018 il governo ha emendato gli articoli relativi alla libertà di associazione e ha richiesto ai partiti politici di mettere l’interesse nazionale al di sopra di tutto. Al voto del 2018 il Partito Popolare Cambogiano ha preso il controllo della totalità dei seggi dell’Assemblea Nazionale, mentre alle elezioni locali di giugno, tra diversi sospetti di irregolarità, ha conquistato oltre il 99% dei voti. Le urne diventano di fatto un esercizio con pochi effetti concreti. Ed è per questo che ora il pallino è interamente in mano a Hun Sen, riluttante a cedere proprio nel momento in cui la sua presa si è fatta ancora più forte. Le sue dichiarazioni sono contraddittorie sull’orizzonte temporale del passo indietro (o meglio di lato), ma secondo molti osservatori si potrebbe arrivare anche dopo il 2030.
Il Primo Ministro si è sbarazzato di tutti i nemici, sia esterni sia interni. Nell’ultimo Congresso è riuscito a nominare due nuovi vicepresidenti del Partito: il Ministro della Difesa Tea Banh e il vice Primo Ministro Men Sam An, entrambi suoi stretti alleati. Una mossa utile a rafforzare l’appoggio delle élite militari e ad assestare un duro colpo al Ministro dell’Interno Sar Kheng, l’unico che aveva avuto il coraggio di esprimere perplessità sull’indicazione di Hun Manet come suo successore. Nessuno è in grado di fermarlo se, come pare, vorrà riformare la costituzione per la terza volta in quattro anni. Probabilmente per ridurre i poteri dell’Assemblea Nazionale e aumentare quelli del Primo Ministro. Anche perché la figura del figlio non è amata da tutti. Qualcuno tra i più anziani potrebbe non accettare la rapida ascesa del figlio di Hun Sen, che ha peraltro già dichiarato che imporrà un passo indietro di tutta la sua generazione quando si farà da parte lui. E anche nella generazione più giovane non è impossibile si inneschino lotte di potere.
Nel frattempo, Hun Sen pare volersi giocare il forte controllo interno per iniziare a prepararsi un’eredità da statista anche a livello internazionale. Sfruttando la presidenza di turno dell’Asean (l’Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico) per il 2022 ha provato a incidere sulla crisi in Myanmar. Lo scorso gennaio è diventato il primo leader di Stato a visitare Naypyidaw dopo il golpe militare del febbraio 2021. E non ha portato risultati. All’interno dell’Asean, peraltro, c’è chi non vede benissimo Hun Sen. Nel 2012 la Cambogia ha bloccato la pubblicazione di una dichiarazione congiunta sulla contesa tra la Cina e diversi Paesi del Sud-est asiatico sulle dispute nel Mar Cinese Meridionale. Non è certo un mistero che Phnom Penh sia probabilmente la capitale più inserita negli ingranaggi di Pechino tra quelle della regione. Nel 2022 è entrato in vigore un accordo di libero scambio tra i due Paesi e la presenza della Belt and Road è ampiamente visibile in Cambogia, dai progetti infrastrutturali ai siti turistici come Sihanoukville, popolarissima tra i cinesi prima del Covid-19. A proposito di pandemia, Hun Sen è stato l’unico leader straniero a visitare Pechino tra l’inizio dell’emergenza sanitaria e il febbraio 2022 per i Giochi Olimpici Invernali. Il 5 febbraio 2020, quando Wuhan era ancora in lockdown e il coronavirus sembrava un affare prettamente cinese, il Primo Ministro cambogiano ha incontrato Xi Jinping come segno di solidarietà e vicinanza.
Gli Stati Uniti guardano con sospetto alle manovre sulla base navale di Ream, temendo che possa essere utilizzata dalla marina cinese. Durante la sua visita in Cambogia del 2021, la Vice Segretaria di Stato Wendy Sherman ha cercato chiarimenti sulla demolizione di due strutture finanziate da Washington, ma non le è stato concesso di visitare la base. Timori che sembrano essere stati confermati negli scorsi mesi, quando è stato reso noto dall’esercito cambogiano che imprese ed esperti tecnici delle forze armate cinesi costruiranno e rinnoveranno una serie di strutture della base militare. Ma di recente Hun Sen sembra anche voler migliorare i rapporti con l’Occidente. Alla fine del 2021 ha introdotto una nuova legge sugli investimenti per attrarre realtà straniere offrendo una serie di incentivi, come l’esenzione dall’imposta sul reddito e dai dazi doganali. Mossa che sta rafforzando le relazioni con l’Europa. A inizio agosto, il giorno dopo la visita di Nancy Pelosi a Taipei, Hun Sen ha ospitato a Phnom Penh il Segretario di Stato Antony Blinken, il quale ha sottolineato l’importanza dell’appoggio cambogiano a due risoluzioni delle Nazioni Unite di condanna all’invasione russa dell’Ucraina.
Nulla è lasciato al caso per mettere al sicuro un potere che in 37 anni non è mai apparso meno traballante di ora.
Questo articolo è pubblicato anche sul numero di settembre/ottobre di eastwest.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
“Preoccupata? Se Pechino invaderà o non invaderà non dipende da me, da noi. Perché non dovrei andare avanti con la mia vita? È come se non facessi più nulla perché so che un giorno morirò”. Hsiah-han, neolaureata di Taipei, sintetizza quel misto di fatalismo e ineluttabilità che pervade molti a Taiwan. La visita di Nancy Pelosi e le esercitazioni militari più vaste di sempre intorno all’isola rischiano di convincere le tre parti coinvolte in questa nuova crisi sullo Stretto che la soluzione militare sia inevitabile, prima o poi. Il Partito comunista cinese teme che l’escalation diplomatica degli Stati Uniti sia tesa a cambiare lo status quo portando verso un’indipendenza di Taipei come Repubblica di Taiwan, che sarebbe formale e non più de facto come Repubblica di Cina. Un grande frammento della politica americana e del Pentagono teme che l’escalation militare di Pechino sia volta alla modifica dello status quo a suo vantaggio, in cui la “riunificazione” (“unificazione” per Taipei) dovrà essere ottenuta anche a costo di utilizzare la forza. Taipei, in mezzo alla contesa tra le due superpotenze, vorrebbe mantenere uno status quo che è già stato parzialmente eroso e teme di doversi davvero preparare a un ipotetico conflitto che si è sempre ritenuto possibile senza però intravederne i contorni.
D’altronde, Taiwan è un tema sul quale negoziare è impossibile. Sia tra le due sponde dello Stretto sia tra Usa e Cina. Il massimo che si può ottenere col dialogo è trovarsi d’accordo di essere in disaccordo, all’interno però di un perimetro controllato nel quale le tensioni restano sotto la soglia di pericolo. Un perimetro che si è progressivamente dissolto dal 2016 in poi. L’arrivo della Presidente Tsai Ing-wen a Taipei ha portato Xi Jinping a cancellare il processo di dialogo che era sfociato l’anno precedente con lo storico incontro con Ma Ying-jeou a Singapore. Il Partito progressista democratico taiwanese non riconosce il “consenso del 1992”, secondo cui Taipei e Pechino ammettevano l’esistenza di un’unica Cina senza però stabilire quale fosse. Precondizione richiesta dal Partito comunista per il dialogo. In questo contesto le due superpotenze hanno iniziato a testare le rispettive linee rosse. Da una parte con la telefonata tra Donald Trump e Tsai, la vendita di armi e l’intensificarsi delle visite politiche dopo l’eliminazione delle restrizioni auto imposte nei rapporti bilaterali operata da Mike Pompeo e confermata da Joe Biden. Dall’altra con l’erosione dello spazio diplomatico di Taipei nelle organizzazioni internazionali e con una posa muscolare che ha portato alla regolarizzazione delle incursioni nello spazio di identificazione di difesa aerea a partire dal 2019.
Per le due superpotenze Taiwan è importante, cruciale. Nel contesto della loro relazione ma anche per le loro stesse ambizioni. Per la Cina, Taiwan è un obiettivo storico. La “riunificazione” è la missione da compiere per archiviare definitivamente le cicatrici delle “umiliazioni” passate e completare il “ringiovanimento nazionale“. Il panorama del 2049, centenario della Repubblica Popolare, potrebbe essersi avvicinato. Il terzo libro bianco sulla questione di Taiwan, così come l’agenda che verrà probabilmente annunciata durante il XX Congresso di ottobre, reca la formula della “nuova era”. Potrebbe essere l’orizzonte politico di Xi. Per gli Usa, la Cina è diventato il primo rivale e il centro della loro strategia è diventato l’Asia-Pacifico. Da allora la Casa Bianca si prodiga a rassicurare Taipei sulla volontà di difenderla. Tra gaffe (di Biden) e finti segreti svelati (la presenza di consiglieri militari a Taiwan), l’ambiguità strategica sembra essere meno ambigua. Kiev è il 67esimo partner commerciale di Washington, Taipei il nono. Taiwan ha anche un’importanza simbolica. Esempio vivente che un governo etnicamente cinese può prosperare senza la guida comunista. Se Taiwan cadesse, il Pacifico (cioè il centro cruciale degli interessi e del potere americani) sarebbe improvvisamente meno a stelle e strisce. E Pechino potrebbe sfondare oltre la prima catena di isole. Taiwan è un argine impossibile da abbandonare o, nella peggiore delle ipotesi per i taiwanesi, l’esca per attrarre la Cina in un’avventura che potrebbe anche mettere a rischio la tenuta interna del suo sistema.
Senza contare il ruolo cruciale dei semiconduttori taiwanesi. L’isola controlla circa il 66% dello share globale del comparto di fabbricazione e assemblaggio dei microchip (la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, pesa da sola oltre il 50%), il “petrolio elettronico” del terzo millennio. Il dominio è ancora più esteso dal punto di vista qualitativo: i produttori taiwanesi detengono il 92% della manifattura di chip sotto i dieci nanometri. Non è un caso che sia Washington sia Pechino stanno cercando disperatamente di ridurre la dipendenza dagli attori taiwanesi con finanziamenti mastodontici per i player nazionali. Quel momento appare ancora lontano, ma quando uno o l’altro non avranno più bisogno di Taiwan, verrà meno uno dei motivi per evitare la guerra.
Quello che può succedere dipenderà molto dalla percezione che Pechino avrà sul tempo e sulle proprie opportunità di vincere un possibile conflitto, possibilmente senza il coinvolgimento degli Stati Uniti. La vicenda ucraina non è collegata a quella taiwanese ma ha portato un insegnamento importante a Pechino: se ci sarà invasione dovrà essere il più veloce possibile. Per questo sembrano decadere le possibilità di uno stress test su un’isola minore come Kinmen o Matsu, arcipelaghi a pochi chilometri di distanza dalle coste del Fujian con gli abitanti che si percepiscono come cinesi (della Repubblica di Cina fondata da Sun Yat-sen) e non come taiwanesi e tradizionale punto di interconnessione sullo Stretto. L’ipotesi era valida se si pensava che tale azione avrebbe portato il governo taiwanese a negoziare. Ma i fatti degli ultimi mesi, a partire dalle rispettive reazioni dopo l’invasione russa, vanno in direzione opposta. Attaccare solo queste isole potrebbe significare perdere l’ultima speranza di dialogo col resto del territorio amministrato da Taipei. Gli analisti militari taiwanesi credono che se Pechino opterà per un’azione militare sceglierà l’invasione su larga scala. Ma i tempi non sarebbero ancora maturi. Nella prima fase vanno trasportate almeno 60mila truppe ma per ora ne possono portare solo la metà.
Fino a qualche tempo fa, Pechino era convinta che il tempo fosse dalla sua parte. Ora ci sono molte variabili ed è ansiosa. Questo rende la situazione più pericolosa. Anche perché nel frattempo, dopo essere entrata regolarmente nello spazio di identificazione di difesa aerea, Pechino ha cancellato anche la “linea mediana”, non riconosciuta ma ampiamente rispettata fino alle scorse settimane. Una sorta di “confine” sullo Stretto che ora non c’è più. Mezzi aerei e navali cinesi e taiwanesi saranno sempre più a stretto contatto, aumentando il rischio di incidenti. Anche perché, come spiega Chieh Chung della National Policy Foundation di Taipei, “oltre la linea mediana non arriveranno solo navi da guerra ma anche guardia costiera e milizia marittima”. Un po’ come accaduto intorno alle isole Senkaku/Diaoyu, contese tra Cina e Giappone, dopo la crisi del 2012.
Senza trascurare altri due scenari: un blocco navale e un decapitation strike. Nel primo caso, se le navi dell’Esercito popolare di liberazione circondassero l’isola principale di Taiwan per oltre due settimane metterebbero in grande crisi le riserve di energia e materie prime, con possibili tumulti interni. Anche se una strategia di questo tipo darebbe il tempo di reagire alle forze militari taiwanesi ed, eventualmente, americane. Nel secondo caso, invece, Taipei potrebbe subire un’operazione speciale mirata a eliminare i leader politici e strategici.
Nel frattempo, Pechino affila anche le sue armi normative. La lista nera dei “secessionisti” continua ad allungarsi con politici e diplomatici taiwanesi di primo livello, con conseguenze anche per individui e aziende in qualche modo collegati. I quasi due milioni di taiwanesi presenti in Cina continentale potrebbero diventare obiettivi, mentre circola l’ipotesi di una nuova “legge per la riunificazione” in superamento dell’attuale “legge anti secessione” del 2005, disegnata sull’esempio della legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong. Non avrebbe vigore a Taiwan, fin quando almeno il Partito comunista non ne dovesse prendere il controllo, ma rappresenterebbe una base “legale” per future azioni e per esercitare pressioni sulle autorità straniere nei loro rapporti con Taipei e i taiwanesi.
Non conforta i taiwanesi quello che manca nel nuovo libro bianco. Nel documento manca un passaggio chiave contenuto nei precedenti del 1993 e del 2000: quello in cui Pechino garantiva che non avrebbe inviato truppe o personale amministrativo sull’isola una volta raggiunta la “riunificazione”. E le parole di Lu Shaye, ambasciatore cinese in Francia, sulla necessità di “rieducare” i taiwanesi dopo che sono stati “indottrinati e intossicati” da un’educazione di “desinicizzazione” non lasciano certo presagire un alto grado di autonomia anche qualora Taipei dovesse accettare il modello “un paese, due sistemi”. Eventualità sempre più remota dopo quanto accaduto negli scorsi anni nell’ex colonia britannica.
Se è certo che le pressioni di Pechino e le azioni diplomatiche e legislative americane proseguiranno (gli Usa discuteranno presto il Taiwan Policy Act che darebbe ulteriore spazio di manovra diplomatica a Taipei), la fase tra il 2024 e il 2027 potrebbe essere particolarmente delicata. Elezioni taiwanesi col possibile avvento di William Lai, una figura ben più radicale della centrista Tsai, elezioni americane e poi il XXI Congresso del Partito comunista. Questione di tempo e di finestre di opportunità. Coi fatti di queste settimane il rischio che qualcuno possa provare ad aprire queste finestre per vedere che cosa c’è fuori si è fatto più concreto.
Questo articolo è pubblicato anche sul numero di settembre/ottobre di eastwest.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
La cornice è spessa e luminosa. Il quadro, però, è appena abbozzato. Alleanza, partnership strategica, amicizia senza limiti. Sono alcune delle formule utilizzate per definire le relazioni tra Cina e Russia. Cercare di entrare nelle pieghe di questo rapporto, suggellato dalla visita di Vladimir Putin a Xi Jinping del 4 febbraio scorso per l’apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino, non è solo un esercizio lessicale. Soprattutto dopo la guerra in Ucraina, che sta mettendo in luce come tante presunte alleanze siano state magnificate in un mondo non (ancora) diviso in sfere d’influenza e nel quale i posizionamenti e gli interessi sono profondamente asimmetrici. Un mondo nel quale la Russia, dalla guerra in Crimea in poi, si è avvicinata sempre più alla Cina. Dopo essersi accorta che la guerra commerciale di Donald Trump celava il desiderio ben più vasto di contenerne l’ascesa, a sua volta Pechino si è avvicinata a Mosca. Una comunione d’intenti innanzitutto retorica, basata sull’ostilità nei confronti di Stati Uniti e Nato, ancor prima che commerciale o soprattutto militare.
La Cina guarda alla Russia soprattutto come un esempio da non imitare. Il crollo verticale dell’Unione Sovietica è una lezione alla quale il Partito comunista continua a guardare per non ripetere gli stessi errori. Le conseguenze della perestrojka di Gorbacev, bollata come “liberalizzazione borghese” da Deng Xiaoping, hanno convinto Pechino che le riforme economiche non avrebbero dovuto essere accompagnate da riforme politiche. Gli avventurismi militari del nostalgico Putin hanno creato più di un imbarazzo a Xi Jinping. Non è un caso che la Cina non abbia mai riconosciuto la Crimea, così come non riconosce ora le repubbliche secessioniste di Donetsk e Lugansk. I motivi sono molteplici. Il primo: per non subire quelle che considera interferenze esterne su dossier come Hong Kong e soprattutto Taiwan, Pechino non può che difendere l’integrità territoriale degli altri paesi “parte dell’Onu” (e dunque non di Taipei), Ucraina compresa. Il governo cinese non ha peraltro mancato di sottolineare le differenze tra Taipei e Kiev, sostenendo che la Cina è “l’unico membro permanente del consiglio di sicurezza a non aver completato la propria riunificazione”. Il secondo: ciò comporterebbe la rottura dei rapporti con l’Occidente.
Pechino tesse da decenni la sua tela ed è convinta di potersi mettere al centro del palcoscenico globale grazie alle sue arti diplomatiche e ai suoi tentacoli commerciali ormai insinuatisi in tutto il mondo attraverso la Belt and Road. Dietro le quinte, il fastidio per i colpi di testa russi non manca. Mosca è vista come il partner irascibile che invadendo l’Ucraina rischia di gettare in aria un tavolo sul quale Pechino muoveva con pazienza le proprie pedine convinta di avere il tempo dalla sua parte. I passi cinesi verso la Russia erano stati fatti in maniera visibile, apposta per essere visti. Con parole ripetute a voce alta, apposta per essere udite. Ostentare la profondità di un’alleanza non ancora compiuta sul piano concreto è considerato strategico, insieme leva negoziale e deterrente nei confronti dei rivali.
Diversi segnali, dalla mancanza di un piano di evacuazione dei cittadini cinesi alla macchina retorica che si era già messa in moto per giustificare la “piccola incursione” nel Donbass di cui aveva parlato anche Joe Biden, lasciano pensare che il governo cinese non si aspettasse un’azione su così larga scala. Nonostante questo, non può apertamente condannarla. La firma del documento congiunto solo qualche settimana prima dell’invasione, nonché il forte rapporto anche personale tra Xi e Putin, fanno sì che per Pechino sia impossibile scaricare Mosca. Da una parte per non creare problemi sul fronte interno, già aperti dai malumori sulla strategia zero Covid e per il rallentamento dell’economia, nell’anno del XX Congresso e della probabile terza investitura di Xi. Dall’altra perché incolpare la Nato e gli Usa della guerra è funzionale agli obiettivi cinesi in Asia-Pacifico. Per la Cina l’estensione a est dell’Alleanza Atlantica è la prova che Washington abbia gettato “benzina sul fuoco”, causando il conflitto. Allo stesso modo, iniziative come Quad o Aukus sono lette come tentativi di “accerchiare” Pechino che, dunque, se dovesse reagire in qualche teatro come Taiwan o il mar Cinese meridionale lo farebbe in reazione alla “minaccia” portata dagli Usa e i suoi alleati. Anche perché Xi sa che per il Pentagono la Russia è come uno tsunami, mentre la Cina è il cambiamento climatico.
Allo stesso tempo, pur diffondendo la propaganda anti occidentale sui propri media, Pechino non può nemmeno appoggiare esplicitamente l’invasione russa. Nonostante si stia preparando già da tempo a rendersi più impermeabile alle turbolenze esterne: autosufficienza tecnologica, doppia circolazione e prosperità comune hanno tutte questo obiettivo. Ma la transizione da fabbrica del mondo a società di consumi non è ancora completata e l’economia cinese continua a reggersi su progetti infrastrutturali a debito ed esportazioni. In un ipotetico decoupling, o in un ritorno di un mondo a blocchi, la Cina avrebbe molto da perdere. La Russia sta provando a tirare fuori la Cina dalla sua ambiguità strategica, per esempio alimentando le tensioni col vicino Giappone sulle isole Curili o intensificando i passaggi navali nello stretto di Tsugaru.
Ma dietro la coltre retorica, sul piano pratico la Cina non sta venendo meno alla sua neutralità. Vero che nel primo trimestre del 2022 l’interscambio commerciale è aumentato del 30,45% rispetto allo scorso anno. Ma è altrettanto vero che la rapidità dell’aumento è diminuita rispetto a 12 mesi fa (+35,8%) e l’aumento registrato a marzo (+12,76%), quindi dopo l’invasione, è stato molto più blando di quello registrato a febbraio (25,7%). Non solo. Le raffinerie statali stanno onorando i contratti esistenti sul petrolio russo, ma stanno evitando di siglarne di nuovi, nonostante i forti sconti promessi dal Cremlino. Per quanto riguarda i rapporti energetici, il gas che per ora fluisce verso l’Europa non ha una via alternativa verso la Cina. UnionPay, elaboratore di carte di credito cinese, sta rifiutando le richieste di assistenza delle banche russe, che cercano alternative dopo che Visa e MasterCard hanno sospeso le operazioni nel paese. Persino Huawei, il colosso tecnologico finito nel mirino dell’amministrazione Trump, ha messo in pausa le proprie operazioni in Russia. Se non dovesse riavviarle presto le conseguenze per Mosca sarebbero rilevanti. Tutti elementi che dimostrano come la Cina voglia evitare a tutti i costi di finire nel mirino di sanzioni internazionali. Per questo, pur condannandole a livello politico, in larga parte le rispetta a livello commerciale.
Le asimmetrie tra Cina e Russia non sono finite. Basti pensare ai rapporti stretti che Mosca intrattiene con India e Vietnam. Entrambi i paesi spendono cifre ingenti per assicurarsi armi e sistemi difensivi russi. Entrambi i paesi sono rivali regionali di Pechino. Con l’apparente paradosso che Nuova Delhi utilizza droni armati spediti dal Cremlino per pattugliare l’enorme confine conteso con la Repubblica popolare, dove gli scontri violenti di circa due anni fa hanno causato una crisi diplomatica e strategica ancora irrisolta. Mentre Hanoi naviga con sottomarini made in Russia nelle acque contese del mar Cinese meridionale. Lungo la via artica, sulla quale Xi conta per implementare la sua “Via della Seta polare”, la Russia ancora non apre alle navi del gigante asiatico la rotta più interna e dunque più vicina alle sue coste e infrastrutture sensibili. La rottura totale dei rapporti con l’Occidente può portare Mosca a rivedere le sue posizioni e divenire sempre più quello che non vorrebbe essere: il fratello minore della Cina. Durante la guerra fredda, quel ruolo spettava a Mao Zedong, il quale aprì la porta agli Usa per dismetterlo. Nell’idea di “futuro condiviso” di Xi quel posto potrebbe essere riservato a Putin.
Questo articolo è pubblicato anche sul numero di maggio/giugno di eastwest.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Pechino vuole la “riunificazione”. Washington vuole impedirla. Da una parte annunci più o meno virulenti sul possibile utilizzo della forza e incursioni aeree, dall’altra vendita di armi e un’ambiguità strategica che con Joe Biden sta diventando sempre meno ambigua. La sfida su Taipei appare sempre più LA sfida dei prossimi anni. Eppure, mentre si analizzano mosse e volontà delle due potenze, resta spesso sfumato un aspetto fondamentale: che cosa vuole Taiwan. Aspetto che resta spesso sfumato in una narrazione binaria che non coglie la complessità di quella che viene descritta come “isola” ma che è in realtà un insieme di 166 isole. E non sempre c’è di mezzo il famoso Stretto. A Kinmen, avamposto militare bersaglio dei bombardamenti di Mao Zedong negli anni Cinquanta, la metropoli cinese di Xiamen dista solo due chilometri e mezzo. Luogo sospeso nello spazio e nella storia dove assume un senso concreto il nome ufficiale di Taiwan: Repubblica di Cina. Da qui Chiang Kai-shek sognava di lanciare la riconquista della madrepatria. Negli anni il desiderio ha lasciato posto alla paura di subire un’invasione. Ma la gente del posto non crede all’ipotesi: “La guerra? Discorsi da politici, nella realtà i rapporti tra Kinmen e Xiamen sono sempre stati ottimi”, ripete la grande maggioranza.
Anche a Taipei e nelle principali città taiwanesi non si respira un clima da bunker. Oltre la metà dei taiwanesi ritiene “improbabile” una guerra con la Repubblica Popolare entro i prossimi dieci anni. Le incursioni dei velivoli di Pechino nello spazio di identificazione di difesa aerea sono percepite più come una parata militare che come preparativi di invasione. Nemmeno all’inizio di ottobre, quando si sono verificate 156 incursioni in quattro giorni, il sentimento prevalente era di “paura”. Tra gli over 30 si ricorda la terza crisi sullo Stretto del 1995-1996 come un momento di vera crisi. Tra i più giovani prevale la rabbia. D’altronde, più Pechino mostra i muscoli e più i taiwanesi se ne allontanano. Lo si evince dai sondaggi annuali della National Chengchi University sui rapporti intrastretto. I numeri mostrano che la stragrande maggioranza dei taiwanesi, l’85,6%, vuole lo status quo, pur con diverse sfumature. Il 28,8% vuole lo status quo per decidere successivamente, il 25,8% per andare verso l’indipendenza, il 5,6% per andare verso l’unificazione. Dal 2019 il secondo dato è aumentato molto, mentre il terzo è diminuito. Alla base la crescente assertività di Xi Jinping sulla “riunificazione” e il possibile utilizzo della forza e la repressione di Hong Kong. Il prepensionamento del modello “un paese, due sistemi” ha reso sempre meno appetibile un possibile accordo con Pechino, che aveva intenzione di offrire lo stesso paradigma a Taipei.
Il 25,5% vuole invece lo status quo a tempo indefinito. È quello che dice di volere la Presidente Tsai Ing-wen, che seguendo la teoria dei due Stati concepita da Lee Teng-hui ritiene non ci sia bisogno di una dichiarazione di indipendenza in quanto Taiwan è già indipendente de facto come Repubblica di Cina. Il Guomindang, principale partito d’opposizione, non si è mai discostato dal principio della “unica Cina” e dal “consenso del 1992” nel quale si era formalizzato con Pechino l’accordo sul disaccordo in merito a chi fosse quella legittima. Il Partito democratico progressista invece sostiene che di fatto esistono due Cine. Restando in un comunque insidioso perimetro che non prevede la dichiarazione di indipendenza come Repubblica di Taiwan, Tsai sta insistendo su una costruzione identitaria taiwanese nella quale emerga non solo l’alterità politica nei confronti della Repubblica popolare, ma anche quella etnico-linguistica e persino storica. Ecco allora i finanziamenti a film e serie tv che evidenziano (e talvolta mitizzino) il multiculturalismo taiwanese e rimandano al progressismo di Taipei in materia di diritti civili.
Nel frattempo, le relazioni commerciali proseguono spedite. La Repubblica popolare è saldamente il primo partner commerciale di Taiwan. A novembre 2021, le esportazioni taiwanesi verso la Cina hanno pesato da sole il 41,2% del totale. E il volume è in crescita del 18,9% su base annuale. Si parla di possibili divieti di esportazione per prodotti tecnologici verso Pechino ma in realtà è già da diverso tempo che gli Stati Uniti premono Taiwan per bloccare l’export, in particolare di semiconduttori. Il colosso taiwanese TSMC è leader mondiale nella fabbricazione e assemblaggio di chip e ne controlla oltre il 50% dello share globale. Eppure, dopo il ban trumpiano del 2020 per i rifornimenti a Huawei il posto del gigante di Hsinchu è stato preso da un altro competitor taiwanese, MediaTek, che ha conquistato una posizione dominante nella catena di approvvigionamento dei marchi cinesi di smartphone. TSMC ha appena chiuso altri accordi con Oppo.
Ad aprile sono state interrotte le spedizioni alla Tianjin Phytium Information Technology, impegnata nello sviluppo dei supercomputer, solo dopo ripetute insistenze di Biden. Taipei è titubante sul recidere quel cordone tecnologico e a realizzare il decoupling desiderato dalla Casa Bianca. Da una parte per gli interessi commerciali delle sue aziende, dall’altra per motivi politici. In assenza di dialogo tra i governi, infatti, i colossi tecnologici svolgono una funzione semidiplomatica. Non è un caso che proprio TSMC e Foxconn abbiano trattato con la cinese Fosun Pharma l’acquisto di dieci milioni di dosi di Pfizer all’alba della campagna vaccinale taiwanese.
Rimuovere quella leva diplomatica toglierebbe un asset importante a disposizione di Taipei nel gioco a specchi con Pechino. Anche per questo, oltre che a fronte del crescente pressing militare cinese, a Washington viene chiesta una maggiore chiarezza strategica. In questo senso va letto l’annuncio di una “non notizia”: la presenza di un contingente militare statunitense in territorio taiwanese, dato di fatto conosciuto anche da Pechino e mantenuto implicito per decenni. Seguendo Xi, anche Taipei ha alzato i giri della retorica del conflitto intrastretto. Se una volta ai media taiwanesi, a partire dall’agenzia di stampa CNA, veniva indicato di non dare risalto alle manovre militari cinesi per non generare insicurezza o far apparire debole il governo, ora dall’esecutivo arrivano indicazioni opposte.
I recenti report del Ministero della Difesa avvisano con un’urgenza in precedenza sconosciuta delle capacità militari di Pechino. Obiettivo: stimolare la prontezza a combattere dei taiwanesi e, soprattutto, a chiedere aiuto all’esterno durante una finestra d’opportunità diplomatica fertile come quella attuale. Con le opportunità ci sono però anche i rischi, che per i taiwanesi sono rappresentati più dall’arsenale normativo a disposizione di Pechino che non da quello militare. Sanzioni e blacklist annunciate di recente spaventano più degli aerei militari perché possono colpire le imprese e i tanti cittadini taiwanesi residenti oppure operanti oltre lo Stretto. Il patron di Far Eastern Group ha per esempio già dovuto disconoscere l’indipendenza taiwanese dopo che la sua azienda era stata multata per aver finanziato un evento pubblico al quale aveva partecipato il premier taiwanese Su Tseng-chang, inserito nella lista nera di Pechino. Il rischio che si estenda l’interpretazione dell’appoggio al cosiddetto “secessionismo” esiste.
Ma questa misura potrebbe creare una frattura ancora più profonda tra le due sponde dello Stretto. Più il tempo passa e più la narrazione identitaria sembra avere presa. Basta guardare ai dati secondo i quali ormai il 65% dei cittadini si considera “solo taiwanese”, con poco meno del 30% “sia taiwanese sia cinese” e il 2,6% “solo cinese”. Nel 1992 a definirsi “solo taiwanese” era il 17,6%. Un trend che pare inarrestabile e che mette in difficoltà il Guomindang. I nazionalisti hanno appena cambiato leader e hanno aperto un ufficio a Washington per cercare di lanciare la corsa verso le elezioni del 2024. Sarà forse l’ultima spiaggia per loro e per il riavvio del dialogo politico tra Taipei e Pechino.
Questo articolo è pubblicato anche sul numero di gennaio/febbraio di eastwest.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Quando si pensa di averla compresa, sorprende sempre. La Cina sta di nuovo cambiando volto. Non è ancora chiaro quali saranno le sembianze finali, ma si iniziano a intravederne i tratti. “Prosperità comune” è il concetto chiave che torna più spesso. Il discorso del 17 agosto di Xi Jinping promette di essere un manifesto politico in vista del fondamentale congresso del 2022 che dovrebbe consegnargli il terzo mandato, nonché il pilastro della nuova era che il Partito comunista è pronto a lanciare.
L’adozione di una nuova “risoluzione sulla storia”, al plenum di novembre, rappresenta un passaggio fondamentale. In passato, tale operazione era stata compiuta solo nel 1945 e nel 1981. In entrambi i casi fu funzionale a una maggiore assunzione di potere dei leader dell’epoca, Mao Zedong e Deng Xiaoping, che imposero la propria linea archiviando l’era precedente. Se il “piccolo timoniere” aveva rinnegato la Rivoluzione Culturale e lanciato la stagione della Riforma e Apertura, ora Xi vuole dare nuovo impulso al suo sogno cinese di “ringiovanimento nazionale”. Obiettivo da perseguire attraverso un maggiore controllo dell’economia privata, come già anticipato dal sistema della doppia circolazione lanciato nel 2020, una redistribuzione della ricchezza e un modello di sviluppo più controllato. Anche a patto di provocare un “rallentamento strutturale” alla crescita, come spiegato da Giuliano Noci del Politecnico di Milano. I primi segnali sono arrivati dai dati sul Pil del terzo trimestre, influenzati dalla doppia crisi immobiliare ed energetica ma anche dalla stretta sui colossi digitali.
L’altra (omessa) faccia della medaglia della “prosperità comune” è infatti un potere sempre più concentrato nelle mani del Partito comunista che si fa ancora più pervasivo in tutti i gangli della vita economica e sociale della Cina. La priorità, come sempre, è la stabilità e l’imposizione di una narrativa nella quale il Partito resta sempre al centro, unico possibile garante dell’ordine e agente propulsore di una società più equa. Dopo l’epoca delle privatizzazioni e del capitalismo sfrenato, il Partito torna un po’ più comunista (non a caso negli ultimi anni le citazioni di Marx da parte di Xi sono aumentate) per intercettare qualche segnale di malessere e insoddisfazione nella popolazione cinese. Entrano così nel mirino le grandi concentrazioni di denaro, le azioni spericolate a debito fatte sulla pelle dei piccoli investitori, gli orari di lavoro massacranti imposti dai “capitalisti cattivi”.
L’episodio di Jack Ma sembrava rispondere al classico metodo “colpirne uno per educarne cento”. In realtà, si è poi compreso che la vicenda di Ant Group e Alibaba era solo l’inizio di un processo nel quale il Partito ne colpisce tanti per educare tutti. Improvvisamente, i campioni tecnologici nazionali sono diventati esempi di avidità, chiamati a condividere il proprio successo con le piccole e medie imprese, entità alle quali si sta pensando di dedicare una nuova borsa da aprire a Pechino. La stretta a tenaglia sui colossi digitali è duplice: politica e normativa. Ed ecco allora la triade di leggi su privacy, cybersecurity e protezione dei dati personali, o ancora l’applicazione più severa delle regole antitrust a contrasto di posizioni dominanti in realtà sedimentatesi nel corso del tempo. O ancora la sentenza del Supremo Tribunale Popolare che ha messo fuorilegge il cosiddetto “996”, la massacrante prassi lavorativa imposta dalle grandi piattaforme. Il Partito si propone di correggere e standardizzare comportamenti e pratiche che “pregiudicano gli interessi della popolazione e impediscono una competizione giusta sulla strada dello sviluppo, prevenendo il monopolio delle piattaforme e l’espansione disordinata del capitale”, come ha spiegato Xi in uno dei suoi discorsi pre-plenum.
Sotto la patina di una linea politica popolare (c’è anche chi direbbe populista, con caratteristiche cinesi), scorre il petrolio dei dati. La gran parte del nuovo arsenale normativo di cui si stanno dotando le autorità gravita intorno al controllo di quella miniera di informazioni che il Partito sta provando a togliere dalla disponibilità esclusiva dei privati. Succede per esempio sul fronte dei pagamenti digitali, con la recente richiesta di spacchettamento delle attività di Alipay e la contestuale consegna dei dati dei clienti utilizzati dall’unità dei servizi di microprestito a una nuova joint-venture di valutazione del credito che sarà in parte di proprietà statale. Sono inoltre state dichiarate illegali tutte le attività collegate alle criptovalute, mentre la banca centrale si prepara a lanciare la sua moneta digitale tracciabile e centralizzata.
Attraverso questo “smembra et impera” si raggiunge un triplo obiettivo: rafforzare la nuova retorica della redistribuzione e il ruolo del Partito, togliere il controllo dei dati ai giganti privati e, infine, impedirne la potenziale evoluzione in centri di potere non solo finanziario ed economico ma anche come portatori di istanze politiche. Non a caso la vicenda di Jack Ma è partita proprio da degli appunti mossi dal fondatore di Alibaba su alcune politiche finanziarie portate avanti dal Governo. Non possono più essere celebrate nemmeno figure come quella di Xu Jiayin, il fondatore di Evergrande, il colosso immobiliare che barcolla sull’orlo del default. Xu si è arricchito sfruttando due tendenze storiche della Cina degli ultimi decenni: urbanizzazione ed estensione della classe media. Ma lo ha fatto con un modello esposto a rischi finanziari e all’accumulazione di debito. Un modello che gli ha consentito di diventare prima l’uomo più ricco di Cina e poi l’uomo più ricco d’Asia, traguardi ostentati con l’acquisto di squadre di calcio, jet privati e mega yacht. Se fino a qualche tempo fa tutto questo rendeva Xu un simbolo della crescita cinese, ora lo rende un perfetto bersaglio nei tempi dello sviluppo “controllato” e della “prosperità comune”. Anche a questo, oltre che agli oggettivi problemi economici, si deve il mancato salvataggio di Evergrande, sulla quale invece il Partito sembra voler operare un ennesimo spacchettamento degli asset.
Nella nuova era cinese sembra esserci sempre meno spazio anche per qualsiasi forma di associazionismo. In questo senso vanno letti, per esempio, gli interventi sui gruppi a difesa dei diritti della comunità LGBT+, che negli scorsi mesi sono stati cancellati e chiusi a decine sulla rete cinese. Non si tratta tanto di omofobia, quanto della necessità di tenere sotto controllo qualsiasi movimento possa creare elementi di instabilità attraverso il perseguimento di istanze sociali. La “sicurezza nazionale”, altro mantra della Cina di Xi, viene prima di tutto. Parallelamente, è in corso una “campagna di rettificazione” dello star system e della fan culture. A fine agosto, la Commissione centrale per l’ispezione disciplinare ha annunciato di voler mettere ordine alla “caotica” industria dell’entertainment, colpendo le abitudini “malsane” che “instillano valori scorretti” nei giovani. Dopo il caso del cantante sinocanadese Kris Wu, arrestato con l’accusa di molestie, erano apparsi sui gruppi di suoi fan messaggi di solidarietà e persino ipotetici piani per liberarlo dal carcere. Nel giro di pochi giorni sono stati cancellati più di 150mila post, oltre 4 mila account e circa 1300 gruppi, mentre sono state rimosse 39 app legate a celebrità o a competizioni tra star.
Non a caso, nel “decalogo” della nuova campagna è inclusa anche la messa al bando delle “idol competition“, programmi in cui le star si sfidano per conquistare i voti degli utenti. In diversi articoli degli scorsi mesi, i media di stato hanno descritto la fan culture come un “culto” che può facilmente diventare un bersaglio di “forze straniere che vogliono dividere la società cinese”. Le celebrità devono proporre un’immagine “sana” e “patriottica” e non proiettarsi, anche involontariamente, al di sopra delle regole o del ruolo del Partito.
La “prosperità comune”, ha spiegato da Xi, “è il requisito essenziale del socialismo e una caratteristica importante della modernizzazione in stile cinese” e ostacolo all’estremizzazione delle “disparità sociali” come invece accaduto in Occidente. La sfida, non semplice, sarà quella di mantenere un equilibrio tra efficienza ed equità. A 40 anni dall’ultima volta, la Cina si sta preparando a un passaggio fondamentale. Non si sa ancora come ne uscirà, ma di certo ne uscirà diversa.
Questo articolo è pubblicato anche sul numero di novembre/dicembre di eastwest.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Da una parte Washington, dall’altra Pechino. Il Sud-est asiatico è abituato a essere al centro delle trame geopolitiche delle due principali potenze. Ma da periferia sta diventando centro, da corollario tangenziale a campo di gioco principale. Lo testimonia il doppio pressing diplomatico portato avanti nelle scorse settimane sia dagli Stati Uniti sia dalla Cina. Antony Blinken e Wang Yi, rispettivamente segretario di Stato Usa e Ministro degli Esteri cinese, sono particolarmente attivi sulla regione con visite, incontri, summit e dialoghi bilaterali e a livello di blocco. Proprio nei giorni scorsi il capo della diplomazia a stelle e strisce ha concluso il suo viaggio tra Malesia e Singapore, con la tappa thailandese cancellata a causa degli effetti di Omicron.
Blinken ha manifestato la volontà di elevare i rapporti tra Stati Uniti e Asean a “livelli senza precedenti” nei settori della sicurezza e dell’economia, promettendo importanti investimenti nel commercio, nel digitale e nelle infrastrutture. E nelle acque del Mar Cinese meridionale e del Pacifico appaiono sempre più navi appartenenti a flotte internazionali. Non solo Stati Uniti ma anche Francia, Regno Unito, Australia, Germania e persino Paesi Bassi.
Da quando alla Casa Bianca siede Joe Biden, Washington ha chiarito all’Asean che il periodo di Donald Trump è archiviato. Se l’ex Presidente marcava visita da lungo tempo ai summit del blocco regionale del Sud-est asiatico, Biden ha deciso di collegarsi alla prima occasione utile. I rapporti con Indonesia (tra l’altro Presidente di turno del G20 fino al 30 novembre 2022) e Filippine, che con modi e gradi diversi sembravano essere in avvicinamento a Pechino negli anni precedenti, sono stati riavviati. Pur in attesa delle elezioni presidenziali a Manila del prossimo maggio, che potrebbero rimescolare le carte dopo che Rodrigo Duterte è tornato sui suoi passi e ha rinnovato il Visiting Forces Agreement che aveva più volte minacciato di stracciare.
C’è però un’ombra nella strategia americana. Ed è rappresentata dalla figura della Cambogia. Sì, perché il 1° gennaio 2022 Phnom Penh assumerà ufficialmente la presidenza di turno dell’Asean. Non è un mistero che la Cambogia abbia ottimi rapporti con Pechino e Washington teme che la sua presidenza di turno possa favorire il rivale. Una postura filo-cinese dai connotati storici, che è stata rivendicata dal governo nazionale anche nel 2019, quando il Primo Ministro Hun Sen ha definito la Cambogia un “amico di ferro” della Cina. Proprio Hun Sen è stato il primo e unico leader straniero a visitare Xi Jinping a Pechino durante le prime fasi di quella che allora era ancora descritta come un’epidemia con epicentro a Wuhan.
La Cina intravede mosse favorevoli, a partire dalla questione del Mar Cinese meridionale. La Cambogia non appare interessata a internazionalizzare il dossier come vorrebbero invece altri attori. Se con la presidenza di turno del Vietnam del 2020 si era ottenuto un documento unitario sull’argomento, appare più complicato questo possa succedere durante l’anno cambogiano. Gli Usa accusano tra l’altro da tempo Phnom Penh di dare accoglienza a mezzi militari cinesi, in particolare nella base navale di Ream. Sospetti acuiti dal mancato accesso completo fornito alla vicesegretaria di Stato Wendy Sherman durante una visita della scorsa estate. In tale ottica si può leggere il recente embargoalla vendita di armi istituito da Washington nei confronti della Cambogia.
Anche sulla vicenda Myanmar ci si aspettano contrasti sia nei rapporti con Washington sia all’interno della stessa Asean. Dopo aver ribadito con forza il principio di non interferenza rivendicato dall’Associazione come caposaldo del suo paradigma di valori, Phnom Penh sembra intenzionata a riavviare il dialogo con la giunta militare dopo che la stessa era stata esclusa dagli ultimi vertici regionali. Tra le altre cose, Hun Sen ha subito annunciato una visita in Myanmar durante la quale incontrerà il generale Min Aung Hlaing. Il 2022 presenta un menù interessante, e piccante, sulla direttrice del Sud-est.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Recuperare insieme, recuperare forte. È l’auspicio del tema della presidenza di turno del G20 del 2022, quella dell’Indonesia. Si tratta della prima volta storica non solo per Giacarta ma anche per un Paese dell’area Asean. Non sarà l’ultima, visto che entro il 2030 le dieci economie che fanno parte dell’Associazione delle Nazioni del Sud-est Asiatico dovrebbero diventare tutte insieme la quarta economia mondiale. E a fare da traino, come da tradizione, ci sarà l’Indonesia, vero fulcro economico e commerciale di una regione protagonista di una forte crescita che il mero dato del prodotto interno lordo non riesce a restituire in maniera completa.
Da sempre, Giacarta svolge il ruolo di rappresentante Asean all’interno del Gruppo dei Venti, nonché quello di mediatore tra le economie occidentali e i Paesi Brics. Il processo di crescita dell’Indonesia rispetto a quando il G20 fu fondato è stato imponente, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista geopolitico.
All’epoca la crisi finanziaria asiatica ebbe un impatto violento sull’economia di Giacarta, ma il processo di democratizzazione che ne è seguito ha fatto crescere a ritmi sostenuti un Paese sostenuto da una demografia in espansione e dalla rilevanza diplomatica in netto rafforzamento.
Il Presidente Joko Widodo ha ricevuto il passaggio del testimone dal Presidente del consiglio italiano Mario Draghi durante il summit di Roma del 30 e 31 ottobre. “Questo è un onore per noi, per l’Indonesia, e allo stesso tempo una grande responsabilità, che dobbiamo svolgere bene”, ha detto Widodo, che ha già annunciato i pilastri della presidenza indonesiana: ambiente e partenariato, promozione della produttività, aumento di resilienza e stabilità, assicurazione di una crescita sostenibile e inclusiva, creazione di una leadership globale collettiva più forte. L’intenzione di Giacarta è quella di far cambiare il passo al G20 dopo due anni dominati dall’emergenza. Anche nel 2022 la pandemia non terminerà di colpo, ma l’Indonesia è convinta che sia l’anno giusto per trovare una strategia di uscita concreta e di lungo termine per uscire dalla crisi e sostenere la ripresa e la crescita futura.
Tra i focus annunciati anche la standardizzazione dei pagamenti transfrontalieri e l’accelerazione della transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, con una spinta alla finanza sostenibile. Attenzione anche all’inclusione finanziaria digitale, con un occhio di riguardo per le comunità meno servite, ma anche donne, giovani e piccole e medie imprese. Previsti anche passi avanti sulle strategie di pianificazione fiscali internazionali come Base Erosion and Profit Sharing.
L’Indonesia vede la presidenza, cominciata ufficialmente il 1° dicembre e che culminerà nel summit di Bali dell’ottobre 2022, come una forma di riconoscimento internazionale della propria ascesa a diventare una delle più grandi economie mondiali, ma soprattutto si sente come rappresentante delle altre economie in via di sviluppo che non fanno parte del consesso. Allo stesso tempo, Giacarta percepisce l’appuntamento come un’occasione per mettere in mostra le opportunità rappresentate dal suo mercato, nonché tutta l’offerta disponibile nel settore turistico e produttivo.
Vista la grande esposizione dell’Indonesia agli effetti del cambiamento climatico, ci si può aspettare un’azione incisiva sul tema della transizione energetica. Ma completare questa transizione non sarà per niente semplice. Il territorio indonesiano è composto da oltre 17mila isole e la capitale Giacarta sta sprofondando. I progetti sono tanti e ambiziosi, come un parco solare a Java che verrà completato entro la fine del 2022 e sarà, con i suoi 145 megawatt, il più grande del Paese. Allo stesso tempo, le attività produttive sono profondamente radicate intorno alle fonti fossili.
A livello geopolitico, interessante la posizione di Giacarta che per ora è sempre riuscita a mantenere un punto di equilibrio tra Washington e Pechino. Il recente incidente intorno alle isole Natuna, al centro di una disputa territoriale con la Repubblica popolare, potrebbe portare a qualche tensione con il grande vicino asiatico. Attenzione anche al triangolo con la Cambogia, che nel 2022 ha la presidenza di turno dell’Asean, che potrebbe così fare dei passi verso la Cina.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
L’ultima volta, nel novembre del 2017, gli era andata male. Si erano schierati contro di lui persino 17 membri del suo partito e aveva dovuto lasciare la carica di Primo Ministro.
Stavolta invece, Manasseh Sogavare ha superato l’esame e ha passato indenne il voto di fiducia che si è svolto nel Parlamento delle Isole Salomone. Solo 15 hanno votato per rimuoverlo dal suo posto, mentre in 32 hanno scelto di stare dalla sua parte. Il premier di questo arcipelago del Pacifico meridionale resterà dunque al suo posto, alla guida di un Paese la cui importanza strategica si sta manifestando in maniera sempre più evidente di fronte al caos delle ultime settimane.
Sogavare è stato costretto a questo appuntamento per la mozione dell’opposizione, che lo accusa di corruzione e di aver utilizzato fondi cinesi per sostenere il suo Governo. Intorno a una vicenda che ha profonde radici nella storia di questa nazione insulare e nelle sue divisioni interetniche, si è infatti innestato un argomento del tutto geopolitico. Tra i motivi delle proteste delle ultime settimane c’è infatti la decisione, ufficializzata nel 2019, di Sogavare di rompere i rapporti diplomatici con la Repubblica di Cina (Taiwan) e stabilire quelli con la Repubblica popolare cinese. Attenzione: le rivolte non nascono per questo, ma il triangolo con Taipei e Pechino è di certo uno degli ingredienti di un menù ben più composito che comprende rimostranze per la redistribuzione delle risorse economiche tra l’isola di Guadalcanal, dove si trova la capitale Honiara, e quella di Malaita, provincia più popolosa dell’arcipelago.
Mentre Honiara stabiliva i rapporti con Pechino, Malaita proseguiva a intrattenere rapporti molto profondi con Taipei e anche con Washington. Gli schieramenti si sono mossi in maniera sostanzialmente speculare. Il leader politico di Malaita, Daniel Suidani, ha di fatto estromesso le aziende cinesi dalla provincia, accettando invece gli aiuti sanitari e finanziari di Taipei anche durante la pandemia da Covid-19. Dall’altra parte, Honiara ha cercato di stoppare gli investimenti diretti di Washington a Malaita e si è opposta al ricevimento di aiuti da Taipei, dove peraltro Suidani ha trascorso quasi sei mesi tra maggio e ottobre 2021, ufficialmente per motivi sanitari.
Sogavare descrive dall’inizio le proteste, che hanno tra l’altro causato tre morti e diversi edifici danneggiati in particolare nell’area della Chinatown di Honiara, come un complotto ordito da forze straniere. Riferimento neanche troppo implicito a Taiwan e Stati Uniti, che come detto sostengono in maniera diretta un’amministrazione locale come Malaita, che da tempo vorrebbe tenere un referendum di indipendenza che il governo centrale continua invece a negarle. Una tesi, quella delle interferenze straniere, sostenuta anche da Pechino. Più volte il portavoce del Ministero degli Esteri di Pechino, Zhao Lijian, ha alimentato questa versione. Ribadita anche dopo l’esito del voto di fiducia dall’ambasciata cinese a Honiara: “La nostra cooperazione ha raggiunto livelli e risultati importanti. Ogni tentativo di sabotare la nostra relazione è destinato a fallire”, si legge in una nota della rappresentanza diplomatica.
Lo stesso Sogavare si è espresso chiaramente sulla questione durante la discussione in Parlamento: “La Cina è una potenza economica che ci offre l’opportunità di sostenere le nostre esigenze e le nostre sfide legate allo sviluppo”, ha detto il premier. “Le Isole Salomone hanno riconosciuto la Repubblica popolare cinese e questa è la fine della storia”. Mentre pensare a un ritorno alle relazioni con Taiwan, come richiesto dall’opposizione “è una perdita di tempo e di energia” visto che le decisioni sulle relazioni diplomatiche spettano “al Governo centrale e non ai Governi provinciali”.
Il voto di fiducia si è svolto in una capitale blindata e presidiata non solo dalle forze di sicurezza locali, ma anche da circa duecento unità inviate nel Paese dall’Australia e da altri Governi della regione come Papua Nuova Guinea e Isole Fiji. Ma il rischio sottolineato da diversi analisti è che le proteste di Malaita possano riprendere e acquisire anche maggiore vigore, visto l’insuccesso del tentativo di ottenere il cambiamento passando per la strada della politica. “Questo è un Primo Ministro che ha compromesso la nostra sovranità per il suo personale guadagno politico”, ha detto il leader dell’opposizione Matthew Wale, che ha sostanzialmente espresso il punto di vista secondo il quale il governo di Sogavare sia subalterno a quello cinese.
Intanto, sale l’attenzione su quanto può accadere anche in un altro Paese dell’area che per ora riconosce Taiwan: le Isole Marshall.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Se esisteva qualche dubbio ora non esiste più. La strategia zero contagi di Pechino può proseguire con tutto il suo vigore. L’architrave della retorica del Governo cinese circa la superiorità del suo modello di gestione della pandemia rispetto a quello delle democrazia occidentali regge, anzi diventa ancora più solida. La variante Omicron, la cui pericolosità e maggiore contagiosità rispetto alla Delta non è ancora stata del tutto dimostrata, sta creando nuovi timori in tutto il mondo. Diversi Paesi hanno già chiuso le proprie frontiere. Altri accorciano i tempi necessari per procedere alla terza dose dei vaccini, altri impongono nuove restrizioni o nuovi lockdown. E poi c’è la Cina, che va avanti sulla stessa strada da molto tempo.
Una strada nella quale non c’è tolleranza per il virus e sulla quale si cerca di mantenere i cosiddetti “zero contagi”. E dire che nelle ultime settimane erano iniziati a sorgere alcuni dubbi sulla bontà di questa misura. Prima un editoriale su Caixin, nel quale l’opinionista Zhang Fan sosteneva che le misure di contenimento eccessivo stanno producendo “più danni che benefici”. L’opinionista cita nuove misure ancora più severe di quelle passate, come lo stop a due treni ad alta velocità dopo che due membri dell’equipaggio sono stati indicati contatti stretti di un malato Covid.
“La chiave per assicurare che l’economia e la società vadano avanti in modo normale sta nella prevedibilità delle politiche di prevenzione pandemica”, scrive Zhang, che addirittura prefigura che la vicenda Covid possa diventare una “piccola falla che affonda la grande nave”. Perplessità ribadite anche dal noto virologo Guan Yi, che era stato a Wuhan durante le prime fasi dell’allora epidemia. Guan, intervistato dalla cinese Phoenix Tv, ha parlato dei possibili danni della politica “zero contagi” e ha messo in dubbio l’efficacia dei vaccini cinesi, chiedendo alle autorità di ritirarli senza garanzie sul loro funzionamento.
Poi però il Governo e gli altri media hanno ribadito l’importanza e la centralità della strategia zero Covid, mettendola in rapporto con la nuova ascesa di casi che stava interessando l’Europa anche prima di Omicron. Poi è uscito un report della Beijing University che dà manforte alla bontà dell’approccio del Governo. Secondo lo studio, una revoca delle restrizioni di viaggio e un’apertura avrebbe effetti devastanti sulla Repubblica popolare, che potrebbe registrare oltre 630mila nuovi contagi da coronavirus al giorno se decidesse di interrompere la sua tolleranza zero. “La Cina ha evitato almeno 200 milioni di infezioni da Covid-19 e 3 milioni di morti grazie alla sua piena attuazione di una politica dinamica di zero casi”, ha detto Wu Zunyou, capo epidemiologo del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) dopo la pubblicazione dello studio.
Omicron non sembra per il momento una preoccupazione per la Cina: secondo il Global Times, i principali epidemiologi cinesi hanno dichiarato che modello dinamico zero-Covid del Paese e la rapida risposta alle riacutizzazioni e ai focolai locali assicurerebbe che il Paese sia in grado di affrontare qualsiasi variante. Tra questi anche Zhang Wenhong, direttore del CDC, che ha lodato la “risposta rapida del Paese e la strategia dinamica di compensazione può far fronte a tutti i tipi di nuove varianti di coronavirus”. Wu Zunyou ha definito la strategia zero contagi „un‘arma magica” per controllare eventuali focolai interni. Le aziende farmaceutiche cinesi stanno già intensificando gli sforzi per rilevare il virus e modificare i vaccini attuali, la cui efficacia ha peraltro spesso sollevato dubbi dentro e fuori dal paese.
Un’altra occasione fornita alla Cina da Omicron arriva dalle chiusure dei Paesi occidentali nei confronti di quelli africani, che ha causato rabbia tra i Governi della regione, a partire da quello sudafricano. Pechino ha risposto con le parole di Xi Jinping, che durante il Forum triennale Cina-Africa ha annunciato la fornitura di un miliardo di nuove dosi di sieri anti Covid al continente.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
“Il caso Peng Shuai non è un caso diplomatico”. Il Governo cinese ha provato a dirlo dall’inizio. Ma la realtà è che il caso Peng è diventato un grande caso diplomatico. Con al centro la possibilità di boicottare, quantomeno a livello di rappresentanza diplomatica, i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. La sparizione dell’ex tennista subito dopo la pubblicazione e la rimozione di un lungo post su Weibo nel quale raccontava di essere stata molestata sessualmente da Zhang Gaoli, ex vicepremier della Repubblica popolare, è una storia che si è gonfiata giorno per giorno. Era partita come un’accusa di abusi e di richiesta di un’indagine, per passare poi alle voci sulla localizzazione e la libertà di movimento dell’ex campionessa cinese. Per poi rischiare di diventare il casus belli del boicottaggio olimpico del secondo evento a cinque cerchi in meno di 14 anni a essere organizzato nella capitale cinese.
Zhao Lijian, portavoce del Ministero degli Esteri di Pechino, sostiene che il caso Peng sia stato “gonfiato ad arte” per attaccare la Cina. “Credo che alcune persone dovrebbero smettere di gonfiare in modo deliberato e ostile questa vicenda, per non parlare del politicizzarla”, ha dichiarato Zhao nella consueta conferenza stampa quotidiana. Si tratta della prima volta che il Ministero e il Governo cinesi commentano questa vicenda, che prima si erano limitati a definire “non diplomatica” e “non pertinente agli affari esteri”. Ora, però, Pechino ha capito il rischio e passa al contrattacco.
Non è un caso che la presunta sparizione di Peng sia durata meno del solito rispetto a casi simili. Con l’avanzare delle proteste della comunità internazionale e delle voci di boicottaggio espressamente sostenute da Joe Biden e sulle quali starebbero riflettendo anche Regno Unito e Francia, i media di Stato cinesi hanno fatto circolare a ritmo sostenuto foto e video dell’ex tennista. Per poi arrivare alla videochiamata tra Peng e il Presidente del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) Thomas Bach. Un modo per provare a placare il coro di critiche e di domande che arrivavano da più parti, a partire dal mondo del tennis con le dichiarazioni dei vari campioni Serena Williams, Novak Djokovic e Roger Federer.
Ma neppure la videochiamata con Bach ha spazzato via tutti i dubbi. Bach è stato affiancato dalla Presidente della Commissione degli atleti, Emma Terho, e dal membro del Cio in Cina Li Lingwei. Peng, si legge nella nota, ha ringraziato il Cio per essersi preoccupato di lei e del suo benessere e ha affermato che è al sicuro e sta bene, che vive nella sua casa a Pechino e vorrebbe che la sua privacy fosse rispettata in questo momento. Ma i dubbi sono rimasti, soprattutto sulla sua libertà di movimento e indipendenza nelle dichiarazioni rilasciate. “Nulla ci dice che è libera”, sostiene Human Rights Watch, che anzi se la prende con il Cio, definito “complice della macchina della propaganda e di un caso di coercizione e sparizione forzata da parte del Governo cinese”.
Difficile stabilire la verità, in un contesto nel quale spesso le stesse celebrità finite nel mirino del Governo cinese sanno di dover tenere spenti i riflettori per un po’ in modo da arrivare alla completa riabilitazione. Il caso di Jack Ma insegna. Ma qui c’è una componente in più, vale a dire quella della denuncia di abusi sessuali, rivolta a un’alta carica del Partito comunista. Il 75enne Zhang ha infatti ricoperto la carica di vicepremier dal 2013 al 2018 e ha servito nel Comitato permanente del Politburo del Partito comunista tra il 2012 e il 2017. Peng è dovuta tornare a mostrarsi nel tentativo di bloccare le voci di boicottaggio, ma dall’altra parte essere troppo morbidi potrebbe dare un inedito slancio al Metoo cinese. E la Women Tennis Association chiede di tornare a concentrarsi sulla denuncia di Peng e di condurre un’indagine indipendente sulle sue accuse.
Intanto ci si interroga sulle modalità del possibile boicottaggio. Potrebbe coinvolgere solo funzionari e non gli atleti. Probabilmente nemmeno gli sponsor. Difficile conciliare le accuse vigorose in arrivo dall’esterno con il bisogno di fare affari.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Timoniere. Xi Jinping è stato definito così da uno dei funzionari presenti nella conferenza stampa di chiusura del sesto plenum del 19esimo Comitato centrale del Partito comunista cinese. Una terminologia di certo non neutra, nella Repubblica popolare, e che fotografa meglio di tante altre parole l’elevazione dello status concessa al Presidente cinese. La terza risoluzione sulla storia ha definitivamente messo Xi al livello di Mao Zedong e Deng Xiaoping. Anzi, sembra tracciare una sottile (ma neanche troppo) linea rossa che unisce il “grande timoniere” della rivoluzione e il “nuovo timoniere” del ringiovanimento nazionale. Il “piccolo timoniere” tra i due non viene ridimensionato, ma è costretto a condividere la stessa era, quella dell’apertura economica e della modernizzazione, con Jiang Zemin e Hu Jintao. Mao occupa invece da solo due ere, quella della rivoluzione e quella della costruzione.
Mentre Xi è alla guida della nuova era del rafforzamento e dell’ambizione. L’attuale Presidente viene presentato, in ottemperanza a quello che gli è sempre accaduto durante la sua carriera politica sin dai tempi degli incarichi provinciali, come un uomo che risolve problemi. Corruzione e inefficienza da sempre, ma il comunicato finale dell’evento a porte chiuse durato quattro giorni gli mette anche sul petto la medaglia della soluzione della crisi di Hong Kong. Nell’ex colonia britannica è tornato l’ordine dopo il caos, gli riconosce il testo. Ora manca il tassello Taiwan, sul quale comunque il Partito è riuscito a mantenere “mantenere l’iniziativa e la capacità di guidare le relazioni tra le due sponde dello stretto”.
Il sesto plenum ha spazzato via i dubbi residui: il Partito è con Xi. Non è dal suo interno, come ha scritto Simone Pieranni, che il Presidente potrebbe avere problemi. Il sesto plenum e la risoluzione sulla storia sono stati il preambolo al suo terzo mandato, che con ogni probabilità sarà ufficializzato durante il ventesimo congresso che si terrà nella seconda metà del 2022. Xi è al centro del Partito, dunque al centro dello Stato, dunque al centro della Cina. La centralità del Partito è l’unica garanzia di stabilità, progresso, rafforzamento e ambizioni. Per non tornare più a un passato “recente” (per i parametri della civiltà millenaria cinese) di umiliazioni. Per guidare la nave in tempi dei quali si riconoscono le sfide e i cambiamenti “senza precedenti” serve una mano sicura e forte. Ecco perché Xi non può mollare quel timone, ma anzi lo afferra con una presa ancora più stretta.
Dall’altra parte, però, c’è qualcosa che si muove all’esterno. In previsione e in concomitanza del plenum ci sono stati diversi segnali “interessanti”. Il primo sul Covid. Da più parti si sono sollevate critiche sulla politica di zero contagi portata avanti dal Governo. Dapprima su Caixin, con un commeno a firma di Zhang Fan nel quale si sostiene che le misure di contenimento eccessivo stanno producendo “più danni che benefici”. L’opinionista cita nuove misure ancora più severe di quelle passate, come lo stop a due treni ad alta velocità dopo che due membri dell’equipaggio sono stati indicati contatti stretti di un malato Covid.
“La chiave per assicurare che l’economia e la società vadano avanti in modo normale sta nella prevedibilità delle politiche di prevenzione pandemica”, scrive Zhang, che addirittura prefigura che la vicenda Covid possa diventare una “piccola falla che affonda la grande nave”. Perplessità ribadite anche dal noto virologo Guan Yi, che era stato a Wuhan durante le prime fasi dell’allora epidemia. Guan, intervistato dalla cinese Phoenix Tv, ha ribadito i possibili danni della politica “zero contagi” e ha messo in dubbio l’efficacia dei vaccini cinesi, chiedendo alle autorità di ritirarli senza garanzie sul loro funzionamento. Non solo. Il direttore del Global Times, noto falco conosciuto anche all’estero, ha pubblicato un post su Weibo nel quale se la prendeva col Governo per il trattamento riservato ai media sottolineando la differenza tra giornalismo e propaganda. Proprio la notte prima della chiusura del plenum, il colosso immobiliare Evergrande si è trovato a un passo dal default con una società di consulenza tedesca (Dmsa) che ne ha chiesto la bancarotta.
Poi il plenum è finito. La risoluzione sulla storia è passata, Xi ha cementato la sua presa e la sua visione sul futuro immediato del Partito. Il consigliere del Governo sul Covid-19 Zhong Nanshan ha ribadito la bontà della strategia portata avanti finora, che potrà essere interrotta solo se il tasso di mortalità dei casi sarà controllato allo 0,1% e il tasso di riproduzione del coronavirus rimanesse nell’intervallo compreso tra 1,0 e 1,5. Hu ha cancellato il suo commento. Per ora vivono tutti felici e contenti. Xi ha superato anche questa giuntura. Un timoniere non lascia la nave finché ha la forza di stringere.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Xizang. Al pubblico occidentale questa parola dice poco, eppure in Cina la conoscono tutti. È infatti questo il nome cinese del Tibet, l’immensa regione autonoma della Repubblica popolare al confine con India, Nepal e Bhutan. I cinesi la chiamano così da sempre, quantomeno da quando è tornata sotto il controllo di Pechino, all’alba dell’era di Mao Zedong. Ma nel mondo è sempre rimasta identificata col nome di Tibet. Da qualche tempo, però, il nome cinese Xizang viene utilizzato con sempre maggiore insistenza anche nella narrazione rivolta verso l’esterno, a partire dai media di Stato in lingua inglese come il Global Times. Non si tratta di un caso. Il Partito comunista sta operando da tempo una “normalizzazione” di una regione cruciale e strategica, sia per motivi interni sia per motivi geopolitici.
Fino a qualche tempo fa, prima delle Olimpiadi di Pechino del 2008, il Tibet era il grande tema legato alla Cina e ai diritti umani, con Governi internazionali e star di Hollywood a rivendicare l’autonomia di un luogo che ha sempre ispirato una forte mitologia, anche per il suo significato a livello storico e religioso: basti pensare alla figura del Dalai Lama. Un dossier che però è sceso nella lista delle priorità esterne, superato da Hong Kong, Xinjiang e da ultimo Taiwan. Anche perché nel frattempo, la situazione tibetana è molto cambiata. Non è più tempo di rivolte come quella del 1957, che portò alla fuga del Dalai Lama in India e all’esilio che dura tuttora. All’autorità religiosa fu offerto il ritorno in Cina dopo la morte di Mao, offerta rifiutata.
Ma la regione è stata via via integrata negli ingranaggi della Repubblica popolare. Prima dal punto di vista economico, con l’istituzione di una commissione ad hoc da parte di Deng Xiaoping. Le tensioni sono rimaste nel corso dei decenni, ma le proteste sono diventate più sporadiche anche grazie alla crescente integrazione economica. Tra il 2016 e il 2020 la regione ha ricevuto 160 milioni di turisti, la maggior parte provenienti da altre regioni cinesi. E in 70 anni sono stati investiti circa 255 miliardi di dollari per infrastrutture e piani economici. Ma gli investimenti sono sempre più accompagnati da processi di assimilazione culturale ritenuta necessaria e funzionale allo sviluppo economico e alla sicurezza nazionale.
Ma il Tibet, considerato a seconda della prospettiva porta d’accesso all’Asia meridionale o valico inespugnabile al cuore della Repubblica popolare, potrebbe presto tornare in cima all’agenda. Per due motivi. Il primo è puramente strategico, viste le crescenti tensioni con l’India lungo il confine conteso. Dopo i sanguinosi scontri della primavera 2020, ci sono stati diversi episodi critici, seppure non deflagrati in maniera così violenta. Ma la tensione diplomatica e militare tra Pechino e Nuova Delhi resta alta. E il Tibet gioca un ruolo importante, ospitando sempre più truppe dell’Esercito popolare di liberazione e sempre più frequenti e vaste esercitazioni militari. Con i media di Stato cinesi che raccontano invece la partecipazione attiva dei cittadini tibetani alla “difesa dei confini”.
Sulle rivolte del passato, d’altronde, Pechino sottolinea come sempre il “ruolo attivo” delle forze occidentali, con alcuni Paesi che hanno rivendicato l’indipendenza del Tibet ed “elevato a terreno di scontro” tematiche come la reincarnazione del Dalai Lama. Una tematica che diventerà fondamentale nei prossimi anni, visto che già si dibatte sulla successione, con il Governo tibetano in esilio (tra l’altro per una prima storica volta ricevuto alla Casa Bianca poco prima che venisse lasciata da Donald Trump) che non vuole lasciare a Pechino il diritto di scelta.
Anche in previsione di una sfida retorica molto accesa, Pechino sta già facendo capire in che modo vuole affrontare la vicenda, cioè facendo capire che non intende arretrare di un millimetro come su tutti gli altri dossier ritenuti interni. In questo senso, significativa la nomina di Wang Junzheng a nuovo segretario del partito in Tibet. Wang, 58 anni, è stato bersaglio negli scorsi mesi di sanzioni occidentali per la repressione dei diritti umani nello Xinjiang. Sì, perché era proprio lui l’ufficiale del partito ad aver amministrato la regione autonoma uigura. Nominarlo in Tibet fa capire che Pechino approva il suo operato e che soprattutto lo vuole comunicare al mondo esterno. Contestualmente, nelle scorse settimane è stata approvata una nuova legge sui confini terrestri che rafforza la sicurezza delle frontiere cinesi, che prevede tra le altre cose prevede la costruzione di strutture per rafforzare i blocchi al confine. L’innovazione normativa viene indicata dagli analisti come un’innovazione normativa fatta soprattutto col pensiero rivolto alle tensioni con l’India, anche perché è stata approvata subito dopo il naufragio dei negoziati bilaterali tra i rispettivi ufficiali militari delle due potenze asiatiche.
Presto si tornerà a parlare di Tibet. O di Xizang.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
La vittoria non era in dubbio, ma era in dubbio come questa vittoria sarebbe arrivata. E alla fine il Partito liberal-democratico ha vinto bene, calando rispetto al passato ma piazzandosi bene al di sopra dell’obiettivo minimo e delle previsioni.
Il Giappone era il grande assente del G20. A Roma era presente solo il viceministro degli Esteri. Sì, perché domenica 31 ottobre si sono svolte le elezioni generali per la camera bassa del Parlamento con la terza economia mondiale che è andata alle urne mentre il mondo era tutto concentrato su quanto accadeva nella capitale italiana. Fumio Kishida, che lo scorso 29 settembre ha ottenuto la nomina a leader del Partito di maggioranza e in seguito è diventato Primo Ministro, può tirare un sospiro di sollievo. Il Jiminto ha conquistato 261 seggi: 15 in meno rispetto ai 276 della legislatura precedente, ma ben al di sopra dell’obiettivo di 233 per ottenere la maggioranza assoluta. A questi vanno aggiunti i 32 seggi del partito buddista Komeito, alleato in crescita rispetti ai 29 conquistati nel 2017. Il totale a disposizione della coalizione di Governo è dunque di 293 seggi sui 465 totali.
Si tratta di un risultato importante e per certi versi insperato, dopo che l’anno di interregno di Yoshihide Suga aveva fatto precipitare il gradimento dell’opinione pubblica nei confronti del Jiminto. Nel 2020 diverse elezioni locali o suppletive erano state vinte dall’opposizione o da candidati indipendenti, rafforzando i timori della forza di maggioranza di poter subire un netto calo alle urne. Anche per questo Suga è stato portato alle dimissioni e sostituito da Kishida. Eppure, anche nei giorni precedenti al voto, i sondaggi restituivano un tasso di popolarità nei confronti del nuovo Governo piuttosto basso. Tanto che c’era già chi immaginava una vittoria mutilata, con tanto di messa in discussione immediata di Kishida e ritorno alla cronica instabilità politica dell’era pre Shinzo Abe, restato in sella per otto anni consecutivi. Un record per il Giappone degli ultimi decenni, dove cambiano spesso i volti dei premier ma non il partito alla guida del Paese.
Le proporzioni dell’affermazione rincuorano invece Kishida, che ora potrà invece portare avanti i suoi programmi, che soprattutto sul piano economico presentano degli elementi di discontinuità rispetto al recente passato e alla cosiddetta Abenomics. Il premier ha promesso nell’ultimo mese una “redistribuzione della ricchezza” (che a diversi analisti ha fatto venire in mente la “prosperità comune” di Xi Jinping) e un nuovo “capitalismo giapponese“. Il primo passaggio dovrebbe essere quello di misure pensate per i lavoratori. Allo studio un graduale aumento del salario minimo orario e sgravi fiscali per le aziende che aumenteranno i salari.
L’idea, insomma, è quella di intervenire sui redditi e sulla capacità di spesa piuttosto che proseguire con una politica monetaria espansiva. In arrivo entro novembre un pacchetto di stimoli da decine di miliardi di yen per rafforzare la ripresa economica post Covid, con un occhio di riguardo alle famiglie. Pronto anche il rilancio della campagna “Go to Travel” di sussidio al turismo e alla ristorazione nazionale. E la manovra di bilancio sarà probabilmente uno dei primi atti del nuovo Governo. Più complesso intervenire sull’aumento delle spese per la difesa, che nei piani di Kishida dovrebbero essere raddoppiate e portare al 2% del prodotto interno lordo. Con un’attenzione nei confronti delle mosse di Cina e Corea del Nord, che tra test balistici, missili ipersonici e passaggi nello Stretto di Tsugaru stanno creando qualche preoccupazione a Tokyo.
Non tutti hanno vinto, però, nella maggioranza. Akira Amari, numero due del Jiminto, è stato sconfitto nel suo distretto e ha rassegnato le dimissioni dal ruolo di segretario generale del partito. Il suo posto verrà preso da Toshimitsu Motegi, attuale Ministro degli Esteri. Di conseguenza, agli Esteri potrebbe approdare l’ex Ministro della Difesa Yoshimasa Hayashi, già stretto collaboratore di Abe. C’è poi da sottolineare il dato deludente sull’affluenza, 55,79%, che è comunque di due punti superiore rispetto al 2017.
Delude anche l’opposizione, che per la prima volta aveva approntato una strategia unitaria e collaborativa per provare a infastidire i liberaldemocratici. Impresa ampiamente fallita. Il Partito democratico costituzionale ha perso 14 seggi rispetto al 2017, scendendo sotto quota 100 (96). In calo anche il Partito comunista, 10 seggi contro i 12 precedenti. Sorprende invece il Partito Ishin (Japan Innovation Party), che diventa la terza forse del Paese con 41 seggi: quasi il quadruplo dei precedenti 11. Partito con radici regionali a Osaka, ha alimentato una retorica conservatrice populista che ha dato i suoi frutti alle urne.
La partita, in Giappone, sembra ancora tutta interna alla maggioranza.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
La Cina sta cambiando, ancora una volta. E lo sta facendo in un processo di lunga durata ma che ha subito un’accelerazione netta nell’ultimo anno e mezzo. La doppia circolazione prima e il caso Jack Ma poi erano solo i prodromi di quanto si sta sviluppando nelle ultime settimane, tra “prosperità comune” e potenziamento dell’arsenale normativo a disposizione del Governo per incidere sull’economia privata. E alle porte potrebbe esserci qualcosa di ben più grande, che investe anche la sfera storico-ideologica del Partito comunista.
Al sesto plenum in programma tra l’8 e l’11 novembre prossimi, infatti, si proporrà una “Risoluzione sui principali risultati e sull’esperienza storica della lotta nel centenario del Partito”. D’altronde, il sesto plenum è quello che tradizionalmente apre sempre l’anno decisivo in vista del conferimento del mandato presidenziale. E il congresso del 2022 sarà appunto chiamato a concedere il terzo mandato a Xi Jinping, dopo l’eliminazione del vincolo dei due mandati ufficializzato nel 2018. Si tratta di quello che Simone Pieranni ha definito “anno elettorale” cinese, se si potesse usare una terminologia presente nelle democrazie occidentali. Il Partito cerca nuovi equilibri, con dibattiti e sfide più o meno pacifiche, ovviamente non esposti al pubblico ma ben celati dietro le mura di Zhongnanhai.
Ma è il sesto plenum quello nel quale solitamente si traccia un bilancio di quanto raggiunto negli ultimi anni e si riflette sulla traiettoria futura del Partito. Nel 2016, per esempio, il sesto plenum del 18esimo comitato centrale aveva elevato la posizione di Xi Jinping a “nucleo” del Partito, aprendo la strada alla rimozione del vincolo dei due mandati. Questa volta, però, si andrà oltre, visto che secondo l’agenda trapelata nei giorni scorsi è emerso che in programma c’è appunto una risoluzione storica.
La coincidenza tra centenario del Partito comunista e vigilia del prossimo congresso ha creato le circostanze utili per cementare la visione di Cina di Xi. Si tratta della terza volta che il Partito compie questo passo. La prima volta avvenne nel 1945, al settimo plenum del sesto comitato centrale. In quel caso si riassumeva l’esperienza acquisita nei primi 24 anni di vita del Partito e si poneva al centro il pensiero politico, strategico e ideologico di Mao Zedong, che riuscì così a imporre la sua visione sul futuro del Partito che sfociò poi nella fondazione della Repubblica popolare nel 1949. La seconda volta è invece datata 1981, durante il sesto plenum dell’11esimo comitato centrale. In quel caso la Cina di Deng Xiaoping ridiscusse se stessa e in particolare criticò la Rivoluzione culturale di Mao, in modo da proiettarsi verso il futuro e la stagione di apertura e riforma operata dal piccolo timoniere.
In entrambe le situazioni, insomma, le risoluzioni sono state funzionali ai leader dell’epoca per porsi al centro dell’azione del Partito. Non dovrebbe fare eccezione per Xi.
Il sinologo francese Jean-Pierre Cabestan ha di recente spiegato in un’intervista: “Il Pcc ha iniziato a riscrivere la storia cinese dal primo giorno. C’è stata una grande discontinuità tra la Rivoluzione culturale di Mao e l’era delle riforme di Deng. Jiang e Hu vi hanno sempre fatto riferimento, ma Xi vuole cancellare ogni punto di svolta e guardare alla storia della Repubblica popolare come un blocco unico, per dimostrare che il Partito ha sempre avuto ragione. Questo è il motivo per cui Jiang e Hu sono stati messi da parte e persino Deng a volte lo è. Oggi Deng non viene più considerato un eroe: certo, è l’uomo che ha lanciato le riforme e aperto il Paese ma è anche colui che ha rischiato di aprire la strada a riforme politiche prima di Tian’anmen, inclusa la separazione tra partito e Governo. La Cina di Xi è tornata a essere paranoica e militante come quella di Mao e nella sua versione della storia Mao ha sempre avuto ragione”.
Ecco perché esiste la possibilità che venga rivalutata anche la rivoluzione culturale criticata all’epoca di Deng. O che comunque si riaffermi il primato della politica sull’economia. Anche se l’ipotesi più concreta è che invece di sistemare il passato questa volta la risoluzione guardi al futuro, quello immaginato da Xi. Arricchirsi è glorioso, certo, ma bisogna farlo in un modo “ordinato” e fino a un certo limite.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Aria, mare e terra. I fronti aperti per la Cina non escludono nessun elemento. Tranne, fortunatamente, il fuoco. Almeno per ora. Da Taiwan al mar Cinese meridionale fino al confine con l’India, i dossier strategico-militari per la Repubblica popolare si moltiplicano. In realtà, sono lì da lungo tempo, ma quantomeno sono stati tutti riaperti nell’ultimo periodo. Le questioni irrisolte sulle dispute terrestri e marittime, nonché quella riguardante lo status di Taiwan, sono sul tavolo da decenni. Ma ora hanno un’urgenza più impellente, perché la Cina non è più quella di Mao Zedong o quella di Deng Xiaoping. La Cina di oggi è forte, ambiziosa e dunque anche assertiva su quelli che considera suoi interessi fondamentali.
A partire dalla “riunificazione” con Taiwan, ferita aperta di una Repubblica popolare che con Xi vuole completare il percorso di “ringiovanimento nazionale”. Negli ultimi anni, appare sempre più chiaro che lo status quo è a rischio. Da una parte, la crescente assertività di Pechino che dopo aver “normalizzato” Hong Kong guarda come prossimo step a Taipei; dall’altra, la costruzione di un’identità “altra” da parte di Taiwan che con Tsai Ing-wen si dice pronta al dialogo ma senza precondizioni. Ergo, senza la preventiva accettazione del principio della “unica Cina”, che invece il Guomindang (il partito nazionalista cinese oggi all’opposizione) riconosceva attraverso lo strumento del cosiddetto “consenso del 1992”.
La prima decade di ottobre, come accade da tempo, è stata particolarmente tesa nei rapporti intrastretto. Prima i 156 mezzi aerei dell’Esercito popolare di liberazione che sono entrati nello spazio di identificazione di difesa aerea di Taipei (la cui esistenza non è riconosciuta da Pechino), poi la notizia delle esercitazioni di invasione terrestre nella provincia del Fujian, a poche miglia nautiche dalle coste taiwanesi. In mezzo la notizia della permanenza a Taiwan di un contingente di consiglieri militari americani, impegnati ad addestrare le forze locali nel resistere a eventuali tentativi di invasione, che secondo il Governo di Taipei potrebbero avvenire entro il 2025.
Difficilmente prima del 2023, quando Xi Jinping dovrebbe ottenere il suo terzo mandato, il Presidente cinese darebbe il via libera a un’operazione con un’ampia forbice di possibilità tra successo e fallimento. Un rischiatutto che non rientra nelle corde della tradizione politica cinese. Non è un caso che nel suo discorso di sabato 9 ottobre, pronunciato in occasione delle commemorazioni per la rivolta di Wuchang, avvio della rivoluzione Xinhai che portò alla fine della dinastia imperiale dei Qing e alla fondazione della Repubblica di Cina (ancora oggi nome ufficiale di Taiwan), Xi non abbia utilizzato la formula della riunificazione da completare “senza escludere l’utilizzo della forza”.
Non tanto un passo verso Joe Biden, che aveva parlato di un presunto “accordo su Taiwan” al quale Xi avrebbe promesso di attenersi durante la loro recente telefonata, quanto un messaggio ai taiwanesi stessi e magari al Guomindang, che nelle ultime settimane ha scelto Eric Chu come suo nuovo leader. Chu ha incontrato Xi nel 2015 e ha subito manifestato la volontà di rilanciare il dialogo intrastretto. Segnale che il Partito comunista vuole incentivare, sperando nella vittoria del Guomindang alle elezioni presidenziali del 2024. Quello che Pechino potrebbe voler creare è una situazione nel quale il voto del 2024 passi per i taiwanesi come una scelta non solo tra Partito democratico progressista e Guomindang ma come una scelta anche tra guerra e pace. Nel frattempo, l’esercito cinese allarga la cosiddetta zona grigia operativa intorno all’isola e alza la pressione.
Negli ultimi giorni è tornato d’attualità anche il tema del confine terrestre con l’India. Il tredicesimo ciclo di colloqui militari, che si è svolto sul lato cinese della frontiere Chushui-Moldo, non ha portato nessun risultato tangibile. Anzi, i giornali indiani hanno parlato di nuovi scontri nella zona contesta dell’Arunachal Pradesh la scorsa settimana. Secondo Nuova Delhi, sarebbero in atto tentativi unilaterali da parte cinese di alterare lo status quo in violazione degli accordi bilaterali. Ricostruzione smentita da Pechino. “La questione del confine tra Cina e India rimane bloccata”, scrive il tabloid di Stato Global Times. “La causa principale è che la parte indiana non ha ancora sviluppato un atteggiamento corretto nei negoziati. Fa sempre richieste irrealistiche non in linea con la situazione reale o con la sua forza”. Questa sembra essere la parola chiave: forza. E Pechino ora sente di averne tanta.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
La dinamica è quasi sempre la stessa. Grande attenzione iniziale, corposa serie di dichiarazioni e moniti poi, infine il silenzio. I riflettori della comunità internazionale sembrano essersi progressivamente spenti sulla sorte del Myanmar. Sono trascorsi poco più di otto mesi dal golpe militare dello scorso 1° febbraio ma l’emergenza birmana è stata superata dalle vicende dell’Afghanistan e piano piano dimenticata. Eppure, nulla è cambiato in meglio. Anzi, la situazione è semmai peggiorata.
Gli scontri tra le forze armate del Myanmar e le milizie parte del cosiddetto Fronte di difesa popolare (Fdp) si sono intensificati dopo la dichiarazione di “guerra di resistenza poopolare” effettuata da parte del Governo ombra di coalizione nazionale, istituito da politici e attivisti birmani. Secondo stime formulate dalla stampa birmana, il Fronte può contare su una forza compresa tra 20mila e 30mila uomini. Secondo i componenti della coalizione, si trattava dell’unica possibilità rimasta dopo l’inerzia della comunità internazionale e delle democrazie occidentali, mai andate oltre gli annunci iniziale e le sanzioni nei confronti di esponenti della giunta militare.
L’insoddisfazione è anche, e soprattutto, nei confronti dell’Asean, l’Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico di cui il Myanmar fa parte. A fine aprile è stato svolto un vertice straordinario nel quale è stato invitato il Generale Min Aung Hlaing, capo del Tatmadaw, e nessun esponente del Governo di coalizione nazionale. Vertice dal quale è uscito un accordo piuttosto vago in cinque punti che non è mai stato del tutto applicato. Anche la scelta dell’inviato speciale Asean è arrivata dopo mesi di trattative solo a inizio agosto. Scelta che è ricaduta sul secondo Ministro degli Esteri del Brunei, Erywan Yusof. Il piccolo Sultanato regge la presidenza di turno del blocco per il 2021. Gli Stati membri più attivi nel tentativo di ampliare l’azione e la profondità dell’azione Asean sono stati Indonesia, Singapore e Malaysia. “Non ci sono stati progressi significativi in Myanmar, né segnali positivi da parte della giunta militare sulle richieste dell’inviato speciale”, ha affermato lunedì 4 ottobre il Ministro degli Esteri di Giacarta, Retno Marsudi, dopo un vertice con i colleghi Asean. “Alcuni membri sostengono che l’Asean non possa limitarsi al business as usual”, ha aggiunto. Ma nessuno dei tre Paesi avrà un ruolo di primo piano nel prossimo futuro, visto che nel 2022 la presidenza del blocco passerà dal Brunei alla Cambogia, forse la più cauta nell’esprimere giudizi sul caso birmano nonché il Paese membro più vicino alla Cina.
La scorsa settimana, un accordo fra Stati Uniti, Russia e Cina ha portato all’esclusione del Myanmar dai tradizionali discorsi in occasione dell’Assemblea generale dell’Onu, tenutasi a New York. Sia l’ambasciatore designato dalla giunta militare golpista al potere dal primo febbraio scorso che il precedente inviato, sostenuto dalla comunità internazionale, avevano chiesto la parola ma non sono potuti intervenire. Segno che non solo l’Asean, ma anche l’Occidente e le altre potenze siano in una posizione di attesa e di osservazione dall’esterno. Anche se Pechino ha riavviato la sua diplomazia che viaggia, come sempre per quanto riguarda il Myanmar, su un doppio binario. Da una parte sono stati riavviati diversi progetti che rientrano nella Belt and Road Initiative e nel corridoio economico Cina-Myanmar con il benestare dell’esercito, dall’altra però esponenti della Lega Nazionale per la Democrazia di Suu Kyi sono stati invitati a un forum dei partiti politici asiatici che si è svolto di recente in territorio cinese. A proposito di Suu Kyi, i suoi legali hanno fatto sapere che soffre di esaurimento nervoso causato da tutta la serie di accuse che pesano su di lei e che potrebbero portare a una condanna fino a 15 anni di carcere.
Intanto, come detto, gli scontri si stanno facendo sempre più violenti e iniziano ad assomigliare una guerra civile che vede impegnati diversi gruppi di milizie etniche armate. Una decina di giorni fa, una trentina di militari sarebbero per esempio rimasti uccisi negli scontri negli Stati di Chin e Kayah. Le violenze continuano anche sui civili. Intanto, Save the Children ha comunicato che dopo il golpe del 1° febbraio e lo scoppio del conflitto armato in diverse aree del Paese, più di 76.000 bambini sono stati costretti a fuggire dalle loro case. In tutto sarebbero 206.000 le persone sfollate. Alla crisi politica si aggiungono anche le drammatiche situazioni legate all’economia e alla sanità. Sul Myanmar si è negli ultimi mesi abbattuta una fortissima ondata di contagi da Covid-19, la peggiore dall’inizio della pandemia. E la valuta locale ha perso più del 60% del suo valore dall’inizio di settembre, facendo salire i prezzi del cibo e del carburante
Una tempesta perfetta, anche se in pochi sembrano ormai curarsene.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Il ritorno in Cina di Meng Wanzhou non è solo il ritorno in Cina di Meng Wanzhou. Così come l’arresto della figlia di Ren Zhengfei, fondatore e Presidente di Huawei, non era solo un arresto.
Prima ancora del Covid-19, è questo l’evento che ha accelerato una serie di tendenze già in atto precedentemente in Cina (internamente) e nel rapporto tra Washington e Pechino. Meng è stata il simbolo dell’escalation nelle relazioni bilaterali. Il suo arresto è stato il grilletto premuto da Donald Trump per far capire a Pechino che Washington non cercava solo un mero riequilibrio della bilancia commerciale. Altro che semplice trade war, la questione non erano solo i dazi e le tariffe. Quell’arresto ha cambiato tutto. Ha convinto la Cina che gli Usa volevano fermarne l’ascesa e avrebbero fatto qualsiasi cosa pur di riuscirci. A partire da far prendere in custodia al Canada, alleato dei Five Eyes, un personaggio di spicco del colosso tecnologico che mirava allo sviluppo delle infrastrutture di rete 5G un po’ ovunque nel mondo. E non solo a quello, ovviamente. È cambiato tantissimo, da 1° dicembre 2018 in cui Meng viene fermata a Vancouver, diretta a un incontro d’affari in Messico. Ma quello è il momento in cui è cambiato qualcosa, inesorabilmente. La Cina raccoglie quell’arresto come una dichiarazione di guerra, e reagisce di conseguenza. Il clima cambia, la retorica anche.
Ecco perché Meng non poteva che essere accolta nel modo in cui è stata accolta dopo il suo atterraggio a Shenzhen, città che ha anch’essa una profonda valenza simbolica per gli ultimi decenni della Repubblica popolare. Da qui Xi Jinping ha lanciato ufficialmente la doppia circolazione nel suo tour al sud dello scorso autunno, qui ora grande e piccola circolazione tornano a scorrere in un intreccio virtuoso. Ecco perché è difficile credere al comunicato della Casa Bianca secondo il quale la liberazione di Meng è una questione meramente giudiziaria, seppure del tema se ne sia parlato durante la recente (e prima) telefonata tra Joe Biden e Xi. Questione che è proceduta in maniera parallela rispetto a quella dei due cittadini canadesi Michael Spavor e Michael Kovrig, rispediti a casa da Pechino dopo essere stati tenuti prigionieri durante la permanenza di Meng nella sua proprietà di Vancouver.
Il collegamento è immediato, diretto, esplicito, quasi ostentato. Assomiglia a uno scambio di prigionieri e Pechino non ha fatto nulla per nasconderlo. Il messaggio è doppio. Il primo, incentrato su Meng, è rivolto all’interno: “Il Partito comunista e il Governo cinese sono forti e hanno vinto il braccio di ferro con gli Stati Uniti”. Il secondo, incentrato sui due “ostaggi” rilasciati, è rivolto all’esterno: “Siamo pronti a fare di nuovo la stessa cosa se ci ostruite la strada”. Una vittoria simbolica e strategica che tiene poco conto delle possibili considerazioni esterne, perché la Cina vuole mostrare di essere forte. E se questo comporta la conseguenza di far provare oltre al rispetto anche timore, così sia.
Sui media cinesi sono apparsi alcuni articoli e opinioni che ritengono che la liberazione di Meng possa stemperare in qualche modo le tensioni tra Usa e Cina. Ancora una volta, la Casa Bianca dice che la linea non cambia dopo questo episodio. Eppure i segnali di un tentativo di dialogo ci sono. Quantomeno di un dialogo diverso da quello duro e confrontativo ufficiale. Forse non è un caso che subito dopo la risoluzione del caso Meng, il South China Morning Post abbia rivelato il lungo viaggio in Cina di John Thornton, pezzo grosso di Wall Street ed ex capo di Goldman Sachs. Un viaggio nel quale Thornton avrebbe incontrato il vicepresidente Wang Qishan e il vicepremier Han Zheng, e che il quotidiano edito a Hong Kong paragona alla missione segreta di Henry Kissinger nel 1971. Forse un paragone esagerato, ma legittimo pensare che qualcosa si stia muovendo, o quantomeno stia provando a muoversi. La liberazione di Meng non è solo la liberazione di Meng.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Se c’è una promessa che Joe Biden sta rispettando è quella di mostrare il rinnovato interesse degli Stati Uniti per il Pacifico, o meglio l’Indo-Pacifico, la vastissima area che va dalle coste occidentali americane a quelle africane passando per Oceania, Sud-est asiatico e oceano Indiano. C’è un però. I partner pensavano che lo avrebbe fatto in un clima di cooperazione, collaborazione e comunicazione. Prevedibilità, insomma. La parola chiave che mancava durante l’ondivaga amministrazione Trump. Il lancio improvviso dell’AUKUS, il nuovo patto di difesa Usa-Regno Unito-Australia, non ha del tutto rispettato questo principio.
L’accordo rischia di creare una frattura con l’Unione europea, in particolare con la Francia a causa della questione dei sottomarini e la rottura del contratto di fornitura sottoscritto da Canberra con Parigi. Ma anche in Asia, seppure con modalità meno esplicite, ci sono diverse perplessità sull’ultima mossa della Casa Bianca. Un caso a parte è Taiwan, che essendo in prima linea a poche miglia di mare dalla Repubblica Popolare, ha accolto la novità con favore.
A partire dai Paesi del Sud-est asiatico, sono quelli meno propensi a esporsi in una contesa aperta con la Cina. Sì, perché nonostante Pechino non sia mai stata nominata nella conferenza stampa di lancio di AUKUS né pare esserlo nella bozza di documento congiunto del primo summit fisico del Quad in programma per venerdì 24 settembre a Washington, appare evidente che il focus del rinnovato pivot to Asia di Washington sia proprio il contenimento dell’ascesa cinese. Più l’obiettivo diventa il confronto con Pechino, meno i Paesi asiatici sono pronti a farsi “arruolare” dagli Usa. Era stato chiaro già dopo l’esplicito appoggio dell’ex Segretario di Stato Mike Pompeo alle dispute territoriali tra governi ASEAN e Cina nel mar Cinese meridionale. Lo è rimasto anche durante le recenti visite diplomatiche di funzionari dell’amministrazione Biden, dal vice segretario di Stato Wendy Sherman alla quale è stato negato il pieno accesso alla base navale di Ream in Cambogia, al Vicepresidente Kamala Harris la cui retorica anti cinese non ha trovato terreno particolarmente fertile in Vietnam.
Non a caso, i Governi di Malesia e Indonesia hanno avvertito dei possibili rischi per la stabilità della regione dopo la firma del nuovo patto di sicurezza. In un comunicato pubblicato dal ministero degli Esteri indonesiano, il governo registra con “attenzione” la decisione dell’Australia di acquistare sommergibili nucleari ed esprime “profonda preoccupazione per la corsa alle armi e dimostrazioni di forza nella regione”. L’inviato australiano presso l’ASEAN ha cercato di placare le ansie dei Paesi del Sud-Est asiatico sul patto di difesa annunciato pochi giorni fa da Washington, Canberra e Londra. Wil Nankervis ha detto che l’accordo non è “un’alleanza militare”. Il diplomatico ha spiegato che l’Aukus non cambierà “l’impegno dell’Australia verso l’ASEAN né il suo continuo sostegno all’infrastruttura regionale guidata dall’Association”.
Ma è più che evidente che la preoccupazione c’è, anche perché da queste parti nessuno vuole essere costretto a scegliere da che parte stare, né tantomeno lanciarsi in una “santa alleanza” anti Pechino. Perché così sarà letta l’iniziativa dal governo cinese, a prescindere dalle reali intenzioni di Washington, Londra e Canberra. Resta la sensazione che la moltiplicazione delle piattaforme multilaterali difensive a guida americana e operanti nel Pacifico sia strumentale anche ad avvicinarsi all’obiettivo di creazione di una sorta di “Nato asiatica”. Obiettivo a cui per ora non sembra poter rispondere il Quad.
La riluttanza dell’India a impegnarsi completamente in un progetto comune difensivo resta, al di là delle dichiarazioni ufficiali e delle frizioni con la Cina. Anche il Giappone sa che più si rende esplicita l’anima anti cinese della piattaforma e meno la si può rendere condivisa. Corea del Sud e altri Paesi asiatici hanno fatto già sapere di non voler entrare nel cosiddetto Quad Plus senza che il progetto prenda direzioni più ampie, con un focus sulla cooperazione infrastrutturale, digitale e sanitaria. Insomma, i Paesi asiatici vorrebbero un Quad pro Asia e non anti Cina. Il contropiede di Biden fa capire che a Washington non mancano piani alternativi per continuare ad alzare la pressione su Pechino.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Il dossier Corea del Nord torna sul tavolo di Washington, Pechino, Tokyo e ovviamente Seul. Lo fa all’improvviso, dopo che quasi i rispettivi Governi speravano che l’attesa recrudescenza post elezioni americane non avvenisse più. E invece Pyongyang ha atteso un momento particolarmente delicato per gli equilibri dell’Asia orientale per tornare a effettuare test balistici, a poche settimane dalla scelta del nuovo leader del Partito liberaldemocratico in Giappone (con a seguire in programma le elezioni generali) e a pochi mesi dalle cruciali elezioni presidenziali in Corea del Sud.
Nella giornata di lunedì 13 settembre è stato infatti reso noto che, durante il fine settimana, il regime di Kim Jong-un ha testato un nuovo tipo di missile da crociera a lungo raggio, a pochi giorni di distanza dalla parata notturna con la quale si era celebrato il 73esimo anniversario della fondazione del Paese. Secondo quanto ha riportato l’agenzia di stampa di Stato della Corea del Nord, la Kcna, i missili hanno viaggiato per poco più di due ore, 7.580 secondi, sopra le acque territoriali, prima di colpire il bersaglio in mare aperto a una distanza di 1500 chilometri.
Il test è stato dunque condotto “con successo” e lo sviluppo dei missili rappresenta “un’arma strategica di grande importanza”, scrive il Rodong Sinmun, organo di stampa ufficiale del Comitato centrale del Partito del lavoro di Corea. Il test è avvenuto alla presenza di alti funzionari del Governo, tra i quali l’astro nascente Pak Jong-chon, ma Kim era assente. Si tratta del primo lancio dallo scorso marzo, quando erano stati testati due missili balistici. Ma in quel caso si trattava di armi a corto raggio, con una gittata molto più breve rispetto a quello lanciato in questa occasione.
Secondo la maggior parte degli osservatori, si tratta di un segnale per provare a rilanciare il dialogo sul dossier nucleare, che è del tutto arenato dal summit di Hanoi del febbraio 2019 tra Kim e l’allora Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Dopo quell’incontro infruttuoso, c’è stato solo quel fugace e molto fotografato estemporaneo incontro nella zona demilitarizzata del 30 giugno dello stesso anno. Poi più nulla, con l’amministrazione Biden che ha tardato ad approntare una strategia chiara sul dossier nordcoreano.
Allo stesso tempo, la provocazione potrebbe anche funzionare per riavviare le discussioni, che la Casa Bianca ha già fatto sapere di essere disposta a riprendere. Per ora, Pyongyang ha però sempre ufficialmente rifiutato, chiedendo come precondizione agli Stati Uniti di abbandonare le proprie politiche “ostili”, riferendosi alle sanzioni economiche che hanno colpito un Paese già affamato da una profonda crisi esito anche della pandemia da Covid-19 (anche se il regime continua a sostenere che il Paese ne sia sostanzialmente immune).
Al regime non piace neanche il rafforzamento dei rapporti difensivi operato dagli Stati Uniti con la Corea del Sud. Durante gli anni di Trump il rinnovo del trattato difensivo era sembrato in bilico, dopo il mancato accordo sulle spese militari. Ma subito dopo l’arrivo di Biden l’accordo è stato trovato e in territorio sudcoreano permangono ancora poco meno di trentamila truppe americane.
Il segnale dato dal nuovo Presidente americano è stato forte per i partner asiatici. Il Primo Ministro (ora dimissionario) giapponese Yoshihide Suga e il Presidente sudcoreano Moon Jae-in sono stati tra i primi leader mondiali a ricevere una telefonata da Biden, e i primi in assoluto a essere ricevuti alla Casa Bianca. Sintomo del tentativo di rinnovare il dialogo trilaterale per porsi in maniera congiunta sul dossier nordcoreano.
Il lancio del missile ha causato inquietudine più che altro ai vicini asiatici, già intenti a cercare rassicurazioni dall’alleato americano dopo la vicenda afghana. Il portavoce del Governo giapponese Katsunobu Kato ha espresso “preoccupazione” e ha affermato che Tokyo sta lavorando insieme a Washington e Seul per monitorare la situazione. Sono intervenuti sulla questione anche i candidati alla guida del Partito liberaldemocratico. Il favorito Taro Kono ha affermato che “è giunto il momento di discutere su come rafforzare la deterrenza nel quadro dell’alleanza Giappone-Usa. Anche se si tratta di abbattere i missili”. Ancora più aggressiva Sanae Takaichi, considerata la candidata più nazionalista, che ha definito il lancio una “minaccia” per il territorio giapponese “che giustifica la corsa a chi riesce a disarmare per primo le basi nemiche”. Stessa preoccupazione anche per la Corea del Sud, che tra poco entrerà in piena campagna elettorale per il voto presidenziale di marzo 2022. Il fronte coreano è riaperto.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Il Giappone torna alle antiche abitudini. Dopo la lunga era di Abe Shinzo, l’interregno di Yoshihide Suga è durato appena un anno. E ora si apre la fase di scelta del nuovo leader del Partito liberal-democratico di maggioranza, che verrà incoronato il prossimo 29 settembre. Con ogni probabilità, si tratterà anche del prossimo Primo Ministro, vista la cronica difficoltà dell’opposizione nel ritrovare una vocazione maggioritaria persa dopo il terremoto e maremoto del Tohoku del 2011. Abe era durato otto anni, una tempistica impensabile per un Paese che nei decenni precedenti aveva cambiato premier a un ritmo (quasi) senza eguali al mondo.
Suga doveva essere un traghettatore e tale si è rivelato, nonostante il buon inizio di mandato gli aveva fatto accarezzare il sogno di restare in sella anche dopo la tornata elettorale prevista entro novembre di quest’anno. La sua provenienza di estrazione popolare, in contrasto con la tradizione delle grandi saghe ereditarie della politica giapponese, sembrava poterlo premiare. Le critiche sulla gestione sanitaria ed economica del Covid-19 e il bassissimo gradimento dei cittadini per lo svolgimento dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 hanno abbattuto le sue possibilità di conferma.
Negli ultimi mesi, il Partito liberal-democratico ha collezionato un insuccesso elettorale dopo l’altro. Alle elezioni locali di Nagano e Hiroshima, a inizio maggio, i candidati liberal-democratici sono stati sconfitti con distacchi nell’ordine della doppia cifra. La principale forza di Governo non ha presentato neppure un candidato in quelle dell’Hokkaido. A fine agosto la mazzata, per certi versi decisiva, di Yokohama. Una sconfitta simbolica anche per Suga, che proprio alla prefettura di riferimento di Yokohama, quella di Kanagawa, ha legato la sua carriera politica. La popolarità del Primo Ministro dimissionario era in picchiata da tempo e, come ha scritto Guido Alberto Casanova per ISPI, il gruppo delle cosiddette “3A” composto da Shinzo Abe, Taro Aso e Akira Amari aveva iniziato a mostrare segni di insofferenza verso la gestione del partito di Suga.
La corsa alla successione si è già aperta. E il favorito sembra Taro Kono, Ministro per le Riforme amministrative e normative ed ex Ministro degli Esteri. Qualche mese fa, Suga gli aveva affidato il ruolo di “zar” della campagna vaccinale anti Covid-19. Ruolo che non ha contrastato la sua popolarità. Anzi, gli ha semmai giovato visto che sotto la sua regia il ritmo delle inoculazioni è decisamente aumentato, colmando almeno in parte il ritardo accumulato con diverse altre economie sviluppate nei mesi precedenti. Cinquattotto anni, è relativamente giovane per la media dei leader politici giapponesi. Secondo gli ultimi sondaggi di Kyodo News, Kono raccoglie circa il 32% dei consensi e sarebbe dunque il favorito.
Ma, come sempre, quello che conta è il peso delle fazioni interne a un partito vasto e complesso come quello liberal-democratico. Kono, molto attivo anche sui social, è visto come un profilo piuttosto indipendente e almeno in parte slegato dalle solite logiche interne. Per questo la sua vittoria, seppure appaia al momento l’ipotesi più probabile, non è scontata. A contendergli la poltrona e dunque la candidatura a premier per le elezioni generali c’è soprattutto Fumio Kishida. Anche lui ha alle spalle un’esperienza da Ministro degli Esteri, elemento che fa capire come in ogni caso Tokyo sembri puntare su figure con un’esperienza diplomatica rilevante. A suo svantaggio la corsa, persa, nel 2020 contro lo stesso Suga e lo scarso gradimento che sembra riscontrare a livello popolare.
La terza incomoda, che potrebbe rivelarsi qualcosa di più, è Sanae Takaichi. Ex Ministra dell’Interno, si è posta l’obiettivo di diventare la prima premier donna della storia del Giappone. 60 anni, è una stretta alleata di Abe e il potente ex Primo Ministro sembra che possa davvero appoggiare lei nella corsa alle primarie. Eletta otto volte in Parlamento, Takaichi non fa parte di nessuna delle fazioni in cui è diviso il Partito al suo interno. Ma ha il sostegno del gruppo di conservatori della Hosoda, vale a dire la fazione più grande.
Non va inoltre scordato che mancano ancora tre settimane alle primarie e potrebbe palesarsi qualche altra candidatura di peso. C’è anche chi ipotizza un possibile ritorno di Abe, anche se per il momento appare più probabile che l’ex premier cerchi finalmente di individuare il suo (o la sua) erede, che magari possa garantire almeno in parte la stabilità politica che il Giappone ha vissuto con lui negli otto anni precedenti all’esplosione della pandemia e alle sue dimissioni per motivi di salute.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Il doloroso processo di distacco degli Stati Uniti dall’Afghanistan sta causando alcuni smottamenti anche in Asia e Pacifico. Come raccontato da eastwest, la Cina ha subito approfittato della caduta di Kabul per criticare la debacle di Washington e alzare la pressione retorica su Taiwan. Una pressione anche strategica, viste le esercitazioni su larga scala condotte dalla flotta dell’Esercito popolare di liberazione lo scorso 17 agosto al largo delle coste taiwanese. Allo stesso tempo, sta cercando di mettere in sicurezza la porzione del suo territorio confinante con l’Afghanistan (cioè la regione del Xinjiang) rafforzando i rapporti difensivi con le ex repubbliche sovietiche dell’Asia centrale. Gli Stati Uniti stanno rispondendo con una serie di azioni militari e diplomatiche per rilanciare la loro presenza nell’Indo-Pacifico, alle porte della Repubblica popolare e all’interno delle acque contese del Mar Cinese meridionale. Un rilancio che passa attraverso un’azione di rassicurazione dei partner dell’area sulle intenzioni di lungo termine di Washington, la cui immagine è stata innegabilmente scalfita dalla dinamica di quanto accaduto a Kabul.
Nessuno vuole fare a meno degli Stati Uniti e della loro protezione difensiva, ma un po’ tutti stanno iniziando a immaginare un futuro nel quale la propria sorte dipende innanzitutto da se stessi. Persino Taiwan, la cui sicurezza dipende in larga parte proprio dagli armamenti e dalle azioni americane, ha iniziato a parlare della necessità di non dipendendere in maniera eccessiva dalla volontà di protezione altrui. Vale a dire Stati Uniti. Ecco, dunque, che venerdì 27 agosto due navi americani, il cacciatorpediniere USS Kidd e un mezzo della guardia costiera hanno effettuato un transito nello Stretto, l’ottavo realizzato dalla Marina statunitense durante l’amministrazione Biden.
Azione apprezzata dal Governo taiwanese, che comunque come tanti altri esecutivi dell’area cerca di diversificare i propri rapporti anche in materia di sicurezza. Guardando nello specifico al Giappone, con il quale è stato lanciato un inedito dialogo a livello partitico tra i due partiti di maggioranza. Lo stesso fanno le potenze medie: Giappone, India e Australia stanno rafforzando i propri legami securitari non solo attraverso la piattaforma del Quad, che include anche gli stessi Usa, ma lo fanno anche a livello bilaterale tra loro. Nei giorni scorsi, proprio in ambito quadrilaterale, sono partite le esercitazioni Malabar 2021, che replicano quelle del 2020, le prime con impegnate le marine di tutti e quattro i Paesi della piattaforma informale che gli Usa vorrebbero rendere sempre più formale, possibilmente allargandola ad altri attori come la Corea del Sud, che per ora ha respinto le “offerte” in tal senso.
L’Indo-Pacifico acquisisce ancora più centralità dopo il caos afghano, anche perché gli Stati Uniti giocano lì la vera partita e non possono assolutamente permettersi di trasmettere una sensazione di debolezza. Ecco spiegato anche il rinnovato interesse per il Sud-est asiatico, area quasi del tutto trascurata dall’amministrazione Trump se si eccettua il singulto finale con il quale l’ex segretario di Stato Mike Pompeo ha appoggiato unilateralmente tutte le rivendicazioni territoriali dei Paesi dell’area coinvolti in dispute marittime con la Cina. Una campagna di arruolamento che non ha funzionato nell’estate del 2020 e non funzionerà nemmeno a distanza di un anno.
Nel giro di pochi mesi si sono succedute diverse missioni diplomatiche nell’area. I risultati, però, sono stati altalenanti. Ottimo successo per il segretario alla Difesa Lloyd Austin, che nelle Filippine ha ottenuto la proroga del Visiting Force Agreement, uno dei pilastri dell’ampio trattato difensivo che regola i rapporti militari tra Washington e Manila e che il Presidente Rodrigo Duterte aveva più volte minacciato di voler cancellare. Decisamente meno soddisfacente la visita di Wendy Sherman, la vice del Segretario di Stato Antony Blinken, che in Cambogia si è vista negare il pieno accesso alla base navale di Ream, che il Pentagono sospetta venire utilizzata come punto d’appoggio dalla flotta cinese. La vicepresidente Kamala Harris si è recata la scorsa settimana in Singapore e Vietnam per riannodare i legami con due dei più strategici Paesi della regione.
Lee Hsien Loong, premier della città-Stato, ha chiesto prove sull’interesse a lungo termine di Washington per la regione. Non allineata nemmeno la posizione di Hanoi, sul quale gli Usa puntano molto per l’affermazione di una linea geopoliticamente assertiva sulla Cina in seno all’Asean. Il premier Pham Minh Chinh ha approfittato del ritardo nell’arrivo di Harris, causato da due possibili casi di cosiddetta “sindrome dell’Avana”, per incontrare l’ambasciatore di Pechino Xiong Bo e garantire che il Vietnam non entrerà in nessuna “alleanza anti-cinese”. Non proprio un segnale incoraggiante. Washington dovrà cercare di elevare la sua azione a livello di blocco per provare a incidere maggiormente, ma tenendo sempre in mente una cosa: nel Sud-est nessuno vuole scegliere da che parte stare.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
La scorsa settimana, nel pieno della crisi in Afghanistan, è stata trascurata un’altra notizia certo più piccola ma che è in qualche modo collegata a quanto stava avvenendo a Kabul. Mercoledì 18 agosto, infatti, la Cina e il Tagikistan hanno dato il via a due giorni di esercitazioni anti terrorismo. I test si sono svolti a Dushanbe, la capitale tagika, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione in materia difensiva dei due eserciti e la loro prontezza di reazione alle “forze terroristiche che minacciano la regione”, come spiegato dal tabloid di stato in lingua inglese di Pechino, il Global Times.
In una lettera inviata al Ministro degli Affari interni tagiko, Rahimzoda Ramazon Hamro, il Ministro della Pubblica Sicurezza cinese Zhao Kezhi ha ribadito i “legami solidi” e l’alto livello di “fiducia reciproca” tra i due Paesi, interessati a mettere in sicurezza i propri confini e respingere le possibili insorgenze di minoranze etniche (come nel caso della Cina nella regione autonoma dello Xinjiang) e di milizie islamiste (soprattutto per quanto riguarda il Tagikistan). Nel documento ufficiale, Zhao sostiene che “la situazione internazionale sta vivendo cambiamenti drammatici e le prospettive dell’anti terrosimo regionale non sono ottimistiche”. Per questo le esercitazioni erano funzionali a rafforzare le “capacità di combattimento e allo stesso tempo mostrare la determinazione di entrambi gli eserciti a combattere contro i terroristi”.
Non viene citato esplicitamente, ma è chiaro che nei pensieri e tra le pieghe delle parole dell’esponente del Governo cinese ci fosse proprio l’Afghanistan. Se, da una parte, la Cina utilizza il ritiro americano e la presa di potere dei Talebani come un modo per colpire retoricamente gli Stati Uniti e lanciare avvertimenti a Taiwan, dall’altra si cautela e cerca di blindare i propri confini e l’Asia centrale. Cina e Afghanistan condividono un confine di poco più di 70 chilometri ma Pechino teme che senza la presenza americana la sottile lingua di terra del corridoio del Wakhan possa diventare una base per l’insorgenza uigura. Per questo dialoga da tempo coi Talebani, che negli scorsi giorni hanno assegnato a Pechino un “grande ruolo nella ricostruzione” dopo che il Ministero degli Esteri cinese aveva definito gli studenti coranici “più moderati” che in passato.
E per questo rafforza i rapporti difensivi con i partner dell’area, a partire dal Pakistan e dalle ex repubbliche sovietiche. Tra esse ha un ruolo rilevante il Tagikistan, il quale ha una parte di territorio confinante proprio con il corridoio del Wakhan. Inoltre, il prossimo summit SCO (Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai) si terrà proprio a Dushanbe a settembre. Un’occasione nella quale Pechino vuole utilizzare la propria influenza diplomatica per cementare la stabilità regionale e disegnare il futuro dell’Afghanistan post americano. Allo stesso tempo, le repubbliche centrasiatiche sperano che il canale di comunicazione avviato da tempo da Pechino coi Talebani possa garantire non solo la sicurezza dei loro confini ma anche la possibile integrazione dell’Afghanistan nel programma di commercio regionale e di modernizzazione infrastrutturale. Un programma nel quale la Cina mira all’integrazione di Kabul nello sviluppo del corridoio economico sino-pakistano.
Difficile, se non impossibile, che la Cina si faccia convincere a giocare un ruolo maggiore nelle dinamiche interne afgane, per esempio sotto il profilo difensivo. Pechino agisce con cautela, sapendo che la stabilità interna dell’Afghanistan è in perenne fase di assestamento. Quindi sì a cooperazione economico-commerciale, sì alla spinta per il riconoscimento internazionale del nuovo Governo islamista, no alla dimensione militare-difensiva. Quantomeno non a Kabul e dintorni, molto di più oltre i confini afgani, dove la collaborazione con il Pakistan e i Paesi dell’Asia centrale è ormai avviata da tempo anche sotto quel profilo. L’obiettivo di Pechino è sempre quello: sostenere la stabilità interna dei Paesi nei quali mantiene degli interessi di qualche tipo (soprattutto economici) e garantirsi l’appoggio, o quantomeno il silenzio assenso, sui propri dossier interni. A partire da quello della minoranza uigura dello Xinjiang, sulla quale i Governi delle ex repubbliche sovietiche non sollevano obiezioni da lungo tempo. Con la stessa logica ci si prepara a fare affari coi Talebani, ma senza legare eccessivamente la propria immagine alla loro.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Luglio 1921. La Repubblica di Cina è un Paese frammentato, debole, umiliato e offeso dalle dominazioni straniere. A Shanghai si riuniscono in congresso 13 delegati in rappresentanza di 57 membri in un clima di semi clandestinità. Nasce il Partito Comunista Cinese e Chen Duxiu viene nominato suo primo segretario.
Luglio 2021. La Repubblica Popolare Cinese è un Paese forte e ambizioso che ha eliminato la povertà assoluta e si prepara a diventare la prima economia mondiale sorpassando gli Stati Uniti. Il Partito Comunista Cinese conta oltre 90 milioni di membri e Xi Jinping si appresta, al ventesimo Congresso dell’autunno 2022, a essere nominato Presidente per la terza volta dopo che la riforma costituzionale approvata nel 2018 ha eliminato il limite dei due mandati.
In cento anni la Cina ha cambiato tanto, compreso il nome. Un processo di trasformazione guidato dal Partito Comunista, che ha saputo conquistare il potere e mantenerlo mentre esso stesso si trasformava, assurgendo al ruolo totale di Partito-Stato ed essendo allo stesso tempo in grado di conciliare la sua missione storica con una continua tensione verso quella che Giovanni B. Andornino definisce “modernizzazione autoritaria accelerata“. Processi divenuti ancora più rapidi e ambiziosi con l’arrivo di Xi Jinping nel 2012.
Composto inizialmente soprattutto da contadini e operai, sin dai tempi delle riforme economiche di Deng Xiaoping il Partito ha iniziato a cambiare pelle, innalzando il livello di istruzione dei propri membri, oggi in maggioranza espressione delle forze produttive più avanzate del Paese. Forze che il Partito e Xi vogliono tenere sotto controllo, per evitare che da centri di potere economico possano diventare futuribili aggregatori di proposte politiche. Necessità esplicitata dal caso Jack Ma e dal crescente ruolo del Partito-Stato nell’economia privata, in un contesto dialettico nel quale si cercano nuovi equilibri coi colossi tecnologici che negli anni hanno accumulato un’immensa quantità di dati, dunque di potere. Per conquistarsi un ruolo di rilievo nella società cinese, essere membri del Partito è necessario, ma non sufficiente. Con Xi l’accento su lealtà e fedeltà è ancora più forte. Appena diventato Presidente ha lanciato una vasta campagna anticorruzione più volte rilanciata durante i suoi primi due mandati e arrivata a coinvolgere personaggi di spicco. Ultimo caso: il processo a carico di Dong Hong, ex assistente del Vicepresidente Wang Qishan, cioè colui che ha gestito la prima e virulenta fase della campagna.
Durante i suoi primi due mandati Xi ha accentrato su di sé molto potere. Ha avocato a un nuovo gruppo direttivo da lui stesso presieduto la politica economica nazionale, solitamente di competenza del Premier. Ha lanciato una vasta ristrutturazione in senso centralista degli apparati politico-statali e una riforma delle forze armate da lui stesso presiedute. Ha soprattutto ottenuto che il suo contributo teorico venisse inserito come ideologia guida nello statuto del Partito e nella costituzione. Non si tratta di un mero riconoscimento formale, ma di un atto con conseguenze concrete visto che Xi è ancora in carica: chi lo critica non critica solo lui, ma l’intero apparato ideologico del Partito.
La crescente presa, quantomeno a livello nominale, di Xi all’interno del Partito è evidente se si guarda alle composizioni del 18esimo e 19esimo Politburo. Nel primo, i membri che avevano già lavorato con lui in passato nei suoi incarichi provinciali o che comunque avevano con lui un rapporto stretto erano cinque, vale a dire circa il 20% del totale. Nel secondo, quello in carica fino al 2022, il numero è salito a 15 e la percentuale al 60%. Secondo la cosiddetta “clausola di Li Ruihan”, i membri del Politburo e del Comitato permanente non possono iniziare un nuovo mandato dopo aver compiuto 68 anni. Clausola che al prossimo Congresso verrà disattesa per Xi, ma probabilmente per nessun altro. Ciò significa che potrebbero cambiare 15 componenti. Tra coloro che dovranno lasciare il loro posto ci sono soprattutto membri esterni al “cerchio magico” di Xi, come il Premier Li Keqiang, la Vicepremier Sun Chunlan, il Presidente della Conferenza politico-consultiva Wang Yang.
Dunque, alcuni mandati apicali saranno liberi e prevedibilmente destinati a fedelissimi del Presidente, che nel prossimo Politburo dovrebbe perdere solo 6 dei 15 uomini a lui più vicini, tra i quali il Presidente del Comitato Permanente dell’Assemblea Nazionale del Popolo Li Zhanshu, l’ideologo Wang Huning e il Presidente del Dipartimento Organizzativo del Comitato Centrale Chen Xi. Pronti a beneficiarne gli attuali membri del Politburo vicini a Xi che possono svolgere un altro mandato. Tra questi Cai Qi (Segretario del Partito a Pechino), Li Hongzhong (Segretario a Tianjin), Li Qiang (Segretario a Shanghai), Li Xi (Segretario nel Guangdong, la cruciale provincia meridionale dalla quale Xi ha lanciato il sistema della “doppia circolazione” prima del V Plenum dell’ottobre 2020) e Huang Kunming (capo della propaganda del Partito). Ma attenzione ai due fedelissimi di Xi più giovani, gli unici senza vincoli di mandato non solo in vista del Congresso del 2022 ma anche in vista del successivo Congresso del 2027. Si tratta di Chen Min’er (Segretario a Chongqing) e Ding Xuexiang (Direttore dell’Ufficio Centrale del Partito). Il primo ha lavorato con Xi nella provincia dello Zhejiang, ai tempi in cui il futuro Presidente si costruì la fama di implacabile punitore dei dirigenti corrotti. Il secondo ha invece lavorato con Xi a Shanghai e lo ha poi seguito a Pechino.
Al momento è impossibile prevedere se nel 2022 Xi indicherà, quantomeno implicitamente, un suo potenziale successore. Se lo farà, è possibile che il nome possa essere quello di Chen o quello di Ding. Se così fosse, si aprirebbe una fase di transizione più o meno lunga in cui l’erede designato sarà fatto crescere all’ombra di Xi, magari dalla posizione di Premier. Già, perché il più logico successore di Li, vale a dire Hu Chunhua, è considerato un uomo vicino all’ex Presidente Hu Jintao e alla cosiddetta fazione dei Tuanpai (gli esponenti della Lega della gioventù comunista). Ma è altresì possibile che anche il prossimo anno non emerga nessuna figura in ottica presidenziale. Attenzione in quel caso agli astri nascenti che tra pochi mesi potrebbero trovare posto nel Politburo. Tra questi, da seguire soprattutto Chen Yixin, Segretario Generale della Commissione centrale per gli affari politici e giuridici nonché capo della nuova campagna anticorruzione, e Chen Quanguo, leader del Partito nello Xinjiang.
Questo sposterebbe l’orizzonte politico di Xi più in là, ancora più vicino a quel 2035 che sembra diventato il prossimo snodo fondamentale della retorica del Partito. Una data a metà strada tra il centenario del Partito stesso e il centenario della Repubblica Popolare (2049). Vale a dire a metà tra il raggiungimento del traguardo di una società “moderatamente prospera” e l’obiettivo della realizzazione di una società “armoniosa”. Il 2035 dovrà rappresentare il completamento della “modernizzazione socialista”, con la Cina prima economia al mondo in grado di archiviare definitivamente il “secolo dell’umiliazione”.
Ma le ipotesi possibili sono tante, compresa quella di una permanenza fuori età o fuori mandato di uno dei membri uscenti del Politburo, magari Wang Huning o Liu He, così come quella (che appare più tortuosa quantomeno nel breve termine) di una successione “controllata” di Xi, che andrebbe a presiedere Partito e Stato da una nuova posizione di potere creata ad hoc. In quest’ultimo caso potrebbe essere il fidato Wang ad assumere la carica presidenziale, con Xi in ascesa verso il titolo maoista di “grande timoniere”. In ogni caso va ricordato che, per quanto Xi abbia dato una svolta personalistica, il Partito Comunista Cinese resta una forza politico-statale-ideologica complessa, mutevole e adattabile, nella quale gli equilibri possono cambiare o evolversi. Ciò non significa che ci sia un’opposizione interna pronta a rovesciare i rapporti di forza, ma Xi non sarà mai un uomo solo al comando. Almeno non del tutto.
Questo articolo è pubblicato anche sul numero di luglio/agosto di eastwest.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Umiliazione. Si tratta di una parola chiave nella storia recente della Cina, portatrice di ricordi mai del tutto dimenticati e che il Presidente Xi Jinping ha anzi spesso utilizzato per alimentare orgoglio e nazionalismo.
Il secolo dell’umiliazione è finito da tempo e Pechino non perde occasione per ribadire come le potenze occidentali non possano in alcun modo alterare la sua traiettoria, o meglio la sua ascesa. Ora la stessa parola domina i racconti e le analisi sull’Afghanistan dei media di Stato cinesi. Ma stavolta non è la Cina a venire umiliata, bensì gli Stati Uniti. Così come lo erano stati in Vietnam. Un parallelo, quello tra Saigon e Kabul, che viene utilizzato da Pechino per sottolineare la presunta “inaffidabilità” (altra parola chiave) degli Stati Uniti. Prima ancora delle considerazioni geopolitiche e strategiche, il caos in Afghanistan sta fornendo alla Cina nuovo materiale per rafforzare la sua narrativa secondo la quale gli Usa hanno perso la leadership mondiale e il modello globale a guida americano non esiste più.
L’11 settembre prima, la crisi finanziaria poi, infine Capitol Hill. Il Partito comunista intravede nel grande rivale i segnali di una decadenza irreversibile. E li espone a uso e consumo del pubblico interno ed esterno. Obiettivo: rafforzare la propria presa sulla popolazione cinese presentando un paragone favorevole con il modello altrui e allo stesso tempo provare ad ampliare le crepe di sfiducia che il ritiro dall’Afghanistan può aprire a livello internazionale. Un ritiro deciso da Donald Trump e al quale Joe Biden si è attenuto, rispettando peraltro le promesse elettorali. Ma la figuraccia fatta sulla presunta, e prontamente smentita, capacità delle forze militari governative di controllare l’avanzata talebana è tutta del Presidente democratico.
L’insistenza retorica sull’inaffidabilità statunitense serve anche sul fronte taiwanese. Sottolineare la mancata difesa degli alleati da parte di Washington a Kabul significa dire a Taipei: “Molleranno presto anche voi quando decideremo di attaccare”. Un messaggio che sta avendo qualche breccia a Formosa, anche per il suo insistente veicolamento da parte del Guomindang, il partito di opposizione che contesta alla Presidente Tsai Ing-wen un eccessivo avvicinamento agli Stati Uniti, che sembra aver causato una irreparabile frattura (quantomeno a livello diplomatico e ufficiale) con la Repubblica Popolare. Ma le due situazioni sono molto lontane l’una dall’altra. Anzi, il disimpegno americano dal Medio Oriente è motivato anche (o soprattutto) dall’intenzione di concentrarsi su quello che anche il Pentagono ha individuato come rivale strategico numero uno: la Cina, appunto.
In realtà, oltre alle opportunità il caos afgano presenta anche qualche timore per Pechino. Soprattutto quello che il corridoio di Wakhan, sottile lingua di territorio che va dal cuore della parte orientale dell’Afghanistan allo Xinjiang. Lungo il percorso, peraltro, separa altri due territori disputati: a nord confina infatti con il Gorno-Badachshan, regione autonoma del Tagikistan nella quale negli anni Novanta si è combattuta una guerra, e a sud con il Gilgit-Baltistan, la sezione di Kashmir controllata dal Pakistan. Pechino teme che in quella lingua di terra possano in qualche modo ritrovare terreno fertile i gruppi armati uiguri, che potrebbero essere in grado di infiltrare lo Xinjiang attraverso il confine condiviso di circa 70 chilometri.
Anche per questo, da tempo la Cina ha allacciato i contatti con i Talebani, riconoscendoli come forza da tenere in considerazione ben prima della presa di Kabul nel giorno di Ferragosto. Già nel 2019 c’erano stati incontri ufficiali, ribaditi nelle scorse settimane. I Talebani cercano l’aiuto della Cina per ottenere un riconoscimento internazionale e yuan freschi da investire nella ricostruzione del Paese. Dall’altra parte Pechino chiede il controllo del territorio e la non proliferazione dei gruppi terroristici, nonché il mancato coinvolgimento nella questione uigura. Non si tratta di una novità strategica, la Cina parla sempre con tutte le parti in causa per tenersi pronta a qualsiasi eventualità.
È accaduto per esempio in Myanmar, dove il Governo aveva costruito rapporti proficui non solo con la giunta militare ma anche (e soprattutto, in realtà) con la Lega nazionale per la democrazia di Aung San Suu Kyi. Allo stesso modo, Xi Jinping aveva parlato con l’ormai ex Presidente Ghani meno di un mese prima della sua fuga dal palazzo presidenziale. Ora, però, i Talebani sono l’unica forza con la quale costruire “relazioni amichevoli”, sperando che siano in grado di garantire quello che è il perenne mantra e necessità della strategia cinese, soprattutto in Asia: stabilità. Ecco perché ora la portavoce del Ministero degli Esteri, Hua Chunying, dice che il governo cinese è pronto a “rispettare la volontà del popolo afgano” e a sviluppare i rapporti coi talebani.
Senza gli Usa, la Cina avrà più spazio nella regione ma anche più responsabilità.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Cina 42 ori, Stati Uniti 38. Così, a poche ore dalla loro conclusione, si stavano avviando alla chiusura i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Quantomeno secondo una versione alternativa del medagliere che è molto circolata sulla rete cinese. Com’è possibile il ribaltamento del finale reale, vale a dire 39 medaglie d’oro a 38 a favore degli Stati Uniti? Semplice, aggiungendo al conto dei successi cinesi quelli di Hong Kong e Taiwan.
L’ex colonia britannica ha conquistato un oro, due argenti e tre bronzi. Taipei invece è stata protagonista della migliore spedizione olimpica della sua storia con un totale di 12 medaglie (2 ori, 4 argenti e 6 bronzi). Medagliere non adottato dai media ufficiali cinesi, anche perché al di là delle considerazioni geopolitiche non si può certo negare che Hong Kong e Taiwan abbiano due federazioni sportive separate da quella della Repubblica Popolare.
L’episodio fa comunque capire quanto la Cina tenga all’affermazione in campo sportivo. Una storia che parte da lontano e che segue l’evoluzione generale dell’ascesa di Pechino.
Dopo una sporadica partecipazione senza medaglie a Helsinki 1952, infatti, gli atleti della Repubblica Popolare spariscono dalla circolazione per il riconoscimento di Taiwan, fino al reintegro nel Comitato Olimpico Internazionale nel 1979. L’ascesa sportiva comincia a Barcellona 1992 e ad Atlanta 1996, quando in entrambe le circostanze si issa al quarto posto del medagliere. Il salto di qualità arriva però a cavallo del nuovo millennio. A Sydney 2000 gli ori sono 28 con il terzo posto finale, mentre ad Atene 2004 si sale a 32 ori e il secondo posto con solo 4 vittorie in meno degli Stati Uniti.

Non è un caso. Subito dopo i Giochi australiani il governo cinese mette a punto il cosiddetto “Progetto 119”, dal numero di medaglie disponibili in alcune discipline sportive messe nel mirino delle autorità. Il programma fu messo a punto dopo le Olimpiadi del 2000 a Sydney, quando appunto erano in palio 119 medaglie tra atletica leggera, nuoto, canottaggio, canoa/kayak e vela. In quell’edizione, gli atleti cinesi avevano conquistato solo una medaglia. L’obiettivo era quello di insistere nell’addestramento dei giovani atleti su quelle discipline, insieme al perfezionamento di quelle in cui tradizionalmente le nazioni occidentali erano più attaccabili.
Risultato: ai Giochi Olimpici di Pechino 2008 la Cina trionfa al medagliere per la prima volta nella sua storia con 100 medaglie, 48 delle quali d’oro e ben 12 in più degli Stati Uniti. Quelle Olimpiadi sono il segno plastico della rinascita cinese. Proprio nell’anno della grande crisi finanziaria che ha colpito l’Occidente, Pechino comunica al mondo che il “secolo delle umiliazioni” è finito. Dopo un secondo posto a Londra 2012 con 38 ori, a Rio 2016 arriva un deludente terzo posto con “solo” 26 ori.
In questi ultimi cinque anni però è successo di tutto: Donald Trump ha avviato una guerra commerciale che si è rivelata essere molto più di una mera questione di dazi e bilancia dell’interscambio. Anzi, con Joe Biden ha assunto le proporzioni di una competizione valoriale e quasi ideologica. Ecco che allora Tokyo 2020, edizione svoltasi in ritardo di un anno a causa della pandemia da Covid-19, è diventato un palcoscenico sul quale la Cina non si accontenta più di mostrare di essersi risvegliata. Ora Pechino vuole primeggiare, in linea con il sorpasso economico agli Stati Uniti che secondo alcuni analisti potrebbe avvenire entro il 2028. In Giappone gli atleti cinesi hanno conquistato 88 medaglie, 38 d’oro, capeggiando la classifica per tutte e due le settimane della manifestazione, subendo però il sorpasso proprio all’ultimo giorno. Questo perché nelle ultime giornate si assegnano le medaglie degli sport di squadra, quelli dove tradizionalmente la Cina fa più fatica e gli Stati Uniti eccellono.
Vari episodi chiariscono che le Olimpiadi per la Cina (e per gli atleti cinesi) non sono solo una questione sportiva. Zhang Yufei, dopo aver conquistato l’oro ai 200 farfalla, ha dichiarato di aver sentito il “potere della Cina” che la sosteneva negli ultimi 50 metri verso la vittoria. Bao Shanju e Zhong Tianshi si sono presentate sul podio dopo aver vinto nel ciclismo su pista a squadre con delle spillette di Mao Zedong.
Dall’altra parte, gli utenti cinesi hanno dato sfogo al nazionalismo prendendo di mira gli “sconfitti”, vale a dire gli atleti che hanno conquistato “solo” una medaglia d’argento in discipline nelle quali la Cina era in partenza favorita. Per esempio Liu Shiwen e Xu Xin, sconfitti dal Giappone nella finale del doppio misto di tennis tavolo. O soprattutto Li Junhui e Liu Yuchen, che hanno perso contro la coppia taiwanese nella finale del badminton.
Yang Qian, prima medaglia d’oro di Tokyo 2020 nel tiro a segno, è stata invece criticata perché indossava delle scarpe Nike, tra i brand internazionali che hanno espresso critiche sui lavori forzati nello Xinjiang. Ora, tra soli sei mesi, si torna a Pechino. A febbraio si svolgono infatti i Giochi Olimpici invernali nella capitale cinese. Mentre da occidente arrivano chiamate al boicottaggio, il governo cinese si prepara all’evento, nonostante le discipline invernali storicamente non sorridano agli atleti locali. Ma, c’è da scommetterci, il palcoscenico per una auspicata nuova dimostrazione di forza sarà pronto.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Lockdown a Wuhan. Un anno e mezzo dopo, torna un’espressione che aveva anticipato quella che sarebbe diventata la triste normalità. Non solo (anzi, non tanto) della Cina ma di tutto il mondo.
Ora, quando ormai i cittadini della Repubblica Popolare pensavano di aver archiviato l’emergenza, il coronavirus torna a bussare alla porta della metropoli della provincia dello Hubei nella quale era stato scoperto. E, in generale, la variante Delta del Covid-19 desta qualche preoccupazione al governo cinese, che dopo l’ondata iniziale aveva gestito in maniera efficace la pandemia di fatto azzerando la diffusione dei contagi per lunghissimo tempo.
La “vittoria sul demone” del virus, preannunciata dallo stesso Xi Jinping in visita a Wuhan nel marzo del 2020, ha consentito peraltro alla Cina non solo di uscire per prima dall’emergenza sanitaria, ma anche di far ripartire la sua economia prima degli altri. Non a caso, Pechino ha fatto segnare una crescita del PIL del 2,3% nello scorso anno. Risultato mancato da tutte le altre economie mondiali, bloccate con il segno meno.
Non solo. L’inefficienza dimostrata da diversi Paesi occidentali, Stati Uniti in primis, nella gestione dell’emergenza (quantomeno nelle prime fasi), ha garantito al Partito Comunista Cinese un’altra doppia opportunità. La prima: rafforzare la propria narrativa interna, mettendo a confronto i propri successi in ambito sanitario e gli insuccessi dei rivali occidentali. La seconda: rafforzare la propria retorica verso l’esterno, attraverso la diplomazia delle mascherine prima e quella dei vaccini poi.
Ora, però, sembra poter tornare tutto in discussione. Già nelle scorse settimane la distribuzione dei vaccini cinesi ha subito qualche battuta d’arresto, a causa della sua efficacia, che sarebbe ridotta di fronte alla diffusione della variante Delta rispetto ad altre opzioni sviluppate da case farmaceutiche occidentali.
Ma, soprattutto, torna la preoccupazione all’interno dei confini cinesi, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 96 nuovi casi di Covid-19, 71 dei quali locali. Si tratta del numero più alto di contagi dallo scorso gennaio.
Il nuovo epicentro dell’epidemia è Nanchino, capitale della provincia sud-orientale dello Jiangsu. Da qui, dall’aeroporto Lukou, ha avuto origine un focolaio tra i dipendenti dello scalo che stavano pulendo un aereo proveniente dalla Russia. I 9,3 milioni di abitanti di Nanchino sono stati tutti sottoposti a due round di tamponi nei giorni scorsi e ora i nuovi contagi giornalieri si sono stabilizzati tra le 30 e le 40 unità.
L’emergenza si è poi spostata anche nelle province interne. Prima nello Hunan, per l’esattezza a Zhangjiajie, meta di diversi turisti provenienti proprio da Nanchino. Qui la fonte del focolaio sarebbe stato uno spettacolo teatrale al quale hanno assistito circa cinquemila persone. Le autorità stanno cercando (a fatica) di tracciare tutti coloro che hanno partecipato, chiudendo nel frattempo tutte le attrazioni turistiche. Chiunque deve sottoporsi a un test anti Covid prima di poter lasciare la città.
È infatti proprio al turismo e agli spostamenti delle recenti settimane che le autorità attribuiscono l’aumento dei contagi su scala nazionale. Per lunghi mesi i cittadini cinesi hanno vissuto come se il coronavirus non fosse sostanzialmente mai esistito. Viaggi consentiti, ristoranti e negozi sempre aperti, folle a concerti e altri eventi di massa.
Ora però questo stile di vita torna a rischio. Tanto che si torna a parlare di lockdown. E la Cina ha già dimostrato che i suoi lockdown sono particolarmente stringenti. Chiusa la città di Zhuzhou (2,7 milioni di abitanti), a rischio anche l’isola di Hainan, altra popolarissima meta turistica della stagione estiva cinese.
È stato intanto imposto il lockdown a sei complessi residenziali nel distretto nord-occidentale di Haidian, mentre nel distretto di Changping lo stesso provvedimento è stato preso per altri nove complessi. A Zhengzhou, già colpita di recente da una violentissima alluvione, sono stati sottoposti a tampone circa dieci milioni di residenti.
Il fatto che la diffusione iniziale sia cominciata da un aeroporto ha fatto sì che la variante Delta arrivasse in diverse province cinesi e che dunque non potesse essere contenuta come fatto di solito a livello locale. Coinvolte anche le province del Liaoning e del Sichuan, mentre Pechino torna a blindarsi, bloccando i treni ad alta velocità in 23 stazioni dopo aver registrato quattro contagi.
In tutto, la variante è arrivata in 35 città e 17 province.
Ma ciò che fa più effetto, anche a livello simbolico, è che in parziale lockdown ci debba tornare anche Wuhan, la città simbolo della prima resistenza alla diffusione del virus.
La zona finanziaria di Zhuankou è stata designata come area a medio rischio e ai residenti sono state imposte forti restrizioni di movimento. Contemporaneamente è partita una campagna di tamponi a tappeto per tutti i 12 milioni di abitanti della città. Dopo che sette lavoratori migranti sono risultati positivi ed è stata confermata la trasmissione locale del virus per la prima volta da giugno 2020.
In tutto, a luglio ci sono stati 328 contagiati: un numero molto basso in generale, ma che è quasi lo stesso del totale delle infezioni dei precedenti cinque mesi in Cina. Nel frattempo, continua la campagna vaccinale. A oggi le autorità affermano di aver somministrato 1,6 miliardi di dosi. Un numero impressionante, ma le perplessità sull’efficacia dei sieri cinesi nel contenimento delle nuove varianti rappresenta un’incognita in più.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Forse alla fine si riveleranno un’opportunità, ma al momento sembrano essere soprattutto un problema. I Giochi Olimpici 2020 stanno creando non pochi grattacapi al Giappone, che ormai a poche ore dal via ufficiale della più importante manifestazione sportiva al mondo si trovano a fare la conta dei danni sanitari, economici e politici. Il premier Yoshihide Suga ha lanciato un appello a “essere uniti” e “portare a termine i Giochi con gli sforzi e la saggezza dell’umanità”. Ecco, il risultato massimo che sembra profilarsi all’orizzonte ora è quello di riuscire a portare a termine le Olimpiadi. Accantonato forse in maniera definitiva l’obiettivo di renderli un successo, sembra proprio che ci si dovrà accontentare di limitare i danni. “Come Tokyo 1964 marcò una nuova era per un Giappone dinamico in pace, così Tokyo 2020 darà all’umanità fede nel futuro”, ha detto il Presidente del Comitato olimpico internazionale, Thomas Bach.
Ma per ora Tokyo è alle prese con problemi molto più concreti. Dal primo luglio a oggi sono 71 le persone risultate positive al Covid-19 tra quelle arrivate in Giappone e in qualche modo collegate alle varie delegazioni olimpiche. Un’atleta della squadra statunitense di ginnastica artistica è solo l’ultimo esempio di una lunga serie di casi, nel quale sono rientrati anche due calciatori della nazionale del Sudafrica, risultati positivi nonostante fossero completamente vaccinati. Nonostante questo, il Cio ha chiesto al Governo giapponese di considerare la possibilità di riaprire alcune gare (programmate per ora interamente a porte chiuse) dei Giochi al pubblico, nel caso il quadro dell’emergenza pandemica migliori nelle prossime settimane. Difficile che questo avvenga, considerato il clima che si è creato nell’opinione pubblica.
A Tokyo è stato dichiarato lo stato di emergenza fino al 22 agosto e la maggioranza dei giapponesi è contrario allo svolgimento dei Giochi. Secondo gli ultimi sondaggi, il 68% dei cittadini è contrario allo svolgimento regolare dei Giochi. Le precauzioni prese all’interno del villaggio olimpico non rassicurano i cittadini, che temono che la presenza di 18mila tra atleti e funzionari possa porre le basi di un mega focolaio. Nelle ultime settimane, la campagna vaccinale ha aumentato il proprio ritmo (inizialmente davvero molto lento) ma per ora solo poco più del 20% della popolazione di 126 milioni di abitanti è stata immunizzata e il 32,4% ha ricevuto almeno una dose del vaccino.
Ma i problemi non si fermano qui. Quattro elettricisti britannici e statunitensi sono stati arrestati per possesso di stupefacenti, un membro dello staff uzbeko è invece accusato di aggressione sessuale ai danni di una collega giapponese. Un atleta ugandese è invece sparito dal villaggio olimpico e si è dato alla macchia. C’è poi l’aspetto economico. Diversi sponsor hanno iniziato a consultare esperti per valutare il danno di immagine del venire collegati ai Giochi. Già, perché la manifestazione è talmente impopolare da aver convinto diversi brand che pubblicizzarla o ancora peggio farne parte possa comportare conseguenze negative a livello di affari e di reputazione. Persino Toyota, la casa automobilistica locale, ha deciso che non manderà più in onda gli spot televisivi registrati con gli atleti che partecipano alle gare. Una mossa clamorosa, se si considera che circa 200 olimpionici sono affiliati a Toyota, che aveva tra l’altro firmato con il Cio un accordo da quasi un miliardo di dollari. Meglio non badare a spese immediate per non alienarsi una fetta importante di pubblico in futuro. Anche altre 60 grandi aziende giapponesi si trovano di fronte allo stesso dilemma. Asahi, Panasonic, Fujitsu e Ntt hanno seguito l’esempio di Toyota e hanno disertato la cerimonia di inaugurazione in programma per venerdì 23 luglio.
Delusioni anche dal punto di vista diplomatico. Le Olimpiadi erano state anche individuate come l’occasione per rilanciare i rapporti con la Corea del Sud. Tanto che era prevista una visita del Presidente coreano Moon Jae-in, il quale avrebbe dovuto incontrare Suga. Il viaggio doveva restare segreto ma i media giapponesi lo hanno reso pubblico, causando le ire di Seul. Non solo. Il vicecapo dell’ambasciata nipponica in Corea, Hirohisa Soma, ha paragonato nei giorni scorsi i tentativi di Moon di riavvicinarsi al Giappone come atti di “masturbazione”. Offesa che ha causato la cancellazione della visita di Moon, nonostante la rimozione dello stesso Soma.
Le conseguenze economiche per Tokyo rimarranno comunque limitate, visto che i 15,4 miliardi spesi per organizzare l’evento sono già stati iscritti a bilancio negli anni scorsi. Le conseguenze possono semmai diventare soprattutto politiche. La maggioranza dei giapponesi ritiene che il Governo non sia in grado di fronteggiare in maniera adeguata la nuova ondata di contagi e il gradimento nei confronti del Primo Ministro Suga è ai minimi storici: 35,9%. Non un buon viatico, in vista delle elezioni generali di fine ottobre. Suga ha dissipato i dubbi e ha chiarito che intende restare al suo posto. A settembre il Partito liberaldemocratico, che nonostante tutti i problemi sembra come sempre senza rivali alle urne, deciderà quale sarà il suo candidato. Un segmento del partito critica Suga per la gestione della pandemia, ritenuta insoddisfacente, e il suo stesso predecessore Shinzo Abe appare scettico sull’operato dell’erede. Eppure, l’assenza di candidati forti potrebbe comunque salvare Suga, che potrebbe essere in serio rischio solo con l’esplosione di un nuovo focolaio interno causato dai Giochi Olimpici. L’evento che doveva essere un trampolino di lancio non solo per Suga ma per l’intero Giappone rischia di rivelarsi una patata bollente.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
L’India è vicina. Forse anche più della Cina. Chi lo avrebbe detto solo qualche mese fa, quando la Commissione europea aveva raggiunto l’accordo sul Comprehensive Agreement on Investment (Cai), proprio alla vigilia dell’insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca. Poi, però, è successo qualcosa. Il nuovo Presidente democratico ha lanciato una campagna di rafforzamento delle partnership a livello globale in funzione anti cinese (quantomeno nell’ottica di Washington). E uno dei perni della sua strategia è il ruolo dell’India, non a caso coinvolta in una serie di strutture multilaterali, a partire dal Quad fino all’invito recapitato al Primo Ministro Narendra Modi per il recente G7 in Cornovaglia. L’Unione europea, almeno in parte, si adegua. Con una più che interessante coincidenza di tempi, Bruxelles ha di fatto congelato la ratifica del CAI rilanciando contemporaneamente il negoziato per un accordo di libero scambio con Nuova Delhi.
Dopo il graduale abbassamento delle tariffe, operato dall’India dagli anni Novanta, i due attori sono diventati partner strategici nel 2004, ma finora le relazioni non sono mai state portate a un livello superiore. Nel 2007 erano partiti i primi negoziati per raggiungere un accordo di libero scambio, poi bruscamente interrotti nel 2013 dopo 16 tornate di trattative risultate infruttuose. Oggi, l’Ue deve ancora far fronte a dazi elevati per l’esportazione di prodotti agricoli e alimentari, automobili e macchinari. I colloqui del 2013 si erano bloccati proprio di fronte all’incolmabile distanza sulla riduzione delle tariffe e sul capitolo degli investimenti, con gli appalti pubblici indiani chiusi agli attori europei.
A distanza di otto anni le trattative riprendono. E non lo fanno all’improvviso. Nel 2018 l’Ue ha adottato una strategia sull’India, tesa a rafforzare la partnership strategica e la cooperazione multilaterale. Il dialogo bilaterale ha poi ripreso velocità durante il 2020, quando in piena prima ondata pandemica il quindicesimo summit bilaterale ha prodotto una “Roadmap 2025“, che nelle intenzioni di entrambi gli attori “apre un nuovo capitolo della partnership strategica tra Ue e India”. La Roadmap, tra le altre cose, prevede un’azione congiunta per quanto riguarda la lotta al cambiamento climatico e la transizione ecologica. Tra i primi risultati in tal senso, la collaborazione nell’ambito dell’Alleanza Solare Internazionale. La stessa roadmap ha istituzionalizzato il dialogo ministeriale sul commercio e gli investimenti, azione alla base della riapertura vera e propria dei negoziati per un accordo che, stando a uno studio del 2020 del Parlamento europeo, potrebbe portare benefici economici pari a 8,5 miliardi di euro sia per l’Ue sia per l’India. Una stima precedente alla Brexit. E non a caso l’India sta trattando un ulteriore accordo di libero scambio con il Regno Unito, che in questi mesi ha dimostrato di guardare con attenzione verso Oriente già con i negoziati conclusi con Vietnam e Singapore.
I margini di miglioramento delle relazioni commerciali è evidente. L’Ue è il primo partner commerciale dell’India (che destina invece al blocco dei 27 il 15% delle sue esportazioni) e il suo più grande investitore straniero. I 67,6 miliardi di euro di investimenti del 2018 hanno rappresentato il 22% di quelli totali ricevuti dall’India, ma sono comunque meno della metà di quelli che nello stesso anno l’Ue ha dislocato in Cina (175,3 miliardi di euro). L’interscambio commerciale Ue-India si è fermato a poco più di 60 miliardi di euro nel 2020, contro i 585 miliardi di euro di quello Ue-Cina.
I negoziati saranno composti da tre capitoli fondamentali: commercio, investimenti e tutela delle indicazioni geografiche. La loro riapertura è motivata innanzitutto da forti interessi commerciali. La nuova ondata pandemica che ha colpito l’India sta mettendo a serio rischio la ripresa economica di Nuova Delhi, che ha bisogno di nuovi “motori” e nuove partnership per ripartire. Con la decisione di restare fuori dalla Regional Comprehensive Economic Partnership (Rcep), l’accordo di libero scambio che unisce Cina, Giappone, Corea del Sud, Australia, Nuova Zelanda e i 10 Paesi del blocco Asean, Nuova Delhi ha iniziato a guardare verso occidente per il suo bisogno di investimenti. Dal canto suo, l’Ue spera di poter risolvere la questione di accesso a un mercato immenso come quello indiano, che la crescita demografica dovrebbe rendere il principale (almeno quantitativamente) al mondo entro pochi anni.
Ci sono diversi settori che sarebbero destinati a dei vantaggi se si arrivasse a un accordo di libero scambio tra Ue e India. L’esportazione di metalli di base dall’Ue potrebbe raddoppiare (passando da 2,9 miliardi a 5,7 miliardi), con notevoli stime di crescita anche per prodotti chimici, macchinari e attrezzature. Previsti notevoli guadagni anche per automotive e prodotti alimentari come il vino, che soffrono ancora di tariffe elevatissime. Tra i comparti con maggiori potenziali di crescita, in particolare per l’Italia, c’è la meccanica strumentale. Nell’altra direzione, si stima una grande crescita per le esportazioni indiane di prodotti tessili (+5,4 miliardi), che rappresentano la stragrande maggioranza delle importazioni europee dall’India, e servizi. In generale, le esportazioni comunitarie verso l’India potrebbero aumentare tra il 52 e il 56%, mentre le importazioni da Nuova Delhi dovrebbero crescere tra il 33 e il 35%. Sono previsti, inoltre, investimenti congiunti in Paesi terzi in materia di infrastrutture, trasporti, energia e settore digitale. La Roadmap 2025 prevede tra l’altro cooperazione in materia di tecnologia, intelligenza artificiale e urbanistica.
Restano comunque diversi nodi da sciogliere, a partire dalla protezione dei brevetti, la sicurezza dei dati e l’accesso al mercato, così le ineguaglianze del sistema indiano e le condizioni dei lavoratori. Ma il raggiungimento di un accordo garantirebbe la possibilità di diversificare le catene di approvvigionamento e ridurre (per entrambi) la dipendenza economica dalla Cina. Sull’esempio dell’accordo di libero scambio raggiunto con il Giappone nel 2019, l’Ue sta cercando di irrobustire i legami con le potenze medie asiatiche. L’intenzione dichiarata è quella di “proteggere e promuovere i diritti umani, un ordine globale basato sulle regole, un vero multilateralismo, uno sviluppo sostenibile e il libero commercio”. Appare chiaro che geopoliticamente l’Ue abbia deciso di seguire gli Stati Uniti, che nella loro strategia sull’Indo Pacifico puntano molto sul ruolo dell’India per contenere l’ascesa dell’influenza cinese. E questo nonostante le varie strette sul fronte dei diritti civili operate negli ultimi anni dal Governo Modi, protagonista di una traiettoria nazionalista e di accentramento dei poteri.
La cooperazione tra quelle che si definiscono “le due più grandi democrazie al mondo” può andare al di là degli aspetti commerciali. L’Ue e diversi Stati membri come Germania, Francia e Paesi Bassi hanno adottato di recente una strategia sull’Indo Pacifico che li rende attori non solo commerciali ma anche geopolitici nella principale arena di competizione sino-statunitense. La Roadmap 2025 prevede l’istituzionalizzazione del dialogo di sicurezza marittima bilaterale. E il raggiungimento di un accordo di libero scambio, unito all’attivismo navale europeo, potrebbe dare una spinta all’influenza di Nuova Delhi nell’area. Non solo dal punto di vista della sicurezza, ma anche da quello degli investimenti, in competizione con la Belt and Road di Pechino insieme alla Supply Chain Resilience Initiative già lanciata da India, Australia e Giappone e soprattutto alla Build Back Better World (BW3) Partnership annunciata durante il G7 e ipoteticamente tesa a offrire un’alternativa al programma cinese nei Paesi in via di sviluppo.
La strada per un possibile accordo tra Ue e India è ancora lunga ma, se percorsa fino in fondo, non porterebbe solo a sviluppi importanti dal punto di vista commerciale, ma anche a una ricalibratura della politica asiatica dei 27.
Questo articolo è pubblicato anche sul numero di luglio/agosto di eastwest.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
I colossi tecnologici cinesi devono restare quello che sono, vale a dire dei colossi tecnologici. Il loro potere economico non può diventare potere politico. E allora serve intervenire sul loro potere strategico, rappresentato in primis dalla conservazione di una sterminata quantità di dati, e sul loro margine di manovra, dunque sulla loro proiezione verso l’esterno. Nella Cina di Xi Jinping e della doppia circolazione, le Big Tech devono imparare che non solo non possono diventare portatrici di istanze politiche, ma che non possono nemmeno ambire a diventarlo.
Il Governo cinese ha rotto gli indugi e negli ultimi tempi sta intervenendo con sempre maggiore decisione su un settore che potenzialmente potrebbe farsi portavoce di istanze politiche, economiche e sociali. Non importa quanto queste istanze possano essere vicine o lontane dalla sua linea, il Partito comunista cinese non vuole altri poli in grado di aggregare consenso e visioni di futuro.
Il caso Jack Ma lo aveva fatto capire già qualche mese fa: non basta essere tra gli uomini più ricchi della Cina ed essere membri del Partito per pensare di poter avanzare critiche sulle politiche finanziarie del Governo. Il caso Didi ha però chiarito che l’obiettivo del Pcc non è solo quello di reprimere qualsiasi segnale di possibile dissenso, ma anche quello di intervenire in maniera ancora più drastica sulle azioni dei principali brand privati. Già, perché a differenza di Ma, il fondatore del gigante del ride-hailing, Cheng Wei, ha sempre tenuto un basso profilo e anzi si è dimostrato più volte fedele alla linea del governo e del partito. Tanto da lanciare nel 2018 una campagna di assunzione di membri del Partito comunista. Oltre a Didi, l’Ufficio di revisione ha dichiarato che le indagini saranno estese anche alla piattaforma dedicata al lavoro Boss Zhipin e a due piattaforme per i trasporti, Yunmanman e Huochebang, parte della Full Truck Alliance quotata a New York, citando ragioni di sicurezza nazionale.
Il governo di Pechino si sta dotando di un insieme di strumenti a sua disposizione per colpire le aziende. Non solo con le indagini antitrust per le accuse di monopolio. Nei giorni scorsi è stata presentata una bozza per un piano d’azione sulla sicurezza informatica. Quasi tutte le società intenzionate a quotarsi all’estero dovranno sottoporsi a una procedura di screening molto più approfondita di quanto accadeva in passato. Il periodo per il controllo di sicurezza passerà infatti da 45 giorni a oltre tre mesi. Nel 2021 già 37 società cinesi si sono quotate negli Stati Uniti, per un totale di 12,9 miliardi di dollari di Ipo. Pechino cerca invece di spingere le società tecnologiche verso le borse cinesi o quella di Hong Kong. Le nuove regole si applicano a tutte le azioni che detengono dati di oltre un milione di utenti. Un numero molto basso e semplice da raggiungere in Cina. La motivazione ufficiale della nuova legge è quella di esaminare i potenziali rischi per la sicurezza nazionale derivanti dalle quotazioni all’estero e dalla possibilità che i dati cinesi possano essere “influenzati, controllati e sfruttati in modo dannoso da governi stranieri”. La riforma si aggiunge alla legge per la sicurezza dei dati informatici, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021, e alla recente legge sulla privacy. Lo scopo di queste riforme è sempre quello di circoscrivere e limitare (a livello di potere decisionale e di quantità di dati a disposizione) il campo d’azione delle big tech e ribadire che il Partito è l’unico possibile garante e sovrintendente dell’ecosistema digitale nazionale.
Nel frattempo, la Cyberspace Administration cinese ha rimosso 25 app di Didi, che potrebbe subire un impatto davvero sostanzioso sul proprio giro d’affari. La drasticità con la quale sta intervenendo il governo cinese sull’azienda (che sarebbe stata causata anche dal fatto che Didi avrebbe ignorato alcuni avvertimenti delle autorità sull’Ipo per la fretta di raccogliere fondi negli Usa) sta avendo effetti anche sugli altri attori del settore del ride-hailing e in generale sui colossi tech cinesi. Meituan, l’app di food delivery cinese, sta rilanciando la sua divisione di ride-hailing dopo le difficoltà di Didi, grazie anche al fatto che la sua informativa sulla privacy afferma che i dati degli utenti non sarebbero mai trasferiti verso terze parti non autorizzate dalle autorità. Anche se sul patron di Meituan, Wang Xing, c’è un’ombra, vale a dire la sua recente pubblicazione di un poema dei tempi della dinastia Tang considerato portatore di valori anti establishment.
La stretta su Didi ha lanciato un messaggio chiaro a tanti. LinkDoc Technology, una app di dati medici, ha rinunciato all’Ipo all’estero, seguita dall’app di fitness Keep e dalla startup Meicai. Non solo. Bytedance, la multinazionale che possiede l’app Douyin e la sua versione internazionale TikTok, ha sospeso i piani relativi a un’offerta pubblica iniziale a Wall Street, dopo una valutazione di 180 miliardi di dollari. Un approccio prudente, quello di ByteDance, per evitare di diventare vittime di un nuovo caso Didi.
Non è finita. Nel mirino dell’antitrust cinese ci è finita anche Tencent, il colosso che controlla la celebre super app WeChat. Secondo le accuse, Tencent Music avrebbe usato i diritti esclusivi su alcune etichette musicali per la creazione di una situazione di monopolio e vincere la concorrenza di rivali meno noti. Tencent dovrà abbandonare il progetto di fusione tra i due maggiori operatori cinesi di siti di streaming di videogiochi, Huya Inc e DouYu International Holdings Ltd, perché la fusione avrebbe violato le regole di concorrenza. Le autorità si muovono anche a livello locale per implementare un maggiore controllo sui dati, come accade nella provincia meridionale del Guangdong, che ha annunciato la reazione di una piattaforma comune di dati che coinvolgerà anche Hong Kong e Macao in una riedizione cibernetica della Greater Bay Area.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Il Giappone non vuole la guerra, ma vuole aumentare il suo potere di deterrenza ed essere pronto ad agire all’occorrenza. Negli ultimi tempi, Tokyo ha aumentato e diversificato i suoi movimenti di natura difensiva, perseguendo non solo un rafforzamento delle proprie forze armate ma implementando anche accordi e cornici di azione bilaterali e multilaterali. Certo, il Quad. Ma non solo. Il Governo giapponese sta promuovendo con decisione la cooperazione militare con altri Paesi dell’Asia-Pacifico, a partire dall’Australia ma senza trascurare (anzi) i Paesi Asean, soprattutto Vietnam e Indonesia ma con un recente rinnovato focus sulle Filippine.
Di solito si parla sempre dell’ambito multilaterale, dunque del Quad. Dal 2015 Tokyo partecipa ai test navali con India e Usa e nel 2019 ci sono state anche esercitazioni terrestri. Nel novembre 2020, a Malabar, si sono tenute le prime esercitazioni navali quadrilaterali congiunte con inclusa anche l’Australia. A marzo si è svolto il primo summit virtuale tra i leader dei quattro Paesi. Solo poche settimane fa, al G7 di Cornovaglia erano presenti tutti e quattro i leader Quad. Un’accelerazione che sembra derivare anche dal nuovo protagonismo geopolitico del Giappone. Tokyo porta avanti le sue relazioni con la Cina su un doppio binario: competizione strategica e cooperazione commerciale. Ma il governo nipponico non si muove solo all’interno di una piattaforma dall’innegabile imprinting statunitense. La latitanza degli Stati Uniti targati Donald Trump sono stati di insegnamento al Giappone, che ha rafforzato le sue partnership difensive a livello bilaterale.
Nel 2020 sono stati firmati diversi accordi per la condivisione di basi militari e lo scambio di informazioni sia con l’Australia sia con l’India, gli altri due lati del quadrilatero. Ora Tokyo e Canberra si preparano non solo a intensificare l’addestramento militare congiunto ma a un ulteriore salto di qualità delle relazioni difensive. Si parla, infatti, della realizzazione di progetti di infrastrutture regionali. Ergo, basi. Lo ha dichiarato direttamente l’Ambasciatore giapponese in Australia, Shingo Yamagami, che ha collegato l’approfondimento della relazione bilaterale a un’ottica di “resistenza” alla Cina. “Il Giappone opererà con Canberra e gli altri Paesi liberi per assicurare “un contrappeso contro una tale potenza dominante” che cerca di “cambiare lo status quo”, ha aggiunto il diplomatico giapponese. Entro la fine dell’anno i due leader Yoshihide Suga e Scott Morrison dovrebbero finalizzare un accordo che stabilità un quadro normativo chiaro per permettere ai militari di ciascuna delle due nazioni di operare nell’altro Paese, semplificando le modalità per esercizi congiunti e per missioni umanitarie attraverso la regione.
Il Giappone non si ferma qui. Il focus in materia difensiva sull’area del Sud-est asiatico è stata evidente sin dai primi vagiti del Governo Suga. Il Primo Ministro nipponico ha compiuto la sua prima visita all’estero proprio in Vietnam e in Indonesia, nell’ottobre del 2020. Durante il viaggio in Vietnam è stato annunciato un accordo che prevede il rafforzamento della cooperazione tra i due Paesi in materia di difesa e sicurezza e l’esportazione di tecnologie e attrezzature militari giapponesi ad Hanoi. Coinvolti due velivoli di Kawasaki Aerospace: quello di pattugliamento marittimo P-1 e quello da trasporto tattico C-2. Già in precedenza, Tokyo aveva prestato 348 milioni di dollari al Vietnam per la costruzione di unità navali. Accordo simile a quello concluso con l’Indonesia in seguito a una ministeriale che ha coinvolto i rappresentanti di Esteri e Difesa dei due Paesi.
Nelle ultime settimane si sta rilanciando anche il rapporto con le Filippine, che con il Presidente Rodrigo Duterte avevano compiuto più di un passo in direzione della Cina. L’arrivo di Joe Biden e le tensioni sulla presenza di navi cinesi nelle acque contese del Mar Cinese meridionale hanno però portato a un parziale riposizionamento di Manila, maggiormente in equilibrio rispetto agli anni scorsi. Non è un caso che proprio in questi giorni si stanno svolgendo le prime esercitazioni aeree congiunte tra le forze dell’aviazione di Giappone e Filippine, nell’ex base aerea statunitense di Clark, nel nord dell’immenso arcipelago del Sud-est asiatico. Le esercitazioni si concentreranno sul settore del soccorso umanitario e della risposta ai disastri. Alle manovre parteciperà un aereo cargo giapponese C-130H che, assieme al personale dei due Paesi, simulerà la consegna di beni di soccorso in aree isolate. Ma è evidente che i rapporti difensivi bilaterali sono in via di approfondimento, aspetto fondamentale per la posizione strategica delle Filippine rispetto al territorio giapponese.
Tra Filippine e Giappone si trova poi Taiwan, intorno a cui si gioca molto della partita geopolitica dei prossimi anni e decenni. Il rinnovato protagonismo militare giapponese è testimoniato anche dalla sempre minore ambiguità strategica nei confronti di Taipei. Nei giorni scorsi, il vicepremier Taro Aso, ha dichiarato che una eventuale invasione di Taiwan da parte della Cina verrebbe interpretata da Tokyo come “una minaccia alla sopravvivenza del Giappone”, e che per tale ragione il Paese schiererebbe le proprie Forze di autodifesa a fianco degli Stati Uniti per difendere l’isola, secondo il principio della cosiddetta “autodifesa collettiva”. Che ciò accadrebbe davvero sarebbe da verificare, ma quel che è certo è che Tokyo vuole proiettare di sé un’immagine militarmente più forte rispetto agli ultimi decenni, allentando i lacci che la tenevano ferma in memoria della Seconda guerra mondiale e dell’epoca delle colonizzazioni.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Alla fine, sarà un bel centenario. Nonostante il Covid-19, l’aumento delle tensioni geopolitiche con gli Stati Uniti e con l’Occidente in generale, i fronti aperti con i vicini asiatici (dagli scontri al confine con l’India alle dispute nel Mar Cinese meridionale e nel Mar Cinese orientale con diversi Paesi Asean e con il Giappone).
Nonostante i nuovi problemi all’orizzonte, in particolare la questione demografica e un equilibrio da ritrovare con i colossi privati di un’economia che comunque continua a crescere. Insomma, nonostante tutto il Partito comunista cinese arriva al 1° luglio in ottima salute e con una presa sulla Repubblica popolare divenuta forse ancora più forte rispetto a quella pre Covid.
In molti pensavano che la pandemia potesse essere il famoso “cigno nero” per la Cina di Xi Jinping. Così non è stato. Anzi, è semmai diventato un ulteriore trampolino all’ascesa cinese. Pechino ha saputo contenere l’emergenza sanitaria, facendo ripartire per prima la sua economia e chiudendo il terribile 2020 con una crescita del Pil del 2,3%. Unico segno più tra le grandi economie mondiali. Non solo. Le difficoltà e inefficienze di tanti Paesi europei e soprattutto degli Stati Uniti hanno permesso al Partito di sottolineare le sue virtù e gli errori altrui. Le uscite di Donald Trump su virus e mascherine, così come il mancato riconoscimento del risultato delle elezioni presidenziali del 3 novembre e l’assalto a Capitol Hill, sono state presentate come segno del decadimento delle democrazie occidentali.
Mentre i rivali erano in altre faccende affaccendati, la Cina ha lanciato la sua “diplomazia delle mascherine”, con una rimodulazione in chiave sanitaria della sua Via della Seta, ha sostenuto l’export e proseguito la sua traiettoria di trasformazione del modello economico con l’annuncio della “doppia circolazione”, modello che si concentra soprattutto sullo stimolo ai consumi interni per ridurre la dipendenza dalle turbolenze in arrivo dal mondo esterno. Così facendo il Partito è riuscito a mantenere l’obiettivo storico dell’eliminazione della povertà assoluta e dunque della realizzazione di una “società moderatamente prospera” entro il 2021, in tempo per le celebrazioni del suo centenario.
Il Partito è cambiato tantissimo dal 1921 a oggi. Se all’inizio era una forza rivoluzionaria e composta soprattutto da contadini e operai e impregnata di marxismo-leninismo, ora è un gigante con oltre 90 milioni di membri che provengono però soprattutto dalle classi dirigenti, accademiche e imprenditoriali, con un’ideologia patchwork che mischia elementi di socialismo, maoismo, marxismo-leninismo e capitalismo sfrenato. Eppure, Xi riesce a tenere tutto insieme in un melting pot dalle “caratteristiche cinesi” che non solo preserva il ruolo di Mao per ribadire che il Partito non sbaglia mai e non ha mai sbagliato, e allo stesso tempo recupera il confucianesimo e il valore della tradizione millenaria cinese che non viene più rinnegata come in passato ma semmai rivendicata sulla strada del riconoscimento della Cina come superpotenza culturale. E il Partito-Stato, ovviamente, è l’unico collante in grado di tenere unito un Paese immenso che separato rischierebbe la frammentazione foriera di indebolimento e domini stranieri come durante il “secolo dell’umiliazione”.
Ecco perché, a un anno di distanza dal cruciale Congresso del 2022, che dovrebbe sancire l’avvio del suo terzo mandato presidenziale, Xi appare sempre più forte. La sua Cina, che non nasconde più le proprie ambizioni e il proprio ruolo come faceva quella di Deng Xiaoping, è costruita sempre più a sua immagine e somiglianza. Partito e forze armate sono sotto il suo diretto controllo, il Politburo è pieno di suoi fedelissimi e dopo il 2022 presumibilmente lo sarà ancora di più. Il Partito, dunque Xi, controlla in modo sempre più forti le politiche economiche e con il caso di Jack Ma e Ant Group ha dimostrato che non intende lasciare spazio di critica politica ai colossi tecnologici e alle entità private, per non ripetere l’errore della Russia con gli oligarchi. Proprio quella Russia che si sta avvicinando sempre più a Pechino, come dimostra il nuovo summit tra Xi e Putin di lunedì 28 giugno, che segue di pochi giorni l’incontro del Presidente russo con Joe Biden a Ginevra. È attraverso questo rapporto che si gioca molto del futuro posizionamento globale cinese, con Mosca che per ora accetta l’abbraccio di Pechino consapevole che possa essere un’importante arma negoziale in un ipotetico riavvicinamento con l’Occidente.
Intanto, le celebrazioni del centenario del Pcc sono cominciate. Nell’iconico Stadio olimpico “Nido d’uccello” si è tenuto lo spettacolo “Il grande viaggio”, a cui ha preso parte il Comitato permanente del partito al completo più il Vicepresidente Wang Qishan. Mentre Xi ha consegnato nella Grande Sala del Popolo le “medaglie del primo luglio” a 29 eroi della patria: membri del Partito, giornalisti, diplomatici, comuni cittadini e anche uno dei soldati morti durante gli scontri del 2020 lungo il confine con l’India. Il ciclo di eventi si concluderà giovedì con un discorso di Xi, che darà indicazioni anche sulla traiettoria futura della Cina, con un occhio al secondo grande centenario del 2049 (quello della fondazione della Repubblica popolare) e alla cruciale data a mezza via del 2035, il probabile orizzonte politico di Xi entro il quale la Cina dovrebbe aver già da tempo completato il sorpasso agli Stati Uniti per diventare la prima economia mondiale. Non ci sarà una vera e propria parata dell’Esercito Popolare di Liberazione, con la speranza che l’ascesa cinese possa continuare senza tensioni militari.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
Un mese esatto, poi sarà tempo di Giochi Olimpici. Eppure, il Giappone si aspettava uno scenario migliore per l’evento che avrebbe dovuto rilanciare la sua dimensione globale. Almeno a questo ambiva il Governo Abe l’ormai lontano 7 settembre 2013, quando durante la 125esima sessione del Cio si annunciò che le Olimpiadi estive del 2020 si sarebbero svolte a Tokyo. Mentre lo stesso Shinzo Abe intravedeva nell’occasione la sua possibile eredità politica. Così non è stato. Il 24 luglio 2020, scelta come data d’inizio della manifestazione, è diventato 23 luglio 2021 per l’emergenza pandemica che ha portato al rinvio di un anno. E, nel frattempo, Abe ha dovuto lasciare il suo posto per problemi di salute e il Giappone si avvia ora a elezioni generali (che forse verranno anticipate rispetto alla scadenza naturale di ottobre).
Lo stesso svolgimento dei Giochi Olimpici è stato a lungo in dubbio e larga parte della popolazione ancora preferirebbe che non si svolgessero mai, per timore dell’arrivo di una nuova ondata di Covid-19. Così il Giappone è costretto a non spegnere la torcia olimpica, per l’impossibilità di rinviare ancora per la mancanza di date possibili o semplicemente di cancellare tutto per le forti conseguenze economiche e diplomatiche che ciò comporterebbe. Inoltre, la nuova ondata di contagi che sta colpendo l’Asia e che impedisce di associare davvero questi Giochi Olimpici all’evento della ripartenza mondiale post pandemica. A quel titolo, ulteriore beffa, può invece provare ad ambire la Cina con i Giochi Olimpici invernali di Pechino, che prenderanno il via il prossimo 4 febbraio, meno di sei mesi dopo la fine delle Olimpiadi giapponesi.
Dopo due picchi, il primo a gennaio e il secondo a metà maggio con oltre seimila nuovi contagi al giorno, la curva Covid in Giappone è tornata a scendere e le restrizioni vengono progressivamente allentate. Ma più di due terzi delle oltre 14mila vittime totali nel Paese hanno perso la vita nei primi mesi del 2021. Per le Olimpiadi sono attese circa centomila persone in arrivo dall’estero, tra atleti e componenti delle spedizioni. Le gare non saranno aperte a spettatori stranieri e avranno un limite di capienza di 10mila persone, e in ogni caso non oltre il 50% della capienza massima delle strutture che le ospitano. Yoshihide Suga ha già spiegato che in caso di peggioramento della situazione sanitaria (a Tokyo i contagi giornalieri sono appena tornati in risalita) gli eventi si svolgeranno a porte chiuse.
Thomas Bach, Presidente del Comitato Olimpico Internazionale, assicura che almeno l’80% di loro sarà vaccinato prima dell’inizio dei Giochi, anche se si è registrato il primo caso di positività di un membro di un team olimpico (in questo caso dell’Uganda) in arrivo nel Paese. Questo non basta ai giapponesi. Circa l’86% dei cittadini teme che le Olimpiadi possano tradursi in una ondata di contagi. La percentuale di chi chiede che la manifestazione venga annullata è pari al 30,8%, ma altri recenti sondaggi dei media sostengono che la percentuale arrivi addirittura tra il 60 (Kyodo) e l’83% (Asahi Shimbun). Oltre 350mila persone hanno firmato una campagna online per chiedere l’annullamento della manifestazione. Anche l’associazione dei medici di Tokyo ha esortato il Cio a non far svolgere le gare. In molti poi sostengono che le risorse per testare e vaccinare la popolazione locale verranno dirottate sui Giochi, causando dei problemi a una campagna vaccinale che procede già a rilento.
La nuova ondata di contagi ha portato a delle conseguenze anche sul piano politico. Il 68% dei giapponesi ritiene inoltre che il Governo si sia mosso troppo lentamente nell’approvvigionamento dei sieri e soprattutto nell’organizzazione della campagna, che per ora ha coperto poco più del 7% della popolazione totale (performance peggiore di altri vicini asiatici come Corea del Sud e Cina). Poche settimane fa, il comitato di verifica del Ministero della Salute ha dato il via libera per le importazioni e le somministrazioni dei vaccini di Moderna e di AstraZeneca. Si affiancano a Pfizer, l’unico che fino a maggio ricevuto luce verde. Il Governo è sotto accusa anche per la ricerca pubblicata dalla Japan Lung Cancer Society, secondo la quale sarebbero stati oltre 8.600 i malati di cancro al polmone rimasti senza cure adeguate dall’inizio della pandemia a causa delle misure restrittive applicate per il Covid.
I segnali di malcontento nei confronti dell’esecutivo sono emersi anche dalle urne. A fine aprile si è votato a Nagano, Hiroshima e in Hokkaido. Nei primi due casi i candidati del partito di maggioranza hanno subito delle vere e proprie batoste, con sconfitte nell’ordine della doppia cifra. In Hokkaido il Partito liberaldemocratico non si è neppure presentato. Il tutto a pochi mesi di distanza dalle elezioni generali, previste a ottobre. Un mese prima, il partito di maggioranza sarà chiamato a scegliere il suo leader che correrà per essere nominato primo ministro. Non appare più così scontato che quel nome sarà Suga, il quale potrebbe cercare di convocare elezioni anticipate per provare a capitalizzare l’attuale vantaggio di cui gode all’interno del partito. Ha aperto all’eventualità lui stesso, a margine del G7 in Cornovaglia. “Il mio mandato è compiuto, per cui teoricamente da adesso in poi uno scioglimento della Camera bassa può avvenire in qualsiasi momento”, ha dichiarato l’attuale Primo Ministro. Il Giappone con questi Giochi Olimpici ambiva alla medaglia d’oro, ora gli basta uscirne indenne.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

“Through this we can still rule the world”. Attraverso questo possiamo ancora dominare il mondo. È la scritta che campeggia sopra l’illustrazione utilizzata dal Global Times, il tabloid cinese di Stato in lingua inglese, per ritrarre la riunione del G7 in Cornovaglia come una “ultima cena”.
Al centro, ovviamente, l’aquila statunitense che punta il dito contro la Cina. Alla sua destra c’è un lupo grigio che fa segno di no con le mani. Rappresenta l’Italia, riluttante a seguire Washington nella sua campagna anti cinese. Vengono raffigurati poi un cane (Giappone) che offre da bere agli altri astanti, un canguro (Australia), un falco (Germania) e un gallo (Francia) che ascoltano in silenzio. E ancora un leone (Regno Unito) e una nutria (Canada), mentre da sotto il tavolo una rana (Taiwan) cerca di saltare abbastanza in alto per farsi vedere.
Ma, attenzione: il disegno, pubblicato dall’utente Bantonglaoatang su Weibo, non è solo un divertissement. Rappresenta visivamente e testualmente il pensiero della Cina sull’attuale ordine internazionale a guida statunitense, di cui il G7 è uno dei pilastri. Ebbene, la concezione cinese è chiara: per Pechino il G7 è una struttura basata su un ordine unipolare, un vecchio circolo di presunti amici non al passo con i tempi e con il nuovo ordine multipolare. E dunque il vertice anti cinese sarebbe un artificio attraverso il quale gli Stati Uniti e i suoi (più o meno) alleati si convincono di poter ancora controllare un mondo che invece gli è sfuggito di mano. Through this we can still rule the world, appunto.
Non c’è dubbio che sia al summit del G7 in Cornovaglia che al successivo vertice Nato di Bruxelles si sia parlato molto di Cina. Nonostante le rassicurazioni arrivate dal segretario generale Nato Jens Stoltenberg (“non vogliamo una guerra fredda”) a cui hanno fatto eco quelle di Emmanuel Macron e Boris Johnson, Pechino interpreta sempre di più questi eventi multilaterali a cui non è invitata come azioni e organizzazioni ostili nei suoi confronti.
Partiamo dal G7, da dove sono arrivate sfide alla Cina su più direttrici. La prima è quella economica. È stato annunciato l’avvio della cosiddetta Build Back Better World (B3W) Partnership, voluta da Joe Biden. Si tratta di un piano infrastrutturale congiunto che mira a diventare un’alternativa alla Belt and Road cinese, proponendo investimenti da miliardi di dollari da realizzare soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, proprio laddove il programma cinese fa solitamente più gola.
Ovviamente, l’economia si intreccia con la diplomazia, come dimostra il fatto che l’iniziativa propone anche la distribuzione di miliardi di dosi di vaccini anti Covid-19 nei Paesi coinvolti dai progetti infrastrutturali. C’è poi la direttrice geopolitica. Al termine del G7 sono stati citati non solo i diritti umani con riferimento a Xinjiang e Hong Kong, ma anche “l’importanza della pace e della stabilità sullo Stretto di Taiwan” e le dispute territoriali marittime nel Mar Cinese meridionale e nel Mar Cinese orientale. Coinvolto anche l’aspetto narrativo, come dimostra la richiesta congiunta di un nuovo studio trasparente e approfondito sull’origine del coronavirus in Cina. Appello ascoltato dall’Organizzazione mondiale della sanità, che ha subito chiesto cooperazione a Pechino.
I media cinesi hanno accolto l’esito del G7 come un “esempio vivente di mentalità da guerra fredda” e hanno liquidato i “valori comuni” citati nel comunicato finale come “pregiudizio ideologico e arroganza”. In realtà, in seno al G7 le posizioni sono un po’ sfumate. C’è chi, soprattutto Germania e Francia, insistono sul mantenere separate la dimensione politica e quella economica nei rapporti con la Cina. E in effetti il summit si è concluso senza un accordo sul divieto alla partecipazione occidentale a progetti che beneficiano in qualche modo dal lavoro forzato.
Segnali potenzialmente ancora più interessanti sono arrivati dalla Nato. Al termine del vertice di Bruxelles, per la prima volta l’Alleanza Atlantica parla della Cina come di una “sfida sistemica“, ma non ancora di una “minaccia”. Segnala comunque l’inizio di un cambio nel pensiero strategico, che segue quello compiuto dal Pentagono nei giorni scorsi, che ha significativamente posto la Cina in cima alle sue priorità. Una svolta potenzialmente epocale, se seguita anche dalla Nato che ha lanciato la revisione del proprio concetto strategico (datato 2010), in via di definizione nei prossimi mesi. Il comunicato finale indica Pechino come un rischio per la sicurezza dell’Alleanza. Vengono citati non solo gli aspetti strategici militari, ma anche quelli legati al mondo cyber.
Non a caso il piano Nato 2030 prevede ingenti investimenti per rispondere alle minacce ibride e a quelle digitali. Ancora una volta, però, né Angela Merkel né Emmanuel Macron hanno citato direttamente la Cina nei loro interventi, dimostrando che non esiste ancora una chiara unità di intenti sull’approccio da adottare. La narrativa di una nuova contrapposizione tra blocchi non restituisce l’esatta immagine di un mondo nel quale le sfere di influenza (laddove esistono) sono mobili e compenetrabili. Guardare la presa di distanza della Corea del Sud (invitata in Cornovaglia) dalla lettura anti cinese del G7 per credere.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

“Through this we can still rule the world”. Attraverso questo possiamo ancora dominare il mondo. È la scritta che campeggia sopra l’illustrazione utilizzata dal Global Times, il tabloid cinese di Stato in lingua inglese, per ritrarre la riunione del G7 in Cornovaglia come una “ultima cena”.
Al centro, ovviamente, l’aquila statunitense che punta il dito contro la Cina. Alla sua destra c’è un lupo grigio che fa segno di no con le mani. Rappresenta l’Italia, riluttante a seguire Washington nella sua campagna anti cinese. Vengono raffigurati poi un cane (Giappone) che offre da bere agli altri astanti, un canguro (Australia), un falco (Germania) e un gallo (Francia) che ascoltano in silenzio. E ancora un leone (Regno Unito) e una nutria (Canada), mentre da sotto il tavolo una rana (Taiwan) cerca di saltare abbastanza in alto per farsi vedere.
Ma, attenzione: il disegno, pubblicato dall’utente Bantonglaoatang su Weibo, non è solo un divertissement. Rappresenta visivamente e testualmente il pensiero della Cina sull’attuale ordine internazionale a guida statunitense, di cui il G7 è uno dei pilastri. Ebbene, la concezione cinese è chiara: per Pechino il G7 è una struttura basata su un ordine unipolare, un vecchio circolo di presunti amici non al passo con i tempi e con il nuovo ordine multipolare. E dunque il vertice anti cinese sarebbe un artificio attraverso il quale gli Stati Uniti e i suoi (più o meno) alleati si convincono di poter ancora controllare un mondo che invece gli è sfuggito di mano. Through this we can still rule the world, appunto.
Non c’è dubbio che sia al summit del G7 in Cornovaglia che al successivo vertice Nato di Bruxelles si sia parlato molto di Cina. Nonostante le rassicurazioni arrivate dal segretario generale Nato Jens Stoltenberg (“non vogliamo una guerra fredda”) a cui hanno fatto eco quelle di Emmanuel Macron e Boris Johnson, Pechino interpreta sempre di più questi eventi multilaterali a cui non è invitata come azioni e organizzazioni ostili nei suoi confronti.
Partiamo dal G7, da dove sono arrivate sfide alla Cina su più direttrici. La prima è quella economica. È stato annunciato l’avvio della cosiddetta Build Back Better World (B3W) Partnership, voluta da Joe Biden. Si tratta di un piano infrastrutturale congiunto che mira a diventare un’alternativa alla Belt and Road cinese, proponendo investimenti da miliardi di dollari da realizzare soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, proprio laddove il programma cinese fa solitamente più gola.
Ovviamente, l’economia si intreccia con la diplomazia, come dimostra il fatto che l’iniziativa propone anche la distribuzione di miliardi di dosi di vaccini anti Covid-19 nei Paesi coinvolti dai progetti infrastrutturali. C’è poi la direttrice geopolitica. Al termine del G7 sono stati citati non solo i diritti umani con riferimento a Xinjiang e Hong Kong, ma anche “l’importanza della pace e della stabilità sullo Stretto di Taiwan” e le dispute territoriali marittime nel Mar Cinese meridionale e nel Mar Cinese orientale. Coinvolto anche l’aspetto narrativo, come dimostra la richiesta congiunta di un nuovo studio trasparente e approfondito sull’origine del coronavirus in Cina. Appello ascoltato dall’Organizzazione mondiale della sanità, che ha subito chiesto cooperazione a Pechino.
I media cinesi hanno accolto l’esito del G7 come un “esempio vivente di mentalità da guerra fredda” e hanno liquidato i “valori comuni” citati nel comunicato finale come “pregiudizio ideologico e arroganza”. In realtà, in seno al G7 le posizioni sono un po’ sfumate. C’è chi, soprattutto Germania e Francia, insistono sul mantenere separate la dimensione politica e quella economica nei rapporti con la Cina. E in effetti il summit si è concluso senza un accordo sul divieto alla partecipazione occidentale a progetti che beneficiano in qualche modo dal lavoro forzato.
Segnali potenzialmente ancora più interessanti sono arrivati dalla Nato. Al termine del vertice di Bruxelles, per la prima volta l’Alleanza Atlantica parla della Cina come di una “sfida sistemica“, ma non ancora di una “minaccia”. Segnala comunque l’inizio di un cambio nel pensiero strategico, che segue quello compiuto dal Pentagono nei giorni scorsi, che ha significativamente posto la Cina in cima alle sue priorità. Una svolta potenzialmente epocale, se seguita anche dalla Nato che ha lanciato la revisione del proprio concetto strategico (datato 2010), in via di definizione nei prossimi mesi. Il comunicato finale indica Pechino come un rischio per la sicurezza dell’Alleanza. Vengono citati non solo gli aspetti strategici militari, ma anche quelli legati al mondo cyber.
Non a caso il piano Nato 2030 prevede ingenti investimenti per rispondere alle minacce ibride e a quelle digitali. Ancora una volta, però, né Angela Merkel né Emmanuel Macron hanno citato direttamente la Cina nei loro interventi, dimostrando che non esiste ancora una chiara unità di intenti sull’approccio da adottare. La narrativa di una nuova contrapposizione tra blocchi non restituisce l’esatta immagine di un mondo nel quale le sfere di influenza (laddove esistono) sono mobili e compenetrabili. Guardare la presa di distanza della Corea del Sud (invitata in Cornovaglia) dalla lettura anti cinese del G7 per credere.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

È nato, quasi per caso, in risposta ai danni causati dallo tsunami del 2004. Nel 2007, su impulso di Abe Shinzo, ha mosso i primi passi come progetto di convergenza democratica in Asia, accompagnato alla nuova concezione di Indo-Pacifico. Dopo essere finito a lungo nel dimenticatoio, è stato ripresentato, sul tramonto dell’amministrazione Trump, come una sorta di “Nato asiatica”. Ora, all’alba dell’amministrazione Biden, si potrebbe rivelare un esercizio di pragmatismo geopolitico che, rafforzando il sistema di partnership e lavorando in maniera congiunta su temi concreti come i vaccini e gli investimenti, cerchi di sostenere le fondamenta di un’impalcatura in grado di stare in piedi riducendo progressivamente la propria dipendenza dalla Cina. Stiamo parlando del Quadrilateral Security Dialogue, noto come Quad, che riunisce in una piattaforma per ora informale Stati Uniti, Giappone, India e Australia.
Nel 2018, il Ministro degli Esteri cinese lo aveva paragonato a “schiuma marina”. L’iniziativa era appena tornata di attualità, dopo dieci anni in cui sembrava essere stata accantonata per le ritrosie dei Paesi coinvolti a unirsi in un progetto dalle sembianze anti cinesi. Ma l’approccio mercantilistico di Trump ha creato problemi con i partner asiatici (a loro volta impegnati in contese commerciali tra di loro, come Giappone e Corea del Sud) e ha tenuto a lungo tranquillo il governo cinese sulle potenzialità del progetto. D’altronde, la Cina è il principale mercato di esportazione per Giappone e Australia ed è ancora il primo partner commerciale dell’India (il cui export verso Pechino è aumentato dell’11% nel 2020, nonostante le tensioni militari e diplomatiche). Anche per questo nell’ultimo anno, mentre la Casa Bianca passava a una fase di arruolamento anti cinese, Pechino non ha avuto remore a mostrare i muscoli. Fisicamente, con India e Giappone lungo il confine conteso e intorno alle isole Senkaku/Diaoyu, figurativamente, con l’Australia attraverso una mini guerra commerciale. Sviluppi che, combinati al rinnovato impegno nell’area di Washington con l’arrivo di Biden, potrebbero però dare maggiore concretezza al Quad.
Nel novembre 2020, a Malabar (India), si sono tenute le prime esercitazioni navali quadrilaterali congiunte. A marzo si è svolto il primo summit virtuale tra i leader dei quattro Paesi. E a giugno, a margine del G7, potrebbe esserci il primo summit Quad in presenza. Un’accelerazione che sembra derivare anche dal nuovo protagonismo geopolitico del Giappone. Tokyo porta avanti le sue relazioni con la Cina su un doppio binario: competizione strategica e cooperazione commerciale. Negli anni pre Covid, complice la normalizzazione dei rapporti condotta da Abe e Xi Jinping dopo le precedenti tensioni, aveva nettamente prevalso la seconda. Nel 2020, oltre il 20% dell’export nipponico è finito sul mercato cinese. Nonostante il piano China Exit, tante grandi aziende giapponesi (a partire da quelle automobilistiche) conservano un’enorme parte dei loro ricavi in Cina. Anche per questo è stato adottato un atteggiamento meno aggressivo sul tema del Xinjiang. Abe e il suo successore Suga Yoshihide hanno sempre allontanato dal Quad l’etichetta di “Nato asiatica” perché il Giappone vuole garantire la sua sicurezza senza pregiudicare i propri interessi economici. Ora, però, appare sempre meno timido nell’esporsi su dossier politicamente delicati. Durante la loro visita a Tokyo, Antony Blinken e Lloyd Austin hanno trovato una sponda per le loro accuse alla Cina, mentre Suga (primo leader straniero ricevuto da Biden alla Casa Bianca) ha accettato di includere Taiwan (prima volta dal 1969) nella dichiarazione congiunta al termine del suo incontro con il presidente Usa. Suga ha anche accettato di aumentare le capacità militari del Giappone nei prossimi anni. Per il 2021 è stato approvato un budget difensivo record da 51,7 miliardi, prevedendo una crescita fino a 56,7 miliardi nel 2024.
L’attivismo giapponese non piace a Pechino, che ha iniziato a prendere il Quad più seriamente. Anche perché, nonostante i suoi membri affermino che l’iniziativa non è volta a contenere nessuno, risulta difficile credere alla versione del club delle democrazie. Narendra Modi guida da tempo un processo di centralizzazione politica e di omogeneizzazione culturale ed etnica che sta semmai avvicinando l’India al sistema cinese. Eppure, gli Stati Uniti sostengono la crescita di Nuova Delhi, obiettivo al centro del documento strategico sull’Indo-Pacifico desecretato da Mike Pompeo prima di lasciare il Dipartimento di Stato. Il tentativo di trasformare l’India in un polo produttivo che offra una vera alternativa alla Cina si scontra però con carenze infrastrutturali, la forte dipendenza economica di Nuova Delhi da Pechino e la non sufficiente apertura del suo mercato. Basti pensare alla scelta di restare fuori dalla Regional Comprehensive Economic Partnership. Esistono anche altre perplessità. Gli scontri lungo il confine sinoindiano hanno fatto vacillare la storica autonomia strategica di Nuova Delhi (il rinnovo dell’accordo difensivo Usa-Maldive, che anni fa aveva causato invece non poche polemiche, è stato accolto con favore), ma non l’hanno cancellata. L’86% degli armamenti indiani resta di origine russa, anche se il peso delle forniture americane sta rapidamente aumentando.
In ogni caso, Giappone e Usa puntano a un maggiore coinvolgimento dell’India. Durante il summit virtuale del Quad è stato annunciato un programma a sostegno della produzione indiana di un miliardo di dosi di vaccini anti Covid. Si tratta di uno dei progetti concreti di cooperazione che mirano a rendere il Quad più solido. I Paesi asiatici, Giappone e India compresi, sanno che devono coesistere con la Cina. Per questo sperano che l’approccio di Washington sia meno reattivo e più propositivo, con l’integrazione di una componente commerciale al fianco di quella legata alla sicurezza. Non è un caso che Usa e Giappone abbiano lanciato un progetto infrastrutturale e di investimenti congiunto da realizzare nell’area dell’Indo Pacifico. Il tentativo è quello di provare a competere con la Belt and Road ma anche con la tecnologia cinese: verrano spesi 4,5 miliardi di dollari per lo sviluppo del 6G e si punta al mercato dei cavi sottomarini.
Per rendere più solida l’impalcatura regionale e diminuire i rischi si cerca invece di allargare il numero dei partecipanti alla sua costruzione. La Corea del Sud, che Pechino considera l’anello debole della strategia asiatica degli Usa, ha per ora rifiutato l’invito a entrare a far parte del Quad. Il Presidente Moon Jae-in sa che non può fare a meno di Xi per provare a riavviare il dialogo con Pyongyang, ma a maggio incontra Biden in un bilaterale. Si lavora anche al meccanismo Quad Plus per includere altri Paesi asiatici, in particolare quelli del Sud-est. Mentre Trump disertava i summit ASEAN, il Giappone ha rafforzato la sua presenza commerciale e diplomatica nell’area. Il primo viaggio all’estero di Suga è stato in Vietnam e in Indonesia, dove sono stati raggiunti accordi per il trasferimento di componenti militari e tecnologie difensive. Il Primo Ministro giapponese ha rilanciato anche i rapporti con le Filippine che, dopo essersi avvicinate alla Cina per volere di Rodrigo Duterte, si sentono minacciate dai recenti movimenti navali e dalla nuova legge sulla guardia costiera approvata da Pechino. Stanno assumendo un ruolo diretto anche alcuni Paesi europei. Ad aprile, la Francia ha condotto le esercitazioni La Pérouse nel golfo del Bengala, alle quali hanno preso parte anche le quattro marine del Quad. Poco prima della visita a Washington di Suga si è tenuto il primo dialogo bilaterale 2+2 tra i ministri di esteri e difesa di Germania e Giappone. Anche Regno Unito e Paesi Bassi hanno inviato dei mezzi navali nell’Indo Pacifico, le cui acque si stanno facendo sempre più affollate. La “schiuma marina” non è ancora pronta per diventare uno tsunami, ma la corrente si sta facendo più forte.
Questo articolo è pubblicato anche sul numero di maggio/giugno di eastwest.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Da un ex wrestler a un politico di lungo corso appartenente a una famiglia di autisti. Da Khaltmaagiin Battulga a Ukhnaa Khurelsukh. Questo dovrebbe essere, secondo tutti i pronostici, l’esito delle elezioni presidenziali in Mongolia in programma mercoledì 9 giugno. Ma dalle urne non uscirà solo un nuovo capo dello Stato: comunque vada, ci sarà una svolta nella vita politica del Paese asiatico stretto tra Russia e Cina.
Il sesto Presidente democraticamente eletto sarà infatti il primo a essere scelto dopo la riforma costituzionale di fine 2019. La riforma allunga il mandato presidenziale da quattro a sei anni, ma lo fa diventare singolo. Ciò significa che il Presidente non potrà più essere rieletto, già a partire da questa tornata. Il che ha scatenato le polemiche tra le forze politiche, con l’uscente Battulga che ha provato fino alla fine a rovesciare la decisione che di fatto lo ha estromesso dalla ricandidatura. Inoltre, gli emendamenti hanno tolto alcuni poteri al Presidente, che finora aveva il potere di veto sulle leggi proposte dal potere legislativo. Negli ultimi anni, gli elettori hanno spesso controbilanciato il potere del Parlamento scegliendo come Presidente i candidati del partito di opposizione. Anche questa tradizione, però, appare destinata a finire.
I candidati alla presidenza sono tre. Il primo, favoritissimo, è Khurelsukh. È il leader del Partito del popolo mongolo, forza di maggioranza di ispirazione socialista (ed ex partito unico marxista-leninista) che controlla con 62 seggi su 76 il Grande Hural di Stato, il Parlamento unicamerale del Paese. Fondatore della Federazione dei Giovani Democratici Socialisti, negli anni Novanta Khurelsukh si è fatto conoscere come attivista e con i suoi scioperi della fame in protesta contro la corruzione politica. Dal 2000 entra nel Grande Hural e da lì parte la scalata all’interno del partito che lo porta, nel 2008, a diventare il suo Segretario Generale. Nel 2017 è stato nominato Primo Ministro, ruolo in cui ha ampliato il concetto di politica estera multipolare che guida la diplomazia mongola già da circa un decennio. Mentre Battulga approfondiva soprattutto i rapporti con la Russia di Vladimir Putin, Khurelsukh ha chiuso importanti accordi con la Cina (firmando un patto di cooperazione economica e tecnologica), con l’India (sulla raffineria di petrolio nella provincia di Domogobi) e con gli Stati Uniti, firmando nel 2019 l’accordo di partenariato strategico. Ha inoltre rafforzato a livello diplomatico i rapporti con Giappone e Corea del Sud. Lo scorso gennaio si è dimesso dal ruolo di Primo Ministro dopo le proteste dei cittadini contro l’insufficienza del servizio sanitario mongolo e le scarse opportunità di lavoro, dopo un 2020 nel quale il Pil locale è calato del 5,3% a causa della pandemia da Covid-19.
Il principale sfidante è Sodnomzundui Erdene, Presidente del Partito democratico, forza di centro-destra che in Parlamento è all’opposizione dal 2016 ma che esprime il Presidente dal 2009, prima con i due mandati di Tsakhiagiin Elbegdorj e poi col mandato di Battulga. Lo slogan della campagna è “Mongolia senza dittatura”, visto che secondo Erdene in caso di vittoria di Khurelsukh il Paese rischierebbe di tornare al partito unico. Farà fatica però a convincere l’elettorato, dopo che il suo compagno di partito Battulga ha provato negli scorsi mesi a dissolvere il Partito del popolo con un decreto presidenziale nel tentativo di ribaltare la decisione di escluderlo dalle presidenziali di quest’anno. Questo, però, solo dopo che lo stesso Battulga si era accordato con il Grande Hural controllato dalla forza rivale per ottenere l’autorità di licenziare e sostituire giudici e funzionari.
Il terzo contendente è invece Dangaasuren Enkhbat, candidato della Right Person Electorate Coalition, una coalizione composta da Partito nazionale laburista, Partito socialdemocratico e Partito della giustizia (che ha vinto un seggio alle legislative dello scorso anno). Enkhbat sta provando a intercettare il voto di protesta presente nelle aree urbane, ma la sua campagna ha subito un colpo d’arresto dopo che è risultato positivo al coronavirus.
Già, perché nel frattempo in Mongolia è in atto la peggiore ondata di contagi dall’inizio della pandemia. Dopo essere ufficialmente rimasta a zero morti e solo una manciata di casi (elemento che ha favorito il trionfo del Partito del popolo alle legislative di un anno fa), a partire da marzo i contagi sono aumentati. Attualmente sono oltre mille al giorno. Allo stesso tempo, però, la Mongolia è uno dei Paesi asiatici con la campagna vaccinale finora più efficace. Quasi il 45% della popolazione è già protetta e l’obiettivo del Governo è quello di vaccinare tutta la popolazione sopra i 18 anni di età (vale a dire il 62% del totale) entro fine luglio. Un obiettivo reso possibile grazie al fatto che la Mongolia ha ricevuto tantissime dosi e da diverse fonti. Oltre due milioni e 600mila sono arrivate attraverso il programma Covax, ma Ulan Bator ha fatto valere i rapporti privilegiati con i due grandi vicini, Cina e Russia, per ricevere in modo prioritario i sieri di Sinopharm e Sputnik V. Anche l’India ha donato 15mila vaccini AstraZeneca alla Mongolia, mentre gli Stati Uniti hanno lanciato un fondo di 450mila dollari a sostegno della risposta pandemica del Paese.
Nel caso della quasi certa vittoria di Khurelsukh, la Mongolia cercherà di proseguire a rafforzare e diversificare i suoi rapporti diplomatici. Già nella campagna delle elezioni parlamentari 2020, il candidato del Partito del popolo aveva insistito sulla necessità di far diventare la Mongolia indipendente a livello energetico da Mosca. Ma Ulan Bator gioca un ruolo fondamentale per lo sviluppo di Power of Siberia 2, il gasdotto che collegherà Russia e Cina passando proprio attraverso la Mongolia, che continuerà a cercare di sfruttare la sua posizione strategica tra i due colossi. Magari con la spinta di un’economia che nel 2021 dovrebbe crescere del 4,8% e nel 2022 del 5,7%.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Una statua dedicata a Xi Jinping, da posizionare preferibilmente nel centro della città. Non è un progetto di una delle megalopoli della Repubblica popolare cinese, ma un’idea nata in Serbia, “Il popolo serbo ci tiene ai veri amici. Sarebbe un gesto simbolico ma importante per mostrare la nostra gratitudine per tutto l’aiuto che ci ha dato”. Aleksandar Banjanac, segretario del Nuovo partito comunista di Jugoslavia (con sede centrale a Belgrado e una distaccata in Montenegro), ha spiegato così il suo piano di erigere una statua in onore del Presidente cinese. Il partito ha pagato diversi spazi pubblicitari per sponsorizzare la proposta con una serie di manifesti lungo le strade della capitale serba.
Il Governo del Paese balcanico non si è ancora espresso in maniera esplicita a riguardo, ma è indubbio il fatto che i rapporti tra Belgrado e Pechino siano stretti come non mai. Il legame tra i due Paesi è storico e si è rinsaldato a più riprese negli scorsi decenni. A partire da quando negli anni Novanta la Cina si era espressa a favore del mantenimento di una Jugoslavia unita e aveva poi criticato i bombardamenti della Nato durante la guerra del Kosovo. Anche per questo il Governo cinese non ha mai dimenticato la distruzione dell’Ambasciata di Pechino in Serbia, involontariamente causata nel 1999 dai missili Nato. Nello stesso luogo sorge ora un nuovo Centro Culturale Cinese da 55 milioni di euro. Le imprese cinesi investono grandi somme nell’industria dell’acciaio e nelle miniere. Ma la Cina ha anche riversato capitali per 8 miliardi di dollari dedicati alla riqualificazione delle infrastrutture. Tutti interventi che hanno salvato oltre 10mila posti di lavoro e risollevato la stagnante economia serba.
Tra Xi Jinping e il Presidente serbo Aleksandar Vučić i rapporti si sono cementati ancora di più. Dal 2019 sono stati fatti enormi passi avanti per lo sviluppo high tech congiunto, culminato nel memorandum sulla cooperazione tecnologica per l’esplorazione spaziale. La pandemia di coronavirus ha avvicinato ancora di più Belgrado a Pechino, allontanandola dall’Unione europea. Dall’inizio della pandemia la Serbia ha ricevuto 58 aerei carichi di attrezzature cinesi. Lo stesso Vučić ha accolto in aeroporto l’arrivo di aiuti sanitari dalla Cina nel momento peggiore della prima ondata di Covid-19. La Serbia è stato il primo Paese europeo a importare il vaccino prodotto da Sinopharm, del quale è arrivata una nuova consegna negli scorsi giorni. In tutto ne sono arrivate quasi quattro milioni di dosi. Il Governo locale dà merito alle forniture di Pechino per il suo successo nella campagna vaccinale, durante la quale ha già ricevuto entrambe le dosi circa il 28% della popolazione, ben al di sopra della media Ue del 15%. Circa il 70% delle dosi inoculate sono provenienti proprio dalla Cina.
La Serbia rappresenta oggi l’alleato più fidato della Cina in Europa centro-orientale, insieme all’Ungheria. Non a caso, le capitali di questi due Paesi saranno collegate da una nuova linea ferroviaria finanziata proprio dai prestiti di Pechino e costruita da compagnie cinesi. L’Ungheria è stata il primo (e finora unico) Paese dell’Ue a utilizzare il vaccino cinese. Non solo. Il Ministro degli Esteri Peter Szijarto, in questi giorni in visita a Guiyang (capitale della provincia sud-occidentale del Guizhou) per incontrare l’omologo Wang Yi, ha dichiarato che l’Ungheria aprirà uno stabilimento per la produzione autoctona del siero cinese. La presenza cinese in Ungheria è forte anche sul lato culturale. E lo sarà ancora di più a partire dal 2024, quando dovrebbe aprire i battenti il campus di Budapest della prestigiosa Fudan University di Shanghai. Si tratterà del primo campus cinese in territorio europeo.
Eppure, non fila tutto liscio per Pechino sul fronte centro-orientale dell’Europa. Dal 2012 la Cina ha ideato il meccanismo del 16+1 (poi diventato 17+1 con l’adesione della Grecia), che riunisce Pechino e i Paesi dell’area. A distanza di qualche anno, tra le fila delle nazioni coinvolte sembra serpeggiare disillusione. Da una parte per alcune problemi nati sugli investimenti cinesi e sulla loro effettività che non sempre si è concretizzata. Dall’altra parte anche per un discorso geopolitico, visto che tanti di questi Stati hanno bisogno della protezione militare degli Stati Uniti in ottica anti russa. In particolare la Polonia e i Paesi Baltici. Non a caso, solo pochi giorni fa la Lituania ha annunciato la sua uscita dal 17+1. “È divisivo”, ha dichiarato il Ministro degli affari esteri Gabrielius Landsbergis, invitando anche gli altri Paesi coinvolti a sciogliere il meccanismo. I media cinesi hanno dedicato molto spazio alla questione lituana (per esempio con questo editoriale del China Daily), criticando Villnius definita “imprigionata in logiche da guerra fredda”. Le stesse critiche che Pechino muove di continuo a Washington e ai Five Eyes.
Per correre ai ripari, Wang Yi ha ospitato in questi giorni non solo l’omologo serbo ma anche quello polacco. Durante gli incontri, il Ministro degli Esteri ha dichiarato che la Cina non ambisce a stabilire una “sfera di influenza” in Europa centro-orientale e che la cooperazione con i Balcani rimarrà “pragmatica” e si concentrerà sul commercio, senza coinvolgere la sfera militare e della sicurezza. Un tentativo per abbassare tensioni e sospetti il cui successo dipenderà però anche dalla risposta dell’amministrazione Biden, che pare intenzionata a premere affinché partner e alleati prendano sempre più le distanze (quantomeno a livello politico) da Pechino.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Attenzione a dare giudizi definitivi sulla crisi pandemica. Il Covid-19 ha già dimostrato di poter ribaltare situazioni e considerazioni in breve tempo. All’inizio dell’epidemia a Wuhan, il coronavirus era definito il possibile “cigno nero” per il Presidente Xi Jinping. Poi lo è diventato per Donald Trump, sconfitto alle elezioni presidenziali anche (ma non solo) per la cattiva gestione sanitaria negli Stati Uniti. La Corea del Sud era stata lodata a livello globale per il suo contenimento dei contagi, ma ora il Presidente Moon Jae-in e il suo Governo sono in crisi di consensi (come dimostrato dalle recenti elezioni locali a Seul e Busan) proprio per l’approccio deficitario alla nuova ondata di casi. Alla dura legge del Covid non ha saputo sfuggire neppure Taiwan, che era stata elevata a modello globale per la sua capacità non solo di reazione ma anche di prevenzione della crisi.
Fino a qualche settimana fa, i contagi totali dall’inizio della pandemia erano poco più di mille e i morti dieci. Il tutto senza operare un lockdown stringente come in Cina, ma chiudendosi a riccio all’esterno (quantomeno nella fase iniziale) e restando aperti all’interno. Scuole, ristoranti, cinema, teatri, concerti: Taiwan è rimasta a lungo un’isola felice mentre il mondo si barricava in casa. Quando lo sport mondiale si è fermato, durante la prima ondata, il campionato di baseball (e non solo) taiwanese si era guadagnato l’attenzione degli sportivi in astinenza.
Poi, qualcosa è andato storto. Tutto sarebbe cominciato dalla diffusione di contagi tra piloti e staff della China Airlines, compagnia aerea di bandiera di Taiwan. Il primo focolaio sarebbe partito dalle case da tè del distretto di Wanhua, nella capitale Taipei. Dal 15 maggio è cominciata così la prima vera ondata di contagi da coronavirus sull’isola. Nel giro di dieci giorni sono stati registrati oltre quattromila casi e 23 morti, facendo improvvisamente impennare i numeri di una crisi che ha improvvisamente cominciato a fare paura. Martedì 25 maggio sono state registrate 542 nuove infezioni “domestiche”, delle quali 281 di giornata a 261 derivanti dall’arretrato dei test dei giorni scorsi. Alcuni errori o ritardi nei conteggi dei casi hanno sollevato tra l’altro alcune polemiche.
L’elemento positivo è che non si è avuto un aumento esponenziale dei casi, che resta più o meno stabile da alcuni giorni intorno alle 500 unità. Le autorità sperano inoltre che presto la crescita possa rallentare, anche perché subito dopo l’aumento dei contagi sono state prese misure drastiche di contenimento. È stato dichiarato lo stato di emergenza fino al 28 maggio, poi prorogato fino al 14 giugno. Ciò significa che i luoghi pubblici e di lavoro sono stati chiusi, a eccezione degli uffici governativi e di quelli che forniscono servizi essenziali. Sono state chiuse anche le scuole, mentre il 17 maggio è stata annunciata (per almeno un mese) la chiusura delle frontiere a tutti i cittadini stranieri sprovvisti di regolare carta di residenza. Nessuna eccezione, neppure per motivi di lavoro o per ricongiungimenti familiari, nonostante chiunque all’arrivo (dopo tampone negativo) si deve sottoporre a 14 giorni di quarantena solitaria (e geolocalizzata) e a ulteriori sette giorni di auto isolamento.
Secondo diversi critici, il Governo ha delle responsabilità per la nuova ondata di contagi. In particolare, viene sottolineata la rilassatezza con la quale sono stati diminuiti i giorni di quarantena necessari ai piloti e lo scorso numero di test e tamponi effettuati negli ospedali. Secondo Our World in Data, nel mese di febbraio Taiwan ha effettuato 0,57 test ogni mille persone. Un numero bassissimo se paragonato al 6,21 di Singapore e all’8,68 del Regno Unito. L’assenza di casi locali di coronavirus avrebbe provocato una sottovalutazione del rischio di un ritorno dei contagi. Chi sostiene questa versione cita anche la bassissima percentuale di taiwanesi vaccinati. Se si guarda ai dati, in effetti, la campagna ha accelerato solo a partire dall’emersione dei nuovi casi che ha fatto percepire l’emergenza. Fino al 7 maggio erano state somministrate solo 91mila dosi su una popolazione di oltre 23 milioni di persone. Nel giro delle due settimane successive ne sono state invece somministrate oltre 200mila.
Sul tema del vaccino, però, subentra anche la geopolitica. Taiwan ha ordinato circa 20 milioni di dosi, soprattutto da AstraZeneca e da Moderna, ma fino a qualche giorno fa ne aveva ricevute meno di un milione. E tutte da AstraZeneca. Il Governo taiwanese accusa quello della Repubblica popolare cinese di aver interferito sulla distribuzione dei sieri e ora si è rivolto agli Stati Uniti per provare a ottenere più dosi. La Cina, da parte sua, sostiene di aver offerto i propri sieri a Taiwan, ricevendo un rifiuto. Il mancato dialogo politico tra le due sponde dello Stretto, e le tensioni militari che coinvolgono Esercito popolare di liberazione ed esercito Usa, impediscono un confronto sereno sul tema vaccinale. Da una parte, Pechino farebbe pressioni per gestire la distribuzione vaccinale in un territorio che considera suo, dall’altra parte Taiwan non può politicamente accettare l’aiuto (reale o dichiarato) di un Governo che non esclude l’utilizzo della forza per eliminare la sua autonomia. Da qui uno stallo che rischia di creare ulteriori conseguenze per i cittadini taiwanesi.
Un altro argomento di scontro è quello legato all’Organizzazione mondiale della sanità, dalla quale Taiwan è esclusa perché non fa parte delle Nazioni Unite. Da anni Taipei chiede di essere riammessa all’Assemblea nazionale della sanità, dalla quale è esclusa da cinque anni per volere di Pechino. Esattamente da quando alla presidenza è arrivata Tsai Ing-wen del Partito democratico progressista, invisa al Partito comunista cinese. Il Ministro degli Esteri Joseph Wu e il Ministro della Salute Chen Shih-chung hanno scritto una lettera di protesta all’Oms per l’esclusione dalla 74esima sessione dell’Assemblea parlando di “continua indifferenza verso i diritti alla salute dei 23,5 milioni di taiwanesi” e di “un buco nella prevenzione globale delle malattie”. Il Governo cinese sostiene di aver notificato a Taiwan la situazione sull’epidemia 260 volte e di aver accettato la partecipazione di esperti sanitari taiwanesi alle attività tecniche dell’Oms per 16 volte ma Taipei definisce falsa la versione secondo la quale Pechino tutelerebbe il passaggio di informazioni.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

0,53%. Questa è la percentuale che preoccupa il Governo cinese. Quella percentuale rappresenta il tasso di crescita della popolazione della Repubblica popolare del decennio 2010-2020, periodo nel quale i cinesi sono passati da un miliardo e 340 milioni a un miliardo e 412 milioni. Si tratta della media più bassa mai registrata. E il trend è in costante peggioramento, visto che tra il 2019 e il 2020 si è raggiunto il minimo storico delle nascite. Nel primo anno della pandemia da coronavirus si sono registrate 12 milioni di nascite, il 18% in meno rispetto alle 14,65 milioni del 2019 e il valore più basso degli ultimi 60 anni. I dati derivano dall’ultimo censimento realizzato dalla Cina, i cui risultati sono stati resi noti pochi giorni fa. Numeri che restituiscono la fotografia non solo di un Paese che inizia a invecchiare, e la cui popolazione potrebbe iniziare a scendere a partire dal 2027, ma nel quale perdurano diseguaglianze sociali e disparità geografiche e di genere.
Circa sette milioni di persone, con un’ampia fetta di volontari, hanno visitato tutte le abitazioni dell’immenso territorio cinese. Il rallentamento della crescita è particolarmente evidente se quello 0,53% viene raffrontato al 5,83% emerso dal censimento del decennio precedente. Secondo le proiezioni, ogni donna cinese avrà in media 1,3 figli nel corso della propria vita, il tasso di fertilità più basso al mondo fatta eccezione per Corea del Sud, Singapore, Malta, Spagna, Italia e Ucraina. Insieme alle nascite cala anche il numero di donne in età fertile, mentre aumenta il grado di invecchiamento.
Nell’ultimo decennio, i cittadini cinesi over 60 sono aumentati del 5,44%, arrivando a 264 milioni: ciò significa che il 18,7% della popolazione cinese ha più di 60 anni. Qualche passo avanti per quanto riguarda lo storico squilibrio di genere tra uomini e donne, retaggio della politica del figlio unico abolita nel 2016. Per ogni 100 bambine femmine, sono nati 113.5 bambini maschi. Dieci anni fa, il rapporto era di 118,1 a 100. La disparità di genere fa sì che in Cina esista un esercito di circa 30 milioni di uomini alla ricerca (spesso vana) di una moglie.
La pandemia di Covid-19 potrebbe aver influito sul rallentamento della crescita della popolazione, ma in realtà il trend era cominciato già in precedenza. Nonostante l’abolizione della politica del figlio unico, le nascite sono aumentate solo nel 2016 ma sono poi diminuite del 3,5% già nel 2017. Cifre dovute non solo all’aumento del costo della vita, ma anche all’innalzamento del livello di istruzione che porta a sposarsi e fare figli più tardi. Tra il 2010 e il 2020 il tasso di analfabetismo è sceso dal 4,08% al 2,67%, mentre il numero di cinesi con un’istruzione universitaria è lievitato del 73%.
L’innalzamento dell’età media ha conseguenze sociali ed economiche. Si va restringendo, infatti, la popolazione nella fascia d’età lavorativa. Anche per questo, il Governo cinese ha già previsto l’aumento dell’età pensionabile, oggi ferma a 60 anni per gli uomini e a 55 anni per le donne. Una decisione impopolare ma necessaria, se si pensa che, stando a un rapporto della China Development Research Foundation, nel 2050 gli over 60 sono destinati a raggiungere le 500 milioni di unità, quasi un terzo della popolazione complessiva.
L’invecchiamento rischia di avere pesanti ripercussioni non solo sulla produzione industriale, ma anche sui consumi interni, che Xi Jinping sta cercando di stimolare ulteriormente con la strategia della “doppia circolazione” e con il nuovo piano quinquennale. Il basso tasso di natalità rischia di rallentare anche il sorpasso della Cina agli Stati Uniti, che hanno sopperito ai nodi demografici importando forza lavoro dall’estero. Processo meno semplice per una Cina i cui confini sono ancora più inespugnabili dopo il Covid. Secondo le proiezioni dell’istituto di credito, la popolazione cinese è destinata a diminuire di 32 milioni di persone da qui al 2050, al contrario negli Stati Uniti se ne aggiungeranno altri 50 milioni.
In che modo pensa il Governo cinese di provare a risolvere, almeno parzialmente, la situazione? Oltre all’innalzamento dell’età pensionabile, verranno allentate (o persino cancellate) le restrizioni sulle nascite. Si cercherà poi di intervenire anche per incentivare le giovani coppie a sposarsi (anche i matrimoni sono in costante calo in Cina negli ultimi anni) e a fare figli. In che modo? Per esempio tagliando le tasse sugli immobili, come previsto dal nuovo piano quinquennale, e introducendo contributi economici ad hoc.
Il Governo è chiamato a intervenire, come esso stesso ha più volte dichiarato durante il V Plenum e le recenti “due sessioni“, anche sulle diseguaglianze regionali. Nonostante gli sforzi e gli investimenti nelle province più interne, le disparità sono infatti cresciute. La percentuale di persone residenti nelle province nord-orientali del Paese, quelle meno dinamiche, è scesa dell’1,2% a fronte di un incremento del 2,15% riportato nelle province orientali, quelle più sviluppate. Con un contestuale aumento dei migranti interni, che nel 2020 erano ben 376 milioni.
Se ti interessa l’argomento, scopri il nostro Workshop di Geopolitica sulla Cina.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Alla fine è caduto nell’Oceano Indiano. Le previsioni apocalittiche sull’impatto (magari in Italia) dell’ormai celeberrimo razzo cinese in discesa libera dallo spazio non si sono verificate. Ma la vicenda è stata, ed è ancora, un’occasione per criticare le eventuali responsabilità di Pechino nel mancato controllo di questo razzo (e degli altri presenti in orbita) e per rinfocolare la polemica in un settore nel quale la competizione tra Cina e Stati Uniti si sta ampliando nel corso degli ultimi anni: lo spazio, appunto.
I detriti del vettore Lunga Marcia-5B Y2 sono rientrati nell’atmosfera domenica 9 maggio alle 10,24 ora di Pechino. La maggior parte di loro sono stati bruciati nell’atmosfera, quelli restanti sono finiti a ovest dell’arcipelago delle Maldive. Per diversi giorni si era speculato, anche in Italia, sul possibile punto di impatto. Con la maggior parte della superficie terrestre coperta di acqua, le probabilità che i detriti colpissero un’area popolata o addirittura una città erano molto basse, ma l’episodio è stato sfruttato per criticare la mancanza di trasparenza della Cina e la sua incapacità nel fornire rassicurazioni più forti nel periodo precedente al rientro.
Non è la prima volta che avvengono rientri incontrollati di detriti. Il caso più celebre risale al 1979 e alla caduta in Australia di grossi frammenti della stazione spaziale della Nasa Skylab. Proprio gli osservatori della Nasa criticano ora la Cina per non aver previsto la possibilità di rientri incontrollati e in particolare per non aver predisposto delle contromisure precise. Si tratta peraltro del secondo episodio che coinvolge il Lunga Marcia-5B. Nel maggio 2020, altri detriti del razzo erano caduti in Costa d’Avorio nel villaggio di N’Guessankro, non lontano dalla città di Bouake. Il timore è quello che incidenti del genere possano ripetersi, vista l’intensa attività spaziale della Cina.
Le accuse sono però state respinte dalla Cina. Il portavoce del Ministero degli Esteri Wang Wenbin ha parlato invece di “pratica comune in tutto il mondo che gli stadi superiori dei razzi brucino mentre rientrano nell’atmosfera”. La collega Hua Chunying ha invece dichiarato che la Cina “ha monitorato con precisione il rientro dei detriti” e “ha condiviso una previsione pertinente con la comunità internazionale”, promettendo la disponibilità alla “cooperazione internazionale per affrontare il problema dei detriti spaziali al fine di garantire la sostenibilità a lungo termine delle attività nello spazio”.
Segnalando però che nei mesi scorsi parti di un razzo statunitense fabbricato da SpaceX sono rientrate nella proprietà di un contadino residente nello Stato di Washington. “Siamo disposti a collaborare con altri Paesi, inclusi gli Stati Uniti, nell’uso pacifico dello spazio, ma ci opponiamo a tenere un doppio standard sulla questione”. Il Global Times ha definito “campagna pubblicitaria occidentale” la copertura mediatica del rientro del razzo. Secondo il tabloid di Stato in lingua inglese gli scienziati della Nasa hanno fomentato timori in modo “non intellettuale”, seguendo una campagna anti cinese impostata dagli Stati Uniti e in generale dall’Occidente. “Queste persone sono gelose del rapido progresso della Cina nella tecnologia spaziale”, si legge ancora, “e alcune di loro stanno cercando di usare il rumore da loro provocato per ostacolare e interferire con l’intenso programma di futuri lanci cinesi per la costruzione della propria stazione spaziale”.
Il razzo ha messo in orbita un modulo Tianhe senza pilota e diventerà l’abitazione per tre membri dell’equipaggio su Tiangong 3. Si tratta della prima stazione spaziale cinese permanente, che verrà costruita attraverso 11 missioni. Al primo lancio del 29 aprile dal sito di lancio spaziale di Wenchang sull’isola di Hainan seguiranno dunque altri dieci lanci per completare la missione entro l’inizio del 2023. Le ambizioni spaziali della Cina non si fermano qui. Tra non molto il rover Zhurong (il dio del fuoco secondo la mitologia cinese) dovrebbe atterrare su Marte. Il rover viaggia a bordo della sonda Tianwen-1, lanciata nel luglio 2020 che è entrata con successo nell’orbita di Marte il 24 febbraio scorso. Di recente è stata poi conclusa con successo una missione di ricerca nel “lato nascosto della Luna”.
Nelle scorse settimane, il vicepremier cinese Han Zheng ha partecipato all’inaugurazione a Xiongan della China Satellite Network Group, nuova azienda statale che ha il compito di lanciare nello spazio satelliti LEO (Low Earth Orbit). Nonostante la sua giovane età, la China Satellite Network Group è al 26° posto nell’elenco ufficiale di Pechino delle 98 aziende statali, subito dopo i tre grandi operatori di telecomunicazioni del Paese: China Mobile, China Unicom e China Telecom. L’azienda è anche la prima impresa cinese a livello statale ad aver istituito la sua sede principale a Xiongan, situata in una regione rurale selezionata però dal Presidente Xi Jinping quattro anni fa per essere ricostruita in una futuristica città intelligente. Attraverso i lanci della nuova entità, Pechino mira a competere con i colossi americani per l’offerta di connessione internet satellitare. La Cina ha presentato già domanda all’Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU) delle Nazioni Unite lo scorso settembre, segnalando l’intenzione del Paese di costruire due costellazioni LEO per un totale di 12.992 satelliti.
La vicenda dei detriti del razzo segnala che la competizione tra le due potenze mondiali interessa ormai da vicino anche lo spazio. La Cina fonda parte della sua retorica proprio sullo sviluppo spaziale. Lo si riscontra anche nel proliferare, su indicazione del Partito comunista, del genere fantascientifico sia a livello letterario che a livello cinematografico. Il tentativo è quello di creare un’epica spaziale cinese, come dimostra il celebre tentativo col film “The Wandering Earth“, adattato da un altrettanto celebre romanzo di Liu Cixin.
La contesa si gioca dunque su più campi. Il primo è quello strategico, tanto che gli Stati Uniti si sono dotati di un commando militare spaziale durante l’amministrazione Trump. Il secondo è quello commerciale (con gli interessi legati alla connessione internet satellitare) e della ricerca scientifica. Il terzo è proprio quello narrativo: dopo lo sbarco sulla Luna e la fine della Guerra fredda, gli Usa non sono più abituati a condividere gli onori della ribalta spaziale con altri attori. La Cina vuole provarci. Ecco perché i detriti di un razzo che cadono nell’atmosfera non sono solo i detriti di un razzo che cadono nell’atmosfera.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

“GET THE FUCK OUT”. Teodoro Locsin Jr. lo ha scritto proprio così, tutto in maiuscolo, in un thread su Twitter che rappresenta il punto più basso delle relazioni tra Manila e Pechino. Già, perché Locsin Jr. è il Ministro degli Esteri delle Filippine e il bersaglio della sua espressione, che di diplomatico ha ben poco, è la Cina. Alla base c’è una storica disputa territoriale tornata prepotentemente di attualità nelle scorse settimane, dopo lo stanziamento di una flottiglia di navi cinesi nelle acque contese. Una vicenda che si inserisce nel contesto delle oscillazioni diplomatiche delle Filippine che, in seguito all’avvicinamento al vecchio rivale cinese promosso dal Presidente Rodrigo Duterte e le tensioni con gli Stati Uniti di Donald Trump, sembrano essere in procinto di tornare (ma solo parzialmente) all’ovile dell’ex colonizzatore.
“Amici miei cinesi, come posso metterla educatamente? Lasciatemi pensare… Ecco… Levatevi dalle scatole!”, ha scritto Locsin Jr. “Che cosa state facendo alla nostra amicizia? Voi. Non noi. Noi ci stiamo provando. Ma voi sembrate dei tizi brutti e stupidi che cercano di catturare l’attenzione di un bel tipo che vuole semplicemente esservi amico”, ha proseguito il Ministro degli Esteri di Manila che ha poi chiesto “che cosa ci sia di così difficile da capire” nelle dichiarazioni di Duterte, il quale negli scorsi giorni aveva ricordato la sentenza del tribunale internazionale dell’Aja, che nel 2016 aveva dato ragione a Manila in riferimento alle dispute marittime nel Mar Cinese meridionale. Sentenza che non è mai stata riconosciuta dal Governo cinese. Cosa che ha creato non poche tensioni tra i due Paesi, ravvivate da oltre un mese, da quando circa 200 pescherecci cinesi hanno cominciato a stazionare nelle acque circostanti Juan Felipe (nome internazionale Whitsun Reef), atollo delle isole Spratly (che la Cina ritiene sue e chiama Nansha). Il segretario alla Difesa di Manila, Delfin Lorenzana, sostiene che Pechino voglia occupare più territori nelle acque contese e ha chiesto di “rispettare la sovranità delle Filippine sulle isole Kalayaan” (il nome utilizzato da Manila per le Spratly). Il 1° aprile Manila ha anche dichiarato di aver individuato delle strutture illegali in altri punti delle Spratly.
Le tensioni si erano però affievolite negli ultimi anni, dopo che Duterte aveva avviato sin dall’inizio del suo mandato presidenziale di voler lanciare una nuova stagione nei rapporti tra Manila e Pechino. A ottobre 2016, durante una sua visita nella capitale cinese, aveva annunciato la “separazione” delle Filippine dagli Usa e il “riallineamento” con la Cina. “L’America ha perso”, sentenziava Duterte poche settimane prima della vittoria di Trump alle elezioni. Negli anni successivi, le relazioni tra Pechino e Manila si sono intensificate. A livello economico nell’ambito della Belt and Road, ma anche a livello politico. Dopo la “chiamata alle armi” di Mike Pompeo, che lo scorso luglio aveva cercato di arruolare i Paesi del Sud-est asiatico contro la Cina in merito alle dispute marittime, Duterte aveva risposto freddamente, sostenendo che le attività cinesi nell’area “non si possono fermare”.
Nel 2020 il Presidente filippino ha persino annunciato che avrebbe “stracciato” il Visiting Forces Agreement, uno dei pilastri del trattato bilaterale di mutua sicurezza che, dal 1951, regola la partnership militare tra Manila e Washington. Alla base della scelta una polemica sulla revoca del visto americano all’ex capo della polizia delle Filippine, Ronald Dela Rosa, attivo nella guerra alla droga lanciata da Duterte che ha causato negli scorsi anni un’ondata di omicidi extragiudiziali. Ma se lo scorso anno Trump aveva risposto con indifferenza all’annuncio di Duterte, il neo Presidente Joe Biden sta cercando di riannodare il legame con il Paese del Sud-est asiatico, che tra le altre cose ha un’importanza cruciale per la sua posizione nei pressi dello Stretto di Taiwan. Gli scambi diplomatici tra Usa e Filippine si sono intensificati negli ultimi mesi. Qualche settimana fa, il nuovo segretario di Stato Antony Blinken ha avuto una conversazione telefonica con Locsin Jr., durante la quale entrambi hanno reiterato l’invito a Pechino a rispettare il pronunciamento arbitrale del 2016. D’altronde, le Filippine hanno iniziato a rivolgersi agli Stati Uniti dopo la recente escalation strategica nelle acque contese. I due Ministri degli Esteri hanno riaffermato la reciproca adesione al trattato bilaterale di mutua sicurezza e si sono da poco concluse delle esercitazioni militari congiunte durate due settimane. Hanno parlato tra loro anche il Consigliere alla Sicurezza Nazionale Usa Jack Sullivan e il suo omologo filippino Hermogenes Esperon, convenendo su un’azione coordinato nel Mar Cinese meridionale.
Attenzione però a concludere frettolosamente che le Filippine abbiano scelto di stare dalla parte degli Stati Uniti. Duterte ha preso le distanze dal thread di Twitter di Locsin Jr., definito “maleducato”. “La Cina resta il nostro benefattore. Solo perché abbiamo un conflitto con la Cina non significa che dobbiamo essere scortesi e irrispettosi”, ha dichiarato il Presidente delle Filippine, richiedendo poi a Pechino di lasciare “che i nostri pescatori peschino in pace e non ci saranno problemi”. Duterte sta cercando di mantenere basso il livello dello scontro ed è riluttante a fronteggiare Pechino sul tema del Mar Cinese meridionale, anche perché le Filippine sono in una seria situazione di difficoltà sanitaria, a causa della pandemia da Covid-19. E il loro piano vaccinale dipende proprio dalle forniture cinesi, nonostante ci siano stati degli abboccamenti in tal senso anche con Washington. Proprio in questi giorni, Manila sta trattando l’invio su base mensile di quattro milioni di dosi del siero di Sinovac Biotech. Duterte si è invece fatto iniettare, a favore di telecamera, il siero prodotto da Sinopharm. L’arrivo di Biden e le ultime tensioni un risultato però intanto ce lo hanno avuto: dal progressivo scivolamento nell’abbraccio di Pechino, Manila è tornata a cercare di camminare con maggiore equilibrio lungo la sottile linea rossa che divide le due potenze.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

“Abbiamo già vinto una volta la guerra contro il Covid senza vaccino. Lo rifaremo insistendo su test, tracciamento e cura”. Lo diceva una ventina di giorni fa Narendra Modi, mostrando fiducia nella possibilità di riuscire in qualche modo a contenere la nuova ondata pandemica in India. Non è andata così.
Martedì 27 aprile sono stati registrati 323.144 nuovi contagi. Meno del record di 349.691 di lunedì 26 aprile, ma comunque un dato altissimo, con la barriera dei 300mila superata per il sesto giorno consecutivo. Le vittime si stanno avvicinando a diventare tremila ogni 24 ore e il totale dei contagi galoppa verso i 18 milioni, con un aumento di oltre due milioni di unità nel giro di una settimana.
Si tratta di una vera e propria esplosione, visto che fino a febbraio i casi giornalieri erano in media novemila. A peggiorare la situazione anche la “qualità” dei contagi, non solo la quantità. In circa il 16% dei casi attivi, i contagiati hanno dovuto essere ricoverati in ospedale. La conseguenza è che il sistema sanitario indiano è allo stremo. Alla base di questa virulenza c’è la cosiddetta variante indiana, che sta preoccupando anche nel resto del mondo tanto da portare anche l’Italia alla chiusura degli arrivi dall’India. Scoperta per la prima volta a ottobre nel Maharashtra, questa variante si trova ormai in oltre la metà dei campioni sequenziati. La città più colpita è la capitale, Nuova Delhi, che registra in media 25mila nuovi contagi ogni giorno con un tasso di positività al 35%.
Ad aumentare le preoccupazioni c’è la recente scoperta di un’ulteriore mutazione del virus nel Bengala occidentale. Eppure, proprio in questo Stato si stanno svolgendo in otto fasi le elezioni per il rinnovo dell’assemblea legislativa locale. Nonostante il progressivo peggioramento della situazione pandemica, il processo, cominciato il 27 marzo, non si è interrotto e si concluderà giovedì 29 aprile. L’affluenza è stata finora sempre molto alta e potrebbe aver contribuito alla diffusione dei contagi. Non è un caso isolato. Si sta votando anche negli Stati del Kerala, del Tamil Nadu e dell’Assam e nel territorio di Pondicherry. In tutti e cinque i casi, lo scrutinio è stato fissato per domenica 2 maggio.
Secondo la giornalista indiana Shikha Mukerjee, “i cittadini stanno pagando due volte gli errori della commissione elettorale”, mentre i raduni si sarebbero trasformati in “eventi di super-diffusione di proporzioni terrificanti” nel Bengala occidentale, “Stato che è rimasto vittima dei capricci di chi non vuole riconoscere che la crisi del Covid-19 potrebbe trasformarsi in una catastrofe. Effettivamente, si è notato un cambiamento nel comportamento recente del Governo indiano, probabilmente per un’eccessiva sicurezza dopo i buoni risultati del contenimento della prima ondata. Solo a metà marzo il Ministro della Sanità Harsh Vardhan aveva dichiarato che ormai il Paese era fuori dal tunnel pandemico. Per tutto il 2020 il Primo Ministro Modi aveva chiesto grande attenzione da parte dei cittadini e, contrariamente ad altri leader mondiali, non aveva mai sottovalutato la situazione presentandosi in pubblico sempre in mascherina. Qualcosa è cambiato negli scorsi mesi, quando è iniziata la campagna elettorale delle elezioni locali. I partiti rivali hanno in alcuni casi sospeso la campagna elettorale, per esempio nel Bengala, ma Modi ha continuato a organizzare comizi lodando le folle presenti. Non solo. È stato consentito lo svolgimento del Kumbh Mela, un pellegrinaggio di massa indù, addirittura anticipato dal 2022 al 2021 perché le date di quest’anno erano di “buon auspicio”.
I provvedimenti restrittivi sono stati presi per lo più a livello locale dai singoli Stati che hanno imposto lockdown parziali e coprifuoco. Modi ha dichiarato di voler evitare il lockdown totale e nazionale per la necessità di “salvare le attività economiche”, oltre alle vite umane. Nel frattempo si punta alla velocizzazione del processo vaccinale, che finora ha coinvolto circa 140 milioni di persone che hanno ricevuto almeno la prima dose di uno dei sieri indiani, il Covishield del Serum Insititute e il Covaxin di Bharat Biotech. Il paradosso è che proprio l’India è uno dei principali hub produttivi di vaccini anti Covid al mondo. Nei laboratori indiani vengono prodotti localmente anche AstraZeneca e il russo Sputnik V. Dal primo summit virtuale del quattro leader del Quad, la piattaforma informale di dialogo che unisce Stati Uniti, Giappone, India e Australia, è uscita un’ulteriore spinta alla produzione di Nuova Delhi. La promessa è quella di garantire investimenti tali da permettere all’India di produrre oltre un miliardo di dosi entro il 2022. Washington punta sulla diplomazia vaccinale di Nuova Delhi in ottica anti cinese, come dimostra il caso del Paraguay, già raccontato da eastwest.
Con l’India in grave difficoltà, gli Usa stanno ora sbloccando l’export di materie prime per la produzione di vaccini. Il segretario alla Difesa, Llody Austin, ha ordinato al suo dipartimento di attingere alle proprie risorse per offrire aiuto a Nuova Delhi, dove peraltro è stato in visita solo poche settimane fa. Dagli Stati Uniti sono anche arrivati i primi 318 concentratori di ossigeno, mentre il Regno Unito ne ha spediti 495, insieme a 140 ventilatori. Anche Francia, Germania e Canada hanno promesso sostegno concreto. Tra chi si è detto pronto a dare un aiuto c’è però anche la Cina. Una parziale sorpresa, dopo gli scontri militari del giugno 2020 lungo il confine conteso e le seguenti tensioni commerciali e diplomatiche. I due portavoce del Ministero degli Esteri di Pechino, Zhao Lijian e Hua Chunying, hanno dichiarato che la Cina “è pronta a fare la sua parte”. È chiaro che un’eventuale distensione sul fronte sanitario darebbe a Pechino un vantaggio negoziale nei confronti di Nuova Delhi sugli altri delicati dossier in cui i due Paesi sono in “conflitto” e ipoteticamente ridurre il ruolo indiano nel Quad. Male che vada, qualora l’India non accettasse aiuti, la Cina potrebbe utilizzare le sue dichiarazioni e la crisi del grande vicino dal punto di vista retorico.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Ogni anno, nel mese di aprile, in Myanmar ricorre il Thingyan, il capodanno che celebra la tradizione buddhista del Paese. Quest’anno, la giunta militare protagonista del golpe dello scorso 1° febbraio ha deciso di festeggiare liberando 23mila e 184 prigionieri dalle carceri. Un’amnistia nella quale però non sono coinvolti, se non con poche eccezioni, gli attivisti che da oltre due mesi e mezzo manifestano per il ripristino della democrazia e il rispetto dell’esito delle elezioni dello scorso novembre. Tra i rilasciati anche 137 cittadini stranieri che sono stati o verranno deportati.
Al contrario, continuano gli arresti dei birmani che protestano contro il regime, fisicamente o attraverso prese di posizione pubbliche. Tra di loro anche la regista Christina Kyi, fermata (e poi rilasciata) insieme al marito e attore Zenn Kyi mentre si stava per imbarcare su un volo per Bangkok. Aung San Suu Kyi resta invece ai domiciliari e le accuse nei suoi confronti aumentano. Se fosse condannata per violazione di segreti di Stato rischierebbe fino a 14 anni di carcere.
Nel frattempo, nei giorni scorsi è stata annunciata, da parte del Comitato di Rappresentanza dell’Assemblea dell’Unione (ossia il Parlamento birmano), la formazione di un Governo di unità nazionale e di un esercito federale. All’interno ci sono esponenti della Lega Nazionale per la Democrazia ma anche rappresentanti delle minoranze etniche e dei gruppi armati attivi su base regionale. Il Presidente U Win Mynt e il Consigliere di Stato Aung San Suu Kyi mantengono virtualmente il loro ruolo, ma le posizioni di premier e vicepremier saranno occupate da esponenti delle minoranze Karen e Kachin. Il programma che è riuscito a unire anime molto diverse tra loro si basa ovviamente quello della ribellione contro il golpe dell’esercito e sul disconoscimento della Costituzione del 2008 che si vuole sostituire, nel medio periodo, con una nuova Carta che strutturi il Myanmar su base federale. Un vecchio programma mai pienamente realizzato per le tensioni mai risolte con le minoranze.
La composizione di un “Governo ombra” ha una doppia importante conseguenza. Sul piano interno, manda un messaggio chiaro al Tatmadaw, che potrebbe essere costretto a vedersela sul campo non solo con le proteste della comunità civile ma anche con azioni operative delle milizie, aspetto che eastwest aveva anticipato qualche settimana fa. Tanto da far ritenere ad alcuni osservatori che il Paese non sia solo sull’orlo della guerra civile ma che in realtà si sia già di fronte a una riesplosione di un conflitto mai concluso. La convergenza tra la forza politica centrale e i gruppi armati, secondo il The Diplomat, abbasserebbe di netto le possibilità di un negoziato pacifico.
Sul piano esterno, la creazione di un esecutivo di unità nazionale chiama allo scoperto la comunità internazionale. Ci si aspetta il riconoscimento ufficiale da parte di diversi Paesi occidentali e arabi, con la possibilità che venga aperto al fronte anti Tatmadaw l’accesso ai capitali detenuti dal Myanmar all’estero e ai conti bancari congelati negli Stati Uniti e a Singapore. Aspetto rilevante, se si considera che al di là delle sanzioni è in crescita la sospensione delle attività locali delle multinazionali. Una delle ultime a muoversi in tal senso è stata la malese Petronas.
Ma, ancora una volta, sarà decisivo l’atteggiamento e il posizionamento dei vicini asiatici. Qualcosa si muove intorno al Giappone, che ha cospicui interessi commerciali in Myanmar. Durante l’incontro a Washington tra il Presidente Joe Biden e il Primo Ministro Suga Yoshihide si è discusso anche del golpe. Nel comunicato finale si condannano “con forza le violenze commesse dall’esercito e dalla polizia birmani contro i civili” e si richiede “la cessazione immediata delle violenze, il rilascio dei prigionieri e un rapido ritorno alla democrazia”. Tokyo sta protestando da giorni con la giunta militare per l’arresto del giornalista freelance Kitazumi Yuki, fermato dalle autorità birmane con l’accusa di “diffusione di fake news“. La Cina, sin dall’inizio, cerca di mantenere aperti i canali di dialogo sia con l’esercito sia con gli esponenti dell’opposizione, fedelmente alla propria linea di non interferenza negli affari esteri e soprattutto per provare a salvaguardare i propri interessi commerciali e geopolitici nel Paese del Sud-est asiatico. Prosegue l’ambiguità anche dell’India, che al Myanmar ha venduto uno dei propri vaccini anti Covid e che vede nel Paese un importante proscenio per la sua competizione con la Cina.
Chi potrebbe incidere in maniera molto diretta è l’Asean, visto che il Myanmar è uno dei dieci membri dell’Associazione delle Nazioni del Sud-est Asiatico. Sin dall’inizio della crisi, Indonesia e Malaysia sono i due Paesi più decisi sulla necessità di intervenire nella crisi. A Giacarta si parla da tempo di possibile sospensione di Naypyidaw dall’organizzazione. Ma finora l’Asean è stato molto diviso sul golpe. La Thailandia, altro Paese governato da un regime militare, non può permettersi di esporsi contro il Tatmadaw. Non a caso, il suo Primo Ministro Prayuth Chan-ocha ha annunciato che non sarà presente al vertice Asean di sabato 24 aprile a Giacarta.
Il Governo di unità nazionale birmano ha chiesto di essere considerato nei colloqui regionali, ma intanto a Giacarta ci sarà il generale Min Aung Hlaing, cioè colui che di fatto ha organizzato il golpe. Ban Ki-moon, ex segretario generale delle Nazioni Unite ha detto all’Asean che il principio di non interferenza negli affari interni degli Stati membri “non dovrebbe essere utilizzato per giustificare l’inazione di fronte a seri abusi dei diritti umani”. Un passaggio che non sarà semplice da compiere, quantomeno in maniera unitaria. Intanto il Myanmar procede pericolosamente verso il caos.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Efficace gestione sanitaria, ripartenza economica, continua crescita delle esportazioni, promozione del multilateralismo, stabilità politica, un leader che rompe il vincolo dei due mandati, stretta anti corruzione e repressione del dissenso. Ingredienti che fanno subito venire in mente la Cina. In questo caso si parla però del Vietnam, ambizioso vicino del Dragone la cui rilevanza in ambito regionale e internazionale è in costante aumento. Per Hanoi i tempi dell’invidia verso le cosiddette “tigri asiatiche” sembrano ormai un lontano ricordo.
In questo primo anno (e spiccioli) di pandemia, in occidente la parola “modello” è stata accompagnata quasi sempre dall’aggettivo “cinese”, o al limite “coreano”. Molto meno da “vietnamita”. Eppure, secondo uno studio del Lowy Institute, la performance di contenimento del Covid-19 del Vietnam è la seconda migliore al mondo. Meglio ha fatto, secondo il principale think tank australiano, solo la Nuova Zelanda. A febbraio 2021 i contagi totali erano poco più di duemila e i morti appena 35. Numeri impressionanti in positivo, peggiorati solo da una terza ondata esplosa a fine gennaio in concomitanza con il 13esimo congresso del Partito comunista. Successo simile a quello di Taiwan, ma ancor più difficile visto che il Vietnam non è un’isola, e che nasce soprattutto grazie alla prevenzione. Memore della Sars, Hanoi ha iniziato a chiudere scuole e uffici già a gennaio 2020. I protocolli approntati nel 2003, ai quali lavorò prima di morire l’italiano Carlo Urbani, sono stati riutilizzati alle prime avvisaglie epidemiche in arrivo da Wuhan. La chiusura dei confini e lockdown mirati hanno consentito di tenere sotto controllo il virus, con una pronta riapertura quando l’andamento dei contagi ha consentito di portare avanti tracciamento e test. Il tutto sfruttando la presenza capillare dello Stato, e del Partito, sul territorio: altro punto in comune con la Cina.
La sollecita risposta al rischio sanitario ha consentito al Vietnam di rilanciare prontamente l’economia. Proprio come Pechino, nel momento di maggiore crisi globale Hanoi ha avviato una sua versione della “diplomazia delle mascherine“, con l’invio e la vendita di materiale sanitario che ha raggiunto anche l’Italia. Alla fine del 2020 la crescita del pil è stata persino maggiore di quella cinese: +2,9% contro +2,3%. Si tratta in realtà del dato più basso degli ultimi decenni, anche se secondo le stime nel 2021 si tornerà a crescere oltre il 6%, in linea con la media rispettata dal 2011 al 2019. I semi del progresso sono stati gettati nel 1986, con il lancio delle riforme del Doi Moi, programma che ha consentito il passaggio da una pianificazione centralizzata a un’economia di mercato a orientamento socialista, con qualche anno di ritardo dalla “grande apertura” di Deng Xiaoping. Da allora molto è cambiato. Il Vietnam, sempre con qualche anno di ritardo rispetto alla Cina, è entrato nell’Organizzazione mondiale del commercio nel 2007 e nel nuovo millennio ha elevato 45 milioni di persone da una condizione di povertà assoluta.
Il basso costo del lavoro, nonché la guerra commerciale e tecnologica tra Stati Uniti e Cina, sono stati elementi a favore di Hanoi, che ha accolto e continua ad accogliere la delocalizzazione di linee produttive in fuga dai dazi di Washington. A inizio febbraio, per esempio, la sudcoreana LG ha annunciato un investimento di 750 milioni di dollari nella città portuale di Hai Phong con la creazione di cinquemila nuovi posti di lavoro, portando il totale dei suoi interessi nel Paese a 3,5 miliardi. Modernizzazione economica e digitalizzazione sono due parole chiave della strategia economica vietnamita. Basti pensare che l’export di prodotti elettronici è aumentato del 56% nel 2020. Ma l’economia dipende ancora troppo dalle esportazioni, trainate peraltro dalle multinazionali straniere. Con la Cina impegnata a promuovere la “doppia circolazione” e i consumi interni, il Vietnam sta già raccogliendo, almeno parzialmente, il testimone dalla “fabbrica del mondo” sul lato produttivo. Il Governo sa, però, che per mantenere le previsioni del quadruplicamento del volume del pil entro il 2035, che dovrebbe portare l’economia vietnamita a diventare la 19esima al mondo, è rischioso dipendere solo dal commercio internazionale.
Il Partito pare intenzionato, così come accade in Cina, a controllare più direttamente la politica economica del Paese, convinto che la stabilità politica possa favorire la crescita. I segnali che arrivano dal 13esimo congresso (che ha tra l’altro approvato il nuovo piano quinquennale che prevede di portare il reddito pro-capite da 2500 a 4mila dollari annui) sono chiari. Nel nuovo politburo, composto da 18 membri, non figura nessun esponente della Banca centrale. In compenso la carica di presidente dell’Assemblea nazionale (uno dei quattro pilastri del sistema politico vietnamita insieme a quelle di segretario generale del Partito, presidente della Repubblica e primo ministro) verrà ricoperta da Vuong Dinh Hue, ex vice Primo Ministro e segretario del Partito ad Hanoi con una lunga carriera nella finanza alle spalle. Grande abilità in campo economico era stata dimostrata anche dall’ex primo ministro Nguyen Xuan Phuc, che si dovrà però accontentare della presidenza, ruolo più cerimoniale e meno politicamente incisivo di quello di segretario generale. Ruolo che, contro ogni pronostico, continuerà a ricoprire Nguyen Phu Trong. Sarà il suo terzo mandato, nonostante i 76 anni (dopo i 65 non si potrebbe venire confermati in cariche apicali), la salute precaria e il fatto che dai tempi di Le Duan (il successore di Ho Chi Minh) fosse rispettato il vincolo dei due mandati. Trong, in modo simile a Xi Jinping, ha costruito la sua reputazione su una ostentata inflessibiltà in materia di sicurezza e di anticorruzione, promossa attraverso la spietata campagna della “fornace ardente” che gli ha consentito di sbarazzarsi dei rivali politici sconfitti al 12esimo congresso del 2016. Il mancato accordo sul nome del suo successore, con il delfino Tran Quoc Vong rimasto fuori persino dal politburo, ha fatto sì che Trong restasse al suo posto.
La campagna anticorruzione proseguirà, come segnala anche la nomina (inusuale, visto che di solito si sceglieva tra i vice) a Primo Ministro di Pham Minh Chinh, ex generale di polizia proveniente dal potente ministero di pubblica sicurezza, e l’aumento di esponenti di esercito e forze dell’ordine nel politburo. Si teme che possa proseguire anche la repressione del dissenso, complice anche lo scollamento tra l’età sempre più alta dell’elite del Partito e una popolazione molto giovane, con oltre la metà dei 96 milioni di vietnamiti che hanno meno di 35 anni. Secondo i dati di 88 Project, in cinque anni si è passati da 86 a 256 attivisti in carcere. Con gli arresti di dissidenti politici in costante aumento, anche le pene si sono fatte più severe. Per restare agli scorsi mesi, sono stati arrestati Pham Chi Dung, presidente dell’Associazione dei giornalisti indipendenti poi condannato a 15 anni di carcere, e altri due reporter che dovranno scontare 11 anni. Poco prima era stato condannato anche il poeta Tran Duc Tach. Sempre più vietnamiti hanno accesso a internet ma i social non sono luoghi del tutto sicuri. Su richiesta del Governo, Facebook (che ha superato i 60 milioni di utenti locali) ha cancellato il 95% dei post ritenuti sovversivi, youTube circa il 90%.
Il tema dei diritti umani, insieme a quello della tutela dei lavoratori, resta il principale fattore di rischio nei rapporti con Stati Uniti e Unione europea. Eppure, complici le necessità commerciali del Vecchio Continente e quelle geopolitiche di Washington, si può prevedere che i rapporti con il Vietnam continueranno a essere approfonditi. Negli scorsi anni, Hanoi ha firmato accordi di libero scambio con l’Ue e (di recente) con il Regno Unito post Brexit. Sotto la sua presidenza di turno Asean (Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico) è stata sottoscritta la Regional Comprehensive Economic Partnership, che istituisce la più grande area di libero scambio al mondo e di cui fanno parte oltre ai 10 Paesi Asean anche Cina, Corea del Sud, Giappone, Australia e Nuova Zelanda.
I rapporti con Pechino sono complessi e ancora influenzati dal millennio di dominazione cinese. La politica vietnamita con il gigante della porta accanto è tradizionalmente bifronte. A un confronto anche teso su dossier politicamente delicati come il Mar Cinese meridionale (o mare Asiatico orientale come lo chiamano ad Hanoi) e il delta del fiume Mekong, si accompagna una strettissima cooperazione economica. Nel corso dei decenni si sono verificati anche due scontri militari, nel 1974 e nel 1988, che hanno portato la Cina a espandere il proprio controllo sulle isole Paracelso e l’arcipelago delle Spratly.
Il Vietnam resta ancora oggi il Paese Asean più deciso nel rispondere all’assertività di Pechino. Nel 2014 la presenza di una piattaforma petrolifera nelle acque contese ha portato a proteste anti cinesi di massa e nel 2019 c’è stato un nuovo confronto nella Vanguard Bank, area ricca di risorse naturali come gas e petrolio. Subito dopo l’arrivo di Joe Biden alla Casa Bianca, l’incrociatore Russell è transitato al largo delle Spratly e il Jonh McCain al largo delle Paracelso, mentre si è tenuta un’esercitazione congiunta delle portaerei Nimitz e Roosevelt nel mar Cinese meridionale. Segnale che Washington intende mostrare ai partner asiatici il suo impegno a mantenere “libera e aperta la regione dell’Indo Pacifico”, leit motiv della prima telefonata tra il neo segretario di Stato Usa Antony Blinken e il Ministro degli Esteri vietnamita Pham Binh Minh. Ulteriore messaggio in arrivo da Washington, la mancata applicazione di sanzioni nonostante le accuse di manipolazione valutaria.
Ma chi pensa che il Vietnam sia pronto a farsi “arruolare” in chiave anti cinese si sbaglia. Nonostante le pressioni contrapposte, Hanoi ha sempre saputo mantenere un’autonomia strategica. I legami economici con Pechino sono d’altronde fortissimi: il Dragone è il principale partner commerciale di Hanoi e il suo secondo mercato di esportazione dopo gli Stati Uniti (verso i quali nel 2020 si è registrato un surplus commerciale record, 63 miliardi di dollari contro i 47 del 2019). Nel quinquennio appena trascorso i rapporti sono stati riequilibrati sul fronte diplomatico, anche perché Trong e Phuc sono considerati delle “colombe” sul fronte dei rapporti con Pechino. Questo non ha impedito al Vietnam, complice la presenza sempre più ingombrante del vicino e il progressivo inserimento nei suoi ingranaggi dei limitrofi Cambogia e Laos, di promuovere un’estroversione sullo scenario internazionale utile a renderla indispensabile ai partner regionali, in primis Giappone e India, e occidentali. E se davvero è ormai la nuova tigre asiatica, Hanoi vuole ruggire sempre più forte. Possibilmente senza essere costretta a scegliere, né a tirare fuori gli artigli per difendersi.
Questo articolo è pubblicato anche sul numero di marzo/aprile di eastwest.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20
La dichiarazione delle autorità cinesi sulla scarsa efficacia dei loro vaccini getta un’ombra sulla campagna di esportazioni di Pechino. Intanto la rivale India aiuta il Paraguay (e Taiwan)

“La Cina ha ammesso che i propri vaccini contro il Covid-19 hanno una bassa efficacia”. Sui media e sulle agenzie di stampa di mezzo mondo la notizia è stata battuta così. Pechino ha smentito e sta provando a porre riparo a quella che definisce una “totale incomprensione”, ma una certa dose di danno appare comunque irreparabile. Un colpo alla diplomazia del vaccino che il Governo della Repubblica popolare sta portando avanti da diverso tempo (eastwest ne aveva scritto qui) e con ottimi risultati, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo. Il tutto accade, peraltro, mentre aumenta la competizione in materia vaccinale di rivali geopolitici come l’India.
Tutto nasce da una conferenza tenutasi a Chengdu sabato scorso. Gao Fu, direttore del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie, ha affermato che la Cina sta esplorando la possibilità di mescolare diversi sieri anti coronavirus per aumentare l’efficacia di quelli esistenti, “che non è sufficientemente elevata”. Il giorno dopo, Gao ha detto di essere stato “completamente frainteso” e in un’intervista al Global Times, il tabloid in lingua inglese espressione del pensiero del Partito comunista cinese, ha sostenuto che si stesse riferendo alla situazione vaccinale globale. “I gradi di protezione di tutti i vaccini nel mondo è talvolta alta, talvolta bassa”, dice Gao. “Per questo, suggerisco di rivedere il processo di vaccinazione”. In particolare, Gao si riferisce alla possibilità di regolare il dosaggio, rivedere l’intervallo di tempo necessario tra le somministrazioni oppure aumentare il numero stesso di dosi da inoculare.
La risposta a questa domanda non è semplice. Sinopharm afferma che i suoi due sieri avrebbero tassi di efficacia rispettivamente del 79% e del 72,5%. I dati sul Sinovac ballano tra il 50,4% di alcuni studi effettuati in Brasile e l’83,4% di altri studi realizzati in Turchia, ma la sua efficacia reale sarebbe compresa tra il 50 e il 60%. Secondo il Global Times, l’efficacia del Sinovac si alza al 62,3% qualora l’intervallo tra le dosi passi da 14 a 21 giorni. E funzionerebbe anche contro le varianti brasiliane. Il siero di CanSino Biologics è quello che ha attirato maggiore interesse per ora in Europa (è stato adottato per uso di emergenza anche da uno Stato dell’Unione europea, l’Ungheria). L’azienda dichiara un tasso di efficacia del 75%.
Percentuali più basse di alcuni degli altri sieri, in primis il 97% di Pfizer, ma questo non significa che i vaccini cinesi siano pericolosi o sia meglio non assumere nulla piuttosto che uno di loro. Ed è per questo che molti Paesi si sono rivolti proprio a Pechino per ottenere il vaccino, visto anche che a lungo Stati Uniti e Unione europea hanno bloccato le esportazioni. La Cina ha invece puntato da subito sulla diffusione globale dei propri seri, strumento non solo di guadagno economico ma anche di aumento del proprio soft power globale. Decine di Paesi, territori e organizzazioni internazionali hanno importato uno dei sieri provenienti dalla Repubblica popolare. Nelle ultime settimane, la mappa della loro diffusione si è allargata in Medio Oriente: in particolare in Giordania, Libano e Palestina. Tutto ciò è avvenuto in concomitanza di un viaggio del Ministro degli Esteri Wang Yi nell’area.
A oggi Pechino non ha ancora approvato nessun vaccino straniero da usare in territorio cinese. Ed è per questo che tra le dichiarazioni di Gao risulta particolarmente significativa quella sulla possibilità di mescolare diversi vaccini. Già, perché finora le autorità di Pechino avevano sempre criticato la composizione dei sieri occidentali, in particolare per l’utilizzo della tecnologia dell’Rna messaggero (Pfizer e Moderna) o per lo sfruttamento del vettore adenovirus (Johnson&Johnson e AstraZeneca). Funzionamento e composizione molto diversi dai sieri cinesi che sono a virus inattivati, e anche per questo possono venire conservati a temperature più naturali rispetto agli altri. La possibile miscela di vaccini con composizioni diverse può aprire alla possibilità che la Cina importi virus dall’estero. I partner cinesi di BioNTech stanno cercando l’approvazione per utilizzare il loro vaccino nella Repubblica popolare, ma intanto sul South China Morning Post si parla già dell’arrivo di un “rivoluzionario” vaccino mRNA completamente Made in China.
Nel frattempo, la competizione sul vaccino si aggiunge alla lunga lista di controversie tra Cina e India. Già da tempo, Nuova Delhi compete con Pechino per la diffusione dei sieri in Asia. E talvolta ha avuto la meglio, per esempio in Myanmar, dove poco prima del golpe ha esportato decine di milioni di dosi del suo Covishield di Serum. Ulteriore e significativo episodio negli ultimi giorni. La scorsa settimana su eastwest avevamo raccontato il caso del Paraguay, ultimo alleato diplomatico di Taiwan in Sudamerica. In necessità di un vaccino, le autorità di Asunciòn hanno dichiarato di essere state avvicinate dal Governo cinese che aveva promesso l’invio delle dosi necessarie in cambio della rottura dei rapporti con Taipei. Ebbene, in soccorso del Paraguay (e di Taiwan) è arrivata l’India, che ha donato al Paese latinoamericano un primo lotto di centomila dosi di Covaxin della Bharat Biotech. Segnale interessante se si considerano i recenti (non ufficiali) abboccamenti tra Nuova Delhi e Taipei, nonché il rinnovato ruolo dell’India all’interno del Quad.
Tornando al piano interno, le autorità sanitarie cinesi hanno intimato alle autorità locali di interrompere le vaccinazioni obbligatorie e di proseguire solo su base volontaria. Sin dall’inizio la somministrazione dei vaccini in Cina si basa sulla scelta individuale dei cittadini. Ma dopo che la campagna di inoculazione procedeva a rilento, il Governo ha fissato l’obiettivo di vaccinare almeno 560 milioni di persone entro giugno. Al momento, in tutto il Paese sono state inoculate 164,47 milioni di dosi. Per poter raggiungere l’obiettivo, alcune città avevano deciso di rendere obbligatoria la somministrazione. Tra queste la provincia di Hainan (rinomata meta turistica), che aveva stabilito che le persone non vaccinate non avrebbero potuto utilizzare il trasporto pubblico o entrare in luoghi come i ristoranti. Disposizioni cancellate dalle autorità centrali che hanno ribadito il principio della volontarietà da applicare su base nazionale.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Poco più di mille casi e 10 morti. Totali. Numeri che in Italia apparirebbero come una chimera da avere nel giro di qualche ora, a Taiwan sono quelli generali dall’inizio della pandemia da Covid-19. Un successo a dir poco colossale. Eppure, Taipei è finora rimasta fuori dall’Assemblea mondiale della sanità (Ams). La Repubblica popolare cinese, che ritiene Taiwan parte del suo territorio, resta l’unico interlocutore dell’Ufficio Regionale del Pacifico Occidentale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), nonostante di fatto Pechino e Taipei abbiano due Governi e due giurisdizioni differenti. Un tema che potrebbe tornare presto di attualità, dopo che già lo scorso anno diversi Paesi (in primis gli Stati Uniti) si erano esposti per chiedere l’ammissione di Taiwan. Richiesta poi naufragata anche a causa dell’improvviso ritiro dall’Oms da parte di Donald Trump, che aveva accusato l’organizzazione di essere un “fantoccio della Cina”. Ma il vuoto lasciato dal tycoon potrebbe essere riempito da Joe Biden, con conseguente riapertura del caso e potenziali nuove tensioni tra Washington e Pechino.
Ma iniziamo a capire qualcosa in più sulla gestione sanitaria del coronavirus da parte di Taiwan. A differenza di quanto accaduto altrove, il governo di Taipei ha potuto agire in prevenzione e non in reazione di una ampia diffusione dei contagi. Taiwan si è chiusa in modo pressoché ermetico all’esterno ma è rimasta aperta all’interno. Nessun lockdown, nessuna chiusura di attività commerciali e produttive o delle scuole. Dopo un iniziale stop agli eventi che prevedono partecipazioni di massa come concerti e festival, tutto è ripartito come prima già durante l’estate del 2020. Già nei primissimi giorni di gennaio 2020, quando si parlava ancora solo di “strani polmoniti a Wuhan”, negli aeroporti taiwanesi erano stati installati dei termoscanner per i passeggeri provenienti dalla provincia dello Hubei. I confini sono stati presto chiusi per coloro in arrivo dalle aree a rischio, con le operazioni coordinate dal National Health Command Center da cui dipende il Central Epidemic Command Center. Strutture forti con ampie deleghe decisionali concesse dal potere politico ed eredità della traumatica esperienza della Sars nel 2003. Esperienza che, come accaduto in altri virtuosi esempi di contenimento del Covid in Asia orientale (per esempio in Vietnam), ha garantito una prontezza di riflessi (anche culturale) molto più ampia di quella dei Paesi occidentali.
Il Governo ha subito deciso di aumentare la produzione delle mascherine, ottimizzando la distribuzione attraverso un sistema di acquisto nominale che ne garantisce l’acquisto di un numero limitato ogni settimana. Elementi che hanno portato poi anche alla donazione e all’esportazione di mascherine taiwanesi verso diversi Paesi a livello mondiale, Italia compresa. Anche a Taiwan, come in Cina e in Corea del Sud, si è fatto un largo utilizzo degli strumenti tecnologici, in primis i big data, in un sistema di gestione centralizzato per i dati sanitari e di viaggio, che hanno consentito una forte capacità nel contact tracing e nel backward tracing. Quando, a fine gennaio 2021, si è creato un piccolo focolaio originato dall’ospedale di Taoyuan, in breve tempo sono state rintracciate e messe in quarantena circa cinquemila persone, limitando i contagi a 21 unità.
Tra il 2009 e il 2020, Taiwan ha chiesto di partecipare a 199 riunioni tecniche dell’Oms, ma è stata ammessa solo 69 volte, poco più di tre volte su dieci. La scorsa primavera, dopo che Jared Kushner e altri membri dello staff della Casa Bianca avevano indossato mascherine Made in Taiwan, gli Stati Uniti si erano esposti nel tentativo di far ammettere Taiwan all’Ams. Con loro anche Giappone, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Francia, Regno Unito, Germania, Danimarca, Paesi Bassi e Svezia si erano espressi a favore. Il successivo ritiro dall’Oms annunciato da Trump aveva però fatto passare in secondo piano l’argomento, che potrebbe però tornare d’attualità nel prossimo futuro. Joe Biden, come promesso già in campagna elettorale, ha stoppato la fuoriuscita di Washington dall’Oms. L’intenzione del Presidente democratico, come già su diversi altri tavoli multilaterali, è quella di tornare a far sentire il peso degli Stati Uniti. Non a caso, c’è anche chi collega le recenti critiche a Pechino di Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms considerato vicino al Governo cinese, al ritorno sulla scena degli Usa.
La riapertura del caso della partecipazione di Taiwan all’Ams potrebbe causare nuove tensioni tra Washington e Pechino, che sull’isola democratica si sono già scontrati durante il recente summit in Alaska. Ma c’è un caso particolarmente emblematico del complesso triangolo Cina-Usa-Taiwan in materia di contrasto al Covid-19 (e non solo): è quello del Paraguay. Asuncion è l’ultimo alleato diplomatico di Taipei in Sudamerica. Ma il Governo locale ha un problema: l’approvvigionamento dei vaccini. Taiwan non ha ancora un siero autoctono da offrire e gli Stati Uniti hanno il freno tirato sulle esportazioni. Il Governo della Presidente Tsai Ing-wen ha offerto sostegno economico per le importazioni, ma Pechino cerca di sedurre Asuncion promettendo cospicui invii di sieri cinesi in cambio dello “switch” diplomatico, dunque della rottura con Taipei. Come sempre, tanta carne al fuoco per un’isola il cui ruolo è sempre più fondamentale per capire gli equilibri non solo asiatici ma anche globali.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

L’esercito lo ha celebrato per la ricorrenza del “giorno delle forze armate”. Ma sabato 27 marzo 2021, in Myanmar, passerà alla storia come “il giorno della vergogna“. Oltre 90 morti nel giro di 24 ore, tra cui anche molti minorenni. Si tratta del bilancio più drammatico dall’inizio delle proteste contro il golpe militare dello scorso 1° febbraio. Tragico record che periodicamente aumenta, visto che la repressione sempre più violenta del Tatmadaw non sta riuscendo a fermare le manifestazioni.
Secondo le cifre dell’Associazione di assistenza per i prigionieri politici, a martedì 30 marzo il numero totale delle vittime in meno di due mesi è superiore a 500. L’esercito non nasconde quasi più la realtà che è chiara a tutti: i soldati hanno ricevuto l’ordine di sparare per uccidere. In diversi video che circolano sui social si vedono militari che sparano in direzione dei manifestanti anche senza aver subito provocazioni o persino in luoghi nei quali non ci sono proteste. Sempre nella giornata di sabato 27 marzo, le forze armate avrebbero appiccato il fuoco nella municipalità di Pyi Gyi Dagun, nella città di Mandalay, causando un rogo che ha coinvolto circa 60 abitazioni. Chi arrivava per provare a dare una mano a spegnere l’incendio è diventato bersaglio dei proiettili. Un uomo è stato lanciato su una barricata di gomme in fiamme ed è arso vivo. L’ambasciata degli Stati Uniti ha reso noto che ci sono stati degli spari contro l’American Center di Yangon, senza conseguenze.
Tra le vittime del fine settimana, secondo The Irrawaddy, ci sono anche 12 bambini. Sospesa qualsiasi pietà, sospeso qualsiasi diritto. Sulle circa 2600 persone arrestate dall’inizio delle proteste, solo 37 risultano al momento ufficialmente incriminate. Le altre sono trattenute in attesa di conoscere il loro destino. Nel mirino anche la stampa. Due giornalisti sono stati colpiti da proiettili di gomma e poi arrestati durante una manifestazione nella provincia di Kachin.
L’esercito ha iniziato a prendere di mira anche le minoranze etniche. Sono stati effettuati degli attacchi aerei contro degli insediamenti della minoranza Karen nello Stato di Kayin. Circa tremila persone sono scappate oltre il confine con la Thailandia, altre migliaia stanno cercando riparo nelle foreste presenti nell’area. La mossa arriva dopo che il gruppo Karen National Union ha deciso di supportare il Governo ombra istituito dagli esponenti rimasti liberi della Lega nazionale per la democrazia, il partito di Aung San Suu Kyi.
Il Myanmar, come già raccontato da eastwest, ha al suo interno numerose minoranze etniche organizzate in milizie armate. Alcune di esse ora dicono di essere pronte a scendere in campo per combattere l’esercito. Tra queste l’Arakan Army, che opera nello Stato di Kachin. Un suo portavoce ha dichiarato che l’intenzione è quella di unire le forze tra le milizie etniche della regione di unirsi per “proteggere le vite e le proprietà degli oppressi birmani”. I combattimenti tra Arakan Army ed esercito si sono intensificati tra il novembre 2018 e il novembre 2020, causando centinaia di morti e circa duecentomila sfollati. Dopo una tregua il regime aveva deciso di rimuovere la milizia dalla lista delle organizzazioni terroristiche. Sembrava un primo passo verso la distensione, ora invece torna la possibilità di uno scontro.
Non si tratta di un passaggio banale. Le minoranze etniche in Myanmar costituiscono circa un terzo della popolazione e se i vari gruppi riuscissero a mettere da parte le divergenze per schierarsi contro il golpe gli equilibri potrebbero cambiare. Soprattutto se ci fosse una convergenza con lo United Wa State Army e il Kachin Independence Army, due milizie attive in zone lungo il confine con la Cina. Entrambe sono in possesso di armi sofisticate di produzione cinese, incluso anche (nel primo caso) di un sistema di difesa aerea.
L’influenza di Pechino su questi gruppi è da sempre considerata rilevante, tanto da aver causato in passato più di qualche frizione tra l’esercito birmano e il Governo cinese. Un paio di settimane fa, come spiegato da eastwest, dalla Cina era arrivato l’invito a “ristabilire l’ordine” dopo che i manifestanti avevano preso di mira numerose aziende del Dragone presenti in Myanmar. Ordine che non sembra poter garantire il Tatmadaw, soprattutto nel caso di uno scontro su larga scala con le milizie etniche. Osservare i movimenti dello United Wa State Army e del Kachin Independence Army potrebbe dare indizi importanti sulle reali volontà di Pechino. Il portavoce del Ministero degli Esteri Zhao Lijian ha ribadito la sua “preoccupazione” per l’evoluzione degli eventi in Myanmar e ha auspicato che “tutte le parti tengano presente gli interessi fondamentali del popolo birmano, continuino a impegnarsi per allentare le tensioni attraverso il dialogo e le consultazioni” e proseguendo “a portare avanti il processo di transizione democratica nel Paese”. A prima vista può sembrare una dichiarazione in perfetta linea con il dogma cinese di “non interferenza” negli affari interni altrui, ma il riferimento alla “transizione democratica” apre a potenziali interpretazioni.
Intanto, gli Stati Uniti hanno sospeso l’accordo commerciale firmato nel 2013 e mercoledì il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite voterà per tagliare l’accesso della giunta militare ai fondi e alle armi, col possibile deferimento alla Corte penale internazionale. I capi delle forze armate di dodici Paesi, tra cui anche l’Italia, hanno condannato apertamente le violenze.
C’è anche chi sembra invece intenzionato a “intensificare” i rapporti con il Myanmar, a dispetto del golpe e delle violenze. Si tratta della Russia. Sabato scorso, otto Paesi hanno mandato die rappresentanti a Naypyidaw in occasione della giornata delle forze armate: Cina, India, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Laos e Thailandia. Più, appunto la Russia. Con una differenza. Nel caso degli altri Paesi, tutti asiatici, si trattava di funzionari militari. Per Mosca era invece presente il vice Ministro della Difesa Aleksandr Fomin. Non si tratta di un caso. Negli ultimi anni l’esercito birmano ha insistito sulla cooperazione in materia militare con la Russia, anche per ridurre la dipendenza in tal senso dalla Cina. Tra le numerose visite reciproche ad alto livello, sono stati firmati diversi accordi per la fornitura di armi. Lo scorso gennaio, poco prima del golpe, i due Paesi hanno sottoscritto un accordo per la fornitura dei missili terra aria Pantsir-S1, dei droni Orlan-10E e di radar. Il mantenimento delle relazioni “non significa assolutamente che approviamo gli eventi tragici registrati nel Paese”, ha dichiarato Dmitry Peskov, portavoce di Vladimir Putin. Ma nel puzzle birmano non vanno ascoltate tanto le parole, quanto guardati i movimenti dei diversi tasselli.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Ristabilire l’equilibrio quando ci si trova su un piano inclinato non è impresa semplice. Soprattutto quando su quel piano inclinato ci sono la principale potenza globale e la sua prima (possibile) contendente.
Stati Uniti e Cina hanno riavviato i canali diplomatici con l’incontro 2+2 andato in scena nei giorni scorsi in Alaska. Il segretario di Stato Antony Blinken e il consigliere per la Sicurezza nazionale Jake Sullivan da parte statunitense, il Ministro degli Esteri Wang Yi e il direttore dell’ufficio della commissione centrale degli Affari esteri Yang Jiechi, artefice della diplomazia targata Xi Jinping, da parte cinese. Questo il quartetto che si è ritrovato nella (rigida) vigilia di primavera di Anchorage, a oltre un anno e mezzo di distanza dall’ultimo incontro di tale livello, quando il volto della politica estera a stelle e strisce era ancora Mike Pompeo.
In mezzo è successo di tutto, tra la pandemia, il “chinese virus” di Donald Trump, le sanzioni e l’apertura di molteplici dossier in una contesa che dalla sfera commerciale ha invaso da tempo anche quelle tecnologica, mediatica, strategica e quasi ideologica. Dopo l’Alaska, potrebbe succedere ancora altrettanto. Partiamo da un presupposto: il cosiddetto “restart summit” non ha resettato i rapporti. Troppo forte l’impatto di Trump, troppo inclinato il piano per riportarlo in orizzontale. Le due parti, che non avevano nemmeno concordato sulla definizione di “dialogo strategico” (proposta da Pechino e disconosciuta da Washington), hanno esordito con accuse reciproche a favore di telecamera. Yang ha preso il proscenio, parlando per 16 minuti invece dei tradizionali due della conferenza stampa iniziale. E da lui sono arrivate alcune frasi che fotografano il sentimento cinese attuale nei confronti degli Usa. Riassumibili in questa: “Gli Stati Uniti non possono permettersi di parlare alla Cina in tono condiscendente o da una posizione di forza” e “non possono darci lezioni come se ci fossero superiori”.
Ecco la chiave. La Cina di Xi Jinping non nasconde più la sua forza, come faceva quella di Deng Xiaoping. La Cina di Xi è ambiziosa e non fa nulla per celarlo, sin dal lancio della Belt and Road Initiative nel 2013. L’offensiva trumpiana ha rafforzato il nazionalismo interno e ha velocizzato il processo di estroversione cinese, accompagnato dal perseguimento dell’autosufficienza tecnologica e da tutta una serie di azioni volte a limitare gli effetti delle turbolenze esterne sul fronte interno, in ossequio a quella doppia circolazione che il Presidente Xi ha presentato durante la visita nel Guangdong anticipatoria del V Plenum dello scorso ottobre.
La Cina esige una relazione tra pari, basata sul “dogma” della non interferenza, a protezione dei delicati nodi interni tra cui Pechino, oltre Hong Kong, Tibet e Xinjiang, annovera anche Taiwan. Prerequisito difficile da accettare anche per gli Usa di Joe Biden. Con questi presupposti era piuttosto scontato che il summit non producesse grandi risultati, ma che semmai collezionasse una serie di linee rosse da non oltrepassare a vicenda. La coppia cinese ha citato quei quattro capitoli di cui sopra, mentre il duo americano ha citato, tra le altre cose, il rispetto dei diritti umani, i cyberattacchi contro gli Stati Uniti e le misure di coercizione economica utilizzati contro gli alleati, in primis l’Australia.
È prevedibile che le tensioni proseguiranno su tutti i dossier citati dalla Cina. Per Trump i diritti umani erano soprattutto uno strumento da utilizzare sul tavolo negoziale, per Biden invece sono un argomento per il quale passa la credibilità della sua retorica del riavvio delle alleanze. Non a caso, proprio alla vigilia del summit, il neo Presidente americano ha comminato le sue prime sanzioni contro ufficiali cinesi sul tema di Hong Kong, per poi passare, in contemporanea a Regno Unito e Unione europea, allo Xinjiang. Presto potrebbe tornare d’attualità anche il tema del Tibet, visto che si è aperta la lotta per la successione del Dalai Lama, che il Partito comunista vuole controllare. Ma il potenziale flashpoint più rischioso resta Taiwan. L’amministrazione Biden ha ribadito la sua aderenza al principio dell’unica Cina, ma allo stesso tempo continua a sostenere l’indipendenza de facto di Taipei.
C’è però spazio anche per una possibile collaborazione in alcuni settori, come emerso durante i meno bellicosi e più concreti colloqui a porte chiuse. A partire dalla crisi climatica, citata esplicitamente dal report post vertice di Xinhua. Anche qui, però, le versioni differiscono. L’agenzia di stampa cinese sostiene sia stato predisposto un gruppo di lavoro comune, elemento smentito ad Axios da un portavoce del Dipartimento di Stato americano. Trovati punti di contatto anche sull’inoculazione dei vaccini anti Covid-19 ai rispettivi diplomatici presenti nei due Paesi. Potrebbe essere messo un freno alla stagione delle espulsioni reciproche, culminata nelle chiusure dei consolati di Houston e Chengdu, ma anche in quelle di giornalisti dei rispettivi outlet media. Le due parti hanno concordato un abbassamento dei toni sia tra esponenti politici e diplomatici. In tal senso continuerà a giocare un ruolo fondamentale l’ambasciatore cinese Cui Tiankai, ben al di là dei canonici termini di mandato ma considerato pedina fondamentale da Pechino in terra statunitense. Il report di Xinhua cita anche un possibile miglioramento del coordinamento bilaterale in alcune sedi internazionali, tra cui per esempio il G20 e l’APEC.
Ma, in realtà, se il dialogo sarà più civile questo non significa che ci sia una convergenza di vedute. La possibile cooperazione su alcuni dossier di politica estera, in primis la Corea del Nord, è offuscata dalla ancora confusa linea Biden su Pyongyang e, soprattutto, dai movimenti asiatici dell’amministrazione democratica. Lo dimostra il tour di Blinken e del segretario alla Difesa Lloyd Austin a Tokyo e Seul, con il secondo che ha proseguito la sua permanenza asiatica anche a Nuova Delhi. I risultati sono stati ambivalenti: dichiarazioni esplicite sulla Cina dal Giappone, profilo molto più basso dalla Corea del Sud. Ma il messaggio, se sommato al precedente summit virtuale Quad, è chiaro: Washington vuole utilizzare le partnership asiatiche per arginare la Cina, che legge questo tentativo come una riesumazione delle sfere d’influenza dei tempi della Guerra fredda. Non a caso, a poche ore di distanza dal vertice in Alaska, Wang Yi ha ricevuto a Guilin l’omologo russo Sergej Lavrov. Il messaggio, che comprende anche un passaggio tutt’altro che trascurabile sul possibile sganciamento dal dollaro per mettersi al riparo dalle sanzioni americane, è chiaro: la Cina non starà a guardare le mosse di Biden.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Il punto di non ritorno è vicino, forse è già stato superato. In Myanmar le proteste contro il golpe militare dello scorso 1° febbraio proseguono senza sosta, così come prosegue e, anzi, si intensifica la repressione da parte delle forze di sicurezza. Mentre la comunità internazionale condanna (per ora soprattutto a parole) le violenze, la Cina chiede di ristabilire l’ordine dopo che suoi cittadini e fabbriche sono stati presi di mira.
Nella sola giornata di domenica 14 marzo, la giornata più sanguinosa dall’inizio delle proteste, ci sarebbero stati 59 morti (tra cui un agente di polizia) e 129 feriti. Numeri drammatici in continuo aggiornamento (lunedì 15 marzo si sarebbero registrati un’altra ventina di decessi) e che i medici temono in realtà siano molto più alti. Stando ai dati dell’ufficio diritti umani dell’Onu, in un mese mezzo le vittime sarebbero 138 (ma con un conteggio al ribasso dei morti di domenica, che per le Nazioni Unite sono 38), tra i quali anche donne e bambini.
Secondo l’Associazione per l’assistenza prigionieri politici della Birmania i manifestanti politici uccisi sarebbero almeno 191 con oltre duemila arresti. La giunta militare ha imposto la legge marziale in sei distretti di Yangon (Hlaing Thayar, Shwepyithar, North Dagon, North Okkalapa, South Dagon e Dagon Seikkan), in cinque distretti di Mandalay (Aung Myay Tharzan, Chan Aye Tharzan, Chan Mya Thazi, Mahar Aung Myay e Pyi Gyi Takhoon) e in altri punti del Paese. Attivisti e organizzazioni non governative, tra cui Amnesty International, accusano l’esercito di utilizzare “armi da battaglia” contro chi scende per strada a manifestare. Dalla zona industriale di Yangon è cominciato un piccolo esodo di abitanti che cercano di lasciare la zona. Secondo il quotidiano birmano The Irrawaddy, la polizia ha risposto lanciando lacrimogeni e sparando sul traffico di motociclette e tuk-tuk.
Alla repressione fisica si somma quella digitale, con i ripetuti blocchi di Internet e dei social media, utilizzati dagli attivisti per organizzare le proteste. A causa della mancanza di connessione è stata anche rinviata l’udienza in tribunale per Aung San Suu Kyi. Il premio Nobel per la Pace 1991 ed ex consigliere di Stato tornerà in aula il prossimo 24 marzo per rispondere di quattro accuse: importazione illegale di walkie-talkie, mancato rispetto delle restrizioni legate al coronavirus, violazione di una legge sulle telecomunicazioni e incitazioni ai disordini.
Gli Stati Uniti continuano a denunciare la violenza dei militari. Il segretario di Stato Antony Blinken, in viaggio a Tokyo, ha accusato il Tatmadaw di “reprimere brutalmente i manifestanti pacifici” e di stare cercando di “ribaltare i risultati di un’elezione democratica”. Proprio in concomitanza della visita del diplomatico Usa, anche il Giappone sta pensando di rompere gli indugi e condannare in maniera esplicita l’operato dell’esercito. Finora il Governo nipponico è stato piuttosto timido sull’argomento, così come molti altri vicini asiatici, che hanno in maggioranza applicato un principio di “non interferenza” volto anche a mantenere i (numerosi) interessi economici e geopolitici in Myanmar.
L’aumento delle violenze sta rendendo però questa linea sempre più difficile da mantenere. La Corea del Sud ha annunciato la sospensione della cooperazione in materia di difesa e il divieto all’esportazione di armi verso Naypyidaw e sempre più aziende internazionali presenti sul territorio birmano stanno rivedendo i loro accordi e la loro produzione. Per restare alle realtà nipponiche, il produttore di birra Kirin Holdings Co ha annunciato dopo sei anni la fine della collaborazione con la Myanma Economic Holdings, controllata dai militari. Suzuki ha temporaneamente fermato la produzione nei due stabilimenti locali, archiviando per ora la costruzione di un terzo. Anche Toyota ha congelato l’apertura di uno stabilimento a Yangon, inizialmente prevista per marzo. In fase di riflessione Mitsubishi, che a dicembre ha concluso un accordo con la Myanma Railways.
Gli ultimi avvenimenti stanno invece spingendo la Cina ad assumere una linea diversa. Le proteste contro il golpe stanno assumendo sempre più una sfumatura anti Pechino. Nello scorso fine settimana sono state attaccate 32 fabbriche cinesi presenti in Myanmar, in particolare nell’area di Yangon. Alcune di esse sono state date alle fiamme, causando danni pari a circa 37 milioni di dollari. Il Governo di Taipei ha chiesto alle proprie aziende di issare la bandiera taiwanese per evitare rappresaglie. Durante gli attacchi, condotti da un gruppo di qualche decina di motociclisti armati di sbarre di ferro e taniche di benzina, sono rimasti feriti anche due lavoratori cinesi. Episodi che hanno spinto il portavoce del Ministero degli Esteri, Zhao Lijian, a sollecitare le autorità birmane affinché adottino “misure urgenti volte a porre fine agli attacchi e a consegnare alla giustizia i responsabili delle azioni”. L’Ambasciata di Pechino in Myanmar ha ricordato che gli investimenti nell’industria tessile hanno creato quasi 400mila posti di lavoro.
A torto o a ragione, come già raccontato da eastwest, tra i manifestanti c’è la convinzione che il Governo cinese abbia avuto in qualche modo un ruolo dietro il golpe, anche se sono state date alle fiamme anche due stabilimenti di aziende giapponesi. Questo nonostante Pechino avesse rapporti probabilmente migliori con la Lega nazionale per la democrazia di Aung San Suu Kyi (che ha un rapporto ottimo con Xi Jinping) che non con il Tatmadaw, con il quale è spesso entrata in rotta di collisione sul presunto sostegno alle milizie etniche. La Cina ha sempre mantenuto interessi importanti in Birmania. Il China-Myanmar Economic Corridor (CMEC) dovrebbe connettere lo Yunnan al golfo del Bengala (e dunque all’Oceano Indiano) attraverso il porto di Kyaukpyu, aggirando lo stretto di Malacca. Ma 29 dei 38 progetti in ambito CMEC sono ancora da approvare. Inoltre, quasi la metà delle importazioni cinesi di terbio e disprosio (terre rare con alto valore atomico) provengono proprio dal Myanmar.
L’avvio della transizione democratica era stata decisa dai militari anche per diversificare i rapporti commerciali e diplomatici e ridurre la dipendenza da Pechino. Lo dimostrano anche gli eccellenti rapporti costruiti nel tempo con Russia (soprattutto in materia militare) e India (poche settimane fa è stato acquistato un siero anti Covid di Nuova Delhi per far partire la campagna vaccinale, bloccando la distribuzione di quello cinese). Con un nuovo isolamento, però, il Myanmar potrebbe essere costretto a riavvicinarsi alla Cina, il cui interesse è soprattutto quello di stabilità. E ordine. Proprio il contrario di quanto sta accadendo. “La priorità assoluta è impedire il verificarsi di nuovi sanguinosi conflitti e ottenere un raffreddamento della situazione il prima possibile”, ha detto Zhao. A Naypyidaw il messaggio potrebbe essere letto come un via libera a ristabilire l’ordine (dunque, reprimere le proteste) il più presto possibile. Con qualsiasi mezzo.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

L’anno scorso era maggio inoltrato. Stavolta si è tornati al canonico inizio di marzo. Dopo aver contenuto il Covid e aver fatto ripartire l’economia prima degli altri, la Cina torna alla normale calendarizzazione per il lianghui, le cosiddette “due sessioni“, il suo principale appuntamento legislativo durante il quale si riuniscono la Conferenza Politica Consultiva del Popolo cinese e l’Assemblea Nazionale del Popolo. La prima, le cui riunioni sono cominciate giovedì 4 marzo, è composta da circa 2200 delegati in rappresentanza di varie componenti della società cinese, compresi partiti non comunisti, associazioni di categoria e minoranze etniche: il suo compito è quello di formulare proposte da sottoporre al Governo in varie materie, a partire da quelle economiche. La seconda, che ha preso il via venerdì 5 marzo, è formata da circa tremila delegati e formula, vota e approva le leggi. Tutto (o quasi) è in realtà stato messo a punto nei mesi precedenti, in particolare durante il V Plenum dello scorso ottobre. Ma è in questi dieci giorni che il Partito comunista presenta alla Cina i suoi piani e la Cina presenta i suoi piani al mondo.
Le “due sessioni” del 2021 sono particolarmente importanti perché Pechino svela i dettagli del suo 14esimo piano quinquennale, con scadenza ufficiale 2025, nonché la sua visione quindicennale per il 2035, potenziale orizzonte politico individuato dal Presidente Xi Jinping nonché punto a metà strada tra il recente raggiungimento dell’obiettivo dell’eliminazione della povertà assoluta e il centenario della Repubblica popolare del 2049. La roadmap del Partito è chiara: leadership economica entro il 2035, completamento della “modernizzazione socialista” e realizzazione di una società “armoniosa” entro il 2049.
Per centrare gli obiettivi la prima parola chiave che emerge dalle “due sessioni” è quella di “prosperità“. Presentando il tradizionale rapporto sul lavoro del Governo, il premier Li Keqiang ha fissato in “oltre il 6%” il target di crescita per il 2021. Anche qui un ritorno al passato dopo che lo scorso anno, a causa della pandemia, si era deciso di non fare numeri. La cifra individuata è in realtà al ribasso rispetto alle previsioni degli analisti che stimano una possibile crescita tra l’8 e il 9%. La novità è che manca invece un target di crescita quinquennale, segno della volontà di avere maggiore flessibilità di fronte alle possibili turbolenze interne e soprattutto esterne. In generale, lo Stato, e dunque il Partito, avrà un ruolo ancora più importante nell’economia. Lo dimostrano il recente caso della mancata IPO di Ant Group, la nuova legge sulla protezione delle informazioni personali (che prevede un maggiore controllo dei colossi tecnologici privati) e lo sviluppo della moneta digitale che sottrarrà spazio alle app di pagamento che dominano il mercato cinese da anni.
L’obiettivo è anche quello di rendere la crescita più sostenibile sul piano economico, con un abbassamento del deficit al 3,2% del Pil, e più omogenea. Lo storico problema della diseguaglianze tra regioni costiere e province interne e più in generale tra centri urbani e campagne è ancora lungi dall’essere stato risolto. Il Governo dichiara di voler creare oltre 11 milioni di nuovi posti di lavoro urbani ma allo stesso tempo pare intenzionato a riformare l’hukou, un sistema di residenza che regola i diritti e l’accesso ai servizi tradizionalmente penalizzante per i migranti interni, sfruttati per lo sviluppo dei vari hub manifatturieri ma di fatto cittadini di serie B. La riforma dovrebbe sveltire e facilitare il raggiungimento dei requisiti per ottenere la residenza. Previsti anche dei tagli alle tasse sugli immobili e misure a sostegno di acquisto e affitto di appartamenti e case, soprattutto per i più giovani. L’intenzione è anche quella di favorire maggiori nascite, visto che all’orizzonte si intravede una crisi demografica che costringerà tra le altre cose ad aumentare in modo graduale l’età pensionabile.
La “prosperità” passa anche attraverso lo sviluppo rurale, altro tema ricorrente durante le “due sessioni”, e uno sviluppo più “green“. La Cina ha annunciato di voler raggiungere la neutralità carbonica entro il 2060. L’obiettivo del prossimo piano quinquennale è di mantenere il ritmo di riduzione delle emissioni (-18,8%) raggiunto nel precedente quinquennio e di ridurre l’intensità energetica del 13,5%. Sarà aumentata la capacità di produzione di energia nucleare, ma l’utilizzo di combustibili fossili dovrebbe crescere ancora nei prossimi anni.
Come già chiaro da tempo, il traino della crescita cinese è però individuato nel settore tecnologico, in cui nelle “due sessioni” si è ribadito di voler raggiungere l’autosufficienza. Capitolo fondamentale della contesa con gli Stati Uniti, la Cina sta provando da tempo a rendersi autonoma in materia per mettersi al riparo dalle intemperie esterne (come il ban all’export di semiconduttori verso i player cinesi introdotto dall’amministrazione Trump). La spesa in ricerca e sviluppo aumenterà di oltre il 7% ogni anno, in particolare in sette aree strategiche: intelligenza artificiale, informazione quantistica, neuroscienze, biotecnologia, medicina clinica, ricerca spaziale, esplorazione polare, semiconduttori. Da questo elenco emergono attuali punti di forza e punti di debolezza di Pechino, oltre a precisi obiettivi geopolitici. L’attuale vantaggio sulle terre rare dovrà essere mantenuto attraverso lo sviluppo della Polar Silk Road, la rotta polare della Via della Seta che può dare accesso a enormi risorse minerali ed energetiche. Sui semiconduttori invece il ritardo verso i competitor taiwanesi, “arruolati” da Washington, è ancora lontano dall’essere colmato. In linea con la “doppia circolazione” teorizzata da Xi, la Cina vuole rafforzare la produzione interna avanzata mantenendo però aperta la porta ai contributi esterni, ridurre la propria dipendenza dalle esportazioni e sviluppare in senso qualitativo i consumi.
Tra gli altri punti fondamentali emersi durante le riunioni di questi giorni l’aumento delle spese militari (+6,8% contro il +6,6% del 2020). Una crescita che accelera in modo minimo (+0,2%) ma che, se unita alla riforma della guardia costiera, basta per allarmare i vicini asiatici, viste le tante contese aperte o deflagrate durante gli scorsi mesi: Taiwan e Mar Cinese meridionale, ovviamente, ma anche Senkaku/Diaoyu e il turbolento confine sinoindiano. Li ha insistito sul punto di “prontezza a combattere” per l’Esercito popolare di liberazione, anche perché dalle prime mosse di Joe Biden si intuisce che il principale teatro di contesa globale sarà proprio quello dell’Indo-Pacifico.
Ma per diventare più forte la Cina deve innanzitutto “sistemare” le questioni interne. A partire da Hong Kong. Durante il lianghui dello scorso anno era stata annunciata la legge sulla sicurezza nazionale che ha di fatto messo fine al modello “un Paese, due sistemi“. Stavolta verrà introdotta una riforma del sistema elettorale di Hong Kong che rischia di escludere completamente l’opposizione democratica dalla vita politica dell’ex colonia britannica. Il capo esecutivo Carrie Lam ha tra l’altro aperto a un possibile nuovo rinvio delle elezioni inizialmente previste per settembre 2020 e poi fissate a settembre 2021. Il processo di normalizzazione e di integrazione di Hong Kong nel sistema cinese verrà portato a compimento.
Quanto accade a Hong Kong porterà inevitabilmente a qualche nuova frizione con l’Occidente, in particolare con gli Stati Uniti, è ormai chiaro, come dimostrato dalla sua diplomazia del vaccino, che Pechino punta tutto sulla cooperazione con il sud del mondo e con i Paesi in via di sviluppo tra Asia, Africa e America Latina. Linea confermata anche dal discorso programmatico di domenica scorsa del Ministro degli Esteri Wang Yi. La ratifica dell’accordo sulla Regional Comprehensive Economic Partnership (il mega accordo commerciale che include anche Giappone, Corea del sud, Australia, Nuova Zelanda e i 10 Paesi Asean) ribadisce ancora una volta: la Cina vuole essere pronta a fare (quasi) da sola, o meglio senza Occidente, ma continuerà a proporsi come alfiere del multilateralismo.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

“Il vaccino cinese è il mio preferito”. Parola di Viktor Orbán. Il Primo Ministro ungherese è il primo leader politico di un Paese dell’Unione europea a farsi iniettare il siero della Sinopharm, uno dei quattro produttori Made in China di vaccini anti Covid-19.
Budapest ha già ricevuto 550mila dosi e ne avrà altre 4,5 milioni entro maggio. Potrebbe presto non essere l’unico, visto che il Presidente Xi Jinping ne ha parlato in una telefonata con l’omologo della Polonia Andrzej Duda. Nel mondo sono già 45 i Paesi che hanno ricevuto e acquistato le dosi da Pechino. È successo a tutte le latitudini, dal Sud-est asiatico al Medio Oriente, dall’Africa all’America Latina. E questo nonostante gli studi sull’efficacia sono meno dettagliati rispetto ai vaccini sviluppati altrove. Ma la lentezza della distribuzione dei sieri occidentali, nonché i blocchi alle esportazioni, ne stanno aiutando la diffusione a livello globale, soprattutto in Paesi che hanno urgenza di approvvigionamento.
Quando il coronavirus ha smesso di essere un’emergenza solo per Wuhan, il Governo cinese ha iniziato a esportare mascherine, tute protettive e respiratori in tutto il mondo, Italia compresa. Ora sta facendo lo stesso con i suoi sieri anti Covid. Tutto rientra nella rimodulazione in chiave sanitaria della Via della Seta e nello sviluppo della cosiddetta “diplomazia del vaccino“, che nei piani di Pechino è destinata da una parte a sostenere l’export e dall’altra a garantire riflessi positivi sul suo soft power.
Come già accaduto con le mascherine, Pechino ha saputo agire più rapidamente degli altri. I vaccini autoctoni approvati in Cina sono quattro: due prodotti da Sinopharm, uno da Sinovac e uno da CanSinoBIO. Nonostante la loro efficacia sia in generale più bassa rispetto ai vari Pfizer/BioNTech e Johnson&Johnson, i vaccini cinesi hanno dalla loro un grande vantaggio: la possibilità di essere conservati a temperature da freezer normali. I produttori cinesi affermano di poter garantire almeno 2,6 miliardi di dosi nel 2021. E per mesi le imprese statali e le società private, con il sostegno del Governo, hanno messo a punto una catena di approvvigionamento che rende i vaccini cinesi accessibili in tutto il mondo. Lo schema è quasi sempre lo stesso: un primo lotto di sieri arriva in donazione, poi si passa all’esportazione vera e propria.
Partiamo dall’Asia. Le Filippine hanno ricevuto 600mila dosi del vaccino di Sinovac e Rodrigo Duterte si è presentato all’aeroporto di Manila per accogliere la consegna. Il Presidente filippino, che durante il suo mandato ha messo in discussione la storica alleanza con gli Stati Uniti, ha minacciato ancora una volta di stracciare il Visiting Force Agreement (il trattato che regola la presenza di truppe e basi americane nel Paese del Pacifico) se Washington non dovesse inviare “venti milioni di vaccini”. Prima delle Filippine si era realtà mossa l’Indonesia, visto che già a gennaio il Presidente Joko Widodo si era fatto inoculare il siero di Sinovac, distribuito anche in Malaysia e Thailandia. Brunei, Cambogia e Laos hanno ricevuto il vaccino di Sinopharm, così come due Paesi che rientrano nella tradizionale sfera d’influenza indiana: Nepal e Sri Lanka. Nuova Delhi ha segnato però un suo punto a favore in Myanmar, quando poco prima del golpe militare ha venduto 30 milioni di dosi del vaccino di Serum a Naypyidaw (supporto confermato anche in seguito), con il Governo birmano che ha stoppato la distribuzione di quello cinese.
I sieri cinesi stanno avendo una forte distribuzione anche in Medio Oriente, dove sono stati acquistati da Emirati Arabi Uniti, Iraq e Bahrein. Pechino punta molto anche sull’Africa. Al momento sono state fornite dosi a Guinea Equatoriale, Zimbabwe, Sierra Leone, Egitto e Marocco, ma il Ministro degli Esteri Wang Yi ha dichiarato che saranno coinvolti nei rifornimenti anche altri 16 Paesi del continente. Lo snodo principale per la distribuzione in Africa sarà Addis Abeba, capitale dell’Etiopia dove tra l’altro le imprese cinesi hanno partecipato alla costruzione del quartier generale dell’Unione africana, grazie anche a una cooperazione tra Alibaba Group Holding ed Ethiopian Airlines. In Uganda, dove sono arrivate 4mila dosi destinate al solo utilizzo di cittadini cinesi, il Ministro della Sanità ha smentito che il presidente Yoweri Museveni abbia ricevuto il vaccino.
La distribuzione arriva anche in America Latina, talvolta anche con modalità poco trasparenti. Un rapporto del Governo peruviano sostiene che l’ex Presidente Martin Vizcarra e altre 500 persone avrebbero ricevuto in gran segreto il siero prima che lo stesso fosse approvato dalle autorità locali. Il Cile, che ha la migliore performance di vaccinazioni nell’area, ha adottato come primo vaccino il CoronaVac di Sinovac. La Bolivia riceverà mezzo milione di dosi di quello Sinopham. Persino il Brasile ha dato il via libera al vaccino Sinovac, nonostante l’iniziale opposizione del Presidente Jair Bolsonaro.
La chiave utilizzata da Pechino sin dall’inizio è quella della “corsia preferenziale” e del multilateralismo. Sui media cinesi appaiono da diverso tempo molti articoli che criticano il “nazionalismo vaccinale” degli Stati Uniti e dell’Occidente, sottolineando al contrario la “responsabilità” di Pechino nel distribuire i suoi sieri senza nessuna preclusione. Un’opportunità geopolitica importante per Xi, che, come ha dimostrato nel suo recente discorso di Davos, tiene molto ad alimentare l’immagine di “potenza responsabile” della Cina e soprattutto di porla al centro della cooperazione sud-sud. Non dimentichiamo che, nonostante il recente annuncio sull’eliminazione della povertà assoluta, ufficialmente Pechino considera se stesso ancora un Paese in via di sviluppo. Etichetta utile a mantenere stretto il legame con diversi Stati, in primis quelli africani, fondamentali nelle varie votazioni presso gli organismi internazionali.
Ma anche in Europa c’è chi inizia ad aprire le porte ai vaccini cinesi. Oltre all’Ungheria e a, forse, la Polonia, il siero di Sinopharm è già distribuito anche in Serbia. E anche in altri Paesi, compresi Germania e Italia, c’è chi chiede di non escludere a priori la loro adozione. Eppure, all’interno, la campagna vaccinale cinese procede a rilento. Al momento ha ricevuto la somministrazione meno del 4% della popolazione, contro il circa 7% di quella europea e il 22% di quella statunitense. Dato che ha diverse spiegazioni, a partire chiaramente dall’enorme numero di abitanti della Cina. Può avere contribuito il focus del Governo sull’esportazione del vaccino, resa possibile anche dal fatto che a livello interno i contagi (a parte qualche focolaio locale) sono sempre rimasti sotto controllo sin dalla scorsa primavera. Ci sono poi da considerare i limiti di età. I vaccini prodotti da Sinopharm e Sinovac sono raccomandati solo per le persone in buona salute di età compresa tra i 18 e i 59 anni. E secondo diversi sondaggi c’è anche chi non vuole partecipare al ciclo vaccinale per paura degli effetti collaterali. La Cina manda i suoi vaccini in giro per il mondo ma sul piano interno potrebbe non raggiungere l’immunità di gregge fino al 2022 inoltrato.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

“Se si aprono le finestre per fare entrare aria fresca, è necessario aspettarsi che entrino anche alcune mosche”. Parola di Deng Xiaoping. La celebre citazione del “piccolo timoniere” della Repubblica popolare, successore di Mao Zedong, viene considerata alla base dell’approccio cinese al mondo di Internet.
In Cina, intorno alla Rete è stata costruita negli anni una grande muraglia virtuale, la cosiddetta “Great Firewall“. Obiettivo: evitare il ronzio di idee ostili o contrarie al Partito comunista e “garantire la sicurezza nazionale”, proteggendo gli utenti cinesi dalle influenze esterne. Il tutto creando un ecosistema autoctono e autosufficiente di siti, app e servizi, aggirabile con l’utilizzo di vpn la cui gradazione di libertà di movimento viene manovrata dalle autorità di volta in volta. Di recente, il modello cinese sembra sempre più appetibile anche in altri Paesi.
Con la pandemia da coronavirus si sono accentuate tendenze autoritarie in Asia, in particolare nel Sud-est. L’onda lunga delle proteste di Hong Kong del 2019 è arrivata negli scorsi mesi in Thailandia e in Indonesia. Poi in Myanmar, dopo il golpe militare dello scorso 1° febbraio. Le motivazioni e gli obiettivi delle proteste sono diverse, ma alla base c’è una comune rivendicazione giovanile di maggiore democrazia e libertà. Ambizioni che passano anche attraverso il web, i social network e gli hashtag come #MilkTeaAlliance, che unisce idealmente gli attivisti dei diversi Paesi dell’area.
Con l’aumento generale di accesso alla Rete, sono in aumento anche le limitazioni delle libertà digitali. Anche dove le proteste non si sono ancora diffuse, proprio con l’obiettivo di prevenire che il ronzio delle “mosche” pro democrazia possa farsi sentire. Succede per esempio in Cambogia, dove l’esecutivo ha emesso nei giorni scorsi un decreto che istituisce un protocollo Internet per il controllo e il monitoraggio del traffico online. Tutte le reti dovranno collegarsi a un gateway al quale dovranno fornire moduli compilati con identità e generalità degli utenti. Il mancato allacciamento al gateway, che dovrà avvenire entro un anno, potrebbe comportare la sospensione delle licenze operative ai fornitori di servizi e persino il blocco dei conti bancari. L’intenzione annunciata è quella di “prevenire e disconnettere tutte le connessioni di rete che minacciano sicurezza, ordine sociale, moralità, tradizioni e costumi” cambogiani. L’operatore del gateway dovrà aggiornare le autorità sul traffico con report regolari. Secondo il Centro cambogiano per i diritti umani la nuova legge avrà ripercussioni non solo sulla protezione dei dati e la privacy, ma anche sulla libertà di parola.
Il nuovo sistema cambogiano ha subito portato a dei paragoni con la Great Firewall cinese. Phnom Penh appare da tempo sempre più integrata negli ingranaggi del Dragone. Basti pensare al viaggio del Primo Ministro Hun Sen a Pechino a inizio febbraio 2020, unico leader straniero a compiere un simile gesto nelle primissime fasi della pandemia. La presenza dei progetti della Belt and Road hanno cambiato il volto di diverse aree della Cambogia. La cooperazione è profonda anche sul piano sanitario: Pechino ha da poco donato al vicino un milione di dosi del suo vaccino di Sinopharm. Collaborazione anche in campo militare, nonostante l’annullamento delle esercitazioni congiunte Golden Dragon, in programma tra il 13 e il 27 marzo, per i rischi legati al Covid (anche se c’è chi ritiene che possa anche essere un segnale di disponibilità al dialogo con l’amministrazione Biden). Da tempo si rincorrono voci, ufficialmente smentite, sull’utilizzo dei porti cambogiani da parte di mezzi navali militari dell’Esercito popolare di liberazione.
Hun Sen è al potere da 36 anni, il che lo rende uno dei leader mondiali più longevi. La mossa sembra una precauzione di fronte al diffondersi delle proteste nei Paesi limitrofi. L’esposizione dei giovani cambogiani alle rivendicazioni dei coetanei stranieri è aumentata negli ultimi anni, visto che tra il 2014 e il 2020 gli internauti sono passati da cinque a oltre venti milioni.
Fenomeno comune al Vietnam, dove lo scorso anno Facebook ha superato i 60 milioni di utenti. Anche qui il Governo, impegnato in una campagna di repressione del dissenso che ha portato in carcere oltre a diversi rivali politici dei leader anche attivisti e giornalisti, ha reagito con una stretta sul web. In particolare sui social media, costretti a sottoscrivere un accordo per la rimozione dei contenuti ritenuti sovversivi. Dopo l’accordo, Facebook avrebbe cancellato il 95% dei post segnalati dalle autorità, YouTube il 90%.
Laddove l’espressione del dissenso è più evidente, più forte è anche la repressione. Per esempio in Thailandia, dove sono state approvate nuove leggi per colpire chi critica online il Governo e la monarchia. Oppure in Myanmar, dove il Tatmadaw ha bloccato a intermittenza l’accesso a Internet dall’inizio della disobbedienza civile e delle manifestazioni contro il golpe militare e l’arresto dei leader democratici tra cui Aung San Suu Kyi.
Lo stesso accade in India, dove le autorità hanno più volte limitato la navigazione in alcune aree di Nuova Delhi (e non solo) per rispondere alle proteste di massa dei contadini contro la riforma agraria del Primo Ministro Narendra Modi. Nel mirino dei Governi, per esempio quello di Bangkok, sono finite anche le app di messaggistica come Telegram. Ma le giovani generazioni continuano a trovare nuovi strumenti per scambiarsi opinioni e organizzare proteste e manifestazioni. Per esempio Signal, che garantisce livelli di privacy più alti delle concorrenti, oppure Bidgefy, dove si possono mandare e ricevere messaggi anche offline. Regimi militari e governi autoritari già minacciati dalle proteste reagiscono con vecchie ricette repressive. Chi invece per il momento vuole prevenirle pensa a modelli più sofisticati di controllo del mondo digitale, come quello cinese. In ogni caso, scacciare il “ronzio” non sarà un esercizio indolore.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Si allargano le proteste, si allarga la repressione. Il Myanmar rischia un ritorno al passato mentre l’esercito prova ad arginare la sollevazione popolare contro il golpe militare dello scorso 1° febbraio. Dai cannoni d’acqua si è passati ai proiettili, Internet è quasi completamente bloccato e, come accadeva tre decenni fa, bande criminali vengono utilizzate per scoraggiare il dissenso e giustificare la stretta sull’ordine pubblico. Si moltiplicano gli arresti anche nella società civile, ma soprattutto le generazioni più giovani non sembrano intenzionate a fermarsi. E il mondo osserva con preoccupazione quello che accade in un Paese chiave per stabilire gli equilibri geopolitici asiatici.
All’inizio si battevano le pentole in segno di dissenso. Ma è ormai da dieci giorni che le strade delle principali città birmane sono invase dalle proteste. Le manifestazioni si susseguono nella capitale politica Naypyidaw, in quella economica di Yangon e a Mandalay, ma non solo. Alle manifestazioni si affiancano gli scioperi, con la presenza anche di diversi monaci buddhisti e di suore e preti cattolici, e una continua disobbedienza civile.
Secondo gli osservatori, era dai tempi della “rivoluzione zafferano” del 2007 (che anticipò le prime riforme e aperture del regime militare) che non si vedeva una partecipazione di massa così numerosa. Con un’ampia presenza delle generazioni più giovani, quelle che sono cresciute in una società che sembrava avviata alla transizione democratica.
Generazioni le cui aspirazioni sono più difficili da contenere per il Tatmadaw, anche per l’utilizzo massiccio dei social media che, come già accaduto altrove, servono a fare da collante per le proteste. Non è un caso che le autorità abbiano imposto un blocco quasi totale di Internet. Navigare liberamente è diventato, per gli utenti birmani, molto complicato negli ultimi giorni. E sempre sui social comincia a serpeggiare la paura che la repressione dei militari possa diventare più violenta. C’è chi teme che alla fine i timori possano bloccare o diminuire l’intensità delle proteste. I manifestanti chiedono di mantenere alta la partecipazione e parlano di “settimana decisiva”, con i dipendenti pubblici chiamati a non cedere alle pressioni.
Se le proteste proseguono, la repressione si intensifica. A Yangon sono arrivati per la prima volta i mezzi blindati e le strade sono pattugliate dai militari. Stando a un video pubblicato su Twitter dal giornalista Mratt Kyaw Thu, le forze di sicurezza hanno aperto il fuoco (non è chiaro se con proiettili veri o di gomma) verso i manifestanti nella città di Myitkyina, nello Stato di Kachin nel nord del Paese. Una ragazza è stata colpita da un proiettile a Naypyidaw e ora è in fin di vita. A Mandalay i dimostranti sono stati respinti a colpi di fionda e di bastoni, con proiettili di gomma sparati anche all’interno delle case. I fucili, per ora, hanno sparato in aria. Ma il timore è che l’escalation di violenza possa presto arrivare a un punto di non ritorno.
All’azione dei militari si accompagna quella delle bande criminali. Ronde di civili armati, in larga provenienti dai 23mila prigionieri liberati dalle carceri nei giorni scorsi, vengono utilizzate dalle forze di sicurezza per giustificare la stretta sull’ordine pubblico e allo stesso tempo per spaventare chi ha intenzione di protestare in modo pacifico.
Alla repressione fisica si accompagna quella legale. Si minacciano fino a venti anni di carcere per “ostruzione alle forze armate” e pene severe anche per chi incita a “odio o disprezzo” verso i militari. Misure pensate anche verso i giornalisti, che sono finiti nel mirino. Almeno sette reporter sarebbero stati arrestati, mentre il Ministero dell’Informazione ha informato giornalisti e gruppi editoriali che “non devono scrivere allo scopo di causare tumulti di piazza”. Il tentativo è quello di controllare la narrazione che si fa delle proteste, che i militari vorrebbero vedere descritte come “tumulti” o “rivolte”, e del golpe stesso. Si sta preparando anche una nuova legge sulla cybersicurezza per imporre nuove restrizioni sui social.
Al momento sono stati fermati oltre 320 parlamentari, ma gli arresti coinvolgono anche la società civile e chi protesta pacificamente. A Naypyitaw sarebbero stati fermati tra i 20 e i 40 studenti, tutti minorenni, e una folla ha protestato fuori dalla centrale di polizia per chiederne il rilascio.
Aung San Suu Kyi, nel frattempo, resta in detenzione preventiva almeno fino a mercoledì 17 febbraio, quando sarà interrogata in videoconferenza per la presunta violazione della legge sull’import-export per la detenzione di sei walkie-talkie. La leader della Lega nazionale per la democrazia, trionfatrice alle elezioni dello scorso novembre, rischia fino a tre anni di reclusione. Pena che di fatto la escluderebbe dalla elezioni “libere” che la giunta militare ha annunciato di voler organizzare per il prossimo anno, al termine dello stato d’emergenza. Accusa alla quale si è aggiunta anche quella di aver violato la legge sulle catastrofi naturali.
A “rassicurare” i militari c’è per ora la timidezza dei vicini asiatici. La Cina continua a definire l’evoluzione come un “affare interno”, in linea col cosiddetto principio di “non interferenza” che governa la politica estera di Pechino e di tanti altri Paesi dell’area. Il Governo cinese ha smentito le voci secondo le quali stia aiutando il Tatmadaw dal punto di vista operativo (l’arrivo di cinque cargo con derrate alimentari dallo Yunnan ha diffuso sospetti sul possibile invio di rinforzi militari) e dal punto di vista informatico, in particolare sulla costruzione di un “great firewall” per bloccare Internet.
Ma in Myanmar non tutti si fidano del Dragone. Nei giorni scorsi ci sono state diverse manifestazioni davanti all’ambasciata cinese. Come già spiegato su eastwest, il Myanmar è fondamentale all’interno del progetto della Belt and Road Initiative di Xi Jinping. Il porto di Kyaukpyu garantisce, attraverso il corridoio economico bilaterale, l’accesso al Golfo del Bengala e dunque all’Oceano Indiano aggirando lo stretto di Malacca. Il Governo cinese aveva ottimi rapporti con Suu Kyi, ma il suo principale interesse è la stabilità. A prescindere da chi ci sia alla guida. Per questo non ha intenzione di interferire coi processi interni birmani.
Timidezza comune anche all’India. Nuova Delhi ha spedito ai militari un sottomarino negli scorsi mesi e ha da poco vinto la corsa sulla “diplomazia del vaccino“, regalando un milione e mezzo di dosi alle quali se ne sono sommate altre 30 milioni vendute. Lo stesso Giappone ha sempre mantenuto rapporti di collaborazione con il Tatmadaw. In una recente visita in Myanmar, il Ministro degli Esteri nipponico Motegi Toshimitsu ha incontrato sia Suu Kyi sia il generale Min Aung Hlaing, come fatto dall’omologo cinese Wang Yi. D’altronde Tokyo ha importanti interessi economici nel Paese.
L’Onu ha avvertito che i capi della giunta militare saranno “ritenuti responsabili” delle violenze nel Paese. “È come se i generali avessero dichiarato guerra al popolo birmano”, ha scritto su Twitter il relatore speciale delle Nazioni Unite Tom Andrews.
Ma per ora, sul fronte occidentale, arrivano soprattutto avvertimenti. In una dichiarazione congiunta, gli ambasciatori di Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Finlandia, Norvegia, Svizzera e da diversi paesi dell’Unione europea (tra cui Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Spagna e Danimarca) hanno fatto appello “alle forze di sicurezza perché si astengano dalla violenza contro i manifestanti e i civili che protestano contro il rovesciamento del loro legittimo Governo”. Nello stesso comunicato vengono condannati gli arresti e “le aggressioni ai giornalisti”, così come “l’interruzione delle comunicazioni” e le “limitazioni dei diritti fondamentali e delle tutele legali essenziali dei cittadini birmani”. Con un ammonimento finale: “Il mondo sta guardando”.
Nei giorni scorsi, il neo Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato l’imposizione di sanzioni contro i militari responsabili del colpo di Stato. Annuncio che è piaciuto ai manifestanti, che si sono radunati sotto la rappresentanza diplomatica americana di Yangon per esprimere sostegno alla Casa Bianca.
“Il mondo sta guardando”. Forse guardare non basta più.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Non si può certo dire che l’India stia attraversando un momento tranquillo. E non solo per il crollo di un ghiacciaio dell’Himalaya che ha causato decine di morti e dispersi. Il Paese è infatti scosso dalle proteste di massa dei contadini che contestano la riforma agraria del Governo. Le manifestazioni vanno avanti da tempo, ma la loro vastità e intensità sono aumentate di recente, dopo che è fallito il tentativo di mediazione della Corte suprema. Narendra Modi continua a ripetere che l’India “è la madre della democrazia“, ma nello stesso tempo cerca di spegnere i riflettori internazionali che si stanno piano piano accendendo sulla vicenda, per esempio bloccando Internet. In realtà, il Primo Ministro porta avanti da tempo una politica nazionalista e autoritaria. Cosa che rischia di creare qualche frizione con Joe Biden, anche se gli Stati Uniti puntano forte sul ruolo di Nuova Delhi per contrastare l’ascesa della Cina, come conferma la strategia sull’Indo-Pacifico desecretata da Mike Pompeo prima di lasciare il suo posto e dalla telefonata tra il neo Presidente americano e il Primo Ministro indiano di lunedì 8 febbraio.
Le proteste sono partite dalle tre regioni settentrionali, Punjab, Haryana e Uttar Pradesh, la cintura agricola del Paese. Nel mirino, tre leggi che regolano stoccaggio, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli. La prima riduce i poteri dei comitati statali, la seconda impone un quadro normativo più preciso e vincolante, la terza limita l’intervento centrale su offerta e individuazione di materie prime essenziali. Tutte insieme mirano a una modernizzazione dell’agricoltura indiana e a un aumento dei profitti.
Il Governo Modi ritiene che le misure daranno nuovo slancio al settore, ma i contadini sono convinti che la riforma preveda un’eccessiva liberalizzazione che favorirà i grandi conglomerati industriali a scapito dei piccoli e medi produttori. Criticata anche la modalità con cui si è arrivati alla riforma, col mancato coinvolgimento dei sindacati e scarsa una concertazione parlamentare. A questo si aggiunge una diminuzione delle risorse messe a disposizione dell’agricoltura, che scendono dal 5,1 al 4,3% del totale. Situazione cavalcata dal Congresso nazionale, principale forza di opposizione, che ha boicottato l’apertura dei lavori della sessione invernale del Parlamento indiano e critica in maniera aspra il bilancio previsto dalla maggioranza del Bharatiya Janata Party per il 2021-2022. Senza dimenticare il forte impatto sanitario ed economico della pandemia da coronavirus, visto che l’India è al secondo posto al mondo per numero di contagi dopo gli Stati Uniti.
Quando si parla di proteste, non ci si riferisce a manifestazioni sporadiche. Centinaia di migliaia di agricoltori sono accampati alle porte di Nuova Delhi dalla fine di novembre. Oltre due mesi di tensioni con le forze di polizia, spesso sfociati nel caos, dopo che i contadini si sono mossi, soprattutto da Punjab e Uttar Pradesh, verso la capitale. L’8 dicembre c’è stato uno sciopero generale, seguito da uno sciopero della fame che, secondo le ong locali, avrebbe causato circa 150 morti a causa del freddo.
I rappresentanti sindacali si sono incontrati con quelli governativi in diverse occasioni, ma non si è mai arrivati a un accordo. La sospensione delle nuove norme operata dalla Corte suprema, che ha istituito un comitato ad hoc per esaminare le leggi, non è bastata a calmare la situazione. Dopo l’ultimo tentativo di negoziato fallito, lo scorso 22 gennaio, la situazione è precipitata. La marcia dei trattori del 26 gennaio si è trasformata in un assalto al Forte Rosso, uno dei simboli della capitale indiana. In quell’occasione sono state arrestate 120 persone e un manifestante è morto, ufficialmente vittima di un incidente col suo trattore, ma secondo alcuni manifestanti per gli spari delle forze dell’ordine. La polizia sostiene che nell’occasione circa 400 agenti siano rimasti feriti. Violenze criticate anche dai leader della protesta.
Sabato 6 febbraio migliaia di trattori hanno operato blocchi stradali lungo le principali arterie del Paese, paralizzando per alcune ore il traffico autostradale. E intanto, si moltiplicano gli episodi di violenza, come a fine gennaio quando un folto gruppo di nazionalisti indù ha fatto irruzione in uno degli accampamenti di contadini lanciando pietre e intimandogli di andarsene. Ma gli agricoltori continuano a ribadire che la protesta andrà avanti fino a quando le tre leggi non verranno abrogate.
Lunedì 8 febbraio Modi è intervenuto al Consiglio degli Stati, cercando di rassicurare i contadini. Ha difeso il contenuto della riforma, ma ha offerto dialogo e ha garantito che il prezzo minimo di vendita non sarà eliminato. Il Primo Ministro ha anche espresso parole di apprezzamento per i sikh, comunità maggioritaria nel Punjab e all’interno della quale ci sono da tempo spinte indipendentiste. Dopo aver definito l’India “la madre della democrazia” ha chiesto agli agricoltori di smettere di protestare e se l’è presa con “i parassiti e agitatori di professione”.
In realtà, con Modi l’India sembra essere protagonista di una svolta autoritaria. I principi di laicità e multiculturalità, pilastri della repubblica, vacillano a favore del nazionalismo indù. Basti pensare all’edificazione del “grande tempio di Ram” sulle rovine di una moschea demolita nel 1992 oppure all’improvvisa revoca dello statuto speciale allo stato del Jammu e Kashmir. Come la Cina opera da tempo una sinizzazione delle minoranze e dei suoi nodi interni più critici, così Modi sta portando avanti una indianizzazione, nella quale tra l’altro diversi attivisti e giornalisti sono finiti in carcere o peggio. Una promessa di preservazione della tradizione indiana e del suo rispetto sulla scena internazionale che potrebbe garantire solo il Bjp.
Nelle ultime settimane, intanto, è stato disposto il divieto di espatrio per una ventina di leader sindacali e Internet è stato a più riprese sospeso in diverse aree.
Le ripercussioni internazionali
La retorica del Governo è quella dell’attacco esterno alla stabilità indiana. Nel mirino sono finite le prese di posizione di celebrità internazionali come Greta Thunberg e la popstar Rihanna, che si sono schierate a favore dei contadini. Sostenitori del Fronte Unito Indù hanno bruciato delle foto delle due, mentre il Governo ha chiesto a Twitter di bloccare oltre un migliaio di account collegati all’hashtag #farmergenocide (genocidio dei contadini).
L’attenzione globale su quanto accade in India è in aumento. E c’è chi ritiene che possa sorgere qualche problema con l’amministrazione Biden, più attenta sui diritti umani rispetto a quella Trump. La scorsa settimana un portavoce del Dipartimento di Stato Usa ha definito le proteste pacifiche e l’accesso incondizionato al web come prerequisiti “fondamentali per la libertà di espressione e segno distintivo di ogni democrazia”. Il Governo di Nuova Delhi ha risposto paragonando l’assalto al Forte Rosso del 26 gennaio all’assedio di Capitol Hill. Non è un mistero, allo stesso tempo, che gli Stati Uniti puntino sull’India per contenere l’ascesa cinese nell’Indo-Pacifico. Linea adottata da Trump e Pompeo, ma ribadita anche da Biden. Il neo Presidente americano ha avuto un colloquio telefonico con Modi durante il quale si è parlato di rafforzare l’architettura regionale “attraverso il Quad“, la piattaforma di dialogo e cooperazione militare che coinvolge, oltre a Washington e Nuova Delhi, anche Giappone e Australia.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Nel 1990, la neonata Lega nazionale per la democrazia vinse le elezioni conquistando circa il 90% dei seggi parlamentari disponibili. L’esercito birmano si rifiutò però di riconoscere l’esito del voto e Aung San Suu Kyi trascorse circa 15 dei successivi 20 anni agli arresti domiciliari nella sua residenza di Yangon. Trentuno anni dopo succede di nuovo: un golpe “costituzionale” disattende il risultato delle elezioni dello scorso 8 novembre e mette fine, dopo un decennio di speranze disattese, alla libertà del premio Nobel per la Pace 1991. Trentuno anni dopo succede di nuovo: il Myanmar interrompe la sua transizione democratica e fa un salto nel vuoto. Ma nel frattempo è cambiato tutto, dentro e fuori il Paese. Suu Kyi, 75 anni, viene guardata a vista stavolta nella sua abitazione di Naypyidaw. E il mondo, soprattutto occidentale, che si era chiuso in una visione manichea del Paese del Sud-est asiatico, a metà strada tra fiaba e distopia, si trova a dover fare i conti con una realtà complessa.
I militari hanno aspettato fino all’ultimo. Poi, alla vigilia della prima sessione parlamentare della nuova legislatura, hanno agito. La consigliera di Stato Suu Kyi, il Presidente Win Mynt e decine di arresti tra politici ai vertici della Lega nazionale per la democrazia, attivisti e artisti sono stati arrestati. Il vice Presidente Mynt Swe, appena nominato Presidente ad interim, ha ceduto tutti i poteri al Tatmadaw (l’esercito birmano). Il capo delle forze armate, il generale Min Aung Hlaing, ha proclamato lo stato di emergenza per un anno e ha annunciato che si terranno “elezioni libere e regolari” al termine delle quali il potere sarà nuovamente trasferito.
In realtà, i militari non se n’erano mai andati. Le riforme adottate dal Governo di Thein Sein a partire dal 2010 avevano consentito a Suu Kyi di conquistare un seggio alle elezioni suppletive del 2012 e al suo partito di correre (e vincere) alle elezioni del 2015, con una progressiva condivisione dei poteri con la sfera politica e civile. Ma l’esercito ha sempre mantenuto il controllo del Paese. La costituzione del 2008 gli attribuisce di diritto tre Ministeri (Difesa, Affari interni e Affari di frontiera) e il 25% dei deputati del Parlamento. Ora che il nuovo Governo è composto per la maggior parte da Ministri già presenti nell’era Thein Sein e che i mezzi armati pattugliano i centri nevralgici della capitale politica Naypyidaw e di quella economica Yangon, appare chiaro anche ai più disattenti che l’esercito non se n’era mai andato.
Myint Swe ha difeso la mossa dei militari sostenendo che il golpe è “costituzionale” in quanto era in atto un “tentativo di usurpare la sovranità dello stato con mezzi illegali”. Secondo la costituzione birmana, i militari possono prendere il potere qualora credano che ci sia una “minaccia alla sicurezza nazionale” che possa causare “la disintegrazione dell’unione”. Secondo l’articolo 417, qualora fossero ravvisati questi rischi, il Presidente deve proclamare lo stato d’emergenza che si traduce automaticamente (articolo 418) nel trasferimento di tutti poteri al capo delle forze armate.
Non si può dire che il golpe non fosse nell’aria. La scorsa settimana erano arrivati aperti avvertimenti sia dal portavoce dell’esercito, Zaw Min Tun, che dal generale Hlaing. Alla base dell’azione ci sono le accuse di brogli elettorali durante il voto dello scorso novembre. Secondo l’esercito, il partito di Suu Kyi avrebbe tratto vantaggio da 10 milioni di voti falsi. A dire la verità, c’erano state perplessità anche a livello internazionale per l’esclusione dal diritto alle urne di alcune minoranze e soprattutto dei rifugiati rohingya. In tutto 17 partiti su oltre 90 andati alle urne hanno denunciato irregolarità ma la commissione elettorale ha sempre detto che non si erano verificati errori su una scala tale da poter parlare di frode.
La Corte suprema aveva deciso di rinviare di due mesi il suo pronunciamento sul ricorso dei militari, ma il suo orientamento sembrava essere quello di confermare l’esito elettorale, che aveva consegnato alla Lnd oltre l’80% dei seggi disponibili, 396 su 476, contro i 33 del Partito dell’unione della solidarietà e dello sviluppo, emanazione politica dell’esercito dal 1990. Una sconfitta di proporzioni inattese per il Tatmadaw, che a questo punto ha temuto di perdere il controllo del Paese, con una condivisione dei poteri che rischiava (ai suoi occhi) di diventare troppo squilibrata a favore della sfera civile. L’esercito ha dichiarato che l’obiettivo è quello di creare una “vera democrazia multipartitica” ma alla base del golpe sembra esserci soprattutto la paura che Suu Kyi potesse tentare la strada della riforma costituzionale, cancellando la regola contra personam che la esclude dalla possibilità di diventare presidente perché ha figli di nazionalità straniera.
C’è poi un elemento più personale. Hlaing, alla guida del Tatmadaw dal 2011 e account Facebook cancellato nel 2018 per le accuse di genocidio ai danni della minoranza rohingya, avrebbe dovuto ritirarsi quest’anno dall’esercito e non ha nascosto le sue ambizioni politiche. Nelle trattative, poi naufragate, con la Lnd, i militari avrebbero tentato di imporlo come Presidente. Dopo una tornata elettorale divenuta soprattutto un referendum popolare, come dice Giulia Sciorati di Ispi, Hlaing e le forze armate hanno temuto che Suu Kyi acquisisse troppo potere, accelerando una transizione democratica che era più che altro un compromesso forzato.
Il Governo Lnd ha deluso molti negli ultimi cinque anni, soprattutto a livello internazionale. Chi si aspettava che Suu Kyi potesse di colpo trasformare la difficile coesistenza con l’esercito in una democrazia occidentale è stato deluso. In particolare dalle sue timidezze sui rohingya, tema sul quale la consigliere di stato è intervenuta all’Aja negando il genocidio. Nonostante questo, la condanna dell’azione militare e del suo arresto è stata unanime nel mondo occidentale. Dagli Stati Uniti sono arrivate le parole più decise. Dopo che l’ex segretario di Stato Mike Pompeo (contemporaneamente alle accuse di brogli di Donald Trump) aveva avanzato dubbi sulla legittimità del voto birmano, Joe Biden ha parlato di “attacco diretto alla transizione democratica” e ha intimato ai militari di “rinunciare immediatamente al potere”, paventando sanzioni. Sulla stessa linea l’Unione europea, mentre l’Onu ha convocato una riunione d’emergenza del Consiglio di sicurezza.
Il Myanmar è uno snodo cruciale per gli assetti geopolitici dell’Asia sud-orientale. Qui la Cina sta sviluppando numerosi progetti in ambito Belt and Road, all’interno di un corridoio economico che ha lo scopo di garantire a Pechino l’accesso al golfo del Bengala (attraverso il porto di Kyaukpyu e la zona economica speciale limitrofa) e un miglioramento delle condizioni delle aree di confine, allo stesso tempo promuovendo lo sviluppo infrastrutturale birmano. A inizio 2020 Xi Jinping è stato in visita a Naypyidaw e per l’occasione sono stati firmati 38 memorandum of understanding, 29 dei quali però sono ancora da approvare. La pandemia ha rallentato lo sviluppo della cooperazione sinobirmana, insieme alla competizione commerciale del Giappone e a quella politico-difensivo dell’India. Dopo aver donato un sottomarino, nelle scorse settimane Nuova Delhi ha elargito al Myanmar un milione e mezzo di dosi del suo vaccino. Il Governo birmano ha stoppato l’approvazione del siero cinese e ha acquistato altre 30 milioni di dosi di quello prodotto da Serum.
Anche per questo, c’è chi ritiene che Pechino possa aver segretamente appoggiato il golpe. Solo poche settimane fa il Ministro degli Esteri Wang Yi ha iniziato dal Myanmar il suo tour nel Sud-est asiatico, incontrando anche esponenti del Tatmadaw. In realtà, il Dragone ha coltivato rapporti positivi con entrambe le fazioni. Xi e Suu Kyi (entrambi figli di padri rivoluzionari) si sono incontrati più volte e hanno parlato di un “legame di sangue” tra i due popoli. Con l’esercito non sono mancate alcune frizioni, in particolare sulla questione delle milizie armate di etnia cinese. Le forze armate birmane sospettano che Pechino le abbia in qualche modo sostenute, sottolineando il ritrovamento di armi cinesi tra le mani dei gruppi indipendentisti del Kachin, mentre in più occasioni delle bombe sono cadute in territorio cinese, causando anche una vittima nel 2017. La sensazione è che, più che parteggiare per una fazione o l’altra, a Pechino faccia comodo soprattutto la stabilità.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Nel 1986 venne annunciato il Doi Moi, il programma di riforme e aperture alla base alla base del balzo economico del Vietnam. Nel 1991 furono normalizzate le relazioni diplomatiche con la Cina, interrotte dopo il conflitto di frontiera del 1979. Nel 2006 si promosse la liberalizzazione del commercio e un’ulteriore apertura agli investimenti diretti stranieri, ultimo step necessario all’ingresso nell’Organizzazione mondiale del commercio.
Insomma, il Congresso del Partito comunista vietnamita è una cosa seria. Si riunisce ogni cinque anni e imprime spesso una svolta cruciale alla traiettoria politica, economica e diplomatica del Vietnam. Anche stavolta non farà eccezione. Circa 1600 delegati sono arrivati nella capitale Hanoi per partecipare al 13esimo Congresso, che ha preso il via lunedì 25 gennaio e si concluderà martedì 2 febbraio. Otto giorni di incontri a porte chiuse per prendere una serie di decisioni fondamentali. Il tentativo è quello di continuare su un percorso di crescita economico e geopolitico, culminato in un 2020 pieno di soddisfazioni, dalla brillante gestione della pandemia (a oggi meno di 1600 casi e 35 morti dall’inzio dell’emergenza) all’ambiziosa presidenza di turno Asean (l’Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico) conclusasi con la firma della Rcep (Regional Comprehensive Economic Partnership).
Al congresso saranno nominati i 19 membri del nuovo Politburo e soprattutto le quattro cariche cruciali del sistema vietnamita: segretario generale del partito, Presidente della Repubblica, Primo Ministro e Presidente dell’Assemblea nazionale (il corpo legislativo unicamerale). Sono le figure su cui si basa il cosiddetto principio dei “quattro pilastri”. Saranno inoltre eletti i 180 nuovi membri del Comitato centrale, il vero organo decisionale del partito. È in quella sede che si consumano trame e battaglie di potere che stabiliscono gli equilibri resi espliciti durante il congresso, dove però non sono rari i colpi di scena.
Lo scorso mese, il Comitato centrale si è riunito per individuare i quattro nomi che dovranno occupare le poltrone principali. Non è stata rilasciata alcuna antiticipazione ufficiale, ma le indiscrezioni riportate dai principali media dell’Asia orientale coincidono: Nguyễn Phú Trọng dovrebbe conservare la carica più importante, quella di segretario del partito. In pochi se lo aspettavano, per motivi personali e legali. Trọng, 76 anni, è quasi scomparso dalla scena pubblica da circa un anno e si rincorrono le voci su condizioni di salute che sarebbero precarie. Non solo. Secondo lo statuto del partito non si può ricoprire quel ruolo per più di due mandati consecutivi. Cosa che Trọng ha già fatto, essendo stato eletto per la prima volta nel 2011 e per la seconda nel 2016. Se l’indiscrezione fosse confermata, Trọng diventerebbe il leader più longevo dai tempi di Lê Duẩn, il successore di Ho Chi Minh. Servirebbe la rimozione del limite dei due mandati, un po’ come accaduto nel 2018 in Cina per Xi Jinping.
D’altronde, non sarebbe la prima regola a essere modificata durante l’era Trọng, con un progressivo e (in tempi recenti) inedito accentramento di poteri. A partire dalla decisione, nel 2011, di sottrarre la direzione del comitato centrale anticorruzione al Primo Ministro e portarla sotto il segretario. Strumento che ha consentito a Trọng di lanciare una dura campagna per sbarazzarsi di alcuni rivali politici dopo il congresso del 2016 che lo vide prevalere sull’allora Primo Ministro Nguyễn Tấn Dũng. Nel 2018 Trọng è stato nominato anche Presidente dopo la morte improvvisa di Tran Dai Quang. Circostanza che ha rotto un’altra consuetudine, quella che una sola persona non possa ricoprire più di una delle quattro cariche principali. La conferma di Trọng potrebbe significare che le diverse correnti del partito non sono riuscite a mettersi d’accordo sul nome del successore, visto che tra i favoriti della vigilia nessuno conquisterebbe posizioni di vertice. A parte il Primo Ministro uscente, Nguyễn Xuân Phúc, che dovrebbe però accontentarsi di diventare Presidente, mentre al suo posto arriverebbe Pham Minh Chinh, l’attuale capo della commissione centrale di personale e organizzazione. L’ultima casella, quella di Presidente dell’Assemblea nazionale, verrebbe riempita da Vuong Dinh Hue, ex vice Primo Ministro e segretario del partito ad Hanoi. Tutti e quattro i prescelti provengono da regioni settentrionali, il che potrebbe provocare qualche malumore visto che solitamente si cercava di rispettare una rappresentanza più diversificata.
Durante il Congresso verrà dato anche il via libera al prossimo piano quinquennale. Il Vietnam ha percentuali di crescita importanti da diverso tempo. Secondo la Banca mondiale, tra il 2002 e il 2018 oltre 45 milioni di vietnamiti sono usciti da una condizione di povertà assoluta e il Pil pro capite è aumentato di 2,7 volte. Nel 2020, il Vietnam è stato uno dei pochi Paesi al mondo a crescere. Nonostante la pandemia, il Pil è aumentato di quasi il 3%, comunque la percentuale più bassa degli ultimi decenni. Secondo le stime, nel 2021 Hanoi dovrebbe tornare a correre tra il 6,5 e l’8%. Questo grazie all’aumento di investimenti esteri, attratti dal successo della gestione sanitaria e dal basso costo del lavoro, che sta favorendo il Vietnam nei confronti della Cina, da dove diverse linee produttive si stanno ricollocando anche a causa degli effetti collaterali della guerra commerciale tra Pechino e Washington. Hanoi conta anche di far ripartire il turismo in entrata, voce importante del Pil locale, grazie alle bolle di viaggio regionali.
L’economia vietnamita, che entro il 2035 dovrebbe diventare la 19esima al mondo, dipende però ancora in maniera eccessiva dalle esportazioni, trainate da compagnie straniere come Samsung o Hyundai. Il surplus commerciale verso gli Stati Uniti, per esempio, è cresciuto di 16 miliardi di dollari in un anno, passando dai 47 miliardi del 2019 ai 63 del 2020. Ci si aspettano mosse per rafforzare la scena delle imprese autoctone e per stimolare i consumi interni.
Un sospiro di sollievo, proprio alla vigilia del Congresso, è arrivato dagli Usa. Negli scorsi mesi Washington aveva accusato Hanoi per manipolazioni valutarie, ma alla fine ha deciso di non imporre sanzioni o tariffe.
Dal Congresso emergeranno anche indicazioni utili per capire l’orientamento della politica estera vietnamita. Il rapporto più complicato di Hanoi è, da sempre, quello con la Cina. Alle storiche dispute territoriali nel Mar cinese meridionale si è aggiunta la questione della valle del Mekong, il maggiore fiume dell’Indocina lungo il quale Pechino sta costruendo dighe e centrali idroelettriche. Il dossier sta creando tensioni anche coi due vicini Cambogia e Laos, sempre più inseriti negli ingranaggi cinesi. Proprio negli scorsi giorni, Xi ha firmato un decreto presidenziale per l’adozione della nuova legge sulla guardia costiera. La riforma, che entrerà in vigore dal 1° febbraio, prevede tra le altre cose un ampliamento dei poteri dei mezzi navali, che potranno anche aprire il fuoco su navi straniere. Ci si aspetta che dal Congresso emergano novità in materia difensiva con un incremento delle spese militari.
Il Vietnam, d’altronde, è il Paese più deciso tra quelli Asean a far fronte alle pretese di Pechino sul Mar cinese meridionale. Negli ultimi anni, Hanoi ha incrementato la cooperazione commerciale e militare con le potenze medie asiatiche, in primis Giappone, Corea del Sud e India. Sin dalla normalizzazione dei rapporti bilaterali, avvenuta nel 2015, gli Stati Uniti puntano sul ruolo di Hanoi nella loro strategia di contenimento della Cina. Ma, come già dimostrato più volte in passato, sarà difficile “arruolare” il Governo vietnamita, impegnato a mantenere un difficile equilibrio con l’ingombrante vicino. Se le tensioni geopolitiche sono innegabili, la cooperazione commerciale con Pechino è imponente. Tra le altre cose, il Dragone è il principale fornitore di materiali per l’industria manifatturiera, settore cruciale per l’economia vietnamita.
Nel frattempo, il Vietnam continua la sua ascesa diplomatica non solo all’interno dell’Asean, di cui nel 2020 ha rappresentato il centro nevralgico anche grazie alla presidenza di turno, ma a livello globale. Basti pensare all’inaugurazione del centro di peacekeeping delle Nazioni Unite di Hanoi nel 2014 e all’accordo di libero scambio con l’Unione europea, entrato in vigore lo scorso agosto, bissato alla fine del 2020 con un ulteriore accordo con il Regno Unito post Brexit. E a proposito di Europa, dal Congresso può arrivare una possibile replica alle accuse del Parlamento Ue sui diritti umani, avanzate per l’arresto di alcuni giornalisti critici del Governo.
Dal 3 febbraio, alla fine del Congresso, sapremo di più sul futuro del Vietnam e degli equilibri a Sud-est.
Abbonati per un anno a tutti i contenuti
del sito e all’edizione cartacea + digitale della rivista di
geopolitica a € 45.
Se desideri solo l’accesso al sito e l’abbonamento alla rivista digitale, il costo
per un anno è € 20

Più 2,3. Si nasconde dietro questo aumento percentuale un anno di (stra)ordinaria follia per la Cina. Il 2020 si era aperto con la diffusione del coronavirus a Wuhan e il Covid-19 che sembrava poter persino essere il “cigno nero” del Partito comunista. Il 2021 si apre con la certificazione di quello che appare chiaro già da tempo: la Cina è uscita per prima dalla crisi sanitaria ed è ripartita. Risultato che rappresenta non solo un buon segnale economico, ma anche un successo a livello geopolitico. Dalle modalità di questa ripartenza si evince, però, che esistono diversi problemi e che l’agognata trasformazione del Dragone da fabbrica del mondo a economia basata sui consumi interni è ancora lontana dall’essere completata.
Partiamo dai numeri. Secondo i dati diffusi dall’ufficio nazionale di statistica, il Pil è cresciuto del 2,3% su base annua: in Asia orientale crescono anche Taiwan e Vietnam, ma l’economia cinese è l’unica tra quelle principali ad avere un segno positivo alla fine del 2020. Si tratta del tasso di crescita più basso mai registrato negli ultimi 45 anni, cioè da prima che il “piccolo timoniere” Deng Xiaoping lanciasse la stagione delle riforme e dell’apertura. Per trovare una performance peggiore bisogna infatti andare al 1976, ultimo anno della Rivoluzione Culturale di Mao Zedong, quando il Pil si contrasse dell’1,6%. Pechino preferisce comunque concentrarsi su un altro dato, vale a dire il superamento (per la prima volta) della quota di centomila miliardi di yuan (circa 15 miliardi e mezzo di dollari) del volume del prodotto interno lordo.
Dato ancora più incoraggiante quello sul quarto trimestre, che segna un parziale del +6,5%. Si tratta di un aumento sopra le attese (si prevedeva un +6,1%) e superiore al +6% dell’ultimo trimestre del 2019. Ciò significa che, negli ultimi tre mesi dell’anno, la Cina è cresciuta a un ritmo persino più rapido del pre Covid. È cresciuta sopra le attese anche la produzione industriale, +2,8% su base annua e +7,1% nel quarto trimestre, trainata dal settore manifatturiero (+3,4%).
I risultati economici, resi possibili da una gestione sanitaria dura ma efficace, garantiscono a Pechino la possibilità di proseguire la linea narrativa portata avanti negli scorsi mesi e che presenta la Cina come il Paese più adatto a fronteggiare le emergenze pandemiche, potenza responsabile e irrinunciabile partner commerciale. Una narrativa che si basa su alcuni episodi ed elementi chiave. Primo: 10 marzo 2020, il Presidente Xi Jinping si recò a Wuhan per dichiarare la prima vittoria sul “demone” virale. Un viaggio che dimostra, ai cinesi e al mondo, la velocità di reazione del Governo. Secondo: rimodulazione sanitaria della Belt and Road con l’esportazione di mascherine e altro materiale medico in Paesi di tutto il mondo, compresa l’Italia, e lancio della “diplomazia del vaccino” che sta portando risultati in particolare nel Sud-est asiatico, dove il Presidente indonesiano Joko Widodo si è fatto iniettare la prima dose di SinoVac. Terzo: l’annuncio dell’eliminazione della povertà assoluta, obiettivo inaggirabile del 2020 per il raggiungimento dello status di “società moderatamente prospera” nel 2021, centenario della fondazione del Partito comunista cinese. Obiettivo raggiunto, almeno ufficialmente, nonostante la pandemia. Da ultimo, appunto, i dati positivi sul Pil mentre il mondo occidentale vedrà solo segni meno. “In un anno straordinario, la Cina è riuscita in risultati straordinari. Una performance raggiunta mentre il mondo ci guarda e che può essere registrata negli annali di storia”, ha dichiarato Ning Jizhe, direttore dell’Istituto nazionale di statistica.
Tutto bene dunque? Non proprio. La crescita del Pil si poggia su due pilastri dai quali il Governo stava cercando di affrancarsi: infrastrutture ed export. Quando è entrata in crisi per la pandemia, la Cina ha reagito nel modo che conosce meglio: lanciando un maxi pacchetto di stimoli fiscali. La naturale conseguenza è stata quella di avviare nuovi investimenti infrastrutturali e immobiliari. Anche a costo di aumentare l’indebitamento delle amministrazioni locali, tanto che il debito pubblico cinese continua a salire. Con la produzione industriale aumenta quella di acciaio, che ha superato il miliardo di tonnellate, e l’estrazione mineraria.
Nel frattempo, l’export è aumentato del 3,6% su base annua e addirittura del 18,1% a dicembre, mentre l’import è diminuito dell’1,1%. I livelli record del surplus commerciale sono stati sostenuti, come accennato, dal lancio della Via della Seta sanitaria. Basti pensare che nel 2020 il Dragone ha esportato materiale sanitario per circa 67,82 miliardi di dollari e un numero pari a circa 40 mascherine a persona in tutto il mondo al di fuori della Cina.
Soffrono invece i consumi, che sembrano palesare una ripresa diseguale. Le vendite al dettaglio sono aumentate solo del 4,6% a dicembre (ben sotto il previsto +5,5%), non riuscendo a evitare il calo del 3,6% su base annua. Segnale che le incertezze sulla situazione sanitaria non si sono ancora del tutto spente.
Secondo i dati ufficiali, il tasso di disoccupazione resta invariato al 5,2% ma nel 2020 circa un terzo dei lavoratori delle aree rurali ha guadagnato meno che nel 2019. Durante il V Plenum di fine ottobre, lo stesso partito ha riconosciuto gli squilibri nello sviluppo tra province costiere e province interne. Un problema cronico, al quale si è aggiunta la sperequazione tra nord e sud: solo Pechino entra tra le prime dieci città cinesi per dimensioni economiche. Alla Conferenza centrale del lavoro sull’economia il Governo ha d’altronde avvertito che le basi della ripresa “non sono ancora solide”, mentre Xi, in un discorso alla scuola centrale del partito, ha ribadito che la contingenza economica presenta “sia opportunità sia incertezze” e che serve superare la “diseguaglianza” a livello sociale e geografico.
Se i dati generali sul Pil dimostrano ancora una volta la grande capacità di Pechino di adattarsi alle situazioni, se si guarda all’andamento economico sorgono alcune preoccupazioni sugli squilibri esistenti e sembrano andare in senso contrario agli obiettivi economici di lungo termine.
La contesa con gli Stati Uniti, le minacce di decoupling, la dipendenza dalle esportazioni, la crescita del debito, le disegueglianze interne. E, infine, la pandemia. Con un mondo esterno che va improvvisamente più lento. Tutti questi elementi hanno portato la Cina ad accelerare sul suo processo di svolta che, nelle intenzioni, la dovrebbe trasformare da “fabbrica del mondo” a società di consumi. Durante un simbolico viaggio nel Guangdong (sud della Cina) alla vigilia del V Plenum, Xi ha enunciato la teoria della “doppia circolazione“, secondo la quale il sistema economico del Dragone deve restare aperto al flusso esterno (commercio globale) ma deve soprattutto basarsi sul flusso interno (consumi). Con altre due parole d’ordine in mente: autosufficienza tecnologica, visti i muri eretti ai colossi cinesi dagli Usa, e sostenibilità ambientale, vedi l’annuncio dell’obiettivo della neutralità carbonica da raggiungere entro il 2060. Risultati da centrare limitando i rischi finanziari e aumentando la presenza dello stato (alias partito) nell’economia, compreso il fintech, come dimostra il caso di Ant Group. Il tutto con un focus su una crescita più qualitativa che quantitativa, come dimostra anche l’assenza di un target specifico sul Pil nel piano quinquennale che sarà approvato a marzo.
I dati economici del 2020 ci dicono che la strada da fare per rendere più equilibrata la crescita e raggiungere gli obiettivi di lungo termine è ancora parecchia.
La Cina, che secondo le stime dovrebbe crescere del 7,9% nel 2021, deve ora fare i conti anche con nuove preoccupazioni sanitarie. Da una settimana i nuovi contagi superano quota cento. Numeri risibili se raffrontati a quelli italiani ed europei, ma comunque significativi in un Paese che sembrava ormai “coronavirus free”. I casi si sono diffusi dalla provincia dello Hebei a quelle dello Jilin e dello Heilongjiang, con milioni di persone tornate in lockdown. A distanza di otto mesi si è registrato anche il primo decesso ufficiale per Covid. I focolai e i nuovi timori potrebbero incidere anche sul settore turistico, che nelle prossime settimane vivrà il suo picco con il periodo del Capodanno cinese, in calendario il 12 febbraio. Se fossero introdotte restrizioni agli spostamenti la crescita del primo trimestre potrebbe risentirne.
Inserendo il codice che hai trovato nel numero cartaceo del nuovo numero di eastwest puoi scaricare anche la versione digitale in PDF gratis